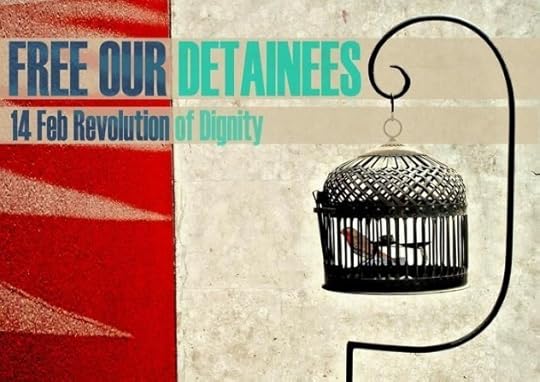Paola Caridi's Blog, page 118
February 21, 2011
Guerra civile? Semmai sollevazione…
Chiamare guerra civile quella che sta succedendo a Libia mi sembra improprio. E' vero che le informazioni sono frammentarie, è vero che non c'è la stampa internazionale e leggere in maniera più o meno neutrale gli avvenimenti, ma tutto ciò che esce dalla Libia, dai medici che parlano con Al Jazeera ai messaggi rimbalzati dagli esuli libici, parla di una sollevazione popolare che si tenta di reprimere nel sangue. Sparando indiscriminatamente sulla folla oppure usando mercenari dall'Africa subsahariana. Io non la definirei guerra civile… Ed è peraltro questo che lega le rivolte (ormai sempre più spesso rivoluzioni) arabe del 2011. Sollevazioni popolari a cui i regimi all'inizio rispondono chiudendo i rubinetti della poca informazione che circola, poi reprimendo con l'uso della polizia e delle forze di sicurezza che controllano.
Comunque, tornando a parlare di Libia, sino a ieri era la Cirenaica il cuore della rivolta. Regione storicamente ribelle. Ma l'area tripolina – quella più sotto il diretto controllo del regime di Gheddafi – non è rimasta impermeabile. Anzi. E' già da ieri sera che nella capitale vengono rimbalzate all'estero notizie di scontri. A fare un gran lavoro è un gruppo di giovani che si definisce – appunto – Shabab Libya. E' possibile seguirli su twitter, ma anche sul loro sito, http://www.libyafeb17.com/, dove sono anche indicate, oggi, rivendicazioni e background per capire qualche cosa di più di quello che sta avvenendo proprio a ovest dell'Egitto.
Intanto, ecco la cronaca che ho scritto per i giornali locali del Gruppo Espresso-Repubblica, e che trovate oggi in giro per l'Italia. Per loro, sto seguendo le rivoluzioni arabe da settimane.
Bengasi – da ieri sera - potrebbe essere sotto il controllo degli oppositori al regime quarantennale del colonnello Muammar Gheddafi. Non è possibile avere il conforto di fonti indipendenti, ma la notizia è stata rilanciata dai testimoni che vivono nella seconda città della Libia. Video e foto pubblicati su internet mostrano i manifestanti che festeggiano e pregano per le strade. Un'atmosfera del tutto diversa da quella della stessa domenica mattina, quando i funerali delle decine di vittime uccise dalle forze di sicurezza fedeli a Gheddafi sono stati di nuovo segnati da un altro massacro. Quando il corteo funebre è passato vicino alla caserma di Birka – questo il racconto di uno degli abitanti di Bengasi – i militari hanno cominciato a sparare sulla folla, indiscriminatamente.
La conta dei morti, tutta affidata alle notizie che arrivano dai medici dei diversi ospedali della città, parla di centinaia di vittime. I morti sarebbero più di 200 nella sola Bengasi, ma si parla anche di 500 vittime. Mentre i feriti – di cui molti in gravi condizioni, colpiti da proiettili anche di grande calibro – sarebbero centinaia e centinaia. Ancora sangue, dunque, e ancora sangue concentrato a Bengasi, capoluogo della Cirenaica, cuore da sempre dell'opposizione a Gheddafi ma anche regione che diede i natali al più grande eroe contemporaneo arabo. Omar al Mukhtar, l'eroe che combatté il colonialismo italiano, il 'leone del deserto' interpretato in un film di trent'anni fa – censurato nel nostro paese – da Anthony Quinn. Anche stavolta, dunque, è la Cirenaica che insorge. Perché non è solo Bengasi ad aver sfidato il potere di Gheddafi, ma una parte importante della Libia orientale.
Le notizie frammentarie, ancora una volta diffuse attraverso internet, dicono che dal pomeriggio Bengasi sia, almeno al centro, sotto il controllo degli insorti, ai quali si è aggiunta almeno una brigata dell'esercito libico, la brigata Saika, che avrebbe aperto la caserma di Al Birka.
Nel pomeriggio di domenica la Libia sembrava ancora spaccata in due, con l'est del paese sempre più coinvolto dalla rivolta contro il Colonnello. A ovest, a Tripoli, il potere di Gheddafi cerca di controllare le strade, dove negli scorsi due giorni si erano svolte solo manifestazioni di poche migliaia di persone a favore dell'autore del Libro Verde. A sera, però, si sono sentiti molti colpi di arma da fuoco proprio nella capitale. La rivolta è infatti arrivata all'area tripolina. A Zawya, a una cinquantina di chilometri di distanza, è stato dato fuoco a una casa di Gheddafi, e il tam tam degli esuli libici parla di manifestanti che dalla stessa Zawya, e da altre località dell'ovest del paese si stavano spingendo verso la capitale.
A rendere più difficile la posizione di Gheddafi in un paese che si regge su un delicato equilibrio tribale, è la notizia che la più importante tribù, quella dei Wirfalla, si sia unita all'opposizione. Potrebbe non essere la sola tribù ad abbandonare Gheddafi, mentre segni di cedimento del potere cominciano a vedersi. L'ambasciatore libico presso la Lega Araba si è dimesso, e la figura più di spicco dell'islam libico, Sheikh Sadiq Al Ghernay, ha dichiarato che protestare in Libia, ora, è divenuto un obbligo per i fedeli musulmani. Il colonnello Gheddafi, per il momento, tace. Sia la dimensione pubblica sia il rapporto con i paesi europei è stato delegato a suo figlio Seif, che sino a pochi giorni fa era considerato il suo erede.
February 19, 2011
USA vs The UN Security Council
Se avessi scritto questo commentino appena l'anno scorso, mi sarei concentrata sugli Stati Uniti, sulla loro politica mediorientale, sull'impossibilità (ormai patente) di poter essere un mediatore super partes. Sul veto, insomma. Sullo stop deciso stanotte da Washington nel consiglio di sicurezza dell'Onu alla risoluzione che condanna l'illegalità delle colonie israeliane in Cisgiordania (poi, un giorno, qualcuno mi spiegherà lo scandalo di una risoluzione del genere, che ribadisce solo la legalità internazionale…). E invece vorrei occuparmi degli altri 14 membri del Consiglio di Sicurezza, gli altri 4 permanenti oltre gli USA, e gli undici a rotazione.
Perché? Perché io gli amici li ascolto. E un mio amico, qualche mese fa, mi raccontò di come sia diverso guardare il Medio Oriente non più dall'occhio del ciclone, ma da una ragionevole distanza. Ci si accorge, mi disse, di come stia montando un sentimento diffuso, contro le posizioni israeliane. Praticamente tutto il mondo vorrebbe cambiare politica, questo il senso del discorso. E allora, quando ho visto il risultato del voto di ieri sera, la compattezza attorno alla risoluzione palestinese proposta dal Libano, la presa di posizione dei più importanti paesi europei severamente contro le colonie e per uno Stato di Palestina entro settembre 2011 (Gran Bretagna, Francia e Germania, per una volta tanto tutti e tre nel Consiglio di Sicurezza, e tutti e tre sulla stessa linea), quando ho visto tutto questo ho pensato che il discorso del mio amico era fondato. 14 a 1, insomma. 14 contro 1. Un risultato che dovrebbe far riflettere gli Stati Uniti, isolati sulla questione israelo-palestinese. Isolati all'interno di rapporti di forze che hanno già dimostrato, soprattutto in questi ultimi mesi, che il mondo è ormai multipolare.
Basta guardare l'elenco degli Stati (tutti) che hanno votato a favore. La Cina, per esempio. La Russia. I tre più importanti Stati dell'Unione Europea, decisi a far politica per conto proprio, a quanto sembra, visto che l'Europa non riesce più a prendere una decisione di peso sul Medio Oriente. E poi, tra i membri non permanenti, ci sono due nomi importantissimi, il Brasile (che ha riconosciuto lo Stato di Palestina) e l'India. Per non parlare del Sudafrica, che da anni cerca di accreditarsi come la potenza regionale africana, assieme a un altro gigante – con parecchi problemi interni, però – come la Nigeria. USA vs tutti, insomma. E questo credo debba far riflettere l'amministrazione Obama, se non vuole che abbia ragione chi dice – con espressione colorita, lo so – che la strategia mediorientale statunitense la si può gettare da tempo nel cestino.
I palestinesi (l'ANP) non potevano ritirarla la risoluzione, sulla quale peraltro lavorano da mesi e mesi, ben prima che scoppiasse il 2011 arabo e le rivoluzioni che stanno cambiando la faccia della regione. Dopo l'uscita (ad hoc) dei Palestine Papers da parte di Al Jazeera, lo scandalo del rapporto Goldstone rinviato per la pressione americana su Abu Mazen, il presidente dell'ANP non poteva accettare il ritiro della risoluzione come chiesto da Barack Obama in quasi un'ora di telefonata. Per Mahmoud Abbas quel ritiro era semplicemente un suicidio politico. E i suicidi politici non si fanno neanche per gli Stati Uniti, soprattutto dopo il fallimento di quell'ennesimo negoziato sponsorizzato dall'amministrazione democratica che ha avuto vita brevissima. La più breve, forse, nella lunga storia dei negoziati tra israeliani e palestinesi.
La foto sembra lontana dal Palazzo di Vetro. Eppure è nel cuore del conflitto e dell'impossibilità pratica di realizzare la soluzione dei due Stati, israeliano e palestinese. Sheykh Jarrah, Gerusalemme est. David Grossman e Ian McEwan protestano contro i coloni che stanno cambiando la faccia di uno quartieri più importanti della parte est, quella occupata, di Gerusalemme. Ian McEwan non è solo una delle star dell'edizione di quest'anno del Festival della Letteratura di Gerusalemme (ovest), che si apre domani. E' anche il vincitore. Chissà quale sarà la reazione degli organizzatori.
February 18, 2011
Sheykh Qaradawi a Tahrir
Torna dopo trent'anni d'esilio, e subito parla alla folla riunita a piazza Tahrir al Cairo, nella cosiddetta marcia della vittoria. Sheykh Yussuf al Qaradawi fa il suo rientro pressoché trionfale in Egitto, ma cerca di mantenere un linguaggio che salvaguarda il senso della rivoluzione del 25 gennaio. Unità. Ricorda più volte, stamattina, di fronte a una piazza Tahrir gremita come lo era stata la settimana scorsa, il popolo egiziano unito in tutte le sue diversità, musulmani e cristiani insieme, ricorda le forze armate, i ragazzi, e persino Tareq al Bishri, designato come capo del comitato che si occuperà delle necessarie riforme costituzionali. Al Jazeera araba, com'era prevedibile, ha fatto la diretta da Tahrir.
Il rientro di sheykh Yussuf al Qaradawi ha suscitato e susciterà ancora polemiche e critiche. Lontano dall'Egitto per trent'anni, conosciuto come il Global Sheykh o come lo sheykh di Al Jazeera, Qaradawi ha indubbiamente un'influenza forte non solo su quella maggioranza silenziosa e conformista egiziana, ma in generale su quell'islam politico centrista che è stato la vera novità degli ultimi dieci anni. Controverso come studioso e come predicatore, Qaradawi non è formalmente un Fratello Musulmano. Come tale, però, viene dipinto soprattutto dall'area neocon, che non tiene conto di una complessità dell'islam politico che va oltre i confini egiziani.
Nonostante questo rientro che può ricordare il 1979 iraniano, Qaradawi non è Khomeini. Non solo perché non è sciita e, anzi, nel 2008 è stato al centro di uno scontro a distanza con lo sciismo. Non solo perché al sunnismo manca quella gerarchia del clero che è la fondamentale differenza con il percorso della rivoluzione iraniana del 1979. Ma anche perché l'islam politico egiziano non è per niente omogeneo, e anzi molto probabilmente renderà evidenti le sue divisioni interne soprattutto dopo la rivoluzione del 25 gennaio. Qaradawi, insomma, è diverso da Tareq al Bishri, così come è diverso da una leadership dei Fratelli Musulmani che ha già mostrato diverse anime.
Sull'argomento, per chi volesse leggersi qualcosa di più approfondito, c'è qualche pagina sui teorici islamisti nel libro di Bruce K. Rutheford, Egypt After Mubarak, Princeton & Oxford 2008. Non che si debbano sposare le sue posizioni (Steven Cook le ha per esempio contestate su Foreign Affairs), ma – insomma – la lettura è interessante.
February 17, 2011
Telecamere spente sulla Libia
Quello che sappiamo, della Giornata dei Martiri del 17 febbraio, è tutto affidato alla Rete. Ai video, ai tweets, alle rare foto postate su Facebook. Senza riscontri da parte della stampa internazionale, dei network internazionali. Può succedere di tutto, e forse è già successo. Si dice che si sia sparato sui manifestanti dagli elicotteri, che ci siano morti e feriti. Da una semplice scorsa dei tweets degli oppositori, sono più di quindici i morti.
Ragazzi, molti ragazzi, forse la maggioranza, quelli che si vedono sui video. Jeans, una felpa, un cappuccio calato sulla testa. Gli stessi che abbiamo imparato a vedere in queste settimane. Ma di loro non si sa (quasi) niente, o comunque molto di meno di quello che si può sapere dei ragazzi del Cairo e di Tunisi.
Una buona analisi è quella fatta da arabist, di cui condivido il punto di partenza: è il paese più fragile, perché è di più lunga data il regime (41 anni), difficile quanto in Egitto la successione ereditaria, difficili le condizioni della massa di giovani che compone la popolazione. Ma siccome non di sole analisi vive l'uomo, e queste rivoluzioni hanno anche altri filtri, vi consiglio di nuovo un rap, perché lo hip hop è da anni, da molti anni nel mondo arabo la musica della rabbia e del dissenso. Questo è il rap di Ibn Thabit. Qui è una traduzione in inglese.
Il logo è uno dei tanti che è stato creato e diffuso su internet. In questo caso, è interessante che ci sia il pugno usato dal Movimento 6 aprile in Egitto, molto simile a quello di Otpor a Belgrado.
Schizofrenie americane e Medio Oriente
Jackson Diehl, sul Washington Post, non ci va per niente leggero. Attacca direttamente il segretario di Stato Hillary Rodham Clinton, per non aver compreso quello che stava succedendo nel Bahrein, nonostante l'avesse visitato appena due mesi fa.
To Secretary of State Hillary Rodham Clinton, all was well in Bahrain when she visited two months ago. "I am very impressed by the progress Bahrain is making on all fronts – economically politically, socially," she enthused. Now, however, Bahrain is the only Persian Gulf state where the popular protests of Tunisia and Egypt have spread.
La ABC va oltre, e dice che – secondo le sue fonti – oggi l'amministrazione Obama dovrebbe chiamare l'alleato di Manama per dirgli di non esagerare con la repressione delle proteste. Oggi? Solo oggi? Eppure le proteste vanno avanti da giorni e giorni, anche se è solo stanotte che la repressione è stata molto dura, a giudicare anche dal reportage in diretta che l'inviato di Al Jazeera English ha fatto, raccontando come stavano i cadaveri che aveva visto alla morgue e i feriti (medici compresi) in maniera seria che erano ricoverati all'ospedale. Eppure, il segretario di Stato americano era stata molto dura con il regime di Teheran che ha immediatamente represso le manifestazioni pacifiche che avevano riempito le strade di Teheran… Certo, dimenticavo, Teheran è Teheran, e Manama è un alleato prezioso, da trattare con i guanti, per la Quinta Flotta soprattutto.
Quello che non comprendo ancora bene, è come mai l'amministrazione americana non abbia ancora compreso, a sua volta, che il doppio standard usato negli anni come strategia prioritaria in Medio Oriente non funzioni più. Non solo. Come mai non abbia ancora compreso che il doppio standard può solo peggiorare l'immagine e la stessa politica mediorientale degli Stati Uniti. Washington, insomma, arriva sempre in ritardo, in queste prime settimane delle rivoluzioni arabe del 2011. Sempre in ritardo, sempre quando già i giochi sono fatti o quasi, sempre quando la piazza (pacifica) ha già mostrato chi è che reprime e chi è che invece reclama democrazia. Lo ha fatto con l'Egitto, e continua a farlo con il Bahrein.
Il ritardo è dimostrazione di due mancanze. La mancanza di conoscenza reale delle società arabe, delle sue dinamiche e delle sue richieste. Una mancanza di conoscenza sulla quale noi che viviamo e lavoriamo in Medio Oriente ci interroghiamo da anni, spaventati – appunto – dal fatto che la superpotenza abbia una inabilità ormai pluridecennale nella comprensione della regione, pur vantando – dal punto di vista accademico – fior di esperti seri. Non funziona, dunque, il collegamento tra la ricerca (politologica, storica etc) e chi consiglia il presidente e il dipartimento di stato. L'altra mancanza, però, è quella di una politica estera univoca dell'amministrazione americana. Con un dipartimento di Stato che guida la politica estera seguendo schemi vecchi e ormai veramente anacronistici, e una Casa Bianca che non riesce a far sentire del tutto la sua voce su quello che sta succedendo, per giunta indebolita rispetto a quando Obama si insediò. Io continuo a pensare, insomma, che tra Barack Obama e Hillary Rodham Clinton ci sia ancora la stessa divergenza di vedute sul Medio Oriente che era chiara durante le primarie per la candidatura dei democratici alla presidenza. E penso ancora che questa schizofrenia della politica estera americana, divisa tra Casa Bianca e Dipartimento di Stato, non faccia bene agli Stati Uniti, né al Medio Oriente.
Un esempio su tutti. Quando Obama, seppure in ritardo, parla dei giovani egiziani a Tahrir, io percepisco – da persona che ha vissuto e lavorato in Egitto – che Obama ha capito quello che sta succedendo al Cairo, nelle strade del Cairo. Quando sento Hillary Clinton, mi rendo conto che il suo stesso linguaggio è frutto di strategie a tavolino, di un'astrazione che vuole farsi realtà. Eppure, sono certa che entrambi le strade del Cairo o di Tunisi o di Manama non le conoscono. Dov'è la differenza? Nei consiglieri? Nel tipo di consiglieri? Nel tipo di conoscenza che i consiglieri hanno dei luoghi, dei visi, delle persone?
Spero che in Italia la questione del Bahrein non si limiti all'angoscia per il rinvio possibile del Gran Premio di Formula1… e che ci si interroghi su quello che i testimoni descrivono, compresi grandi giornalisti come Nicholas Kristof, del New York Times, che anche su twitter attacca il re Hamad. Ha perso credibilità per esempre dice Kristof. Il sangue è per sempre sulle sue mani. Kristof sta raccontando da ore la brutalità della repressione. Alle 8 della mattina, c'erano centinaia e centinaia di feriti, dopo l'attacco notturno della polizia alla Piazza delle Perle.
La foto è stata scattata da uno dei blogger del Bahrain, anmarek.
February 16, 2011
Intifada libica, in anticipo?
E' cominciata in anticipo, quella che gli organizzatori hanno definito l'intifada in Libia. Prevista per il 17 febbraio da un tam tam, anche stavolta in rete, e specialmente su Facebook, per celebrare il Giorno dei Martiri, l'impiccagione di oppositori al regime di Gheddafi, nel 2006. Le manifestazioni e gli scontri sono invece già cominciati da ieri, e oggi hanno interessato soprattutto Bengasi.
La possibilità di avere immagini e racconti dalla Libia è ridotta, molto più ridotta che in Egitto, ma la Rete ha già cominciato a far circolare foto e soprattutto video di quello che sta succedendo. Anche stavolta stay tuned, la Libia potrebbe essere un paese dove le manifestazioni di piazza (soprattutto dei giovani) potrebbero essere più consistenti. Ancora una volta, twitter riesce a veicolare le poche informazioni disponibili. Due gli hashtag, le parole chiave principali: #Libya e #Feb17.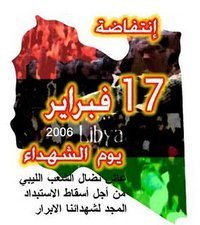
Prove di Nuovo Egitto
Decisioni non rapidissime, ma abbastanza veloci, quelle che sta prendendo il Consiglio Militare Supremo in Egitto. Un percorso incomprensibile, in una dimensione europea, in cui l'idea di un consiglio militare chiamato a gestire una transizione importante, per alcuni versi imponente, come quella egiziana fa venire i brividi. Bisogna, però, riportare il tutto alla dimensione nazionale, per riuscire a capire meglio quello che sta succedendo al Cairo, dopo la fine del primo capitolo – quello eroico – della rivoluzione del 25 gennaio.
Decisioni veloci, dunque. Un parlamento sciolto, soprattutto. Decisione che non deve far accapponare la pelle a chi ha a cuore la democrazia, perché quel parlamento era tutto fuor che democratico, frutto di brogli, e di una gestione delle ultime elezioni del novembre 2010 che avrebbero dovuto – quelle sì – far alzare la voce alle cancellerie occidentali. La voce non si alzò, allora, in nome di una stabilità egiziana che si è scoperto essere, dopo appena due mesi, solo di facciata. Anzi, quel parlamento è stato l'ultimo scandalo che ha fatto traboccare il vaso egiziano, perché la vittoria a mani basse dello NDP (ti piace vincere facile? Dice la pubblicità), senza neanche più la voglia di fico di una opposizione presentabile, ha fatto comprendere agli egiziani che ormai non c'era più neanche da perdere. Se non l'onore e la dignità.
Parlamento sciolto, dunque, e ora un comitato per i necessari aggiustamenti costituzionali composto da otto membri. Otto giuristi, tutto sommato rispettati, con un solo copto, un membro dei Fratelli Musulmani di Alessandria (Sobhi Saleh, ex capo del gruppo parlamentare nella legislatura 2005), e soprattutto un presidente del comitato che è considerato il capofila dei pensatori dell'islamismo moderato, Tareq al Bishry. Rispettato per le sue posizioni estremamente critiche verso Mubarak, conosciuto in ambito internazionale (partecipò a uno dei volumi dell'Onu sullo sviluppo umano nel mondo arabo, quello del 2003 sulla 'società della conoscenza'), Tareq al Bishry non si è tirato appresso molte accuse. Certo, però, non accontenta la parte decisamente laica dell'Egitto, che teme una presenza troppo forte dell'islam politico moderato.
Perché, allora, il Consiglio Supremo Militare ha scelto questa posizione tutto sommato centrista nello scegliere i nomi del comitato? Perché, per esempio, non ha messo Zakaria Abdel Aziz, ex presidente del club dei giudici e strenuo oppositore di quegli emendamenti costituzionali del 2005 che ora bisogna ri-emendare? Due possibili risposte. La prima: i militari seguono in questo modo quella maggioranza silenziosa conformista (in termini semplici, all'italiana, la definirei: democristiana, da prima repubblica), non la scontentano e nello stesso tempo indicano un nome rispettato come quello di Tareq al Bishri. La seconda: potrebbero riservarsi il nome di Zakaria Abdel Aziz per un altro momento, per le altre decisioni che debbono essere prese. Anzitutto, quella relativa al governo di transizione, perché l'idea che a gestire l'ordinaria amministrazione ci sia ancora l'ultimo esecutivo designato da Hosni Mubarak fa arrabbiare molti. Compresi i ragazzi di Tahrir. I blogger e gli attivisti, peraltro, hanno già indicato una rosa di nomi possibili per un governo che guidi la transizione. Sono i nomi dell'Egitto pulito, e vale la pena di leggerseli nel blog di Alaa & Manaal.
Stay tuned. La storia della rivoluzione egiziana non è ancora finita… Altro punto di svolta, ma ne parlo un'altra volta, è al decisione dei Fratelli Musulmani di creare un partito. Decisione già presa alcuni anni fa, ma bloccata dalla discussione infinita sul programma politico, che aveva spaccato conservatori e riformatori dentro l'Ikhwan. Ora si potrebbe fare. Domanda: se la spaccatura continuasse, dall'Ikhwan nascerebbero uno o due partiti?
nella foto di alcuni anni fa, una manifestazione di giudici contro gli emendamenti alla costituzione voluti da Hosni Mubarak per potersi ricandidare alla presidenza senza avversari temibili.
February 15, 2011
C'è Teheran, e… Manama
L'attenzione italiana è giustamente concentrata su Teheran, dove si rischia di nuovo il pugno duro del regime di Ahmadinejad, come nel 2009. L'attenzione americana pure è concentrata sullo stesso quadrante, con il segretario di Stato americano Hillary Rodham Clinton che si affretta a chiedere per i ragazzi di Teheran la stessa possibilità di esprimersi di quelli del Cairo. Si attende dunque, quanto prima, che dica le stesse parole per chi sta manifestando a Manama, nel piccolo emirato del Bahrein, dove le tensioni sono cominciate non da ieri, ma da più giorni. A meno che la presenza della Quinta Flotta statunitense in un luogo considerato strategicamente determinante per controllare lo Stretto di Hormuz non costringa il segretario di Stato ad essere quanto meno più cauta, sull'argomento. Certo, non troppo cauta, perché altrimenti si attirerebbe l'accusa di usare un doppio standard, a seconda della latitudine in cui scoppiano le rivolte nel grande Medio Oriente…
Ieri è stato il giorno dichiarato della "rabbia" dalle opposizioni, che hanno indetto una manifestazione contro lo sheykh Khalifa, e soprattutto contro un sistema di potere in mano alla minoranza sunnita, verso il quale la maggioranza sciita esprime profonde critiche da anni. E da anni, ancora una volta, è il web a fungere non solo da cassa di risonanza, ma da vera e propria agorà telematica dove la dissidenza si è formata, si è unita, è diventata comunità politica ed è poi scesa in strada.
Il sito Bahrainonline, attraverso il quale si possono seguire ora le proteste, è lo stesso che nel 2005 subì l'attacco delle autorità dell'emirato. Fu un vero e proprio caso giudiziario, che coinvolse i 3 fondatori del sito, "colpevoli – secondo il regime di Manama – di aver pubblicato sul sito opinioni non del tutto in linea con quelle del governo. Arrestati e processati tra febbraio e marzo 2005, sono rimasti in prigione solo due settimane prima di essere liberati senza neanche pagare la cauzione richiesta. Complice – questa è stata l'interpretazione più diffusa in Rete – la concomitanza del Gran premio di Formula Uno dell'inizio di aprile e il timore che l'occhio delle telecamere di tutto il mondo si spostasse dal circuito per posarsi su questa pattuglia di dissidenti o, più semplicemente, di ragazzi del web. La storia del trio di bahrainonline.org è comunque servita a scoperchiare il mondo a parte, il pianeta virtuale di Manama, soprattutto quando i blogger hanno deciso di inscenare una protesta tutta telematica, fotografandosi nel proprio salotto di casa con cartelli inneggianti alla liberazione del trio di bahrainonline.org.
Esercizi virtuali che i blogger hanno continuato a fare, nonostante i problemi con la censura non siano stati risolti dall'uscita di galera di quelli di bahrainonline.org. Persino il più importante blogger del piccolo regno arabo, il ricco imprenditore Mahmood al Yousif di mahmood's den, ha dovuto contrattare con le autorità la sua libertà sul web, per evitare l'ordine di bloccare l'accesso al suo sito, emanato alla fine di ottobre del 2006. Gli è "bastato" togliere qualche articolo fastidioso per il governo, e la minaccia incombente del blocco dei visitatori locali si è dissolta in pochi giorni" (il virgolettato è tratto da Arabi Invisibili, sempre nel capitolo dedicato ai blogger, in cui uno dei casi più interessanti era appunto quello del Bahrein).
Oltre cinque anni dopo, la situazione non solo non è cambiata, ma è diventata talmente tesa che è stato facile scendere in piazza dopo le rivolte di Tunisi e del Cairo. Già due i morti, tensione alle stelle. Come finirà? Per chi è interessato all'argomento delle rivolte nel Golfo, e capisce il tedesco, ci sono gli studi di una delle esperte più interessanti dell'area, Katja Niethammer , sul sito del think tank di Berlino SWP.
February 14, 2011
Vento cairota a Ramallah
E' crisi di governo, a Ramallah. Una crisi di governo pilotata, per consentire all'Autorità Nazionale Palestinese di gestire le elezioni presidenziali, politiche e municipali in programma la prossima estate. Il premier del governo palestinese di Ramallah, Salam Fayyad ha rassegnato stamattina le dimissioni sue e del governo che ha guidato negli scorsi tre anni e mezzo, dopo il coup di Hamas a Gaza e la divisione sempre più profonda dei Territori Palestinesi Occupati . Il presidente dell'ANP, Mahmoud Abbas, ha subito reincaricato lo stesso Fayyad di formare un nuovo esecutivo in tempi brevissimi, entro sei settimane, per continuare il disegno di Fayyad, e cioè il programma per uno Stato palestinese indipendente che possa reggere dal punto istituzionale, e – parallelamente – per gestire la preparazione della campagna elettorale. E' per questo motivo che il governo non dovrebbe essere formato solo da tecnocrati, e dovrebbe invece vedere un aumento esponenziale di membri di Fatah tra i nuovi ministri. Come questo gioco possa riuscire, è difficile da capire, visto che le tensioni tra Fayyad e Fatah sono sempre state visibili, in questi tre anni e mezzo.
E' certo, però, che Fatah ha bisogno di concentrarsi sulla base di consenso e sulla gestione del potere, in un momento estremamente critico come questo. I venti di Tunisi (che ospitò l'OLP in esilio, prima del 1994 e del rientro della leadership nei Territori Palestinesi occupati) e soprattutto del Cairo hanno suscitato molte preoccupazione, a Gaza ma soprattutto a Ramallah. E' infatti Fatah a rischiare di più con la caduta di Hosni Mubarak e i cambiamenti epocali in corso in Egitto. Mubarak, patron di Fatah da decenni, era anche un sostegno determinante a Ramallah come cuore del potere dell'ANP, soprattutto sul dossier della riconciliazione. Dossier nel quale l'Egitto, attraverso il mediatore per eccellenza, Omar Suleiman, non è mai stato considerato un attore neutrale, bensì un mediatore che aveva da sempre sposato una delle parti in causa, e cioè Fatah.
Ciò che è successo al Cairo, la caduta di Mubarak, le picconate inferte al suo regime, non può dunque non avere i suoi contraccolpi nella politica palestinese. E i suoi effetti già si vedono. La crisi di governo a Ramallah è solo l'ultima, nelle serie di decisioni politiche importanti prese a Ramallah in appena tre giorni. Prima le dimissioni da capo dei negoziatori palestinesi di Saeb Erekat, travolto dallo scandalo dei Palestine Papers, i documenti riservati resi pubblici da Al Jazeera proprio in concomitanza con l'inizio della rivoluzione in Egitto, poco prima del 25 gennaio.. Poi la decisione, sempre sabato scorso, di indire elezioni presidenziali e parlamentari per il prossimo settembre, presa dal comitato esecutivo dell'OLP e resa nota dal segretario generale Yasser Abed Rabbo. Una decisione che Hamas, che controlla Gaza, ha subito rifiutato come illegittima, rendendo nella pratica impossibile lo svolgersi delle elezioni non solo in Cisgiordania e – con molti forse, stavolta per l'opposizione israeliana – a Gerusalemme est, ma anche nella Striscia di Gaza.
Dall'effetto domino scatenato non solo e non tanto da Tunisi, ma principalmente dal Cairo, la Palestina non può insomma essere esclusa, nonostante non vi siano, almeno al momento, i segnali di un movimento di giovani così importante come quello egiziano. Né, in particolare, può essere escluso Israele. La rivoluzione del 25 gennaio cambia tutto, in Medio Oriente. Non solo la stabilità delle autocrazie arabe, non solo il processo di pace, ma le stesso domande irrisolte dentro la società israeliana sul suo ruolo in Medio Oriente e sulla sua accettazione o meno, tutta culturale e interna, di far parte di questa regione e delle sue dinamiche. E' la domanda che, ormai da settimane, viene fatta da molti intellettuali israeliani alla propria società. A prescindere dagli equilibri geopolitici.
La foto è stata scattata al Cairo, il 13 febbraio, durante la manifestazione dei lavoratori del comparto energetico, un settore che incide sui rapporti tra Egitto e Israele. E' tratta dall'album Flickr di Hossam el Hamalawy, giornalista, blogger e attivista, specializzato sugli scioperi operai, sin dal 2006.
February 13, 2011
Prima, durante, e dopo il 13 febbraio
Se non ora quando. Se non ora, in questo momento, quando riuscire a ribellarsi all'immagine di una donna ancora una volta sotto schiaffo, che dovrebbe sentirsi colpevole in qualsiasi situazione? Un gioco che chi ha la mia età, sulla cinquantina, conosce bene: ci ha segnato per la vita, prima che riuscissimo a alzarci in piedi e a dire che non è così che si trattano le donne (e gli uomini). Non è così che si educano le bambine e le ragazze, a pensare a un futuro in cui l'ingeno, l'intelligenza, l'individuo non conta più per costruirsi la propria vita. Conta un bel seno e, soprattutto, la capacità di sottomettersi al potere di turno per ottenere il sostentamento economico, e magari qualche capriccio. Un po' di biada e il biscottino.
13 febbraio in piazza, dunque. Vorrei esserci, e invece sono qui a Gerusalemme (qualcuno ha detto che ci sto "col culo a caldo…). E allora, in linea diretta virtuale con la manifestazione di Roma, la mia città natale, col Pincio, che mi ricorda le manifestazioni dell'8 marzo di alcuni decenni fa, metto anche qui lo scritto di Nicoletta Dentico, presidente dell'associazione di cui faccio parte anch'io. Filomena. Prima, durante, e dopo il 13 febbraio.
L'Italia vive da troppi anni ormai un'ostinata patologia, un male che ha imbarbarito le persone ed atrofizzato funzioni vitali del paese. Filomena, la rete delle donne, affronta la questione del ruolo e dell'immagine del genere femminile nella società italiana, che è solo una delle metastasi più eloquenti e paradigmatiche di questa infermità. Come vogliamo definirla, nella fattispecie? E' la patologia di una subcultura cartellonistica della scorciatoia e dell'immagine che proditoriamente mescola le carte in tavola e confonde la libertà con il mercimonio; di una forma del potere che, in nome dei soldi e della visibilità mediatica, essa stessa strumento di potere, ha mutato antropologicamente le aspirazioni ed i desideri, ha condizionato le relazioni fra le persone, desertificando questo paese fino nelle sue pieghe più intime e inaccessibili.
C'è, in Italia, un grande bisogno di liberazione. Di una nuova, più credibile, narrazione. E' urgente la necessità di uscire dalla condizione di solitudine che avvolge le vite di tutti noi per socializzare lo spaesamento di milioni di donne e uomini, in questa Italia senza bussola. Occorre uscire insieme, in tanti, per trasformare il disorientamento di ciascuno in un atto di ribelliione condivisa, e tradurre poi questa ribellione – che è un passaggio ineludibile, ma del tutto insufficiente – in una piattaforma di lavoro politico volto a rompere la cappa di potere e di controllo che ci opprime. E che opprime ancora più duramente le donne.
Non a caso il contributo di Filomena sul palco della piazza di Roma il 13 febbraio passa attraverso la presenza di Imane Barmaki, una giovane arabo-italiana di seconda generazione, protagonista indiscussa del paese moderno che vogliamo costruire a partire dal 13 febbraio. La sua presenza allude al futuro dell'Italia cui volgiamo lo sguardo con fiducia. In particolare, la sua presenza oggi agisce da collegamento – ideale, emotivo, politico – fra le 250 piazze italiane e le piazze ancora in fermento nei paesi arabi. Una stringa di parola e di testimonianza che unisce noi alle centinaia di migliaia di donne che in Tunisia, in Egitto, in Algeria hanno sfilato da settimane, e che da anni preparano sotto traccia il vento della rivoluzione che sta abbattendo, uno alla volta, i regimi di quei paesi.
Le vicende magrebine molto ci dicono sulle forme del potere, e sugli stili della leadership. Molto ci dicono anche sulla capacità dei popoli di organizzare la rabbia in discorsi ce azioni entrati sulla dignità di riscatto e di cambiamento. Fuori da dinamiche di spettacolarizzazione della politica. Oltre la sessualizzazione dei meccanismi sociali, vera trappola di passivizzazione della società. Questo 13 febbraio non può dunque essere un evento del quale compiacersi troppo a lungo. La mobilitazione di oggi, autentica ed inattesa novità nella scena politica italiana ed internazionale, ricolloca con forza inaudita la questione di genere tra le priorità in agenda ed inaugura un percorso di lavoro tra uomini e donne sulla costruzione di una Italia matura, moderna, più sana.
Oggi ci misuriamo e ci contiamo, per il da farsi domani. Sapendo che le tentazioni divisive servono solo alla gerontocrazia gaudente che ci governa. Sapendo anche che le donne non devono limitarsi a soppiantare gli uomini, magari per replicarne i modelli. La vera sfida del 13 febbraio è il dopo: un lavoro dal basso, a stazioni, per dare forma e senso profondo alla mobilitazione di oggi. Un lavoro che Filomena sta già facendo con il suo Alfabeto, in viaggio per diverse città d'Italia. Un cammino nel tempo, un'opera sottile dentro le forme del linguaggio, un'operazione sottotraccia e costante, per spezzare i nodi di un berlusconismo inteso come sistema mentale, come modello comportamentale che ha attecchito ovunque, anche negli ambienti più insospettabili. Un processo che intende approdare alla costruzione di una qualità vera della libertà nella relazione fra uomini e donne. Per costruire un mondo dove sia desiderabile vivere, perché più giusto e moralmente maturo.