Antonio Gallo's Blog: MEDIUM, page 113
August 17, 2018
Un libro, un ricordo
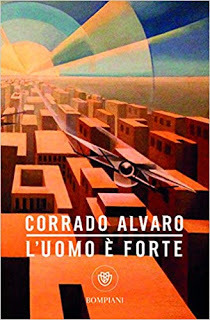 Ho riletto velocemente, in versione Kindle, questo libro che mio padre aveva nella sua indimenticabile piccola ma ricca biblioteca degli anni trenta-quaranta del secolo e del millennio trascorsi. Ricordo che allora lo sfogliai, ma non capii molto.
Ho riletto velocemente, in versione Kindle, questo libro che mio padre aveva nella sua indimenticabile piccola ma ricca biblioteca degli anni trenta-quaranta del secolo e del millennio trascorsi. Ricordo che allora lo sfogliai, ma non capii molto.
Avevo una decina d'anni, mi piaceva tirare fuori dagli scaffali quei libri, allineati in quel mobile dalle vetrate verdi. Lo facevo quando lui non c'era, di nascosto, perchè lui ne era geloso. E poi lui diceva che non erano libri per me. Avevo da leggere altri libri, quelli di scuola, ma quelli non mi piacevano molto.
Amavo tirare fuori quelli suoi, variamente colorati, sistemati per altezza, per collana, per colore, per letterature. La Medusa, la Bompiani, la Rizzoli, Corbaccio, e poi tutte quelle copie in volumi rilegati della "Illustrazione Italiana". Li rimettevo a posto ricollocandoli alla stessa maniera. Ma lui si accorgeva che ci avevo messo le mani, il suo "ordine" era stato alterato ed allora erano guai.
Quel giorno avevo beccato un tre alla versione di greco e quella spia del bidello del ginnasio glielo aveva riferito. Successe quello che successe. Mi resi conto che anche se "L'uomo è forte", come dal titolo del libro di Corrado Alvaro, i ragazzi che non studiavano a scuola erano destinati inevitabilmente a prenderle se non studiavano i libri canonici.
Ho riletto il libro di Corrado Alvaro senza molta passione ed attenzione. Gli ho dato tre stelle seguendo le indicazioni che il recensore del giornale ha scritto nel suo articolo. Non so perchè mio padre lo comprò e cosa ne pensava del libro. C'era anche quell'altro suo libro, "Gente in Aspromonte". Non che mio padre fosse un intellettuale, di sinistra o di destra non conta.
Ricordo che tra i suoi libri c'erano anche quegli altri intellettuali dei quali il Festorazzi parla. Ma mio padre era solo un tipografo gutenberghiano che amava leggere. Lui leggeva le recensioni sul "Corriere della Sera" e poi col suo amico "Totonno" se ne andavano a Napoli a comprare i libri nelle librerie di San Biagio dei Librai. Altri tempi. Tempi di lettori e letture per "dinosauri".
"La recente riedizione dell'opera distopica di Corrado Alvaro, L'uomo è forte (Bompiani), uscita nel 1938, propone una riconsiderazione della statura letteraria dello scrittore calabrese, che anticipò i temi orwelliani del controllo totalitario sull'individuo da parte di uno Stato ispirato all'ideologia collettivista. Alvaro scrisse il romanzo dopo un viaggio nella Russia sovietica, e non c'è dubbio che il modello preso di mira era quello comunista, anche se è altrettanto vero che nella Germania nazista il libro fu vietato.
Dunque, il precursore italiano di Orwell fu un nemico giurato dello stalinismo? Non proprio, perché ora scopriamo che, appena dieci anni dopo la pubblicazione del volume, Alvaro ricevette l'offerta di una candidatura al Parlamento, da parte del Pci. Per comprenderne le ragioni bisogna tornare all'epoca dei suoi esordi narrativi.
L'autore di Gente in Aspromonte, fondamentalmente, era un liberale, ma già il suo approccio nei confronti del fascismo fu molto adattivo, tanto è vero che, grazie anche all'appoggio di Margherita Sarfatti, la «regina» delle arti durante il Ventennio, gli furono spalancate le porte dei maggiori giornali. Pur atteggiandosi, nel dopoguerra, a perseguitato di Mussolini, la sua firma poté comparire regolarmente, sulla Stampa di Torino, a partire dal 1926. Ma essa dilagò anche in una serie di altre testate, dal Primato di Bottai, a Critica Fascista. Impensabile che tale produzione giornalistica avesse potuto aver luogo senza il preventivo endorsement, con relativa iscrizione al partito.
Alvaro, addirittura, beneficiò di un lauto anticipo, di 15mila lire, su fondi della Pubblica sicurezza, per la creazione di un soggetto cinematografico sulla redenzione delle paludi pontine. Nel 1939, del resto, fu propagandista e cantore di Littoria, una delle «nuove città» sorte dalle bonifiche ducesche. Non è perciò un caso che Il Gazzettino di Venezia, pubblicato nel territorio della Repubblica di Salò, il 26 marzo 1945, dando la notizia delle dimissioni dello scrittore dalla direzione in Roma del Giornale radio nazionale della Rai (sottoposto al controllo alleato), a sole tre settimane dalla nomina, lo definisse sprezzantemente «rinnegato». Nel marzo del 1947, Alvaro divenne direttore del Risorgimento di Napoli, da cui fu cacciato, dopo soli quattro mesi, per un insanabile conflitto con l'editore, Achille Lauro, che non approvò la svolta progressista impressa da Alvaro.
Dunque il letterato, nel dopoguerra, virò a sinistra? In realtà, questa «conversione», che possiamo anche leggere come un'ulteriore prova di adattamento, nei confronti di un partito, quello comunista, che faceva incetta di intellettuali da arruolare sotto le proprie bandiere, non è stata indagata. Finora era noto soltanto che Alvaro fu tra le personalità di maggior prestigio del panorama culturale nazionale - insieme a Quasimodo, a Saba, e a molti altri - che si schierarono con il Fronte Popolare, alle elezioni politiche del 1948. Ma, se emergessero - come di fatto adesso emergono - le prove delle ulteriori lusinghe esercitate dal Pci nei suoi riguardi, non ci sarebbe molto da meravigliarsi, se si considera che Togliatti, dopo aver cooptato il meglio della giovane generazione formata dal fascismo, non si fece scrupoli nell'aprire le porte del partitone rosso agli esponenti dell'intellighenzia borghese disposti ad accettare quell'ospitalità.
Vi furono casi celebri, fra tutti quello di Massimo Bontempelli, che nel '48 si candidò al Parlamento, con i socialcomunisti. Nutrita la schiera degli «intellettuali organici» che militarono nel Pci: da Sibilla Aleramo a Vittorini, da Pratolini a Bilenchi e a Brancati, per citare soltanto alcuni nomi. Un caso a parte fu la posizione di empatia di Malaparte nei confronti del comunismo sovietico, che esordì, fin dagli anni della sua militanza nel cosiddetto «fascismo di sinistra», per evolvere poi, nell'ultimo scorcio della sua vita, in filomaoismo. Ciò non valse peraltro a trasformarlo in un aggregato di lusso al variegato convoglio togliattiano; e, ciò, semplicemente, perché Kurt, libertario fino al midollo, era irriducibile a qualunque ideologia, tanto da rinverdire lo storico legame di gioventù con il Partito repubblicano. Ultimo, illustre esponente, invece, dei maître à penser accasati al Bottegone fu Alberto Moravia che, nel 1984, fu eletto, quale indipendente, nelle fila comuniste, al Parlamento europeo.
Ora, per tornare ad Alvaro, un documento eccezionale quanto inedito, una sua lunga lettera autografa all'amico fiorentino Aldo Fortuna (conosciuto nelle trincee della Grande Guerra), svela i retroscena, rimasti ignoti, del suo sofferto rapporto con il mondo comunista. Un rapporto che non giunse mai al livello di sudditanza, per la capacità del letterato di sottrarsi all'abbraccio soffocante con il Pci, al quale scelse di non iscriversi. L'epistola, in possesso di privati, e datata 5 agosto 1952, fu vergata nella casa di campagna di Alvaro, a Vallerano, in provincia di Viterbo. Dato il rapporto di confidenza con il destinatario, che in qualità di legale era stato anche curatore degli interessi dello scrittore, la lettera è caratterizzata da un tono intimo, quasi da confessione. Vi si leggono anche gli echi di considerazioni retrospettive, grazie alle quali questo documento assume il significato di un testamento morale, a bilancio di un'intera esistenza. Alvaro morrà, infatti, l'11 giugno 1956, a 61 anni.
Così si rivolge a Fortuna: «E il tempo stringe, temo di averne perduto troppo, e dovrei concludere questa vita azzardata anche nelle promesse (...). Aver chiuso clamorosamente un'esperienza di direttore d'un giornale di Napoli, con Lauro di cui non volli essere lo strumento dopo che ero andato per fare qualcosa in favore dei miei paesi, mi chiuse la strada della direzione di ben maggiori giornali, e fu anche questa una fortuna. Dopo molti errori in cui ho perduto tempo, denaro, e acquistata finalmente esperienza, mi ritrovo quello che ero, uno scrittore che non deve nulla a nessuno e da nessuno spera niente».
Poi, la notizia più sorprendente: ossia l'offerta, da lui rifiutata, di candidarsi alle elezioni del '48: «Per fortuna ho smesso l'idea di essere utile nella vita attiva, feci in tempo a tirarmi indietro e non varcare la porta del Parlamento, sia pure come indipendente di sinistra». Il diniego di Alvaro, in tal senso, circoscrive il valore della sua dichiarazione di voto a favore del Fronte Popolare. Una scelta di campo, sì, ma non irreversibile e, soprattutto, non incondizionata, fino all'ingaggio stabile nelle solenni aule ove si esercita la democrazia rappresentativa. La lettera all'amico fiorentino contiene anche un accenno, denso di preoccupazione, alle sorti incerte del figlio Massimo, il quale, invece, ha provato sulla propria pelle l'esperienza drammatica di aderire al partito-chiesa, salvo poi doversene distaccare, per una crisi di coscienza. Scrive Alvaro: «c'è Massimo che dopo molte traversie istruttive coi comunisti, nella cui organizzazione era entrato, si ritrova a dover ricominciare, e ad aver appena superato la crisi dei dissidenti o eretici. Ora fa qualcosa alla Radio e al Mondo»."
(IL GIORNALE - Roberto Festorazzi - Ven, 17/08/2018)

Published on August 17, 2018 07:48
August 15, 2018
Review: L'Unico e la sua proprietà. Testo tedesco a fronte
 L'Unico e la sua proprietà. Testo tedesco a fronte by Max Stirner
L'Unico e la sua proprietà. Testo tedesco a fronte by Max StirnerMy rating: 5 of 5 stars
Ho voluto avere nella mia biblioteca cartacea questo libro da poco uscito in una nuova edizione Bompiani, in testo a fronte. Quasi mille pagine. Il libro in altre edizioni lo si può trovare in rete e scaricare il testo gratis. Sono varie le edizioni, ma questa curata da Sossio Giametta mi sembra la più aggiornata oltre che moderna.
Ho letto diverse recensioni su GR in lingue diverse e non mi resta che dire la mia su di un libro il cui autore all'inizio scrive che ha "fondato la sua causa sul nulla". Ma poi si scopre che parla della vita dell'uomo, degli uomini antichi e quelli moderni. Scrive degli ossessi, dello spirito e della gerarchia, dei liberi, del liberalismo politico, di quello sociale e di quello umanistico. La prima parte la dedica all'uomo. La seconda invece si occupa dell'io.
Individualità propria, l'individuo proprietario, la sua potenza, i suoi rapporti, il godimento di se stesso. Alla fine arriva al nocciolo: "l'Unico". Una causa fondata su di esso, anzi su di lui: il NULLA. Ma per Stirner evidentemente il "nulla" vale per il "tutto". Se devo sintetizzare il suo pensiero dirò che Stirner è abbastanza arrogante da cercare di rispondere ai canonici "chi-cosa-quando-dove-perchè" riguardanti l'uomo e la sua vita.
Ci riesce? Non lo so. So che ha avuto il coraggio di provarci senza mai tradire il suo IO, la sua entità, il suo individualismo, che per alcuni è chiamato anarchia, per me invece e solo ricerca. Se date una occhiata alle etichette che ho scelto per classificare questo libro, vi renderete conto di quello che contiene questa opera scritta in pieno ottocento, da un tizio che è stato malfamato ed esaltato, considerato repellente, sguaiato, spaccone, smargiasso, degenerato, zotico, egomane, psicopatico grave, sgradevole, sofista, nauseante ... potrei continuare.
Per me resta un genio. Vi assicuro che nonostante gli abbia assegnato tutte quelle etichette, questo Max Stirner, che poi non si chiamava nemmeno così, è stato tanto assaltato quanto esaltato. Leggerlo in testo a fronte per me è una salutare avventura. Una opportunità, per rispolverare quella lingua che è tanto infernale quanto speciale, la mia "ur-sprache". Ho detto tutto ...
View all my reviews

Published on August 15, 2018 08:05
Max Stirner e il suo "Unico"
 L'Unico e la sua proprietà. Testo tedesco a fronte by Max Stirner
L'Unico e la sua proprietà. Testo tedesco a fronte by Max StirnerMy rating: 5 of 5 stars
Ho voluto avere nella mia biblioteca cartacea questo libro da poco uscito in una nuova edizione Bompiani, in testo a fronte. Quasi mille pagine. Il libro in altre edizioni lo si può trovare in rete e scaricare il testo gratis. Sono varie le edizioni, ma questa curata da Sossio Giametta mi sembra la più aggiornata oltre che moderna.
Ho letto diverse recensioni su GR in lingue diverse e non mi resta che dire la mia su di un libro il cui autore all'inizio scrive che ha "fondato la sua causa sul nulla". Ma poi si scopre che parla della vita dell'uomo, degli uomini antichi e quelli moderni. Scrive degli ossessi, dello spirito e della gerarchia, dei liberi, del liberalismo politico, di quello sociale e di quello umanistico. La prima parte la dedica all'uomo. La seconda invece si occupa dell'io.
Individualità propria, l'individuo proprietario, la sua potenza, i suoi rapporti, il godimento di se stesso. Alla fine arriva al nocciolo: "l'Unico". Una causa fondata su di esso, anzi su di lui: il NULLA. Ma per Stirner evidentemente il "nulla" vale per il "tutto". Se devo sintetizzare il suo pensiero dirò che Stirner è abbastanza arrogante da cercare di rispondere ai canonici "chi-cosa-quando-dove-perchè" riguardanti l'uomo e la sua vita.
Ci riesce? Non lo so. So che ha avuto il coraggio di provarci senza mai tradire il suo IO, la sua entità, il suo individualismo, che per alcuni è chiamato anarchia, per me invece e solo ricerca. Se date una occhiata alle etichette che ho scelto per classificare questo libro, vi renderete conto di quello che contiene questa opera scritta in pieno ottocento, da un tizio che è stato malfamato ed esaltato, considerato repellente, sguaiato, spaccone, smargiasso, degenerato, zotico, egomane, psicopatico grave, sgradevole, sofista, nauseante ... potrei continuare.
Per me resta un genio. Vi assicuro che nonostante gli abbia assegnato tutte quelle etichette, questo Max Stirner, che poi non si chiamava nemmeno così, è stato tanto assaltato quanto esaltato. Leggerlo in testo a fronte per me è una salutare avventura. Una opportunità, per rispolverare quella lingua che è tanto infernale quanto speciale, la mia "ur-sprache". Ho detto tutto ...
View all my reviews
August 14, 2018
Review: L'innominabile attuale
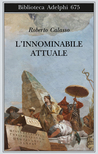 L'innominabile attuale by Roberto Calasso
L'innominabile attuale by Roberto CalassoMy rating: 4 of 5 stars
Mentre leggevo il libro mi sono andato a scorrere quello che su GR hanno scritto alcuni lettori sia dell'edizione italiana che della traduzione in inglese. Ho scritto un provvisorio commento: ""Sto leggendo il libro, lo trovo interessante, ma so già come andrà a finire. Non intendo il libro. Mi riferisco a quello che farò quando avrò completato la lettura. Mi rileggerò il Qoelet e sono sicuro che saprà dare un "nome" all' "innominabile".
Confermo questa momentanea impressione. Grande la cultura di chi scrive, formidabili le intuizioni, pensiero elaborato e complesso, troppe cose date per scontate, ma questa ovviamente è colpa non di chi scrive bensì di chi legge. Se la prima parte sembra più che una cavalcata di un "innominabile" nel presente, una fuga dal passato nel quale, purtroppo, poi Calasso ci riporta nella seconda parte. Desidero riportare una parte del giudizio di Giacomo Cavalleri su questo libro che pienamente condivido:
"Lo stile di Calasso è molto affascinante e non procede per argomentazioni logiche o filosofiche: è un mosaico di citazioni coltissime, debitamente virgolettate, elencate come “Fonti” nelle note: si va da Nietzsche all'amato Burckhardt, a Simone Weil, a Leibniz, Céline, Malebranche, Benjamin, Brasillach, Vassiltchikov, con sopravvalutazione (o disprezzo) del lettore che ben difficilmente andrà a controllare gli originali. Insomma, la scrittura di Calasso è all'insegna dell'ambiguità, perché non si capisce mai bene fino a che punto Calasso condivide le sue devote citazioni. Recensendo La rovina di Kasch sulla “London Rewiew of Books” il 26 gennaio 1995, Malcom Bull così concludeva: «Forse il brivido che si prova alla lettura non è tanto quello di una storia poliziesca, quanto di un romanzo del genere horror: alla fine ci si rende deliziosamente conto che ciò che il tuo affascinante ma elusivo compagno vuole è affondare i suoi denti nel tuo collo». Non si potrebbe dir meglio, e vale anche per l'Innominabile attuale."
Adesso avrete capito perchè mi sono andato a rileggere il Qoelet ...
View all my reviews

Published on August 14, 2018 12:35
L'Innominabile di Calasso
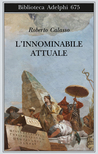 L'innominabile attuale by Roberto Calasso
L'innominabile attuale by Roberto CalassoMy rating: 4 of 5 stars
Mentre leggevo il libro mi sono andato a scorrere quello che su GR hanno scritto alcuni lettori sia dell'edizione italiana che della traduzione in inglese. Ho scritto un provvisorio commento: "Sto leggendo il libro, lo trovo interessante, ma so già come andrà a finire. Non intendo il libro. Mi riferisco a quello che farò quando avrò completato la lettura. Mi rileggerò il Qoelet e sono sicuro che saprà dare un "nome" all' "innominabile".
Confermo questa momentanea impressione. Grande la cultura di chi scrive, formidabili le intuizioni, pensiero elaborato e complesso, troppe cose date per scontate, ma questa ovviamente è colpa non di chi scrive bensì di chi legge. Se la prima parte sembra più che una cavalcata di un "innominabile" nel presente, una fuga dal passato nel quale, purtroppo, poi Calasso ci riporta nella seconda parte. Desidero riportare una parte del giudizio di Giacomo Cavalleri su questo libro che pienamente condivido:
"Lo stile di Calasso è molto affascinante e non procede per argomentazioni logiche o filosofiche: è un mosaico di citazioni coltissime, debitamente virgolettate, elencate come “Fonti” nelle note: si va da Nietzsche all'amato Burckhardt, a Simone Weil, a Leibniz, Céline, Malebranche, Benjamin, Brasillach, Vassiltchikov, con sopravvalutazione (o disprezzo) del lettore che ben difficilmente andrà a controllare gli originali. Insomma, la scrittura di Calasso è all'insegna dell'ambiguità, perché non si capisce mai bene fino a che punto Calasso condivide le sue devote citazioni. Recensendo La rovina di Kasch sulla “London Rewiew of Books” il 26 gennaio 1995, Malcom Bull così concludeva: «Forse il brivido che si prova alla lettura non è tanto quello di una storia poliziesca, quanto di un romanzo del genere horror: alla fine ci si rende deliziosamente conto che ciò che il tuo affascinante ma elusivo compagno vuole è affondare i suoi denti nel tuo collo». Non si potrebbe dir meglio, e vale anche per l'Innominabile attuale."
Adesso avrete capito perchè mi sono andato a rileggere il Qoelet ...
View all my reviews
Published on August 14, 2018 12:04
•
Tags:
calasso, innominabile
Catastrofismo tecnologico
 LocGlob
LocGlobCaro direttore,
non sono d'accordo con Claudio Risè e con il suo catastrofismo tecnologico. Una "droga" pericolosa, grandi sofferenze, perdita del senno e non sto a ricordare quant'altro ha scritto nel suo articolo su "La Verità" l'altro giorno su questo argomento. Secondo lui, la moderna tecnologia mobile è una "roba" che sta per "droga". Una sfida tra uomini e cellulari nella quale (noi uomini) siamo destinati a perdere.
Leggo con grande attenzione ed interesse i suoi articoli, conservo diversi suoi libri, apprezzo molto il suo lavoro di psicoterapeuta ma, anche se non sono nessuno di fronte alla sua scienza, non sono d'accordo. Ho scoperto che apparteniamo alla stessa fascia di età, siamo nati, infatti, nello stesso anno, quindi possiamo considerarci dei "dinosauri". Il termine non mi offende e spero che non offenda neanche lui.
Io sono nato in una piccola tipografia post gutenberghiana del meridione d'Italia. Ho imparato a leggere e scrivere allineando le lettere di piombo sul composimetro di mio padre ma, nella prima metà degli anni ottanta del secolo e millennio trascorsi, il Commodore 64 mi fece comprendere come stava cambiando il mondo.
Quando lasciai l'insegnamento mi iscrissi ad uno dei primi corsi online tenuti dalla Università di Londra, Institute of Education, e diventai un "dinosauro digitale". Nella dissertazione finale del corso coniai un termine con il quale mi piace sintetizzare il mio "sguardo tecnologico" su questa tecnologia: C.A.C. Connessione---->Accesso----->Controllo.
Claudio Risè, concludendo il suo scritto, dice: "Per uscire dal disastro occorre desiderare di essere stabili e felici, noi e i nostri figli." Sono d'accordo con lui, a condizione che dopo di esserci "Connessi", dopo di avere avuto "Accesso", sappiamo assumere il necessario "Controllo" di qualsiasi strumento che abbiamo tra le mani. Come del resto l'uomo ha sempre fatto. Nel bene e nel male.
Cordialmente

Published on August 14, 2018 06:02
Il futuro delle biblioteche
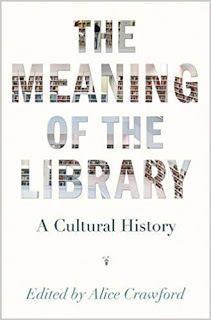 Con l'arrivo della comunicazione digitale e quindi di un nuovo tipo di libro, è lecito chiedersi cosa sarà delle biblioteche, così come le abbiamo conosciute da sempre. Oggi sembra che tutti siano propensi a intonare il canto funebre per la morte del libro cartaceo e dei luoghi dove essi sono stati custoditi e conservati da sempre: le biblioteche.
Con l'arrivo della comunicazione digitale e quindi di un nuovo tipo di libro, è lecito chiedersi cosa sarà delle biblioteche, così come le abbiamo conosciute da sempre. Oggi sembra che tutti siano propensi a intonare il canto funebre per la morte del libro cartaceo e dei luoghi dove essi sono stati custoditi e conservati da sempre: le biblioteche.
È lecito, quindi, porsi la domanda: che fine faranno le biblioteche? Non solo quelle di sempre, cartacee, ma anche quelle virtuali, digitali. Se i miei libri cartacei sono, per numero, quasi una biblioteca, mentre gli ebooks nel mio "Kindle Store" sono centinaia, mi chiedo quale sarà il futuro sia di questa che di quella biblioteca.
Non è una domanda sciocca, se si considera che è stato appena pubblicato un libro, (nella immagine qui accanto), che ne parla in maniera esauriente e da più punti di vista. Una serie di saggi curati da una studiosa del settore quanto mai autorevole.
Un libro molto interessante su di un tema apparentemente triste, quale può essere quello del decesso (presunto) delle biblioteche. Una serie di saggi scritti in un arco di tempo a seguito di alcune conferenze tenute nella biblioteca dell' Università di St Andrews in Scozia, in occasione della celebrazione della fondazione di un'altra biblioteca nel 1612, fondata dai re James VI e I. Quando si dice l'identità di una biblioteca.
Alla pari di un'altra, altrettanto famosa, senza dubbio la più famosa biblioteca della storia: la biblioteca di Alessandria. Per molti secoli, questa ha incarnato la conoscenza umana, eppure ne sappiamo ben poco. Fondata da re tolemaici nel terzo secolo avanti Cristo, della sua realtà fisica, come della sua fine, sappiamo quasi nulla.
Nel suo destino sono stati coinvolti, tra gli altri, Giulio Cesare, il fanatico vescovo Cirillo nel settimo secolo e gli Arabi invasori ai quali viene data la colpa di averla distrutta. La sua identità resta un mistero, come tutti i simboli che essa poteva incarnare: il potere, la conoscenza, la cultura dei suoi autori, tutti elementi decisivi e determinanti per formare quella che chiamiamo memoria dell'umanità.
La biblioteca resta intesa come istituzione dove il contenuto rappresenta qualcosa infinitamente più grande della somma delle parti che la costituiscono. Queste ultime sono testimonianze individuali degli scrittori, mentre il tutto è qualcosa di più, qualcosa che ha un valore strumentale di alta ambizione, quella di preservare intatta la memoria di tutti gli esseri umani. Una ambizione nata dalla volontà dei re tolemaici di conservare tutti i libri reperibili al tempo, originali o copiati.
Un'antica, appassionata, anzi folle, idea che continua da millenni, quella di raccogliere "materialmente" tutto ciò che può essere appreso, in modo da impossessarsi della "saggezza" che si può trovare nei libri. Sono ovvi i rischi che si corrono. Se ne parla non da oggi, se si pensa a quanto si legge nella "Satira dei Commerci", un testo egiziano risalente a circa due millenni a. C. oppure a quello che scrivono Luciano, Giovenale, Seneca, fino alla famosa "Nave dei Folli" di Sebastian Brant.
La libreria è continuamente vista come una fonte di conoscenza, di creatività intellettuale, di stimoli per la mente. Tutte cose che, però, creano grande responsabilità per la stessa mente che si alimenta di questo cibo. Viene affermata la necessità di un ordine, un metodo, una disciplina.
Una biblioteca non può essere soltanto una raccolta confusa di saperi, sterile accumulo di conoscenza, come dice Sebastian Brant nella sua "Nave dei Folli". Non può essere una "scatola" con un tesoro che dia solo risposte a delle domande. Il poeta Callimaco, uno dei primi bibliotecari della biblioteca di Alessandria, scrisse in proposito una sorta di catalogo ragionato di cui ci rimane ben poco.
Un altro tipo di "nave dei folli" per i libri compare in una commedia di Aristofane rappresentata nel 425 a. C.: il drammaturgo greco Euripide, viene presentato seduto su dei papiri mentre legge brani delle sue opere e riflette sul caos intellettuale del tempo. Una scena esemplare per descrivere il significato della biblioteca, vista come luogo creativo, bisognoso di ordine e metodo, non di accumulo, di ricerca, di risposte alle domande degli uomini.
Per molto tempo le biblioteche sono state considerate luoghi di conoscenza e di sapere come potere, forza e status sociale. Soltanto verso la metà del quindicesimo secolo, con l'invenzione della stampa, si afferma il concetto di sapere e conoscenza come libertà, e non solo dall'ignoranza.
Affermare che l'invenzione della stampa fece nascere una nuova classe di lettori, è dir poco. Fu tutto un mondo a scomparire, venendo sostituito da un altro che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. I manoscritti, riservati e accessibili soltanto a pochi, vennero sostituiti dai libri. Questo nuovo soggetto, il libro stampato, poteva passare di mano in mano, essere conservato, letto, riletto e rivenduto, magari ristampato. A poco prezzo. Bastava saper leggere. Non solo.
Chi sapeva leggere, poteva anche scrivere, avrebbe potuto quindi scrivere anche lui e stampare un libro. Per istruirsi, per educare altri, per venderlo e per guadagnare. Tutti questi libri potevano essere conservati in un luogo adatto e tramandato alle future generazioni. Tutto era diventato più "democratico". Alle biblioteche avrebbero potuto accedere tutti.
Dopo questo rapido "excursus" è bene porsi la domanda dalla quale siamo partiti: quale sarà il futuro della biblioteca? Va detto che la biblioteca non è soltanto il luogo dove si conservano libri e opere di scrittori, ma anche il posto dove si raccolgono manoscritti, lettere, documenti, mirabilia e quant'altro possa documentare i giorni di una esistenza umana fatta di progetti, pensieri, ricordi e testimonianze trasmesse e trascritte in vari modo.
La biblioteca moderna, quella del terzo millennio, dovrebbe contenere quattro aree specifiche nelle quali la tecnologia digitale potrebbe svolgere un ruolo decisivo. Esse sono: i così detti obblighi curativi, la ricerca e l'apprendimento, le pubblicazioni, e spazi per chi scrive e legge alla larga.
Sfortunatamente queste idee restano soltanto propositi. Sono ignorate, ridicolizzate e respinte anche da chi dovrebbe saperne di più. Le biblioteche dovrebbero essere in questa nostra era digitale di grandi trasformazioni luoghi di democrazia globale, posti dove si dovrebbe rincorrere la "verità ". Una parola difficile, ingannevole, sulla quale persino Pilato fece uno scivolone.
Se i libri, cartacei o digitali, sono i guardiani delle memorie umane, veri e propri maestri di lingue e linguaggi, sentieri della ragione, per così dire, da percorrere verso l'immaginazione, le biblioteche devono essere antidoti al fanatismo, di ogni tipo. Purtroppo non è così.
Quante biblioteche sono state distrutte nel corso dei secoli? Quante sono chiuse e polverose? Quante deserte e abbandonate? Eppure, esse dovrebbero essere sempre aperte, attive, pronte a farci ricordare chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo. Qualcuno ha scritto che collezionare libri significa voler "controllare tutto ciò che resta di insopportabile nella condizione umana". Saranno le biblioteche in grado di sopportare anche il libro digitale?

Published on August 14, 2018 03:05
August 13, 2018
Il libro infinito
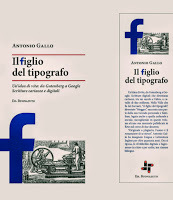 Esiste un libro che non si finisce mai di leggere? Si, esiste. Nato dal mio blog, questo libro è intitolato "Il figlio del tipografo". Ho raccolto sessanta post pubblicati nel corso di venti anni sul mio blog, li ho fatti precedere da altri trenta post dedicati alla scrittura creativa, ho stampato il libro POD (print on demand) e chi vuole può leggerlo acquistandolo cartaceo oppure online free su Internet Archive.
Esiste un libro che non si finisce mai di leggere? Si, esiste. Nato dal mio blog, questo libro è intitolato "Il figlio del tipografo". Ho raccolto sessanta post pubblicati nel corso di venti anni sul mio blog, li ho fatti precedere da altri trenta post dedicati alla scrittura creativa, ho stampato il libro POD (print on demand) e chi vuole può leggerlo acquistandolo cartaceo oppure online free su Internet Archive.
La cosa non finisce qui, ovviamente, perchè continuo a pubblicare post sul blog. In questa maniera posso dire che questo è un libro che si legge online e in cartaceo, si sfoglia, si clicca e non si finisce mai di leggere. Si clicca e si legge. Si sfoglia e si legge. Sono passati alcuni mesi dalla pubblicazione e gli eventi che si sono succeduti non si contano.
Un fiume, un torrente, che dico, un mare oceano di notizie che ogni minuto segnano la nostra insufficienza, incapacità a gestire come vorremmo la vita. Perchè proprio di questo si tratta: mettere in ordine il comune "chi-cosa-quando-dove-perchè" e cercare di darci un senso. Ma poi ti risponde il verso di quella canzone " ... e se il senso non ce l'ha?" Ti ritrovi instupidito come e più di prima. Ti chiedi: ma ne valeva la pena? Leggere, scrivere a che serve poi? Per capire quello che penso ... Il serpente che si manga la coda ...

Published on August 13, 2018 08:14
"L'anima mediterranea"

"Dono di ferragosto per gli amici di MV. Un piccolo saggio sul Mediterraneo. Scaricatelo, stampatelo e conservatelo arrotolato in bottiglia, come un messaggio venuto dal mare". Così ha scritto Marcello Veneziani sul suo blog ed io sono felice di conservare questo post che ha il sapore di un saggio. A futura memoria.
“Nulla mi ha più formato, impregnato, istruito – o costruito – di quelle ore rubate allo studio, distratte in apparenza, ma votate nel profondo al culto inconscio di tre o quattro divinità incontestabili: il Mare, il Cielo, il Sole. Ritrovavo senza saperlo, non so quali stupori e quali esaltazioni primitive. Non vedo quale libro potrebbe valere, quale autore potrebbe creare in noi quegli stati di stupore fecondo, di contemplazione e di comunione che ho conosciuto nei miei primi anni. Meglio di qualunque lettura, meglio dei poeti, meglio dei filosofi, certi sguardi, lanciati senza pensiero definito né definibile, certe soste sui puri elementi della luce..” (Paul Valéry)
Leggo in riva al mare le folgoranti Ispirazioni mediterranee di Paul Valéry. Risalgono al 1933 e sono un inno all’amor fati, cioè alla gratitudine di essere mediterranei: “Sono nato in uno di quei luoghi in cui avrei desiderato nascere”. Leggo Valéry al sole, davanti al mare e al cielo, e ritrovo davanti il senso fluente e luminoso della mediterraneità. Nota Valéry che il pensiero nacque sulle rive del Mediterraneo perché qui sono riuniti tutti gli ingredienti sensibili, gli elementi e gli alimenti che lo generano: luce e spazio, libertà e ritmo, trasparenze e profondità. E in sintonia con le condizioni naturali emergono gli attributi della conoscenza: chiarezza, profondità, vastità, misura…
“Ispirazioni mediterranee” si intitola anche un altro libretto francese, di Jean Grenier, maestro di Albert Camus. Per Grenier il Mediterraneo è “uno spazio breve che suggerisce l’infinito”. Camus coniò l’espressione pensiero meridiano di cui Franco Cassano è stato in Italia in anni più recenti un lucido teorico: è il pensiero che nasce sulle sponde mediterranee, che si nutre del sole e del mare e considera essenziale il genius loci. Camus può definirsi un bigamo mediterraneo, metà di sponda algerina, metà di sponda francese. Il pensiero di Camus si radica nel paesaggio, nel sole, nel mare, nei colori del Mediterraneo. Pensiero meridiano fu la sua geofilosofia mediterranea: “il Mediterraneo, dove l’intelligenza è sorella della luce cruda”. Una filosofia profondamente meridionale, greca e latina, animata dal genius loci. Nella sua visione del mondo affiora il lucore dell’infanzia algerina e poi la luce abbagliante della Provenza, descritti nei suoi magnifici saggi solari dedicati all’estate e al ritorno. Una passione speciale nutre Camus per l’Italia, vista come sintesi tra la sua terra nativa, l’Algeria (“la dolcezza di Algeri è piuttosto italiana”) e la sua terra d’elezione, la Provenza. L’Italia, scrive ne Il rovescio e il diritto, è la “terra fatta secondo la mia anima”. Nella sua filosofia del paesaggio c’è un riferimento remoto, classico, ed uno vivente, prossimo. Il primo è Plotino, metafisico della bellezza e dell’Uno, venuto dall’Egitto a Roma, che per Camus “pensa d’artista, sente da filosofo…la sua ragione è vivente, piena, commovente come un melange di acqua e di luce”, sul filo di una solitudine innamorata del mondo e di una “squisita malinconia”. Parlando di Plotino, Camus parla di se stesso. Il riferimento prossimo è invece ancora a Jean Grenier che fu suo insegnante e poi fu suo amico e che lo folgorò da ragazzo con i suoi scritti dedicati al mare, alle isole e all’ispirazione mediterranee, sulla scia di Paul Valéry. Il maestro poi sopravvisse al discepolo e scrisse su Camus un tenero libro di ricordi.
“Sceglieremo Itaca, la terra fedele, il pensiero audace e frugale, l’azione lucida, la generosità dell’uomo che sa”, Camus tracciò sulle sponde mediterranee una filosofia dell’amore. “Se fossimo déi non conosceremmo l’amore” dice con Platone; ma “l’uomo – scrive nei Taccuini- si realizza solo nell’amore perchè vi trova in forma folgorante l’immagine della propria condizione senza avvenire”. Camus sottrae l’amore all’eternità e lo rende umano, cioè fugace. Il suo fascino è la sua precarietà, il suo tramontare, come l’Occidente. Il fascino geo-letterario di Camus è anche nell’atmosfera pomeridiana della siesta, la nostra meridionale controra, la metafisica del caldo, il ronzìo delle mosche e il sapore mediterraneo dell’anisette che diventa pastis in Provenza, ouzo in Grecia, arak nel Medio Oriente, il raki in Turchia, sambuca o mistrà in Italia, e poi Meletti, Varnelli, e il mitico assenzio che ubriacò la letteratura maledetta dei postromantici… L’incanto del mare, la solitudine come sete d’eternità, gli dei che “parlano nel sole e nell’odore degli assenzi…”. La filosofia di Camus combacia col mito e soffia con il vento mediterraneo della vita.
Un vasto pensiero italico, dalla scuola pitagorica alla letteratura romana, dal pensiero rinascimentale a Vico, che delineò una “geografia poetica”, fino al secolo scorso, si ritrova nel grembo mediterraneo e costruisce una linea filosofica, storia e letteraria profondamente ispirata dalla civiltà mediterranea. Un filosofo tedesco di origine italiana, Romano Guardini, notava che la grande forza del pensiero mediterraneo è nell’unità tra ciò che è visibile e ciò che è invisibile, tra interiorità ed esteriorità, tra anima e corpo, tra chiuso ed aperto. Per Guardini, Dante è “uomo del Sud” e la più alta espressione della sensibilità mediterranea. In lui “ciò che è interiore diventa visibile, udibile, afferrabile con le mani. Ovunque si passa direttamente dalla corporeità manifesta all’interiorità dell’anima”.
A vederlo nel mappamondo, il Mediterraneo è una culla situata al centro del pianeta. E al centro di questo bacino, di questa culla, c’è la penisola italiana e le sue isole. La centralità dell’Italia nel Mediterraneo e del Mediterraneo nel mondo è davvero una realtà prima che un pensiero. Tre continenti si affacciano su questo balcone unico al mondo. La varietà è di casa nel Mediterraneo nei frutti come nelle civiltà. Come la mitezza del clima e il sapore d’anice. Sul piano storico il Mediterraneo, si sa, è il bacino da cui si dipartirono le più significative civiltà, in cui presero corpo le religioni e le filosofie, i codici giuridici e i reggimenti politici, democrazia inclusa, le scoperte e le scienze che hanno pervaso il pianeta. “Giammai e in nessuna parte del mondo s’è potuto osservare in un’area così ristretta e in un così breve intervallo di tempo, un tale fermento di spiriti, una tale produzione di ricchezze” si legge in Valéry.
Ma oggi il Mediterraneo cos’è? È il luogo dell’Europa tardiva, del meridione a rimorchio, dei Paesi indebitati, della Primavera Araba, della fratellanza islamica, del terrorismo, dei barconi di affamati, dei migranti morti. Questa l’immagine prevalente. Il Mediterraneo è oggi il mare della speranza e della tragedia, della civiltà e della barbarie che si incrociano, la cerniera che unisce e separa al tempo stesso, due mondi, il mondo nero e affamato del sud e il mondo lucente e benestante del nord. Potrà mai immaginarsi un’Europa compiuta che rinneghi il Mediterraneo con le sue radici greche, romane, cristiane, oltre le contaminazioni arabe e giudaiche, turche e normanne? E potrà mai pensarsi l’integrazione europea come un puro adeguarsi al paradigma nordico, tecnico, finanziario, cancellando l’inevitabile dualità europea tra la civiltà mediterranea, cattolica e ortodossa, e la civiltà nordica, protestante e calvinista? Si potrà mai pensare l’equilibrio europeo e globale senza tentare di armonizzare i tre continenti, le tre religioni e le culture madri che si affacciano nel Mediterraneo? Oltre gli europei qui ci sono gli arabi, i turchi, gli egiziani, gli illirici e anche gli slavi del croato Pedrag Matvejevic, autore e fautore del Mediterraneo in alcune sue opere significative. Non si può ridurre il Mediterraneo ai barconi dei migranti e non si può ridurre la sua civiltà millenaria alla tragedia dei loro corpi rimasti nei fondali. Peraltro migliaia di altri corpi finirono nelle guerre antiche e moderne, nella storia dei secoli, a Otranto e Lepanto, per mano d’invasori.
È curioso pensare che il più lucido fautore della Repubblica mediterranea sia stato il principale teorico della Lega e della Padania, Gianfranco Miglio. Rifacendosi a Carl Schmitt, e alla tradizione filosofico-giuridica italiana, Miglio ricordava che l’Italia, a differenza dei paesi nordici e protestanti, in cui vige il comando impersonale della legge, è un paese mediterraneo fondato sulla mediazione personale e comunitaria. Da qui l’idea di una repubblica mediterranea, basata su un rapporto fiduciario e diretto tra popolo e leader. Miglio riconosceva l’autonomia sovrana della politica e avversava il dominio delle oligarchie finanziarie e tecnocratiche. Che si debba cercare nei fondali del Mediterraneo la risposta alla crisi economica, alle speculazioni finanziarie e all’asservimento da debito? Si deve proprio a Carl Schmitt la lucida ripartizione in Terra e Mare delle due differenti opzioni che caratterizzano la vita e la storia dei popoli, la lor indole e la loro mitologia. Le potenze marine e le potenze terrestri, il confine liquido e indefinito del mare e la frontiera ben delineata sulla terra, perfino i mostri del mare e della terra, metafore del potere, Behemoth e il Leviatano, i biblici mostri della terra e del mare…
L’Europa è un albero che dà frutti al nord, ma il tronco è italiano e le radici sono piantate nel Mediterraneo, da cui traggono linfa, luce e calore.
Torno al geopensiero di Valéry, alla filosofia imbevuta di paesaggio e di mare, al suo occhio che “abbraccia insieme l’umano e l’inumano”, ai porti mediterranei che descrive animati da un solo personaggio, la Luce. Quei porti dagli odori intensi che sono per lui un’enciclopedia o una sinfonia olfattiva; quel mare che per primo rende concepibile il possibile; quel pensiero che nasce dalla rarefazione del concreto, come un distillato della realtà, frutto soprannaturale della natura; quei puri elementi della luce che suggeriscono agli spiriti contemplativi le nozioni di infinito, di profondità, di universo; quel sole che introduce il modello di una potenza trascendente, di un signore unico; quell’uomo misura tutte le cose che nacque sulle sue sponde, qui diventa soggetto della polis e sviluppa come in nessun altro luogo il potere fascinoso della parola. Qui l’essere sopravanza il fare, il fato torreggia sulla tecnica, le cose valgono più dei mercati finanziari, la vita reale dei popoli conta più degli assetti contabili, come drammaticamente emerge nelle convulsioni mediterranee che hanno colpito la Grecia, Cipro, la Turchia, che hanno lambito l’Italia e la Francia, la Spagna e la Catalogna, e tormentato i paesi slavi che si affacciano nel nostro bacino e che dettero luogo sulla riva maghrebina del Mediterraneo alla Primavera Araba (dalle rivoluzioni fino all’orrore delle esecuzioni filmate sulla riva del mare mediterraneo).
Ispirazioni mediterranee per un pensiero che non si arrende al primato tirannico dell’economia ma esige che l’economia torni al servizio della polis e non il suo contrario. L’Europa torni alle sue origini mediterranee che fu il suo grembo materno. Più che radici, è meglio parlare di matrici, che evocano la madre e il mare, al tempo stesso. Il suo pensiero si radica nel paesaggio, nel sole, nel mare, nei colori del Mediterraneo. Pensiero meridiano chiamò Camus la sua geofilosofia; “il Mediterraneo dove l’intelligenza è sorella della luce cruda”. Una filosofia profondamente meridionale, greca e latina, animata dal genius loci. Nella sua visione del mondo affiora il lucore dell’infanzia algerina e poi della Provenza, descritti nei suoi magnifici saggi solari dedicati all’estate e al ritorno. Una passione speciale nutre Camus per l’Italia, vista come sintesi tra la sua terra nativa, l’Algeria (“la dolcezza di Algeri è piuttosto italiana”) e la sua terra d’elezione, la Provenza. L’Italia, scrive ne Il rovescio e il diritto, è la “terra fatta secondo la mia anima”.
Nella sua filosofia del paesaggio c’è un riferimento remoto, classico, e uno vivente, prossimo. Il primo è Plotino, metafisico della bellezza e dell’Uno, pensatore mediterraneo venuto dall’Egitto a Roma, che per Camus “pensa d’artista, sente da filosofo…la sua ragione è vivente, piena, commovente come un melange di acqua e di luce”, sul filo di una solitudine innamorata del mondo e di una “squisita malinconia”. Parlando di Plotino, Camus parla di se stesso. Il riferimento prossimo è invece Jean Grenier che fu suo insegnante e poi fu suo amico e che lo folgorò da ragazzo con i suoi scritti dedicati al mare, alle isole e all’ispirazione mediterranee, sulla scia di Paul Valéry. Il maestro sopravvisse al discepolo e scrisse su Camus un libro di ricordi. La sua rivolta non nasce dall’insofferenza verso il reale, dall’odio per l’esistente e verso la propria patria, ma al contrario: “Sceglieremo Itaca, la terra fedele, il pensiero audace e frugale, l’azione lucida, la generosità dell’uomo che sa. Nella luce, il mondo resta il nostro primo e ultimo amore”. Pensiero mediterraneo.
Camus tracciò una filosofia dell’amore. “Se fossimo déi non conosceremmo l’amore” dice con Platone; ma “l’uomo – scrive nei Taccuini- si realizza solo nell’amore perché vi trova in forma folgorante l’immagine della propria condizione senza avvenire”. Camus sottrae l’amore all’eternità e lo rende umano, cioè fugace. Il suo fascino è la sua precarietà, il suo tramontare. Mediterranea per Camus è l’atmosfera pomeridiana della siesta, la nostra meridionale controra, la metafisica del caldo, il ronzìo delle mosche e il sapore mediterraneo dell’anisette, l’incanto del mare, la solitudine come sete d’eternità, gli dei che “parlano nel sole e nell’odore degli assenzi…”. La filosofia di Camus combacia col mito mediterraneo e soffia con il vento della vita.
Il viaggio in nave resta il viaggio per eccellenza perché più lento e più inesorabile, più antico e compreso tra i quattro punti cardinali dell’esistenza vagante: il cielo, il mare, il sole, il vento. Viaggiando per mare si scorgono due tipi umani. Ci sono i viaggiatori di prua che amano guardare la nave che fende la verginità dell’ignoto, avanza in cerca di futuro e si eccitano del vento che narra sul loro volto degli invisibili approdi venturi. E ci sono i viaggiatori di poppa, che amano invece vedere il tempo trascorso che disegna gorgoglii di schiuma, che via via si compongono fino a essere inghiottiti nel maestoso oblìo del mare. Gli occhi delle navi (e degli aerei) si chiamano oblò e in quella parola c’è la sorpresa accentata e insieme l’oblio, la meraviglia di una scoperta e la repentina scomparsa allo sguardo. Così scorre nostalgicamente allo sguardo la vita andata, i paesaggi lasciati alle spalle, confusi ormai nell’oscurità della sera. Viaggiatori di poppa e viaggiatori di prua, due disposizioni d’animo che figurano distinte propensioni della mente a perdersi nel futuro e nel passato.
Si deve a Nietzsche la visione del mare come luogo in cui non conta l’origine ma il valore, in cui tutto è affidato alla destrezza e al coraggio, alla capacità creativa di barcamenarsi ed esplorare nuove terre, cercare nuovi approdi, dopo aver lasciato alle spalle la terra natia e il luogo sicuro, navigare nel mare oscuro senza punti di riferimento terreni. In alto mare. “Il mio conforto è che tutto ciò che è stato è eterno- il mare lo riporta di nuovo” scriveva Nietzsche cogliendo nel mare “l’ondeggiante ripetizione”, immagine fluente dell’eterno ritorno. Il mare canta incessante la rapsodia del ritorno: di scomparse e ritorni è ritmato il suo moto. Il viaggio primordiale è quello compiuto nel mare perché il mare è il nostro primo aldilà, il nostro primo altro regno, il nostro più vicino infinito, a portata di corpo; ma al tempo stesso è il liquido amniotico dell’universo, le sue acque placentali. Mare-Mater.
Alla fine, ha avuto ragione Hegel quando nelle sue Lezioni di filosofia della storia coglieva nel segno delineando l’essenza spirituale del mare Mediterraneo, precorrendo le pagine di Nietzsche e di Schmitt, scriveva: “Solo perché è un mare, il mar Mediterraneo ha potuto costituire un centro […]. Il mare ci dà l’idea di qualcosa d’indeterminato, illimitato, infinito, e l’uomo, sentendosi in mezzo a questo infinito, è incoraggiato a varcarne il limite. Il mare invita l’uomo alla conquista, alla rapina, ma anche al guadagno e al profitto. La terraferma, la pianura fluviale, fissa l’uomo al suolo, dal quale gli viene un’infinità di impedimenti; al contrario, il mare lo spinge al di là di queste cerchie limitate. Quanti navigano per mare vogliono anche guadagnare, arricchirsi; ma il mezzo s’inverte rispetto al fine, al punto che essi rischiano di perdere la loro proprietà e la vita stessa. Il mezzo è, perciò, l’esatto contrario del fine che essi si prefiggono. È proprio questo a innalzare il profitto e l’industria al di sopra di se stessi e a farne qualcosa che richiede valore e nobiltà d’animo. Bisogna che il coraggio entri a far parte dell’industria, così come il valore si associa all’intelligenza. Infatti, quando si tratta del mare, il valore dev’essere nel medesimo tempo astuzia, poiché si ha a che fare con l’astuzia stessa, con l’elemento più insicuro e ingannevole. La sua superficie infinita è assolutamente arrendevole, non resiste a una pressione, nemmeno al soffio; appare infinitamente innocente, remissiva, amichevole e adattabile, tuttavia è proprio questa remissività a capovolgere il mare nell’elemento più pericoloso e più violento. L’uomo oppone un semplice pezzo di legno alle illusioni e alla violenza del mare, si affida solo al suo coraggio e alla sua presenza di spirito, e passa così da qualcosa di solido a qualcosa che non gli dà sostegno, recando con sé il suolo da lui stesso fabbricato. La nave, questo vigneto del mare, che sola le pianure ondose in movimenti agili e rotondi, oppure tracciando cerchi, è uno strumento che rende il massimo onore al suo inventore, ovverosia all’uomo, al suo ardimento e al suo intelletto. L’andar per mare, lontano dalla limitatezza della terraferma, è qualcosa che manca allo sfarzo degli edifici statali asiatici, perfino quand’essi diano sul mare, come, per esempio, la Cina. Per questi popoli il mare è soltanto il venir meno della terra, non hanno nessun rapporto positivo con il mare. L’attività alla quale il mare ci invita è di un genere affatto particolare: perciò troviamo che i territori costieri si separano quasi sempre dai territori dell’interno, anche quando siano collegati a essi da un fiume. Così l’Olanda si è separata dalla Germania, il Portogallo dalla Spagna”. È forse superfluo aggiungere che la sfida del mare si addice più ad un mare “concluso” come il Mediterraneo, e meno ad un oceano, che non consente trasmigrazioni umane ma solo ardite, eccezionali esplorazioni. Ma l’impulso a osare la via del mare, suggerisce Hegel, eccede il calcolo contabile della vita e si delinea come eroico, fino a trascendere le finalità mercantili da cui sembra mosso. L’ardire della sfida nobilita anche la bassezza degli scopi e infonde un alone romantico perfino alla pirateria e alle sue scorrerie.
Il mal di mare non è solo il malessere di chi soffre il moto ondoso del mare. C’è un mal di mare diverso, indefinibile e incurabile, che si stenta a confessare, un male che è una malìa. Somiglia al mal d’Africa che colpisce taluni viaggiatori; la nostalgia di libertà e di primordiale innocenza, di purificazione gioconda e di bellezza attingibile, di alchemico sciogliersi dell’io nel tutto; un male che colpisce chi viene dal mare e dal mare poi si allontana. La fatica incessante del mare tra scogli e risacche rivela il travaglio del cosmo; il mare impetuoso disegna nell’aria effimeri altari, innalza bianche torri di schiuma, emette potenti ruggiti e boati. Onde maestose, turgidi flutti che si ergono in piedi, provando il brivido dell’erezione, presto disfatte. È bello entrare nel mare disabitato di primavera, andare lontano, in cima al mare nei cieli disadorni dell’infinito. Liberi tra cielo e mare, immersi nelle consonanze segrete dell’universo, ritmando le bracciate al respiro dei flutti. Su lontani litorali si scorgono rari punti in movimento. Le voci si spengono. E poi scendere nel ventre placido e immenso del mare, inabissarsi lentamente. Le orecchie pulsano di rumori inanimati, sassi si odono cozzare da lontano, bolle d’aria attorniano gli occhi. Una vita ricca e inerme si muove sui fondali. Poi i polmoni si fanno rari, il respiro pesante, si risale al tetto di luce che separa due mondi contigui e remoti. Restituirsi all’aria mentre le gocce d’acqua sulle ciglia scompongono come prismi la luce del sole, disegnando minuscoli arcobaleni. Poi raggiunta la riva, abbattuti nell’inerzia bianca e gessosa dei ciottoli, lasciarsi vivere dal sole, dal vento, dal mare. E perdere il senso delle ore mattutine, fino al tramonto. Nella rosea armonia di un paesaggio di luce, la sapienza del cosmo stempera nel mare la sua musicale magìa. Il miglior viaggio è un beato naufragio sulla riva da cui partimmo. “Simile all’acqua è l’anima dell’uomo. Viene dal cielo, risale al cielo” canta Goethe il viaggio fluviale e pluviale dell’anima.
Le “colonne d’Ercole” furono poi il senso del limite dei mediterranei, abbandonare quel mare significava peccare d’orgoglio e dismisura, hybris, andare incontro alla morte. Ma al suo interno, non c’è libertà più spumeggiante e più coinvolgente di quella che viene danzando sulla cresta dell’onda. Una libertà che si propaga dall’anima al corpo e viceversa. La giovinezza di Afrodite schizza sulla infinita vecchiezza del mare mediterraneo, il mare “vinoso, canuto e ondisonante” cantato da Omero, che separa e unisce le terre come un cordone ombelicale e ne ritaglia le identità, fino a comporre un arcipelago solcato da canali che come vene scorrono e narrano il sangue spirituale del Mediterraneo.
MV

Published on August 13, 2018 07:00
August 12, 2018
Siamo tutti "lettori" oggi

Cosa si dovrebbe dire a chi non legge libri? GoodReads è un sito dedicato ai libri con 75 milioni di iscritti, una biblioteca di oltre due miliardi di libri schedati e commentati, 77 milioni di recensioni, con visitatori che parlano una ventina di lingue conosciute.
Ha per motto editoriale questa dichiarazione: "The right book in the right hands at the right time can change the world", il che vuol dire che in questo posto si può trovare "il libro giusto nelle mani giuste, al tempo giusto, per cambiare il mondo". Intenzioni davvero ambiziose, eppur legittime per chi i libri, li pensa, li scrive, li stampa, li pubblica e, si spera, li vende.
La redazione di recente ha posto ai lettori una domanda riguardante le dodici cose da dire a chi non legge i libri. Hanno risposto centinaia di lettori da tutto il mondo pubblicando le proprie idee, abitudini di lettura e quant'altro caratterizza chi scrive e chi legge. Questa è stata la mia risposta sulla quale intendo qui ritornare per registrare quello che penso:
"Reading for me is just like travelling. Walk to the bookshelf, hold any book, open it, turn the pages and start. Where to? Well, it doesn't matter, really. The journey is the message!"
"Leggere per me è proprio come viaggiare. Vai allo scaffale della tua biblioteca, prendi un libro, lo apri, sfogli le pagine e cominci a leggere. Inizi il viaggio. Per dove? Non importa. Quello che conta è partire. Il viaggio è il messaggio".Eppure al giorno d'oggi si può dire che non ci sia nessuno che non legga. E' vero, la lettura dei libri non sembra mai troppa, mai abbastanza per cambiare non solo le persone, la persona che legge, oppure, addirittura, il mondo. Nessun libro, purtroppo, è mai riuscito a salvare milioni di vittime innocenti scomparse con violenza nella storia dell’umanità. Nemmeno i tanti libri sacri scritti in nome di un dio che invece di unire, ha sempre diviso.
Quando si dice che una persona che scrive libri è uno scrittore “impegnato”, si dovrebbe riflettere bene su questo tipo di impegno. Se questa parola significa l’intenzione di voler cambiare le cose del mondo perché si crede di aver scritto un’opera d’arte, meglio convincersi che questa espressione è fortemente esagerata.
Qualcuno ha scritto che una grande opera d’arte è un sorta di suicidio, e a ben ragione. La vera arte non accetta compromessi, la vita è piena di compromessi. Non ci si salva con l’arte. L’arte della parola è la sola verità, ma l’artista di solito è un grande mentitore. La sua arte potrà dire soltanto la verità del suo tempo.
Ma, allora, serve davvero leggere? Nell'immagine che correda il post si vede chi legge un libro e chi legge un cellulare. La differenza è grande, ma non tanto, a pensarci bene. In un libro puoi leggere di tutto. La stessa cosa puoi fare con un cellulare. Uno strumento è l'uno, uno strumento l'altro. Entrambi sono il "messaggio", come lo intese McLuhan. "Il mezzo è il messaggio" era vero allora, è ancora più vero oggi in digitale.
Con un libro in mano, mentre leggo, viaggio nel tempo e nello spazio, nelle parole di chi ha scritto il libro. Se leggo lo "smartphone", so che, oltre la lettura della Bibbia o del giornale, posso anche leggere le mappe di Google che mi portano dove nessuno potrebbe o saprebbe portarmi.
Ecco, allora, che l'idea del "viaggio" fatto leggendo un libro, diventa un fatto concreto, reale, trasferito dal virtuale. Se desidero vedere la nuova casa che il mio amico Marco ha appena acquistato a Boston mi basta dare a Google l'indirizzo della strada. L'algoritmo e il satellite mi "porteranno" a casa sua. Vi pare poco?

Published on August 12, 2018 09:04
MEDIUM
Nessuno è stato mai me. Può darsi che io sia il primo. Nobody has been me before. Maybe I’m the first one.
- Antonio Gallo's profile
- 52 followers



