Antonio Gallo's Blog: MEDIUM, page 100
March 10, 2021
Elogio e potere del “cazzeggio”
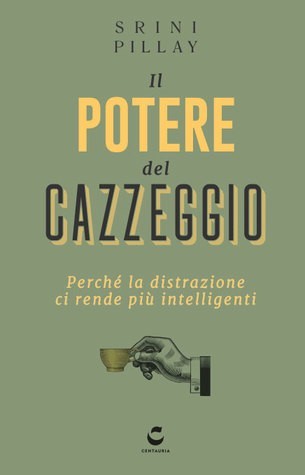 Il Libro
Il LibroAncor giovane sbarbatello, ginnasiale senza voglia di studiare, per evadere dalla grigia atmosfera di provincia, cominciai ad appassionarmi allo studio delle lingue moderne.
In reazione a quelle classiche, (il latino e il greco), mi diedi a studiare le lingue moderne, seguendo le lezioni che la RAI trasmetteva di mattina presto prima del giornale radio delle ore sette.
Seguivo le lezioni di tedesco e inglese. I gloriosi anni cinquanta della radio. Scoprii che quella parola proibita, ma già allora usatissima, esisteva anche in quelle due lingue.
Significava qualcosa di molto diverso. Il gatto era “die Katze” in tedesco, in inglese suonava quasi lo stesso al plurale. Questo per dire che al giorno d’oggi, la parola la potete regolarmente sentire e leggere ovunque senza alcun problema.
L’organo in oggetto ha avuto tanta forza da far “nascere”, è il caso di dirlo, altri termini insieme a tutta una fioritura letteraria che con l’arrivo dei social ha raggiunto il massimo della sua espansione. Ha addirittura assunto un valore culturale.
Hanno scoperto che “cazzeggiare” potenzia le abilità intellettive e conoscitive. E’ questa la tesi del libro “Il potere del cazzeggio”, scritto da Srini Pillay, neuropsichiatra, insegnante ad Harvard.
“Imparare ad alternare concentrazione e cazzeggio vi renderà rapidi, efficienti e produttivi nel pensare e nel risolvere i problemi. Trovare una routine che contenga entrambi gli aspetti è la chiave per migliorare il rendimento, esaltare la creatività e in generale raggiungere la felicità che tutti cerchiamo. Anzi, per quanto possa sembrare ironico, uno degli effetti collaterali del cazzeggio è che quando ne avrete bisogno farete meno fatica a concentrarvi. Per questo trovo che siano due facce della stessa medaglia”.
La prova di quanto ho riportato dal libro la trovo ogni giorno leggendo gli scritti di Marcello Veneziani, uno scrittore che ormai leggo e seguo da molti anni. Veneziani è capace di scrivere di tutto e su tutti.
In occasione della giornata della donna, ha scritto, da par suo, in serietà e competenza. Passata la festa tutta rosa, ha creduto opportuno “cazzeggiare” sui maschietti. Quello che segue è il suo cazzeggio sulla tazza:
 La tazza
La tazzaDopo la lunga giornata delle donne, lasciate che mi dedichi, almeno per cazzeggio, all’angolo dei maschi, con leggerezza. Quando vedo le coppie d’innamorati e la loro dolce demenza, li proietto nel loro futuro dopo la fase acuta e mi viene un po’ da piangere e un po’ da ridere. Penso alla futura schiavitù reciproca e da maschio mi colpisce più quella dei maschi. Li vedo da sposati, li immagino stimati nella loro vita pubblica, ma poi ridotti in casa a larve umane.
Un segnale pericoloso un tempo erano le pattine, per obbedire alle fisime lucenti della moglie. Ma ho scoperto il punto preciso in cui avviene l’abdicazione e poi la resa simbolica dell’uomo alla sua signora o domina (che è poi l’etimo di donna). È quando un uomo accetta il diktat della sua dominatrice di sedersi sul water per orinare. Lo scopo è non produrre schizzi extratazza o sul tarallo; ma la perdita della posizione eretta nella minzione segna la capitolazione del maschio e il suo docile accucciarsi agli ordini della Domatrice. Alza la zampa, e lui la alza; siediti, e lui si siede. Anche i figli vengono così castrati in età precoce. Era uno dei più grandi piaceri mingere al vento in campagna o tra i boschi, sentire il fruscio sull’erba e la complicità delle piante; era una promessa di lealtà urinare in compagnia, assicurando così che non sei un ladro o una spia.
Ricordo un amico di gioventù, rustico e spaccone, uso a grattarsi il pacco e a mingere dove capitava, che dopo sposato, cambiò modi. Non capivamo cosa fosse accaduto. Un giorno scoprimmo che la moglie lo aveva ammaestrato a far pipì seduto sulla tazza. Fu la sua fine. L’organo finì ai domiciliari, lui diventò l’ombra di se stesso. C’è un film con Jack Nicholson che da pensionato, perduta la moglie, riscopre il gusto di far pipì in piedi, come natura vuole. La schiavizzazione dell’uomo comincia dalle vie urinarie. Non prostratevi. (Però siate più precisi con la mira).
MV

March 9, 2021
“Ribellarsi”, ovvero: come “ritornare al bello”
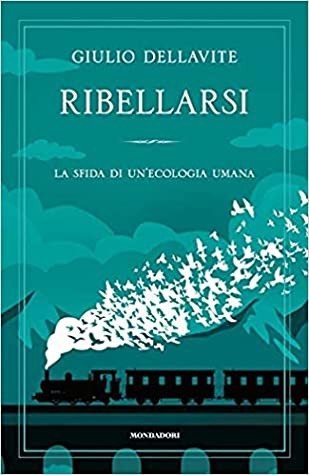 Il libro
Il libroNon lasciatevi ingannare dal titolo. Questo libro non ha nulla a che fare con il comune senso di ribellione o con la tradizionale ecologia che tutti ormai conosciamo.
Ecologia umana è una formula coniata da Papa Benedetto XVI. Qui la parola giusta che intende l’autore del libro, un sacerdote, è “egologia”, vale a dire “cura dell’io”, la sua pulizia, la sua estetica, l’io dei singoli, di ognuno di noi esseri umani.
In un tempo come quello che stiamo vivendo, nel quale l’umanità si vanta della sua potenza di conoscenza, gli individui, anzi le persone, contano men che zero.
Soltanto foglie al vento che non bada al singolo e colpisce la massa nel suo insieme. Ognuno di noi sembra essere considerato men che niente.
A questi esseri impauriti e sperduti, il prete Giulio Dellavite propone di “ri-bellarsi”, cioè di “ritornare al bello” per far fronte alla frantumazione della coscienza, quella coscienza che, nonostante tutto, ognuno di noi sa di avere. Una sfida individuale a rovesciare questa condizione. L’autore scrive:
“Questa sfida prende nel libro le sembianze di una donna in viaggio. Ma verso dove? Verso cosa? O forse verso chi? Lo scopriremo insieme. Intanto vi anticipo una cosa: fidarsi è bene, ribellarsi è meglio!”.
Non si tratta quindi, secondo l’etimologia classica, “fare guerra”, bensì “tornare alla bellezza”, “tornare ad essere belli, rendendo bello ciò che ci circonda, sopratutto il nostro “io”, egologia, appunto. In copertina appare l’immagine di un treno trainato da una locomotiva a vapore il cui fumo sembra diventare polvere di stelle che si spande in un cielo verde-azzurro.
Un libro questo davvero strano, sembra capirsi soltanto da queste poche impressioni che ho detto. Nella sua introduzione l’autore dice che “la lettura richiede un pò più di calma, attenzione, pazienza, fatica”. Arriva, addirittura, a dire che per il lettore sarà come prendere parte ad un tipo di lettura, anzi un viaggio, visto che tutta la vicenda si svolge su di un treno, alla maniera di come un tempo la Chiesa chiamava “esercizi spirituali, quel tipo di incontri che portavano a guardare al lato più profondo di sè, quello meno conosciuto.
Quindi più che un romanzo saggio, questo nuovo libro è un saggio romanzato, in un modo surreale. Una donna, un’insegnante, è la protagonista. Messaggio importante lanciato da un prete al suo personaggio che solo alla fine il lettore conoscerà con il suo nome: “Veintiuna”. Piuttosto misterioso davvero! Lei stessa ammette di avere un significato non solo misterico ma anche femminile. Dice di essere stata variamente chiamata:
“Anima, Via, Vitalità, Interiorità, Coscienza, Personalità, Vocazione, Spiritualità, Vocazione, Energia, Ispirazione, Essenza, addirittura Chakra, alla maniera orientale, oppure Psyche, all’antica maniera greca.”
Una sorta di Gulliver alla scoperta del mondo, cioè di se stessa, di sè e degli altri. Su quel treno salgono di volta in volta personaggi che sono membra del corpo umano e insieme membri dell’umanità.
La famiglia Testa con la madre Bocca e i tre figli Vista, Udito, Naso. Sale poi la PANCIA che è un acronimo di Progetto Atletico New-Educational Calcio Incontro & Agonismo. Con la loro complessità energetica si presentano come una squadra di calcio con i suoi undici giocatori: Cuore, il capitano, i due Polmoni, i due Reni, lo Stomaco, Milza, Fegato, Intestino, Ombelico e Pudenda.
In ogni momento di lettura sono rimasto stupefatto dalla originalità delle situazioni che l’autore riesce a trasmettere al lettore. Vi assicuro che raramente ho letto un libro in cui l’autore sia riuscito a dimostrare la sua erudizione legandola a immagini tanto fantasmagoriche quanto evanescenti, ma con una precisione scientifica e letteraria tanto significativa quanto armonica.
I vari organi coinvolti in un ragionamento ecologicamente ed anatomicamente umano in viaggio, è il caso di dire, con una direzione giusta verso la massima coesione sociale e l’armonia interiore. Il tutto non funziona soltanto in maniera psicoanalitica, ma in una formula che il sacerdote don Giulio dimostra, ovviamente, di conoscere bene attraverso il suo libro mastro che è il Vangelo.
Qualcuno ce l’ha in tasca su quel treno. Quando gli si chiede che libro è, la persona risponde: “E’ un Vangelo. Un libro che ha due primati: è il più venduto e il meno letto”. Dopo l’introduzione, il viaggio inizia con l’ecologia della Testa, poi quella della Pancia, delle Mani e del Piede per concludersi nella Ecologia della “rete”. Mi piace questa immagine con la quale chiudo questo post, invitandovi a leggere questo straordinario libro. Il testo mi serve perchè è una metafora molto significativa:
“Oggi va tanto di moda “fare rete”, se ne sente l’esigenza ovunque e talvolta diventa un’espressione inflazionata, ma per scomprenderne fino in fondo il senso andrebbe ricordata una novella di Johannes Jørgensen. Un piccolo ragno salì su un albero e da lì si calò e raggiunse una siepe dove iniziò a tessere una tela il cui lembo superiore era retto da un filo lucente.. Realizzò un’opera bella e grande, un lavoro raffinato, a tal punto da perdersi nell’azzurro del cielo. Nel tempo il ragnetto cresceva e la ragnatela si faceva sempre più articolata e invidiata. Una mattina il piccolo ragno si svegliò di cattivo umore e inziò a controllare il suo capolavoro, tutto sembrava perfetto, finchè non si accorse che dalla parte superiore della rete partiva un filo teso veso l’ignoto, di cui non ricordava la funzione e nemmeno l’esistenza. Conosceva gli angoli di snodo di tutta la tessitura, il livello di tenuta, il punto di forza al quale si ancoravano i fili; ma quel filo? “Dove andrà a finire? Sembra inutile!”. Lo tranciò e tutto gli rovinò addosso. Aveva dimenticato che, giorni prima, in un mattino soleggiato, proprio da quel fili aveva inziato a tessere la sua tela. Adesso si trovava sulla foglie della siete, avvolto nella sua stessa tela divenuta ormai un umido cencio. In un solo istante quel magnifico lavoro era andato distrutto e soltanto perchè lui non aveva capito l’importanza di quel filo dall’alto.”

Viaggio nel cervello, dopo 12 mesi di pandemia …
 Forbes
ForbesC’è una parte del corpo umano che è la più importante di tutte: la testa. Dentro questa scatola chiamata cranio c’è il cervello. Sono iscritto da diverso tempo ad una newsletter in lingua inglese chiamata “Inside your Head” sul sito “Elemental”. Ogni settimana ricevo una comunicazione che per tema ha il cervello. L’ultimo trattato riguarda un rapido viaggio in questo straordinario organo dopo dodici mesi di pandemia.
Scrivo questo post condividendo le notizie e le riflessioni di chi l’ha scritto con chi mi legge, ma sopratutto con me stesso. (vedi link) Chi scrive, Dana G Smith, è una scienziata del cervello e dice che la pandemia ci ha cambiato, in particolar modo ha cambiato il nostro cervello. Il bilancio di un anno di solitudine, stress, paura, trauma e perdita di milioni di vite hanno avuto un forte impatto sulla struttura e sulla funzione del cervello.
Si sono manifestati chiari sintomi di depressione e ansia durante lo scorso anno. Si tratta di un aumento abbastanza considerevole di tensione.
La domanda fondamentale è se si sono verificati in questi mesi sintomi psichiatrici che corrispondono a cambiamenti fisiologici reali tra i nostri 86 miliardi di neuroni. Diversi psicologi e neuroscienziati a questa domanda hanno confermato che sì, gli ultimi 12 mesi hanno cambiato il nostro cervello e il colpevole è lo stress cronico estremo e continuato.
Bisogna dire subito che sia lo stress che la risposta del nostro corpo ad esso non sono fattori intrinsecamente negativi. In effetti, una risposta acuta allo stress è una buona cosa, ci aiuta a sopravvivere. Lo stress cronico, però, è una bestia diversa, che può portare a cambiamenti nel cervello. Si apre così la porta a possibili disturbi psichiatrici causando depressione, ansia, disturbo da stress post-traumatico e disturbi da uso di sostanze.
Sotto stress cronico, le ghiandole surrenali non rilasciano più un impulso di cortisolo nel flusso sanguigno; è un flusso continuo di questo ormone. Parte di quel cortisolo passa attraverso la barriera emato-encefalica e attiva i recettori dei glucocorticoidi (altri ormoni) sulle cellule cerebrali. L’attivazione a lungo termine di questi recettori può causare cambiamenti profondi e duraturi nella struttura e nella funzione delle cellule cerebrali.
Un cambiamento che si verifica è mediato dal sistema immunitario del cervello, una famiglia di cellule, chiamate microglia, che si trovano in tutto il cervello. In circostanze normali, uno dei ruoli della microglia è quello di sminuzzare e eliminare le sinapsi danneggiate o inutilizzate, le connessioni tra i neuroni che consentono alle cellule cerebrali di comunicare. A piccole dosi, questa è una parte normale del mantenimento di un cervello sano.
Durante i periodi di forte stress, tuttavia, vengono prodotte molte più microglia, che vengono attivate dal cortisolo che circola nel cervello. La microglia in eccesso e iperattivata può quindi iniziare a eliminare le sinapsi, cioè le connessioni, che sono ancora necessarie e funzionali.
“Di conseguenza, si perde l’azione complessa dei neuroni e, se è abbastanza pronunciata, possono seguire una serie di esiti negativi”, afferma James Herman, PhD, professore di psichiatria e neuroscienze comportamentali presso l’Università di Cincinnati. “Può alterare la memoria, può compromettere l’elaborazione cognitiva e può persino compromettere la capacità del cervello di controllare le risposte allo stress. Quindi, in molti modi, questi tipi di risposte cellulari possono addirittura peggiorare lo stress, quasi come in un positivo ciclo di feedback.”
Tre regioni del cervello che sembrano essere particolarmente colpite da livelli di cortisolo cronicamente alti e dalla conseguente eliminazione delle sinapsi sono l’amigdala, che innesca risposte di paura e ansia; l’ippocampo, un’area importante per l’apprendimento e la memoria, nonché per la regolazione dell’umore e delle emozioni; e la corteccia prefrontale, il centro esecutivo del cervello coinvolto in cose come la pianificazione futura e il controllo degli impulsi.
La potatura delle sinapsi che si verifica durante i periodi di stress cronico può interrompere l’equilibrio tra queste regioni del cervello. Nei disturbi d’ansia, e in particolare nel disturbo da stress post-traumatico, la corteccia prefrontale e l’amigdala diventano meno connesse e c’è un’attività maggiore del normale nell’amigdala e minore nella corteccia prefrontale. Di conseguenza, non c’è nulla che trattiene l’amigdala dal suonare costantemente l’allarme, quindi ti senti più stressato per più cose.
Con la depressione, la corteccia prefrontale e l’ippocampo sono i più colpiti ed entrambi vedono una perdita di volume e funzione. Ciò accade perché l’attivazione dei recettori glucocorticoidi nell’area impedisce una nuova crescita nella regione. Di conseguenza, le persone con depressione hanno ippocampi significativamente più piccoli rispetto alle persone non depresse, il che si ritiene contribuisca a una maggiore difficoltà nella regolazione del loro umore.
“Quello che succede con lo stress è che si perde la struttura sinaptica nella corteccia prefrontale, e si pensa che effettivamente rimuove i freni sull’amigdala, e permette all’amigdala di fare un superlavoro ”, dice Herman. “All’amigdala viene detto di crescere, mentre all’ippocampo e alla corteccia prefrontale è stato detto di ritrarsi. È molto interessante per la biologia il modo in cui si sposta l’enfasi del cervello verso una modalità che è più associata alla paura e agli affetti negativi”.
Ho cercato di riportare quanto più possibile correttamente il pensiero degli esperti consultati dall’autrice della ricerca. Quel che mi sento di dire è che ogni momento vissuto, non solo da noi esseri umani, è un momento avvolto nel mistero. Tutto nasce, cresce e muore per poi rinascere. Quando mi sorprendo a sentire il battito di quel misterioso muscolo chiamato “cuore", mi prende sempre un senso di stupore misto a meraviglia, avvolta dal timore fondato che possa in qualsiasi momento o ragione fermarsi.
Inutile dire che mi pongo quelle ragionevoli domande che anche voi che mi stare leggendo vi ponete. Chi, cosa, dove, quando e perché funziona in quel modo, quel muscolo. Strana cosa è poi che questi interrogativi nascono da un chilo e mezzo di viscida materia grigia in quella “scatola” alla quale ho accennato all’inizio.
Una buona e logica conseguenza per provocare un aumento di ansia che va ad aggiungersi a quella causata dalla pandemia. Mi arriva a questo punto un messaggio mentale che non posso ignorare e mi dice che tutto è causato dall’ansia di vivere. Perchè, non dimentichiamolo, vivere genere ansia. La pandemia non è altro che una delle tante figlie della vita fatta di ansia …
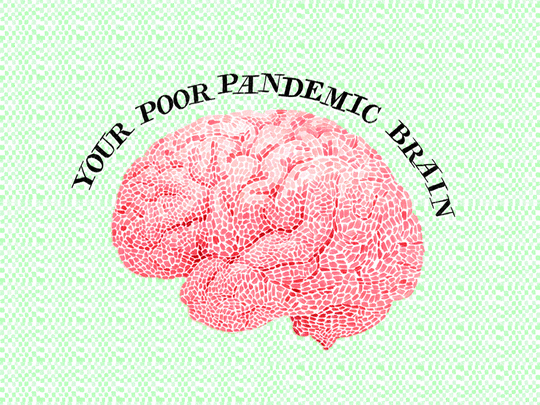 Il nostro povero cervello pandemico —
Elemental.medium.com
Il nostro povero cervello pandemico —
Elemental.medium.com

September 6, 2020
L'algoritmo di GoodReads ...
August 5, 2020
La nostra Chiesa preoccupa ...

Ma deve essere la Chiesa a cambiare o chi ha deciso di credere? Se si studia la storia della chiesa, di tutte le chiese e le religioni, si capisce come sia le une che le altre hanno sempre operato adattandosi ai tempi. A questi si sono dovuti adattare i fedeli e così si va vanti da sempre. La fede nel tempo fa sia le chiese che le religioni e la ruota continua a girare aiutando gli uomini a trovare un punto di riferimento e di aiuto nella fatica quotidiana del vivere.
Prendiamo il caso dell’arrivo di questo nemico oscuro ed invisibile chiamato Covid 19. In pochi mesi ha cambiato il nostro modo non solo di vivere ma anche, in questo caso, di pregare. “La Chiesa deve cambiare” dice il cardinale Robert Sarah, come scrive Fausto Carioti nella sua risposta alla mia domanda se pregare in una chiesa che diventa moschea continua ad essere la stessa cosa sia per chi è cristiano che per chi è musulmano. E se le “cose” devono cambiare, non saranno soltanto le “cose” cristiane a doverlo fare. Non vi pare? Insomma, ci sono tutte le ragioni per essere confusi e per decidere a … Chi credere …

La perduta arte di scrivere lettere ...

Tra le tante "arti" che sembrano essere destinate a scomparire con l'evoluzione dei tempi e della tecnologia, quella di scrivere lettere è la più diffusa se non la più amata. Eppure le lettere scritte a mano, di proprio pugno continuano a suscitare tanto fascino nell'epoca del trionfo di Internet, della posta elettronica e della messaggistica digitale. Leggere le lettere scritte a mano, per ricostruire i retroscena della vita di ogni essere umano, può essere considerata una forma di voyeurismo intellettuale, oppure anche il modo migliore per coglierne la vita personale e interiore pur senza violarne l'intimità.
Per millenni le lettere hanno plasmato la storia e l'esistenza degli individui: la digitalizzazione della comunicazione e l'avvento delle e-mail hanno cancellato la vitalità e l'autenticità di un semplice foglio scritto a mano, con una penna/pennino bagnati in un calamaio pieno di nero inchiostro, oppure vergato da una più moderna penna biro, e poi infilato in una busta affrancata.
Non intendo qui di certo lanciare una crociata contro il progresso tecnologico-informatico. Non rispetterei le mie origini, erede e figlio di una famiglia di tipografi stampatori post gutenberghiani, ed anche genitore di un figlio erede, quotidianamente collegato ad una realtà di lavoro che della connectografia ha fatto il suo ambiente di lavoro.
Desidero, piuttosto, in questo mio "amarcord" postale, riaffermare "il romanticismo della posta", in epoche in cui gli scambi epistolari fornivano "il tramite silenzioso di ciò che era importante e accessorio", "descrivevano le gioie e le sofferenze più intense dell'amore". Così Simon Garfield, in un suo libro su questo argomento. Egli prefigura un mondo senza lettere e francobolli, e al tempo stesso celebra un aspetto centrale del nostro passato, una modalità di scambio basata sulla riflessione e il rispetto.
Storia, aneddotica e curiosità si intrecciano in un racconto venato di erudizione e ironia, dalle tavolette anonime della Britannia romana fino ai nostri giorni: i capolavori di Cicerone e Seneca, le passioni che infuocavano Anna Bolena e Napoleone, l'anonima vita quotidiana di Jane Austen, l'incontenibile esuberanza epistolare di Madame de Sévigné.
Una celebrazione piuttosto grande, sia nel tempo che nello spazio. Per quanto mi riguarda anche io posso dire di averne occupato parecchio sia dell'uno che dell'altro. I ricordi possono avere inizio, guarda caso, dalle "lettere", non quelle di cui stiamo parlando in termini di corrispondenza, ma in senso di lettere dell'alfabeto, quei caratteri mobili che caratterizzavano la stampa fino a qualche anno fa. Non dimentico mai di avere imparato a leggere e scrivere mettendo in fila quei caratteri sul compositore aiutato da mio padre. Caratteri di piombo e di legno che davano vita alla "forma" che poi facevano poi nascere la "pagina" stampata.
Ma qui si parla delle "lettere" sul foglio scritto a mano, estensioni fisiche e mentali, sostituite oggi dalle lettere/caratteri sulla tastiera del pc o del cellulare, diventati estensioni del nostro corpo. Sono ancora ripieni di una sterminata corrispondenza cartacea i cassetti delle mie diverse librerie che raccolgono le tracce di un tempo che ritrovo su questi fogli. Non mi piace aprirli questi cassetti, sfilare quelle buste, aprire e leggere quei fogli, interpretare quelle scritture, mettere in moto la macchina dei ricordi, ritrovare un tempo irrimediabilmente perduto.
Ricordo ancora oggi la voce del postino, quando arrivava alle prime ore del mattino, in quel grande cortile al numero 14 di Via Fabricatore, nella città di Sarno. Si chiamava Alfredo, la sua voce risuonava sul vasto piazzale con il nome del destinatario e sapevi che c'era posta per te: Gallo, Abenante, Squitieri, Sirica, Cristiano ... Sapevi chi aveva ricevuto una lettera quel giorno.
C'è stato un tempo della mia fanciullezza, quel periodo così evanescente della vita umana, compreso più o meno fra il 6° e l'11° anno, e quindi intermedio tra l'infanzia e l'adolescenza, caratterizzato sul piano dell'evoluzione psicologica, durante il quale si formano ricordi che presto svaniscono ma che poi, stranamente, ricompaiono quando invecchi.
Fu in quegli anni che, dopo di avere imparato a leggere e scrivere le "lettere" della tipografia, cominciai a scrivere vere e proprie lettere di mio pugno. In quello stesso portone, allo stesso numero di quella strada c'era anche un'edicola in embrione, quella dei mitici Ciro e Angelina ('Ngiulina & Giritiello). Era iniziata l'era dei fumetti, dei giornali confidenziali e proibiti.
Era cominciata l'epoca della corrispondenza. Potevi trovare su quella stampa indirizzi di tutti i tipi ai quali scrivere per iniziare qualsiasi forma di corrispondenza. Era il tempo dei "Grand Hotel", delle "Confidenze", "Le Ore", "Crimen", "Sogno", "Bolero", "Domenica del Corriere", "Tribuna Illustrata" ...
Abbondavano le lettere con le richieste di corrispondenza. C'erano organizzazioni "Pen Friend" che fornivano indirizzi per ogni tipo di esigenza comunicativa. Le occasioni per scrivere lettere di certo non mancavano. Anche io ne scrivevo molte invece di studiare. Un modo ed una ragione per cercare di evadere da una realtà che poteva essere davvero soffocante.
Giorni fa, ho incontrato il figlio di Alfredo, il portalettere di cui ho detto innanzi. Anche lui postino, che prese il posto del padre. Ci siamo incontrati, guarda caso davanti al microscopico ufficio postale della frazione di Episcopio di Poste Italiane a Sarno. Sotto il sole infuocato di luglio, in piena pandemia, abbiamo fatto la fila per oltre un'ora per ritirare una raccomandata. Non vi dico quello che ci siamo detti a proposito di Poste Italiane, del tempo perduto, di come funzionava una volta il servizio postale.
Abbiamo constatato che si stava meglio quando si stava peggio. Per protestare volevo scrivere una lettera alla direzione di Poste Italiane. L'ho scritta a mano e messa in una busta. Ho vagato per tutto il paese in cerca di un tabaccaio per un francobollo. Non l'ho trovato. Non esistono più i francobolli. Devi fare la fila di oltre un'ora e ritornare all'ufficio postale. Ho rinunciato e ho deciso di inviare un bel "vaffa" a Poste Italiane e a chi so io ...

August 4, 2020
La biblioteca vivente
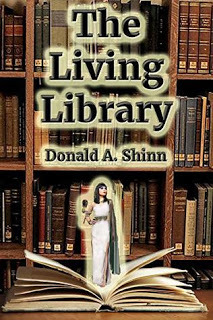 Il libro
Il libro"Diana pensava di trascorrere una settimana in una capanna sulla riva del Jersey, le sembrava che fosse un'idea divertente. Lontana da tutto e tutti, a poca distanza dall'oceano, in una natura selvaggia ed incontaminata. Isolata, senza cellulare o connessione con il mondo, sola con i suoi genitori e i loro amici, in quelle piccole cabine caravan che facevano da alloggio. Non c'era aria condizionata nonostante il caldo soffocante e l'umidità.
Alla disperata ricerca di sollievo, Diana scova un posto più fresco e si imbatte in una cabina trasformata in una vecchia biblioteca con un condizionatore funzionante. Vi entra e si nasconde sotto un tavolo, quindi si sdraia per fare un pisolino. Quando si sveglia si ritrova chiusa in biblioteca e dai loro libri è emerso uno strano cast di personaggi.
Cleopatra, Re Artù, Don Chisciotte e Romeo hanno assunto la forma umana e si offrono di aiutarla. È impazzita? Don Chisciotte estrae il Dr. Freud dalla sua biografia per assicurarle che è sana, il che non la rassicura affatto. I personaggi fanno ciò che possono per aiutare Diana a fuggire dalla biblioteca e lungo il modo in cui impara le loro storie e impara anche di più su se stessa."Questa la breve sintesi del libro la cui copertina è qui riprodotta. In effetti ogni qualvolta entro in GoodReads provo la stessa sensazione di Diana.

L'ambizione dell'aforisma: da Confucio a Twitter
 L'aforisma-orizzonte a Maiori (foto Gallo)
L'aforisma-orizzonte a Maiori (foto Gallo)Questo post riguarda un libro che esplora circa 2500 anni di letteratura in meno di 250 pagine per stabilire una teoria dell’aforisma. Da Confucio a Eraclito, dal Vangelo (apocrifo) di Tommaso a Erasmo, Bacone, Pascal, Nietzsche sino ad arrivare, niente di meno che, a Twitter, a Zengo ( in giapponese “illuminazione progressiva”) e Sutra (i discorsi del Buddha).
Andrew Hui ci dice che non che ha intenzione di scrivere una storia sull’aforisma, cosa che lui ritiene lunga e noiosa. Dice che vuole elaborare invece una teoria. Quale teoria?
Verificare se gli aforismi sono “prima”, “contro” e “dopo” la filosofia. Con questo intende che a volte gli aforismi sono cronologicamente precedenti a una filosofia più sistematica; a volte sono cronologicamente successivi a una filosofia più sistematica; ma, ovunque siano posizionati in ordine cronologico, si trovano sempre in qualche relazione con una filosofia più sistematica.
La sua teoria rivela che l’aforisma spesso è un antenato, a volte un alleato e, talvolta, un antagonista per una filosofia sistematica. Le lingue citate in questo originale ed importante studio includono il cinese, il greco, il latino, il francese, il tedesco, il copto, il giapponese, il sanscrito e il pali. Un intento che rivela un’ambizione di scrittura davvero impressionante. Alla fine del libro c’è anche un breve saggio bibliografico con il quale l’autore dà ragione del suo lavoro. Segue poi una esaustiva bibliografia.
Ho letto il libro in versione cartacea, dopo di avere letto alcuni estratti in versione digitale. Mi sono reso conto che l’argomento mi interessava molto, (le ragioni vanno ritrovate nella stesura di questo post). Per questo motivo mi sono procurato la versione cartacea.
Un argomento del genere, che spazia in tremila anni di storia della comunicazione, non può che essere studiato in maniera “fisica”, oltre che “mentale”, sulle pagine a stampa di un libro tradizionale. La ragione per la quale, (lo faccio raramente), ho riempito le pagine del volume di numerosi segni, sottolineature e annotazioni.
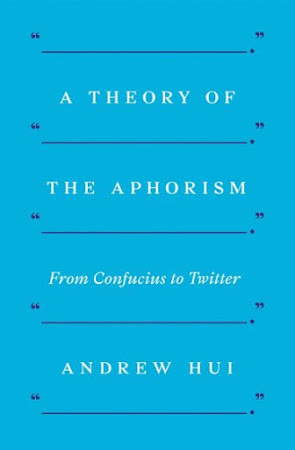 Il libro
Il libroMa che cos’è un “aforisma”? La radice della parola è la stessa di “orizzonte”. Il verbo greco “horizo” significa “delimitare”. Orizzonte è in origine il cerchio che si apre allo sguardo. Francesco da Buti, commentatore trecentesco di Dante, ci offre una definizione precisa:
“L’orizzonte è circulo terminativo de la nostra vista”.
Non meno preciso è il Tasso nel “Mondo creato”:
“Quel che terminò l’umana vista / ne i tenebrosi e lucidi confini / orizonte fu detto”.
Ne ho scritto in una breve recensione dei due strepitosi volumi dedicati agli aforismi italiani nelle edizioni Mondadori dei Meridiani. Ma la storia degli aforismi che scrive Andrew Lui, giovane e brillante studioso di origini orientali, professore alla Standford University, è per un altro verso tutta un’altra ambiziosa storia.
Hui lo definisce come “un breve detto che richiede interpretazione” e lo distingue dai generi correlati come proverbi, massime ed epigrammi. Mentre i proverbi e i detti sono “vicini all’estremo banale” e “facili da capire” (ad es. “L’assenza rende il cuore più affezionato”), le massime e gli epigrammi sono “da qualche parte nel mezzo”, contenenti “un’acuta sintesi” (ad es. “Una colpa quasi universale degli innamorati è non capire quando si è più amati”).
Gli aforismi, al contrario, hanno un “fine filosofico o teologico” e “più nascosto”. I migliori aforismi ammettono un’infinità di interpretazioni, un’inesauribilità ermeneutica”. Quindi, ciò che viene detto “richiede interpretazione” che deve essere compresa secondo precise linee tenendo presente che l’aforisma offre la massima condensazione e promette un infinito di significato (“infinito” è la parola preferita di questo libro). Ma quanto più breve è l’aforisma, tanto più tempo ci si impiega a capirlo.
Nel capitolo 1, “Confucio: il maestro silenzioso” si esaminano gli analisti, gli aneddoti e le conversazioni tra il maestro e lo studente risalenti al V secolo a.C. al I secolo d.C. Viene discussa la tradizione di raccolta, interpretazione e commento che cresce attorno a questi frammenti, così come la graduale evoluzione della raccolta in un “insieme ideologico” sponsorizzato dallo stato. Come dovrebbero essere letti tali frammenti di conversazioni? Zhu Xi (1130–1200) offre consigli: “leggi e rileggi” e “immergiti nelle parole”.
Nel capitolo 2 “Eraclito: cosa è nascosto”, Hui sostiene che il “linguaggio laconico di Eraclito è tratto dalle oscurità degli oracoli”. Questi aforismi sono detti filosofici perché credono nella verità derivata dall’intelletto umano piuttosto che dalla rivelazione divina. Sono quindi “dopo e contro” Omero ed Esiodo, ma “prima e contro” i “sistemi di Platone e Aristotele”. Dopo aver discusso dell’antica divinazione, Apollo, degli oracoli e di Delfi, Hui difende gli oscuri aforismi di Eraclito contro l’argomentazione più sistematica della filosofia platonica. Egli dice che una volta che si inizia a interpretare i frammenti oscuri, si è già sulla buona strada per la saggezza.
Nel capitolo 3 “Il Vangelo di Tommaso: ciò che è rivelato” l’autore segue il modello ermeneutico del capitolo precedente: mentre per “Eraclito, la verità si trova nel logos”, per “Il Vangelo di Tommaso, la verità si trova in se stessi, poiché Gesù dimora in essa“. Hui discute della scoperta di Nag Hammadi, della relazione del testo con i tradizionali quattro vangeli e del messaggio di Thomas, che è uno di “indipendenza radicale”. Egli sostiene che “i lettori devono decifrare per se stessi il significato del testo piuttosto che fare affidamento su qualsiasi dottrina settaria … “. Questo spiega perché Thomas non è mai entrato a far parte del canone ortodosso.
Il capitolo 4 “Erasmo e Bacone: l’antichità e la nuova scienza”. Il racconto delle rivoluzioni intellettuali del XVI-XVII secolo come spiegazione e reazioni all’aforisma. Gli argomenti includono la diffusione dei libri di Erasmo con i suoi “Adages”, le immagini che lui usa delle “gemme”, dei “semi di senape” in forma di pensieri, le “scatole” di Sileno, tutto serve come ad esempio e modo per “guardare nell’ano di un cane”. Grande fatica comunicare in questo modo per collezionare “troppo da sapere”. Si crea così quella crisi che Bacone manifesterà con i suoi aforismi: forniscono “un orizzonte aperto di indagini piuttosto che un sistema chiuso di conoscenza accumulata”.
Il capitolo 5 “Pascal: I Frammenti dell’Infinito” Hui sostiene che i “Pensieri” di “Pascal sono un ripudio della filosofia cartesiana. Poiché questi scritti sono stati trovati in fasci disorganizzati quando è morto, il problema è come organizzare questi “frammenti irrimediabilmente disordinati ed enigmatici”. Diverse edizioni hanno tentato di mettere ordine in questo disordine dove l’ordine non è mai stato voluto. Piuttosto, l’enigmatica instabilità del testo genera molteplicità di pensiero. Ricordando il capitolo di Thomas, “la poetica dell’aforisma di Pascal”, secondo Hui, consiste nella “scrupolosa decifrazione dei segni di Dio”.
Il capitolo 6 “Nietzsche: I Frammenti del Non-finito” considera la straordinaria svolta di Nietzsche nella scrittura di aforismi, a partire dai 638 aforismi di “Umano, troppo umano” (1878), che “segnò una rottura con i suoi primi studi filologici”. Hui esplora diverse ragioni per questa svolta aforistica, dalla debilitante salute, a uno stile di vita peripatetico, alla macchina da scrivere. Il valore degli aforismi per Nietzsche consiste nel fatto che “sono veloci da leggere”. Invece di debilitare la “capacità di pensiero originale” dei suoi lettori con troppe letture, Nietzsche vuole una forma di interpretazione che sia “interna, silenziosa e vissuta”.
Nell’epilogo, non a caso, Hui sceglie l’idea del cerchio per concludere il suo viaggio negli aforismi. Si rivolge brevemente prima a Twitter e dice: “Secondo la mia teoria dell’aforisma, i tweet vengono prima, dopo e contro ogni forma di comunicazione di lungo respiro”. Ma poi, con una svolta sorprendente, chiude il suo libro con una visione autobiografica. In una sezione intitolata: “Esaurimento-Exhaustion”, Hui discute dei due aforismi ai quali si è sempre rifatto scrivendo il libro. Il primo è di Nietzsche:
“A che serve un libro che non riesce a portarci nemmeno oltre tutti i libri?”
Ci sono troppi libri, molto più di quanto riusciremo mai leggere. Questo crea “frustrazione” e “disperazione” riguardo a “tutti gli oceani di testi e montagne di libri che non avrò mai tempo di leggere”.
Qual è la risposta? Offre la meditazione Zen come “contrasto con la miriade di interpretazioni discorsive che abbiamo incontrato nelle pagine precedenti”. Tale pratica è “in fin dei conti non-ermeneutica, ma solo un sistema per svuotare la mente”. È come se, per Hui, il fascino dell’aforisma fosse questa possibilità di andare “oltre tutti i libri”, come se si potesse scoprire la verità, e quindi interrompere la ricerca libresca.
“Una volta attraversato il fiume, la proverbiale zattera, messa insieme dal traballante legname di aforismi, non è più necessario. Resta il silenzio”.
Questa seria ma calda conclusione del libro, così come il capitolo finale di Nietzsche, rivela la grande attenzione di Hui per la scrittura di aforismi nel grande calderone del contesto della moderna comunicazione mediatica. Sin dall’inizio del resto, sono state queste le dichiarate intenzioni del libro: trovare una risposta alla domanda: “Può l’aforisma risolvere il problema della lettura e dare un senso ad essa?” Quando Hui sostiene che l’aforisma viene “prima”, “dopo” e “contro” la filosofia, “alleata” e allo stesso tempo “antagonista” sta nel vero.
L’aforisma è una risposta antica, seria e meditata alla babele logorroica mediatica nella quale la moderna tecnologia ci sta lentamente e fatalmente spingendo a vivere. Se il destino della scrittura e della lettura consiste nella ricerca del senso e del significato della comunicazione umana, l’aforisma può aiutarci a fare piazza pulita di tutte quelle scorie e trivia di cui è capace di creare la mente degli uomini. Possiamo benissimo concludere parafrasando il pensiero di Nietzsche dicendo:
“A che serve una parola se non ci conduce oltre tutte le altre parole?”.
 L'aforisma-orizzonte a Stonehenge (foto Gallo)
L'aforisma-orizzonte a Stonehenge (foto Gallo)
August 1, 2020
Distanziamento fisico e mentale
 Una versione "distanziata" del quadro “Giochi di bambini” (1560) di Pieter Bruegel il Vecchio.
Una versione "distanziata" del quadro “Giochi di bambini” (1560) di Pieter Bruegel il Vecchio. Il quadro originale lo si può vedere qui here
La pandemia di COVID-19 non ha cambiato soltanto il comportamento umano, ma ha introdotto una serie di nuove parole e frasi nel lessico internazionale. La più diffusa non è una frase, visto che non ha nemmeno un verbo, ma contiene un’idea abbastanza forte che, se interpretata letteralmente, significa separare le persone. Se praticata all’estremo, prescrive l’isolamento sociale, qualcosa che è molto dannoso per gli esseri umani.
Un termine più appropriato e accurato sarebbe “distanza fisica” che si riferisce alla distanza che le persone devono mantenere l’una dall’altra per ridurre il rischio di passaggio o infezione da coronavirus altamente contagioso. Come hanno scoperto milioni di persone in tutto il mondo, si può essere perfettamente sociali in piedi a uno/due metri di distanza, o grazie a Internet, essere a migliaia di miglia di distanza.
Ma l’aspetto più insidioso di questa frase è che il distanziamento oltre che fisico, può essere anche mentale con conseguenze sociali, politiche, morali, religiose, razziali. Come dire che c’è della storia dietro questa espressione che merita di essere conosciuta.
Nel diciannovesimo secolo, la “distanza sociale” era un educato ed ipocrita eufemismo usato dagli inglesi per parlare di classe e dagli americani per parlare di razza. Fu poi formalmente adottato negli anni ’20 dai sociologi come un termine per facilitare la codificazione quantitativa che veniva introdotta nello studio nascente delle relazioni razziali.
Nella seconda metà del XX secolo, la psichiatria, l’antropologia e la zoologia questo modo di dire venne adattato per vari scopi. E ‘stato utilizzato negli anni ’90, durante la crisi dell’AIDS, negli Stati Uniti per analizzare cosa successe alla comunità gay di fronte a paure dirette di contagio. Fu nel 2004, in una pubblicazione scientifica di un articolo sul controllo del focolaio di SARS, che il termine “distanza sociale” fu utilizzato per la prima volta dalla comunità medica.
Il primo uso della frase appare nella traduzione del 1831 delle “Memorie” della sua amicizia di Louis Antoine Fauvelet de Bourrienne con Napoleone Bonaparte. Bourrienne descrive come quando Napoleone entrò, nella stanza dopo una campagna militare di successo, e non riuscì più a rivolgersi a Napoleone in modo informale:
“La sua posizione poneva una distanza sociale troppo grande tra lui e me per non farmi sentire la necessità di modellare il mio comportamento di conseguenza. “
Questo uso, riferito al rango sociale degli individui e quindi all’etichetta richiesta tra le persone, fu comune nella cultura anglofona per tutto il diciannovesimo secolo, specialmente per quanto riguarda l’idea di classe sociale. Questo concetto di disuguaglianza si inserì nel tessuto della cultura nel 19 ° secolo in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, dove la schiavitù era una parte radicata della società.
Negli Stati Uniti la distanza sociale fu un modo usato dai bianchi per descrivere la continuazione delle pratiche di supremazia bianca dopo l’abolizione della schiavitù. Un addolcimento del termine nel più grande ed importante contesto legato alla schiavitù e poi in seguito della violenza anti-nera. L’idea di “distanza sociale” trovò la sua prima applicazione empirica nella codificazione e quantificazione di come le persone, appartenenti a una razza, si sentivano su quelle di un’altra.
Nel processo si distanziamento/avvicinamento è stato anche inventato ed introdotto un cosi detto “indicatore quantitativo della distanza sociale” dando al sistema anche una scala di valori. La sua misura statistica avrebbe continuato ad avere un profondo impatto sulla sociologia americana, diventando uno dei più usati strumenti storici psicologici sociali nella storia intellettuale americana.
Si chiama “Social Distance Scale”-(La Scala di Bogardus) ed è ancora in uso oggi. Identifica la “distanza” con il pregiudizio, che calcola sulla base di un gruppo di accordi o divergenze di determinati intervistati con un certo numero di dichiarazioni. Queste hanno lo scopo di valutare la volontà di ciascun membro di quel particolare gruppo sociale di “condividere determinate situazioni” con i membri di altri gruppi sociali.
La “Social Distance Scale”, pubblicata nel 1925, elenca sette gradi di intimità come rappresentativi della gamma di possibili relazioni umane, per misurare il livello di razzismo di un individuo: parentela, matrimonio, amici personali, comunità di lavoro, cittadinanza. Alla fine del XX secolo, la scala della distanza sociale è stata applicata per mappare praticamente qualsiasi contesto da esperti di salute mentale, sociologi, antropologi, economisti, forze dell’ordine, zoologi e infine epidemiologi.
L’autrice dello studio citato Lily Scherlis indica la crisi dell’AIDS nel 1990 come una svolta decisiva per la frase “allontanamento sociale”. Scrive: “Questo momento diventa una cerniera tra l’eredità sociologica del termine e la sua reincarnazione come protocollo di sanità pubblica. “La distanza sociale”, per quanto riguardava la crisi dell’AIDS, veniva spesso utilizzata per analizzare il fenomeno della stigmatizzazione, come era stato in psichiatria.
Allo stesso tempo, il concetto di “distanza” ha assunto una nuova letteralità fisica, nonché un’associazione senza precedenti con la salute pubblica. Con l’epidemia di AIDS, lo stigma palpabilmente attaccato alle (false) ansie sul contagio: un pubblico sieropositivo divenne improvvisamente diffidente nei confronti del tocco anche casuale di quelli profilati come probabilmente sieropositivi, temendo che il virus potesse saltare semplicemente dall’epidermide all’epidermide.
Improvvisamente, la distanza sociale non era solo un modo per distinguere i gradi di pregiudizio contro le popolazioni, ma anche una descrizione della distanza fisica da mantenere da altri individui per la propria protezione. Due discorsi incompatibili si scontrano qui: scienziati sociali che aspirano a colmare le lacune di animosità tra le popolazioni e coloro che cercano di aumentare lo spazio tra i corpi delle persone per paura di quale tossicità potrebbe passare tra loro.
In un’intervista con la rivista Time, Lily Scherlis discute di quanto fosse scioccata nell’apprendere la sua storia e l’impatto sulla cultura americana. Alla domanda su ciò che l’ha sorpresa di più, Scherlis ha risposto:
“Penso che la “Social Distance Scale” sia alla base del nostro modo di pensare inconsciamente attraverso questioni di identità e disuguaglianza. Sembra che le persone ovviamente si adattino perfettamente a questi gruppi che ovviamente si odiano l’un l’altro e che quell’odio è abbastanza semplice da poter essere trasformato in un numero e contato e calcolato in media in una popolazione”.
Scherlis ha ritenuto importante per le persone capire davvero la storia oscura di questa frase che viene usata così casualmente oggi:
“Penso solo che sia davvero importante ricordare con quanta lingua istituzionalizzata sanzionata dal governo è appesantita da razzismo. Quando usi il termine e vedi il termine usato, è bene tenere a mente quanto il termine sia stato usato per giustificare le élite che si sequestrano da persone praticamente emarginate o non autorizzate negli Stati Uniti per 200 anni “.
A partire da luglio 2020, il movimento Black Lives Matter ha già provocato diverse riforme. Ne farà molte altre nei prossimi mesi e anni. Grazie alla brillante ricerca di Lily Schelis, possiamo avere la conferma di quanto “razzista” sia questa “frase azione/pensiero”. Abbiamo grande bisogno di smentire l’allontanamento sociale e sostituirlo immediatamente e sostituirlo con “allontanamento fisico” o qualche altro termine più generico dovrebbe essere una di quelle riforme.
Al distanziamento fisico si accompagna sempre un distanziamento mentale inconscio e inconsapevole. Quando incontriamo per strada qualcuno che, essendo all’aperto, non necessita di indossare la fatidica mascherina, non possiamo continuare ad evitare l’avvicinamento fisico per paura di un contatto che porti infezione. Il distanziamento fisico non deve assolutamente significare distanziamento mentale. Non possiamo vivere in un contesto sociale caratterizzato da isolamento. Nessun uomo è un’isola. L’umanità è un arcipelago di relazioni e di intenzioni.

June 28, 2020
"Antonino Saro Gallio" a Pompei ...
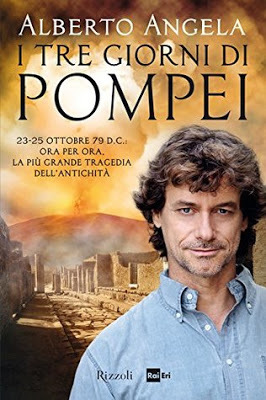 Il libro
Il libroSono trentatrè i personaggi che Alberto Angela, autore di questo libro, fa apparire nella sua narrazione sugli ultimi tre giorni di Pompei tra il 23 il 25 ottobre d. C. ora per ora, quando va in scena sicuramente la più grande tragedia dell'antichità.
Tra immaginari e reali, sono soggetti umani che hanno vissuto in prima persona gli eventi in quei tre giorni. Nel racconto vengono descritte in maniera davvero magistrale le tre giornate, lo scorrere delle ore e dei minuti nelle loro vite.
Non so se è corretto chiamare questa narrazione un libro. In effetti l'Autore, che nasce per formazione naturalista e paleontologo, sa essere anche giornalista e divulgatore scientifico. Lo fa in maniera tanto elastica quanto moderna.
Alberto Angela è anche autore e conduttore di programmi televisivi di grande successo, in una logica culturale ereditata dalla ditta e dal nome paterno, Piero, anche lui grande comunicatore sia di storia che di scienza, nel passato come nel presente e nel futuro.
In poco meno di cinquecento pagine questa narrazione può essere "vista" come in un film, un documentario, come srotolata su un papiro, letta su un manoscritto, in un romanzo, un saggio, un reportage. Alla fine si scopre che il libro è tutte queste cose insieme.
Non so quante volte sono stato a Pompei nel corso degli anni, a partire dai tempi ormai lontani della gioventù. Ogni volta da solo o in compagnia, in fuga dalla scuola, il classico "filone", l'avventura amorosa, la gita scolastica, la visita di studio, l'accompagnamento con esperto e ospite straniero. Ogni volta, la visita ha avuto la sua differenza.
Ha sempre, comunque, influito il fatto di essere vissuto a poca distanza da questi luoghi che trovano la giusta collocazione spaziale e mentale nella mappa acclusa alla fine del volume. Vi propongo di leggerla per meglio capire quanto questa lettura, a distanza di tanti anni, abbia fatto la differenza. Per quanto mi riguarda.
La "Campania Felix", la vita di una regione antica e fertile, ricca sia di storia che di cultura, che non ha mai smesso di sorprendere, testimone ancora oggi di un passato glorioso che la rende unica nel mondo. Una questione di storia e di identità.
Polibio, storico greco, individuò i suoi punti di forza: la fertilità, la bellezza, la vicinanza al mare, la possibilità di fruire di scali e di navigazione interna. Fu Plinio a definirla con un attributo ancora oggi spesso citato ed utilizzato, dall’immenso valore simbolico, destinato a grandissima fortuna: “Campania illa Felix”, appunto.
Comprendeva territori che si estendevano dalle pendici del Monte Tifata (a nord) fino a lambire l’area flegrea e vesuviana (a sud). Plinio distingueva la Campania Antiqua, cioè quella del primo periodo, meno estesa e collocata intorno a Capua, dalla Campania Nova, quella della divisione augustea, che comprendeva anche una parte del Lazio, cioè la Campania di Roma.
Dunque, la Campania antica (Antiqua) andava dalle pendici del Monte Massico, al Nord, fino ai Campi Flegrei a Sud. Fu Plinio il Vecchio a parlare di “Campania Felix”, sia per sottolineare la fertilità della regione, sia per distinguere la Campania antica.
Ed proprio la "ditta" Plinio, per così dire, il "vecchio" e il "giovane", a fare da attori e interpreti principali di questa vicenda davvero allucinante ed unica nel suo genere.

Diamo attentamente uno sguardo a questa cartina. Al centro, ovviamente, ha il posto d'onore "Vesuvius". Va ricordato che nasce "dopo" l'evento. Prima era soltanto monte Somma. Sul golfo, lungo il litorale, a partire da Napoli, subito dopo Ercolano, vediamo il luogo dove tutto comincia nella narrazione: la Villa di Rectina.
Chi è costei? "Nobildonna appartenente all'elite romana: organizza un banchetto nella Pompei che conta a poche ore dalla tragedia. Si salverà". Così la descrive Alberto Angela iniziando a presentare l'elenco dei personaggi del suo racconto, in ordine di apparizione.
Prosegue poi con Plinio il Vecchio, lo schiavo Eutico, il politico Gaio Cuspio Pansa, l'affarista Gaio Giulio Polibio, il banchiere Lucio Cecilio Giocondo ... fino a concludere con Tiberio Claudio Anfio, addetto alla gestione della fattoria del banchiere, che si stringe attorno alla sua padrona per proteggerla (come li hanno trovati) e si conclude con Faustilla, usuraia che tenta di riscuotere i suoi crediti persino durante il fuggi fuggi generale.
Non c'è che dire, un ricco campione di vasta umanità. Ci si sarebbe potuto trovare chiunque fosse proveniente da questa vasta regione nella quale abbondavano i traffici e gli scambi. Sarebbe potuto esserci magari anche un "Antonino Saro Gallio", antenato di un reincarnato Antonio Gallo, come quello menzionato qui al link , nella Valle di Tramonti.
Da Pompei, un salto storico in avanti nel Medio Evo di oltre un millennio, ma anche un salto storico all'indietro nella Pompei che si apprestava ad essere distrutta da "Vesuvius" fino ad allora uno sconosciuto vulcano. Se l'Antonio Gallo dei Monti Lattari era un "guarnimentaio" che trafficava dalla Valle del Sarno a quella di Tramonti, nulla ostava a che ci sarebbe potuto essere anche un Antonino Saro Gallio, proveniente dalla falde del Monte Saro, dove si potevano trovare le sorgenti del fiume Sarno, che bagnava Pompei ed alla città dava un ricco porto. Poteva trafficare in oggettistica pregiata con Rectina, la nobildonna dell'elite pompeiana.
Sarno era anche il fiume che permetteva ai pompeiani di trafficare e dava il nome alla città che ancora oggi porta quel nome con la quale Pompei aveva un forte rapporto. Non a caso Alberto Angela cita molte volte nel suo libro sia il paese che il fiume. Dalla mappa si vede chiaramente sia il percorso del fiume la strada che collegava i due paesi.
In un territorio così traboccante di storia qualsiasi evento immaginario può essere pensato come reale, anche se le ceneri del tempo e dei vulcani possono cancellare le tracce degli uomini. Leggendo questo libro, che mi è piaciuto molto e che ha dato senso alla mia identità sui luoghi così come sono stati illustrati in questa mappa, mi è sembrato possibile vivere una realtà immaginata. Di sicuro, per le possibilità che offre la reincarnazione e per la legge dei "ritorni", può esserci stato un "Antonino Saro Gallio", scampato all'evento solo per caso. La lettura di questo libro mi ha convinto ...

MEDIUM
- Antonio Gallo's profile
- 52 followers



