Antonio Gallo's Blog: MEDIUM, page 97
May 1, 2021
Maggio, il mese “depravato”?
 A Word for Every Day of the Year
A Word for Every Day of the Year
Benvenuti nel mese di maggio. Secondo la poesia di T. S. Eliot Gerontion (1920) è un mese depravato. La poesia contiene uno degli unici due esempi mai registrati della parola “juvescence”. In Gerontion leggiamo: “Nella giovinezza dell’anno / Venne Cristo la tigre / In maggio depravato, corniolo e castagno, giuda in fiore. . .” La versione più comune della parola è “juvenescence”, che significa semplicemente ”giovinezza“. Nel 1989, Anthony Burgess stava esaminando la seconda edizione dell’OED e scelse con stizza questa voce. Eliot aveva torto, scrisse Burgess. “Dovrebbe essere “juvenescence”. La sua autorità prevale e possiamo disonorare l’etimologia latina come desideriamo. L’OED concede il diritto. Si potrebbe rispondere che la giovinezza di Eliot si adatta al metro dove la giovinezza non lo farebbe, e sembra anche un opposto più naturale alla senescenza (età). Inoltre, Eliot avrebbe potuto intendere una relazione più precisa con la radice latina: juvenis era un uomo o una donna specificamente di età post-adolescenziale piuttosto che semplicemente “giovane”, che dopotutto ha più senso se applicato al quinto mese dell’anno.
Juvescence
Welcome to the month of May, which according to T. S. Eliot’s poem ‘Gerontion’ (1920) is ‘depraved’. The poem contains one of only two examples ever recorded of the word juvescence. (The other was by Stephen Spender, twenty-eight years later.) In ‘Gerontion’ we read: ‘In the juvescence of the year / Came Christ the tiger / In depraved May, dogwood and chestnut, flowering judas . . .’ The more common version of the word is juvenescence, meaning simply ‘youth’. In 1989, Anthony Burgess was reviewing the second edition of the OED, and peevishly picked on this entry. Eliot ‘was wrong’, Burgess wrote. ‘It should be “juvenescence”. His authority prevails, and we can dishonour Latin etymology as we wish. The OED bestows the right.’ One might reply that Eliot’s juvescence fits the metre where juvenescence would not, and it also seems a more natural opposite to senescence (age). Moreover, Eliot might have intended a more precise relation to the Latin root: juvenis was a man or woman specifically of post-adolescent age rather than just ‘young’, which after all makes more sense when applied to the fifth month of the year.

Le buone notizie della settimana
 Buone Notizie
Buone Notizie
A causa della pandemia, il mondo della scuola è stato costretto a riorganizzarsi attraverso la didattica a distanza. Se da una parte questo ha provocato dei problemi organizzativi, dall’altra la didattica a distanza ha permesso alla scuola di cambiare in meglio.
Come ormai sappiamo, per uscire dalla pandemia è fondamentale vaccinarsi. Ma nel prossimo futuro potrebbe essere messa a punto una cura innovativa per le malattie infettive. Le premesse ci sono tutte.
Spesso abbiamo sentito parlare del body shaming, cioè della violenza psicologica che prende di mira l’aspetto fisico, con tutte le relative conseguenze in termini di sofferenza. Un fenomeno che riguarda sia uomini che donne, la cui soluzione prende il nome di body positive.
La settimana che si avvia al weekend è stata anche quella che ha messo al centro della sua agenda il problema dei cambiamenti climatici e degli impegni delle superpotenze del mondo per realizzare delle soluzioni concrete, a partire dall’ultimo summit sul clima.
E proprio durante il summit sul clima, i leader del mondo hanno messo sul tavolo i vantaggi che deriveranno dalla svolta verde a difesa dell’ambiente. Tra questi, la creazione di nuovi posti di lavoro.
Rispettare l’ambiente permette di migliorare la qualità della nostra vita. Un’obiettivo che si può raggiungere anche con lo sport. Che porti benessere all’organismo, lo sappiamo tutti. Quel che non tutti sanno è che lo sport può veicolare messaggi importanti, come l’inclusione.
La pandemia in corso ha portato molti musei italiani ad approfittare di questo periodo per innovarsi. Molti sono rimasti indifferenti a questo ammodernamento, ma altrettanti si sono digitalizzati.
Il 3 maggio si celebrerà la Giornata Internazionale della Libertà di Stampa. Il movimento Mezzopieno, insieme a numerosi partner come BuoneNotizie.it, ha organizzato la Giornata Nazionale dell’Informazione Costruttiva: un appuntamento per capire l’importanza, la necessità e le opportunità dell’approccio costruttivo alle notizie, per combattere l’ansia e la depressine derivanti dall’infodemia e promuovere un modello di informazione più orientato alle soluzioni, oltre le polemiche e allarmismi inutili.
Buona lettura e buon weekend in compagnia di BuoneNotizie.it!

April 27, 2021
La Verità …

Ci sarebbe molto da dire su questa risposta. Mi ha detto che sono pessimista, ma non credo di esserlo. Sono solamente realista. E’ il mio punto di vista, ovviamente. Non converge con il suo, pare ovvio. Riesce anzi a ribaltare la situazione a suo favore. Difende il suo lavoro, il giornale su cui scrive, citando un caso politico noto a tutti. Ci sarebbe comunque da obbiettare che Arcuri, con tutti i suoi errori, e’ stato fatto fuori anche perché è cambiato il governo. La Verità, con la maiuscola, è destinata, comunque, sempre ad arrivare tardi o non arrivare mai … E poi, mi sia permesso dire che il giornale sul quale scrive non è un «piccolo giornalino». Un giornalino e’ già di per se’ piccolo, non vi pare?

April 22, 2021
Il “coprifuoco” della natura e quello di Covid 19

“La campana batte il rintocco del crepuscolo,/la mandria che muggisce si stende lentamente sul prato,/il contadino cammina stancamente verso casa,/e lascia alla oscurità e a me il mondo.”
C’è una parola in lingua inglese che mi ha sempre affascinato per la sua dimensione linguistica, sia in senso letterale che metaforico. Tuttora in uso, “curfew” , in italiano “coprifuoco” , ha una forte risonanza poetica ed è stata usata spesso in poesia. Oggi, purtroppo la troviamo in contesti poco poetici, come quando ci sono emergenze di vario genere. Questa che stiamo vivendo da oltre un anno è una emergenza senza dubbio planetaria.
Un nemico tanto invisibile quanto misterioso minaccia il pianeta Terra con i suoi abitanti. Una decisione di questo genere sta facendo discutere non soltanto da noi ma in quasi tutti i paesi del mondo . Sono in gioco i diritti fondamentali di ogni essere umano: la sua libertà di movimento e il suo diritto alla salute . In entrambi i casi sono diritti individuali quanto collettivi. Ma come si fa a conciliarli?
Famoso l’incipit nella foto sopra che riproduce i primi quattro versi della famosa poesia di Thomas Gray , poeta esponente del pre-romanticismo inglese, degno compagno della poesia preromantica italiana con Ugo Foscolo . Il termine “coprifuoco”, usato in poetica, sembra invece essere l’ordine dato all’occhio della natura di chiudere ogni contatto con il mondo e lasciare tutte le cose al mistero della vita. La poesia che vi presento lo dimostra.
E’ stata scritta da Henry Wadsworth Longfellow (1807–1882) uno scrittore e poeta statunitense, tra i primi letterati americani ad assurgere a fama mondiale. Longfellow fu il più famoso poeta della scena del New England nell’’800. Fu un acceso promotore dell’abolizione della schiavitù negli anni prima e durante la Guerra Civile Americana insieme ad altri intellettuali.
Intorno al 1862 diede vita al cosiddetto “Circolo Dante” atto a promuovere la conoscenza della Divina Commedia di Dante Alighieri negli Stati Uniti. Insieme ai suoi colleghi del circolo, Longfellow ne portò a termine la prima traduzione statunitense in inglese nel 1867. Da allora il successo dell’opera di Dante in America fu costante ed in seguito il Circolo diventò la “Dante Society” , una delle più famose associazioni di dantisti nel mondo.
La poesia che ho tradotto liberamente ha non solo qualcosa di malinconico e triste, ma anche di decisivo e finale, quasi una apocalittica, prevedibile conclusione naturale di un evento che può accadere in qualsiasi momento.
Si arriva alla conclusione della lettura e ci si rende conto che accade e si ripete ogni giorno con quella parola decisiva che è il “curfew” . Il “coprifuoco”, quando l’occhio della natura si chiude sulla natura stessa. È chiaro che l’evento riguarda non solo la stessa natura che lo crea, ma anche ogni essere vivente che in essa ritrova e vive, in particolare ogni uomo.
Curfew/Coprifuoco
I.
Solemnly, mournfully,/Dealing its dole,/The Curfew Bell/Is beginning to toll.
Solenne, triste,/Suona il suo dolore,/La campana del coprifuoco/Comincia a rintoccare.
Cover the embers,/And put out the light;/Toil comes with the morning,/And rest with the night.
Coprite le braci,/Spegnete la luce;/La fatica al mattino,/Il riposo la sera.
Dark grow the windows,/And quenched is the fire;/Sound fades into silence,/All footsteps retire.
Si oscurino le finestre,/Si plachino i fuochi;/Il suono finisca in silenzio,/Tutti i passi rientrino a casa.
No voice in the chambers,/No sound in the hall!/Sleep and oblivion/Reign over all!
Nessuna voce nelle stanze,/Nessun rumore nel salone./Il sonno e l’oblio/Regnino ovunque.
II.
The book is completed,/And closed, like the day;/And the hand that has written it/Lays it away.
Il libro si è concluso,/Chiuso, come il giorno;/E la mano di chi l’ha scritto/Lo porti via.
Dim grow its fancies;/Forgotten they lie;/Like coals in the ashes,/They darken and die.
La nebbia faccia sorgere le fantasie;/Esse giacciono dimenticate;/Come carboni nella cenere,/Anneriscono e muoiono.
Song sinks into silence,/The story is told,/The windows are darkened,/The hearth-stone is cold.
Il canto si spegne nel silenzio,/La storia e’ finita,/Le finestre sono state oscurate,/Il focolare è freddo.
Darker and darker/The black shadows fall;/Sleep and oblivion/Reign over all.
Sempre piu’ scure/Cadono le ombre;/Il sonno e oblio regnano ovunque.
“Curfew”
by Henry Wadsworth Longfellow

La Giornata Mondiale del Libro. Leggi che ti passa in farmacia …
 Farmacia Campitiello
Farmacia CampitielloStamattina pioveva a dirotto quando sono entrato in farmacia. Anche il 3 luglio del 1862, a Oxford, fu un giorno di pioggia. Ma non ero a Oxford bensì a Polvica di Tramonti, in Costa d’Amalfi, dove mia moglie ed io stiamo trascorrendo questo lungo periodo di “lockdown/isolamento”. La farmacia è a pochi passi dalla casa dove vidi la luce nel secolo e nel millennio trascorsi. Avevo bisogno di un farmaco. La gentile dottoressa non lo aveva nella confezione richiesta.
Ho salutato e stavo per uscire quando, con un sorriso, mi ha offerto un libretto che avevo visto sul bancone. Era una riedizione del famoso libro di Alice, edito dall’Accademia Nazionale dei Farmacisti Italiani, con una presentazione della coordinatrice Vita Barrile. Ho chiesto quanto le dovevo, mi ha risposto “nulla”. L’ho ringraziata, le ho fatto i complimenti, ho detto che avevo letto in rete della iniziativa, avevo fretta e sono andato via.
Con una successiva ricerca online, ho saputo poi che la Farmacia Campitiello non è nuova ad iniziative simili. Già lo scorso anno, in occasione della Giornata Internazionale del Libro, ha distribuito il capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry, il Piccolo Principe.
I cittadini di Tramonti, in questo particolarissimo 2021, potranno celebrare la Giornata Mondiale del libro che cadrà proprio domani, 23 aprile, in maniera davvero unica e speciale, viaggiando con la mente in luoghi inesplorati che fanno bene all’anima.
Stando comodamente seduti sul divano di casa, la lettura è la metafora più adatta al momento per evadere e riflettere in sicurezza. Tante nuove e terribili fragilità per via del virus possono essere superate soltanto con la lettura. Una proficua giornata di pioggia come quella del 3 luglio del 1862 descritta in un post apparso sul mio blog diversi anni fa e che ripropongo qui di seguito.
Il 3 luglio 1862, a Oxford, fu giorno di pioggia. Per questa ragione, la gita sul fiume — due giovani uomini, il reverendo Charles Lutwidge Dodgson, ordinato da appena un anno diacono e il suo amico Robinson Duckworth, avevano progettato di portare in barca tre bambine, Lorina, Alice e Edith, figlia di Henry Gorge Liddell, il decano del Collegio di Christ Church — dovette essere rimandata. Ma il giorno dopo la gita si potè fare.
Non appena la barca si staccò da Folley Bridge, il reverendo Dogson prese a raccontare una storia che aveva per protagonista una bambina di nome Alice. Remare e raccontare era faticoso, ma le sorelle Liddell lo incalzavano: così, per due ore e mezza, tanto durò il tragitto sino a Godstow, il reverendo Dodgson non cessò di inventare situazioni sempre nuove e bizzarre.
Alla fine, l’assennata Alice gli suggerì di raccontare quelle storie in un libro. Nacque così “Alice nel paese delle meraviglie” che il reverendo Dodgson firmò con lo pseudonimo di Lewis Carroll. Dodgson era timido e balbuziente; nonostante l’accanimento dei biografi, non si è riusciti a scoprire nella sua vita, nessuna storia d’amore; le sole persone con cui si trovava a suo agio erano bambine impuberi, e la preferita fu Alice Liddell.
Ma il reverendo Dosgson non fu il solo a essere incantato da quella bambina straordinaria e a sperimentarne il potere. La stessa esperienza sarebbe toccata all’uomo, anche lui tragicamente timido e inesperto, incaricato dal signor Liddell di impartirle lezioni di disegno. Dopo le lezioni, l’insegnante si fermava a prendere il tè con Alice.
Un giorno, aveva cominciato a nevicare, i genitori rientrarono in anticipo, interrompendo il piccolo rito. In una pagina autobiografica, l’insegnante, che non era solo disegnatore ma anche uno scrittore, e avrebbe contato fra i suoi traduttori francesi, Marcel Proust, confessò, con parole candide e commoventi, la delusione che quel ritorno gli aveva procurato. Quei passi, quelle voci avevano spezzato una magia. Non so se avete capito di chi si parla.Il tè con Alice

April 21, 2021
La maggior parte delle persone non cresce …
 Il Libro
Il Libro
“La maggior parte delle persone non cresce. È troppo difficile crescere. Quello che succede è che la maggior parte delle persone invecchia. Questa è la verità. Onorano le loro carte di credito, trovano il parcheggio, si sposano, hanno il coraggio di avere figli, ma non crescono. Non proprio. Invecchiano. Ma crescere costa la terra, la terra. Significa che ti prendi la responsabilità per il tempo che impieghi, per lo spazio che occupi. È una cosa seria. E scopri quanto ci costa amare e perdere, osare e fallire. E forse anche di più, per avere successo “.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
“Most people don’t grow up. It’s too damn difficult. What happens is most people get older. That’s the truth of it. They honor their credit cards, they find parking spaces, they marry, they have the nerve to have children, but they don’t grow up. Not really. They get older. But to grow up costs the earth, the earth. It means you take responsibility for the time you take up, for the space you occupy. It’s serious business. And you find out what it costs us to love and to lose, to dare and to fail. And maybe even more, to succeed.”
Maya Angelou
Pubblicato per la prima volta nel 1969, Io so perché canta l’uccello in gabbia è uno dei libri fondamentali del Novecento, uno tra i migliori mille libri di sempre, secondo larga parte della stampa e delle riviste letterarie americane.
Descrivendo i primi anni della sua straordinaria esistenza, Maya Angelou vi celebra la voglia di vivere, la bellezza del pensiero e la disarmante sensibilità di una bambina e poi di un’adolescente nera nell’America razzista del secolo scorso.
Il libro muove dall’arrivo di Maya, tre anni, e di suo fratello Bailey, quattro anni, a Stamps, nell’Arkansas. Spediti nel profondo Sud a casa della nonna, dopo la separazione dei genitori. È la stagione in cui i luoghi appaiono ancora sotto la luce magica dell’infanzia. Maya vive con la nonna e lo zio nel retro dell’Emporio di cui Momma (così viene chiamata la nonna) è proprietaria da tempo e, tra granaglie per i polli, cherosene, lampadine, stringhe, lozioni, palloncini e semi di fiori, gioca ininterrottamente con Bailey, come in un luna park senza guardiano.
Nell’America degli anni Trenta, tuttavia, eroi e orchi, incanti e orrori accompagnano inevitabilmente l’esistenza di una bambina di colore. Eroi, per Maya, sono i raccoglitori di cotone che scendono dal retro de gli autocarri, si piegano giù fino a terra e, stanchissimi, le dita tagliate, le schiene, le spalle, le brac cia, le gambe sfinite, si assembrano nell’Emporio. Orchi sono i «ragazzi» bianchi del Ku Klux Klan che, con gli occhi pieni di odio e le facce di pietra, calano a Stamps e costringono lo zio di Maya e gli altri neri a nascondersi tra gli escrementi del le galline. Orco è Mr. Freeman, l’amico della mamma, un uomo grande, grosso e flaccido che a St. Louis, in Missouri, una sera di primavera l’attira a sé.
Opera magnifica, fatta di urla, suoni, passioni, crudeltà e coraggio senza limiti, Io so perché canta l’uccello in gabbia è la storia di una ragazzina afroamericana capace di lasciarsi alle spalle la sofferenza costruendo con orgoglio e ostinazione la propria vita. Una storia che, a quasi cinquant’anni dalla sua prima pubblicazione, conserva tutta la sua bruciante attualità.

April 20, 2021
Cosa significa veramente sentirsi inglesi oggi?
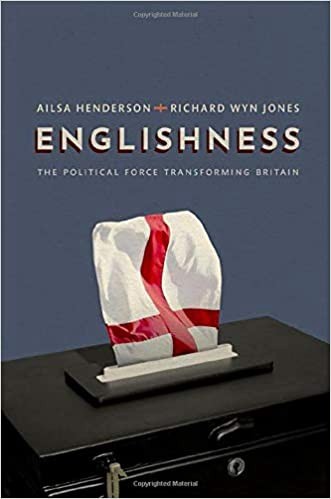 Il libro
Il libro
La domanda se l’è posta di recente l’antico ed autorevole settimanale inglese The Spectator.
Una domanda di grande attualità, visto e considerato che la stessa parola “inglese” risulta essere sempre essere sullo schermo della informazione quotidiana: Elisabetta II Regina del Regno da 70 anni, felicemente sul trono a 95 anni, il principe Filippo suo consorte, da poco passato a miglior vita, Carlo, principe di Galles, futuro re mancato con tutti gli irrequieti eredi, fino ad arrivare a Bojo, lo scapigliato biondo primo ministro Boris Johnson, seguito da una infinita moltitudine di termini e personaggi inglesi adottati in continuazione dai media, per gaudio e odio di tanti anglisti, anglofobi o anglomani.
Ma non è solamente l’aspetto linguistico sociologico a caratterizzare l’interrogativo. C’è, sopratutto, un aspetto storico culturale che, in questa occasione, diventa anche squisitamente personale, se si considera che chi scrive ha fatto di questa parola “englishness” una delle sue “ragioni di vita”.
I giapponesi hanno una parola precisa, “ikigai” , tradotta come “ragione di vita” o “ragion d’essere” : la ragione per cui svegliarsi al mattino. Credono che ognuno di noi abbia dentro di sé il proprio “ikigai” e, per questa ragione, è essenziale scoprirlo, farlo nostro. A dire il vero, nel caso degli inglesi, le parole, per quanto mi riguarda, sarebbero due: “britishness” e “englishness” . Inglesi o Britannici, non è una differenza di poco conto, se si considera che sono le Isole Britanniche a dare un senso completo ai due termini.
Non tutti ricordano, infatti, che quando usiamo il termine “inglese” ci riferiamo a quella complessa realtà geografica, storica e culturale di cui sono fatte: Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord e tante altre piccole isole. Sia nell’uno che nell’altro caso, gli scozzesi, i gallesi e gli irlandesi avrebbero molto da dire ed obiettare. Ma non intendo addentrarmi in questa realtà storica e politica molto complessa. Quello di cui desidero qui occuparmi è la pubblicazione di un libro che affronta questo argomento in maniera molto seria in termini di “nazionalismo inglese”. E’ anche una occasione per me, per ripensare la mia identità.
Ho letto solo alcuni estratti del libro e un paio di recensioni che mi offrono l’occasione per scriverne anche per fatto personale. Gran parte della mia identità culturale la devo a questa realtà che, senza dubbio, ha concorso a creare la mia “ikigai” . Ognuno se ne costruisce una, a seconda dei percorsi di studio e di vita che decide di seguire.
La mia è la somma, ovviamente, di quella identità legata al Bel Paese dove sono nato e cresciuto, dove hanno vissuto i miei antenati e chi mi succede continuerà a vivere. Si è affiancata a quella “inglese” che ho imparato a conoscere e vivere sin da quando avevo venti anni, vivendo e lavorando su quell’isola e per tutti gli anni successivi, legati sia all’attività professionale che ho svolto che alla mia famiglia.
Oltre mezzo secolo di esperienze, amicizie, ricerche, contatti e confronti che continuano ancora oggi, forse non tanto più in maniera fisica. Pesano non soltanto gli anni, ma anche la pandemia che ha violentemente concorso a far chiudere tutte le porte che la globalizzazione aveva spalancato in un mondo diventato improvvisamente e falsamente “ikigaizzato” .
Senza dubbio l’Inghilterra che conobbi agli inizi degli anni sessanta del secolo e del millennio trascorsi non è più quella di oggi. In una ricerca che ho fatto per documentarmi nella stesura di questo post, mi sono imbattuto in una definizione di “englishness” che mi colpito. Il libro dal quale è tratta è presente anche nella bibliografia del libro di cui mi sto occupando. Vale la pena riportarlo per intero:
«Per essere accettabilmente inglese, tutto quello che uno doveva fare era essere Bianco, a favore della causa Imperiale e secondo quella pervadente virtù vittoriana, rispettabile. Quest’ultima qualità consisteva nell’accettazione dei valori condivisi dalle élites anglosassoni: parsimonia, santità della proprietà privata, deferenza verso i superiori, fede nel potere moralizzatore del duro lavoro e dell’igiene. (..) in un contesto coloniale, l’Englishness era fondamentalmente un problema di “pelle bianca, lingua inglese e valori borghesi”».
V. Bickford Smith, Ethnic Pride and Racial Prejudice in Victorian Cape Town. Group Identity and Social Practice, 1875–1902, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, 39.
La citazione è riferita al colonialismo inglese in Sud Africa. Certamente oggi non si intende più questo, nè si è giunti ad una ragionevole definizione che possa essere altrettanto accettabile per ogni membro che faccia parte di questa comunità. La conclusione alla quale sembrano arrivare gli autori di questo libro è che “englishness” continua ad essere una parola precisa, ma che ha un significato molto diverso per ogni individuo che si ritenga essere un “inglese” .
La recente scomparsa del principe Filippo di Edimburgo , consorte di Elisabetta II Regina , (grazie alle discussioni che ho avuto con mia moglie, con la quale ho avuto la fortuna di condividere con lei questa mia “ ikigai inglese” , tanto da farla diventare unica), mi ha fatto andare con il pensiero alla identità inglese e se ne avesse una, intendo quella di Filippo. Lo conoscevamo tutti come il principe di Edimburgo, marito di Elisabetta II d’Inghilterra.
Ma chi era davvero? Philip Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, principe di Grecia e Danimarca , è il ben più celebre duca di Edimburgo. Nato a Corfù nel 1921, ha sposato la regina, che per i suoi 90 anni gli ha ceduto il titolo di Lord High Admiral della Royal Navy. Nelle vene sangue blu: nipote del re di Grecia, ha rinunciato ai titoli nobiliari (e al nome) della sua casata per convolare a nozze con Elisabetta II, adottando così il cognome MountBatten . Un vero esempio di ikigai acquisita .
Durante gli anni che trascorsi in quel caleidoscopico ambiente di lavoro che fu per me Harperbury Hospital , a nord di Londra, a poca distanza dall’antica città romana di Verulamium , la moderna St Albans , ebbi modo di conoscere quasi tutte le diverse identità inglesi che vi lavoravano. Persone la cui realtà di vita era legata alla contea di appartenenza o di nascita, oppure alle quattro diverse realtà di un “regno unito” . Alla maniera di come noi italiani ci diciamo campani, napoletani, milanesi, piemontesi, veneti o siciliani, loro si definiscono inglesi sì, ma anche gallesi, scozzesi, irlandesi del nord o del sud e altro ancora.
Fino al referendum sulla Brexit , c’era un dubbio diffuso sull’esistenza di un nazionalismo inglese, almeno al di là di una piccola frangia. Da allora, è diventata una spiegazione ovvia con il voto di uscita dall’Unione europea. I successivi sondaggi di opinione hanno sollevato dubbi sulla portata del continuo impegno inglese nei confronti della stessa Unione del Regno Unito. Tuttavia, anche se l’inglese sta apparentemente rimodellando il posto della Gran Bretagna nel mondo e forse, in ultima analisi, lo stato stesso, il termine “englishness” rimane poco compreso e poco definibile.
In questo libro firmato da Ailsa Henderson e Richard Wyn Jones gli autori attingono ai dati del “Future of England Survey”, un programma di indagine sugli atteggiamenti pubblici appositamente commissionato che esplora le implicazioni politiche dell’identità inglese, per formulare argomenti nuovi e originali sulla natura del nazionalismo inglese. Da quanto si legge, in questo tipo di “englishness” , di nazionalismo inglese, non c’è solo un rifiuto della Gran Bretagna e della Britishness.
Piuttosto, il nazionalismo inglese combina un senso di risentimento per il posto dell’Inghilterra nel Regno Unito con un feroce impegno per una particolare visione del passato, del presente e del futuro della Gran Bretagna. Si capisce, quindi, che per comprendere questa identità bisogna pensare, quando di parla di “englishness” e “britishness” alla faccia bifronte di Giano , sia in Inghilterra che in Gran Bretagna. Una possibile chiave non solo per comprendere questo tipo di nazionalismo inglese, ma anche per comprendere i modi in cui si sta trasformando la politica britannica rispetto a quella dei miei tempi di cui ho detto innanzi.
Va ricordato anche, a questo punto, il precario futuro di quella sigla che va sotto il nome di “The United Kingdom of England, Scotland and Northern Ireland” . La irrequietezza scozzese, come quella nord irlandese, mette in discussione sia la “englishness” che la “britishness” e entrambi dimostrano un diverso e nuovo senso di identità. Per ora, le persone riconoscono un senso di continuità storica, radicato nelle istituzioni, in particolare la monarchia.
Poi ci sono caratteristiche meno evidenti, come il senso dell’umorismo nazionale, lo sport e così via. In molti casi rimane l’impossibile desiderio di tornare al passato. Non si sa bene se per ri-firmare quel trattato che segnò l’inizio dell’ Unione dei due Regni nel 1706 , oppure anche prima al 1602, quando alla morte di Elisabetta I successe il cugino scozzese James VI.
L’aumento del numero di persone che si considerano inglesi in primis e britanniche poi, che antepongono la loro etnia alla cittadinanza, sembra suggerita dall’affermazione dell’identità scozzese, da persone che preferirebbero non rimanere bloccate senza una propria. È più complessa dell’idea che l’Inghilterra sia di gran lunga il costituente dominante delle isole britanniche.
Agli inglesi dell’Inghilterra è sempre piaciuta l’idea di ritenere gli scozzesi, i gallesi e gli irlandesi loro subordinati. Anche in quella gabbia di matti veri, in quell’ospedale in cui lavorai per un paio di anni, ne ebbi la conferma. Ricordo un inglese “Night Chief Nurse Superintendent” con il quale mi intrattenevo spesso a parlare nei sei mesi di turni notturni che feci a discutere di letteratura inglese. Una notte recitammo insieme la famosa poesia “IF” di Rudyard Kipling (1865–1936), lui in inglese ed io in italiano.
Non credo che gli autori del libro possano pensare con nostalgia a questo passato imperiale, colonialistico e individualistico. Non si può ignorare d’altra parte che alla base del sentimento “Brexistico” ci sia anche qualcosa del genere. Un sentimento che nel caso degli scozzesi si scontra con il tradizionale realismo che caratterizza questa gente che gli antichi Romani conobbero bene qualche millennio fa.
Rimane inevasa, allora, la risposta alla domanda che si è posta il settimanale inglese e che ho dato come titolo a questo post. Ricordo che quando feci quel viaggio che mi portò dall’antica Valle dei Sarrasti in treno, in ben oltre 45 ore di viaggio a Victoria Station , conoscevo ben poco della terra, della lingua e della gente che sarebbe poi diventata la mia “ikigai”, la mia “ragione di vita” o “ragion d’essere”, la ragione per cui svegliarsi al mattino.
Alla stazione di Parigi , nel passaggio dalla Gare di Lyon alla Gare du Nord comprai un libretto che ancora posseggo intitolato: “Les Anglais: Are they Mad?” . Feci il viaggio nello scompartimento con una ragazza di nome Barbara che mi aiutò con il poco inglese che conoscevo. Lei parlava inglese molto bene. Quando salimmo sul battello a Calais per Dover c’era un mare furioso, ebbi seri problemi di stomaco.
La persi di vista e la rividi solo a Victoria quando l’indimenticabile buon Alfred, nato e cresciuto in Inghilterra, figlio di una signora italiana emigrata, diventata inglese, che avevo conosciuto a Tramonti , mi venne a prendere. Scendendo dal treno, ricordo che Barbara mi lanciò la sua risposta al titolo del libro che avevamo letto insieme durante il viaggio. “Yes, remember, Toni, les Anglais are mad!”

April 16, 2021
Che fai, ridi?
 Il sorriso di Machiavelli
Il sorriso di Machiavelli
Il sorriso, il riso e il sogghigno sono espressioni graduate e diversificate di stati d’animo con i quali gli uomini osservano la realtà e con essa interagiscono.
Quella che ci troviamo a vivere nel mondo d’oggi è certamente una realtà molto diversa da quella che gli uomini hanno vissuto in passato. Cambia naturalmente di momento in momento. Le cose non accadono mai allo stesso modo. Ma è certamente mutata la maniera con la quale ci confrontiamo. Restano alcuni momenti e sentimenti che gli uomini condividono da quando vengono al mondo, indipendentemente da dove si trovano o in quale epoca sono vissuti.
 “Sean Connery”
“Sean Connery”Ad una certa età le cose del mondo dovrebbero vedersi in maniera distaccata e disincantata. Possibilmente senza rancore, odio e cattiveria perchè ormai gran parte dei giochi si sono giocati. Si sono conosciute persone ed eventi, ognuno è stato personaggio ed interprete sul palcoscenico della vita.
Se “una certa età” è quella che si è formata col susseguirsi di diversi decenni vissuti con un piede in un millennio ed un secolo nuovi e un altro in quelli precedenti, se si sono visti molti e variegati avvenimenti scorrere sotto gli occhi: papi e presidenti, governi e parlamenti, deputati e senatori, guerre e rivoluzioni, illusioni e delusioni, vittorie e sconfitte, disastri e conquiste, allora si dovrebbe avere la capacità di osservare e vivere la realtà del presente, e degli anni che ci restano da vivere, con quello stato d’animo che caratterizza la prima condizione a cui ho accennato all’inizio: il sorriso.
 Pino
PinoEd invece, così non accade sia per chi ha “una certa età”, sia per chi si trova nella “mezza età” e, più grave ancora, chi è “giovane”.
Come si fa a definire un sorriso? Forse soltanto accompagnando questa parola con aggettivi, di quelli più in uso per descrivere la significativa modifica dell’aspetto e dell’atteggiamento del viso. Quest’ultimo, mai come in questo caso, è l’espressione dichiarata dello stato d’animo della persona che decide di sorridere.
Sorriso leggiadro, grazioso, gentile, dolce, amorevole, pietoso, malinconico, mesto, materno, affettuoso, complice. Il sorriso può essere del cielo, della natura, della vita, della primavera, della bellezza, della giovinezza, della fortuna. Insomma uno stato d’animo quasi sempre positivo, gioioso, creativo.
Il riso, invece, comporta una modificazione fisica accentuata del volto, molto più forte del sorriso. Può essere mesto, triste, di compassione, di odio, di sprezzo, di sdegno, di rabbia, canzonatorio, sardonico, maligno, mefistofelico, smodato, rumoroso, sguaiato, sgangherato.
 Giuseppe De Stefano
Giuseppe De StefanoAvrete notato il forte aumento nella gradualità rispetto al sorriso. Chi ride decide di dare un giudizio, sceglie una morale da assegnare, quasi sempre negativa, un colpevole da designare, una condanna da emettere. Il cammino porta inevitabilmente a quello che è il terzo grado di giudizio decisamente inappellabile: il sogghigno.
La beffa, la provocazione e la malignità caratterizzano il sogghigno. Chi sceglie questo stato d’animo sa che va allo scontro. Ha deciso di dare battaglia e nulla potrà fermarlo. E’ ben sicuro della propria superiorità non solo morale, ma anche culturale, sociale e politica.
A questa persona non interessa il dialogo, il dibattito, la discussione. Ciò che conta è la distruzione dell’avversario, la vittoria su di lui ad ogni costo, il suo annientamento morale, spirituale, politico. Spesso si arriva anche alla eliminazione fisica dell’avversario che non ha via di scampo.
Perchè ho voluto parlare di queste tre condizioni della mente, che ho definito “stati d’animo”, è presto detto. In questi giorni mi sono riletto la biografia di Niccolò Machiavelli di Maurizio Viroli, intitolata “Il sorriso di Machiavelli”, pubblicata diversi anni fa da Laterza. Leggendo le vicende del grande Fiorentino ho avuto modo di capire quanto sia importante, arrivati ad un certo punto dell’esistenza e della propria esperienza vissuta, saper guardare gli eventi con distacco e disincanto, con un lievemente accennato sorriso.
Lo stesso sorriso che si legge sul ritratto che appare sulla copertina del libro. Non ha nulla di ambiguo, inquietante, spregiudicato, subdolo. Insomma di… machiavellico. E’ piuttosto il sorriso di chi, con questo discreto atteggiamento del volto, era vissuto guardando, osservando e vivendo le vicende degli uomini, del mondo e del suo Paese in particolare. Un sorriso che
“rispondeva alle miserie della vita per non lasciarsi vincere dalla pena, dallo sdegno e dalla malinconia, e per non dare agli uomini e alla fortuna la soddisfazione crudele di vederlo piangere. Il suo sorriso era non solo il suo modo di difendersi dalla vita. Era anche il suo modo di immergersi in essa. Nel suo sorriso c’era quell’amore della libertà e dell’uguaglianza civile che fu sempre fortissimo in lui, perchè è solo fra liberi e uguali, non con i padroni nè con i servi, che si può davvero ridere. E c’era sopratutto un profondo e sincero senso di carità, quella carità che gli faceva amare la varietà del mondo ed era il suo amore per la patria, quella carità benigna, che “non ha invidia, non è perversa, non insuperbisce, non è ambiziosa, non cerca il suo proprio commodo, non si sdegna, non pensa il male, non si rallegra di quello, non gode delle vanità, tutto patisce, tutto crede, tutto spera”come scrive nell’Esortazione. Queste parole, che Machiavelli fa sue, sono l’ultima chiave per capire, forse la bellezza del suo sorriso e della sua saggezza di vivere”.
Con queste bellissime parole Maurizio Viroli conclude la biografia del grande Fiorentino. Senza dubbio uno dei più grandi Italiani di tutti i tempi. Il grande teatro della politica del suo tempo ha insegnato ben poco ai suoi compatrioti di oggi a distanza di tanti anni.
Nessuno in questo Bel Paese è disposto ad imparare dalla Storia. Solo e sempre idee di smodata ed infinita ambizione, invidie piccole e grandi, tempeste provocate e prevedibili, vere e presunte tragedie, la vita come farsa e commedia, aggressioni fisiche e giudiziarie, bizantinismi, moralismi, interessi personali e di gruppo. Firenze e l’Italia di allora si ritrovano e si rinnovano nell’Italia di oggi. E’ vero, mancano le impiccagioni, il sangue nelle piazze, le esecuzioni pubbliche, i roghi e gli eserciti invasori. Tutto è più sofisticato, subdolo, strisciante, colorato, virtuale e subliminale, in grado di essere recepito, accettato e fatto proprio dall’individuo e dalla massa, in maniera inconscia.
Sempre in nome della libertà, una parola usata, questa volta sì, con “ipocrito sorriso”. Non si sa più sorridere con leggerezza, accettazione, distacco, con la volontà di capire anche le ragioni dell’altro, di venirgli incontro, di offrire e trovare convergenze. Si preferisce ridere smoderatamente, applaudire all’unanimità, con crudele sarcasmo, demolire con la satira distruttiva che non fa sconti e non costruisce, sgretola gratuitamente, sovverte demonizzando.
Pronti a passare al sogghigno che prelude allo scoppio dell’applauso distruttivo finale, segna l’uscita di scena dell’avversario, stanato e fatto colpevole, pronto allo scherno pubblico, al lancio della monetina, al disprezzo popolare. L’antica gogna, il decisivo rogo, questa volta mediatico. Io, per difendermi e sopravvivere, ho deciso di sorridere prima di me stesso e poi degli altri e del mondo. Ho scelto per questo post Niccolò e vi assicuro di essere stato in buona compagnia.
Chi è arrivato a leggere sin qui non sa ancora chi è il personaggio ritratto nelle tre immagini che si accompagnano al ritratto di Machiavelli. Lo svelo subito: è mio cognato Giuseppe, detto Pino. Lo ringrazio innanzitutto per essersi prestato a questa discussione sul sentimento legato al riso/sorriso di noi umani. Il volto di Peppino ha subito di recente diverse trasformazioni, tanto forti da poter far finire il suo volto in uno studio sulla fisiognomica. Lui è un un agricoltore, un musicologo, ama gli animali e l’elettronica, è un muratore, un pittore, insomma un multi-tecnico creativo e questi suoi selfie lo provano.
Tutto ha avuto inizio con il lockdown che gli ha fatto crescere la barba facendolo somigliare a Sean Connery. Un ottimo odontotecnico ha ricostruito i disastri del tempo ai suoi denti, ma continuava a mancare il sentimento sul suo volto. Al mio consiglio di abbozzare almeno un sorriso, mi ha inviato la seconda foto, un selfie mirato che però non mi ha soddisfatto. Lui mi ha risposto, giustamente che, per sorridere, bisogna avere una ragione. Con i tempi che stiamo vivendo, mi ha detto, c’è ben poco da ridere.
Gli ho risposto che forse ha ragione, ma che un detto antico dice che “il sorriso fa buon sangue”. Il potere della risata come risorsa di guarigione ha origini antichissime. Può sembrare incredibile, ma anche la Bibbia testimonia questo fatto: “Un cuore allegro è una buona medicina, mentre un’anima sofferente secca le ossa.” (Proverbi 17,22). Nell’Antico Testamento se Dio è presentato come una entità assai severa, stupirà forse sapere che il nome del primo figlio di Abramo, Isacco, significa…Dio ha sorriso!

April 12, 2021
Il mio coccodrillo …
 Lacrime di coccodrillo
Lacrime di coccodrilloSe qualcuno piange nel tentativo di fingere rimorso o empatia, diciamo che sta versando “lacrime di coccodrillo”. Ma come e perché abbiamo iniziato ad attribuire insincere manifestazioni di emozione ai rettili a trentadue denti?
L’origine potrebbe essere diventata popolare intorno al XIV secolo quando un libro di memorie bestseller, The Voyage and Travel of Sir John Mandeville, faceva riferimento a serpenti che singhiozzano mentre mangiano le loro vittime umane:
In quel paese e in tutto Inde ci sono moltissimi cockodrilli, che è una sorta di lungo serpente, come ho detto prima. E di notte dimorano nell’acqua e di giorno sulla terra, nelle rocce e nelle caverne. E non mangiano carne durante tutto l’inverno, ma giacciono come in un sogno, come i serpenti. Questi serpenti uccidono gli uomini e li mangiano piangendo; e quando mangiano muovono la mascella superiore e non la mascella inferiore, e non hanno lingua.
Nei secoli successivi, il pianto dei coccodrilli è diventato una metafora del rimorso superficiale. L’espressione è stata usata come una favola per insegnare il pentimento sincero, da Shakespeare per trasmettere un falso dolore e, più recentemente, dai media che prendono in giro politici in lacrime o sospettati di omicidio.
Nel 2007, lo zoologo Kent Vliet dell’Università della Florida ha effettivamente dimostrato che gli animali singhiozzano mentre fanno uno spuntino. Ma poiché i coccodrilli mangiano mentre sono in acqua, rendendo difficile lo studio delle loro lacrime durante il pasto, ha studiato i loro parenti stretti, caimani e alligatori, che potrebbero cenare sulla terraferma. Dei sette film che ha filmato mentre mangiava in un parco di alligatori della Florida, cinque piangevano prima, durante e dopo aver mangiato.
La teoria di Vliet è che quando gli animali schioccano con entusiasmo le loro mascelle, il movimento forza l’aria attraverso i seni dei coccodrilli e alla fine svuota le lacrime nei loro occhi. I loro occhi non solo lacrimano, ma possono schiumare e ribollire, come ha visto Vliet al parco degli alligatori, dove alcuni hanno persino pianto in attesa del loro pasto di pulcini, quaglie e biscotti.
In questo contesto si colloca l’esperienza di scrittura che va sotto il nome di “Il coccodrillo”. Interessante questa iniziativa promossa dal settimanale digitale Zafferano.news: scrivere il proprio coccodrillo. Non sapete cos’è? E’ quello che si scrive di qualcuno famoso quando se ne va all’altro mondo. Tutto il bene o tutto il male del mondo, oppure una mescolanza come vi pare.
Una esperienza da fare tra il serio e il faceto. Tanto la “cosa” è destinata ad accadere. Sia per chi è famoso e importante, come anche per chi è sconosciuto e senza fama: provare a scrivere il proprio coccodrillo e pensare quello che scriveranno e penseranno quando verrà il momento, oppure quello che nessuno penserà o scriverà di noi, un esercizio interessante in quanto nessuno ci conosce meglio di noi stessi. Quello che segue è il mio e l’ho inviato al giornale. Vi farò sapere se lo pubblicano.
Chi fui, lo posso dire. Mi diedero un nome, appartenni ad un cognome, come tutti. Ma non credo che basti. Cosa feci. Più o meno quello che fanno tanti. Non tutto, comunque. Quando apparvi sulla scena del mondo, la mia fascia temporale si estese tra un millennio e l’altro, senza che capissi bene cos’è il tempo. Il luogo dove nacqui non lo scelsi io, ma vissi anche altrove, mi mancò il mondo. Non chiedetemi perché accadde tutto questo, non so rispondervi. Posso dirvi, comunque, che il senso lo conosco solo io. Il resto è silenzio.

April 11, 2021
L’anima e il polmone in terapia intensiva in Costa d’Amalfi
 Il Sole 24 Ore
Il Sole 24 OreSu “Il Sole 24Ore” di domenica 11 aprile, anno secondo del Covid 19, nella pagina Viaggi 24, Weekend, è apparso l’articolo che vedete qui sopra riprodotto. Il servizio si apre con una citazione del poeta Walt Whitman, uno dei più grandi poeti americani di tutti i tempi, autore di “Foglie d’Erba”, famosa raccolta di poesie pubblicata nel 1855 in occasione del giorno dell’Indipendenza americana, un’opera destinata ad essere considerata come la Bibbia democratica americana.
La redazione del giornale ha scelto questi versi per presentare l’auspicato ritorno alla Natura dopo le tante, continue ed implacabili chiusure, pardon i “lockdown”!, che la stessa è stata costretta ad affrontare e noi, poveri, assediati e prigionieri, villici o cittadini, siamo costretti ancora oggi ad osservare. Dice il poeta Whitman :
“Dammi, odoroso all’alba, un giardino di fiori bellissimi dove io possa camminare indisturbato”.
Al leggere l’articolo, il mio pensiero è andato subito in due diverse, ma convergenti, direzioni, non come nella poesia di Robert Frost “ La strada che non presi ” che sono divergenti.
Una direzione verso la Valle di Tramonti nella quale, con mia moglie, mi ritrovo ormai da quasi un anno a causa del lockdown, il cosidetto “polmone verde della Costa d’Amalfi” , l’altra, all’interno di essa, quella che dalla strada provinciale, dal Valico di Chiunzi, porta al mare di Maiori .
Ad un certo punto c’è la svolta verso la frazione di Campinola , in direzione di un giardino definito “segreto”, costretto alla chiusura ormai al secondo anno. Un duro “lockdown”, tanto sofferto quanto segreto, come la sua denominazione lo qualifica: Il Giardino Segreto dell’Anima.
Che strana combinazione: l’anima e il polmone rinchiusi su se stessi, per difendersi dall’attacco di un nemico implacabile e misterioso, il Covid 19. In questo tempo in cui fioriscono i glicini, si preparano a nascere le rose, le 500 rose del “Giardino Segreto dell’Anima” tanto care a Enza Telese, Antonio De Marco e a Giancarlo, non possono offrire ai loro visitatori il loro fascino, la loro storia e le tante valenze simboliche che solo in un territorio come questo nella Costa d’Amalfi il visitatore può trovare.
Una Valle ed un Giardino che fanno pensare al Giardino dell’Eden , un luogo dove si riesce a conciliare l’equilibrio e l’incontro tra uomo e natura, da sempre storicamente vere e proprie destinazioni turistiche internazionali da costituire un grande patrimonio culturale che deve essere protetto e deve continuare ad esistere.
Visitare luoghi come questi significa entrare nella storia , nella botanica , nell’ architettura ma anche nella gastronomia , nelle tradizioni . Nel “genius loci” si ritrova l’ anima e il polmone di una storia che deve continuare a raccontare se stessa, un luogo dove l ’Uomo possa continuare a camminare indisturbato come dice il Poeta .

MEDIUM
- Antonio Gallo's profile
- 52 followers



