Antonio Gallo's Blog: MEDIUM, page 96
May 18, 2021
Non possiamo non dirci stoici …
 Foto@angallo
Foto@angalloLo stoicismo è l’unica filosofia possibile oggi: concreta, nobile, al di là dei dualismi. Una specie di aristocrazia del pensiero. Dialogo con Giuseppe Raciti.
Come tutti i maestri autentici, Epitteto non scriveva: l’insegnamento non può stare nella spirale dei paragrafi, tra il veleno dei verbi, perché le parole coltivano il fraintendimento, tendono a variare un sussurro in legge, l’istante in norma. Piuttosto, è un segno il fatto che Arriano abbia raccolto, con l’acribia del discepolo, i testi di Epitteto — il Manuale e le Diatribe — e scritto una delle più imponenti biografie di Alessandro Magno: pur abitando vite contrarie, una stessa aristocrazia definisce l’opera del sapiente e l’azione del guerriero, uno stesso fuoco freddo, dilatato, blu. Celato in una nebulosa biografica, Epitteto vive tra I e II secolo, nasce a Ierapoli, schiavo, poi liberato da chi ne deteneva la proprietà, un ricco segretario di Nerone. La leggenda lo vuole zoppo, in grado di sbriciolare il dolore in gloria; non si sposa, non ha figli, vive in nobile candore — solo chi ha, può indossare la rinuncia –, apre una scuola a Nicopoli. Pare che il futuro imperatore Adriano fosse affascinato dai suoi insegnamenti: ad ogni modo, così Marguerite Yourcenar — con la sua scrittura sprezzante, stoica, pia — immagina il loro incontro. “Ero andato a visitare il vecchio Epitteto nel suo tugurio alla Suburra, pochi giorni prima che Domiziano lo esiliasse. L’antico schiavo, al quale un padrone brutale anni prima aveva spezzato una gamba senza riuscire a strappargli un lamento, il fragile vecchio che sopportava paziente i lunghi tormenti dei calcoli renali, m’era sembrato in possesso d’una libertà quasi sovrumana. Avevo contemplato con ammirazione quelle grucce, quel pagliericcio, quella lampada di terracotta, il mestolo di legno nella ciotola di creta, gli utensili semplici di una vita pura. Ma Epitteto rinunciava a troppe cose, e ben presto m’ero reso conto che, per me, nulla era più insidiosamente grato della rinuncia. L’indiano, più logico, ricusava addirittura la vita”.
Epitteto non insegnava a espropriarsi da sé, esponendosi a estasi fameliche, ma a capire che nulla ci è proprio, e che è appropriato, semmai, accettare, accogliendo la tassonomia del fato. I suoi detti, ineccepibili come cristalli, risolti in una logica al contempo violenta e regale, hanno trapassato i secoli: è stato Leopardi, nella straordinaria traduzione dell’Enchiridion, nel 1825, a fare di Epitteto il primo dei moderni, il filosofo adatto, da comodino. Scriveva, Leopardi, che la filosofia di Epitteto gli pareva “più delle altre profittevole nell’uso della vita umana”, concentrata sull’unica felicità possibile, “rinunciare, per così dir, alla felicità, ed astenersi quanto è possibile dalla fuga dal suo contrario… cioè non curarsi di essere beato né fuggire di essere infelice”. La lingua che Leopardi inventa per Epitteto è bella, sferica, risoluta, metallica: “Tu non déi cercare che le cose procedano a modo tuo, ma voler che elle vadano così come fanno, e bene starà”. C’è quasi una fatalità taoista — ma priva di foga tra i contrari — in questi aforismi, che sgorgano sgargianti. A partire dalla riproposta di quella traduzione, prima pietra del neo-stoicismo (Aragno, 2021), Giuseppe Raciti — già autore della nuova edizione del Tramonto dell’Occidente di Spengler, per Aragno — compila uno studio, che termina con una domanda-risposta da boxeur tanto radicale — “È forse possibile, oggi, un’altra filosofia, cioè un’altra esperienza della materia? Credo di no. Parafrasando Croce, non possiamo non dirci stoici” — che ho insistito per interpellarlo.
Scrive, al termine del suo ragionamento, nella postfazione del libro, «non possiamo non dirci stoici». Cosa significa?
Le antitesi che da secoli e secoli contrassegnano il nostro modo di pensare — anima/corpo, spirito/materia, mente/cervello, software/hardware ecc. — e in genere i modi di ragionare che procedono per dicotomie, per coppie prefabbricate, ci sono diventati indigesti. Occorre un antidoto. Gli stoici ne hanno uno a portata di mano: basta pensare all’anima come a un corpo, alla mente come a un corpo e così via. Se, poniamo, spirito e materia sono corpi: diversi, certo, ma sempre corpi, l’antitesi svapora. Siamo liberi. La parafrasi del detto crociano allude, ironicamente, a questo senso di libertà. Anzitutto libertà dal cristianesimo e dal suo impianto dicotomico. Inoltre, le antitesi sono facili. Semplificano la vita, ma bloccano il pensiero. Ragionare sui gradi di diversità tra due corpi è più complicato che fissare da un lato il corpo e dall’altro il suo opposto, cioè l’anima. In fondo, si tratta di restituire al ragionamento la sua dignità. Ragionare non è facile. In un certo senso, è un fare contro natura; di sicuro è un fare impopolare.
Che rapporto c’è tra lo stoicismo e la prassi politica? Epitteto, a differenza di Seneca, non si cura di scrivere libri né di ragionare sul governo, semmai sul governare se stessi.
C’è una parentela stretta tra Epitteto e Seneca. Musonio Rufo è a un tempo discepolo di Seneca e maestro di Epitteto. Sicché non può esserci troppa differenza tra il governo di uno stato e quello di se stessi. Il nesso c’è e va dissotterrato. Concetto Marchesi disse una volta che Seneca è stato il vero direttore della politica imperiale al tempo di Nerone. In altri termini, Seneca ha governato la più complessa realtà politica del mondo antico. Ma nei suoi scritti, come nei ragionamenti di Epitteto tramandati da Arriano, si insiste sopra tutto su un concetto: il governo degli altri passa attraverso il governo di sé. Questo è anche il titolo, appena variato, dell’ultimo corso accademico di Michel Foucault. Questo grande pensatore francese ha capito meglio di chiunque altro il senso dello stoicismo: governare se stessi è il frutto della disciplina etica e questo è il presupposto del governo degli altri. Non si tratta, tuttavia, di eticizzare la politica; questo è precisamente l’approdo della più alta riflessione liberale (e penso di nuovo a Croce); si tratta invece — è questo il nodo stoico da sciogliere — di strappare alla politica il primato dell’azione per restituirlo all’etica. Se ne cava un bel paradosso: l’atto è solo etico, la politica non agisce. Nel Novecento è stato Robert Musil a ripensare l’etica in questi termini.
Che rapporto ha lo stoicismo con il ‘mercato’, con l’economia, con il denaro?
Il rapporto è strettissimo. Lo stoicismo è una vera e propria filosofia del denaro. Il ruvido Spengler ha scritto che i Romani diventavano cristiani quando non potevano permettersi un maestro stoico. Era un problema di soldi. Al centro della scena c’è di nuovo Seneca. Tacito allude alle sue ricchezze favolose. E su questo patrimonio grava l’ombra dell’usura. Paul Veyne la racconta in modo diverso: Seneca è stato il primo a fondare un istituto di credito. Ma il pensiero del Cordovano trova questa sintesi: è cosa lodevole maneggiare il vasellame d’argilla come fosse d’argento; ma è altrettanto lodevole maneggiare il vasellame d’argento come fosse d’argilla. E conclude: solo i deboli non sono capaci di reggere la ricchezza. La stessa forza impiegata a governare il corpo agisce sulla ricchezza. Chi vive nel lusso non “regge” il denaro, vi soccombe.
In quali autori (al di là di Leopardi) vediamo in filigrana il pensiero di Epitteto?
Il 1825, l’anno in cui Leopardi porta a termine la sua straordinaria versione del Manuale, è per me il simbolico atto di nascita dello “stoicismo europeo”. Prima ho fatto cenno a Musil, a Foucault, ma bisogna parlare anzitutto di Nietzsche, che dagli stoici eredita il suo concetto più radicale: l’eterno ritorno delle stesse cose. Anche l’attenzione nicciana alle prescrizioni dietetiche viene dagli stoici. La Logique du sens, il testo più importante di Deleuze, è una riflessione sulla logica stoica. La sfuggente aforistica jüngeriana tradisce la medesima origine. Ma torniamo rapidamente a Leopardi. La sua versione del Manuale è un testo fondativo: non una semplice traduzione, ma una reinvenzione di Epitteto. C’è il Manuale di Arriano, che seguiva le lezioni del maestro a Nicopoli, e c’è il Manuale di Leopardi, che riplasma i dettami stoici per la modernità. Il Preambolo del volgarizzatore illustra questo programma nel modo più conseguente.
Che cosa ci insegna lo stoicismo di Epitteto rispetto al corpo, all’anima, al loro legame?
Dell’anima tace. Preferisce parlare di hêgemonikon, cioè del principio direttivo. L’hêgemonikon traccia il perimetro delle tue potenzialità. Se non lo conosci, se non lo misuri con precisione, la tua vita sarà una catena di fallimenti.Del corpo dice: puoi farne quello che vuoi, tanto non è tuo. Al di là della battuta, la questione è seria. L’insistenza stoica sulla morte, cioè sulla perdita del corpo, contiene una critica radicale del concetto di proprietà. Si perde il corpo come un qualsiasi patrimonio. La rinuncia al possesso del corpo è con ciò il presupposto della critica della proprietà. Se rinunci al possesso del corpo, rinunci a ogni altra proprietà, perché il nostro irresistibile istinto al possesso nasce dall’illusione che il corpo ci appartenga. Qui Epitteto dimostra la sua affinità con Seneca: corpo e denaro, carne e patrimonio, sono di qualcun altro, bisogna pertanto governarli, “reggerli”, come se non ci appartenessero. Nel Manuale c’è quest’altra immagine: abita il mondo come se fosse una locanda, la mobilia e il resto non ti appartengono, ma tu abbine cura. Governo senza proprietà, ecco la formula stoica del benessere.
Cosa direbbe Epitteto di fronte a fenomeni come la cancel culture, il ‘terrorismo dei benpensanti’, l’era del dominio della statistica, del numero, del controllo?
Se qualcuno t’insulta, suggerisce Epitteto, non ti devi difendere, ma devi dire: grazie per aver citato solo una minima parte dei difetti che mi affliggono. Jünger riprende il concetto in questi termini: tu e il tuo avversario tirate la fune da estremità opposte, se invece molli la presa, lui stramazza.
Infine: che cos’è la felicità?
Se lo chiede a me la risposta è ovvia: non ne ho idea. Se lo chiede a Epitteto lui risponde: felicità è rinuncia all’idea e alla prassi della proprietà.
Davide Brullo — L’Intellettuale Dissidente
[image error]Non possiamo non dirci stoici … was originally published in Lo Stoico del terzo millennio on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.
Siamo tutti in una rete, anzi in un “network” …
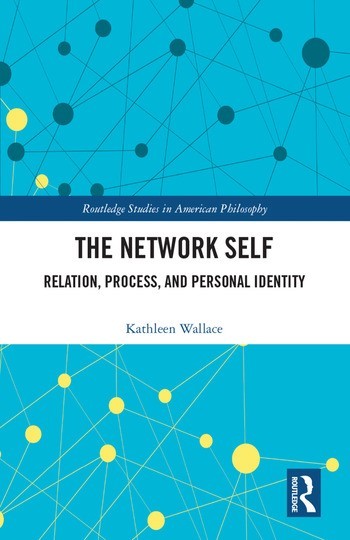 Il Libro
Il Libro
A qualcuno non piacerà la parola. Ancora un anglicismo, un altro attentato alla lingua italiana. Se fosse vivo il poeta secentesco metafisico inglese John Donne, direbbe:
“Siamo tutti in un arcipelago … nessuno uomo è un’isola”.
L’idea è sempre la stessa. Per la mia identità su questo blog ho scritto: “Nessuno è stato mai me. Può darsi che io sia il primo. Nobody has been me before. Maybe I’m the first one.”
Chi sono io? Tutti, prima o poi, ci poniamo questa domanda. La mia identità è determinata dal mio DNA oppure sono il prodotto, il risultato della mia crescita? Posso cambiare durante questo processo, come e di quanto? La mia identità è soltanto una, oppure sono diverse?
Domande forse filosofiche, antiche come se le poneva Socrate il quale pensava che la comprensione di sè fosse essenziale per sapere come vivere con se stessi e con gli altri. Tutto dipende da questa autoanalisi, da quella degli altri e del mondo in cui ci troviamo a vivere.
Anche le forme di governo si fondano sul modo in cui comprendiamo noi stessi e la natura umana. Quindi la domanda “Chi sono io?” ha implicazioni di vasta portata. Il libro che vedete qui sopra affronta questo problema, per me di primaria importanza.
Mi rendo conto che la penso in questo modo perchè, arrivati ad una certa età, raggiunto un certo punto della vita, ci si sorprende a guardarsi indietro nel tentativo di capire quello che abbiamo fatto, come lo abbiamo fatto e, possibilmente, anche perchè.
Facciamo il percorso sempre di corsa, raramente guardando indietro e intorno, riflettendo poco o niente su quello che facciamo. Arrivati a questo punto, mi pare naturale che arrivi il “memento mori”.
Nella rivista digitale internazionale AEON è apparso un articolo molto interessante su questo argomento intitolato “You are a network” con il sottotitolo: “Non puoi essere considerato soltanto un corpo, una mente o un ruolo sociale particolare. Una nuova teoria dell’individualità complessa”.
E’ stato scritto da Kathleen Wallace, Professoressa di filosofia alla Hofstra University di Hempstead, New York. Si occupa di etica e metafisica dell’identità personale e vive a New York City. Il testo che segue è un mio libero adattamento per la stesura di questo post in attesa di leggere il libro.
Molti filosofi, almeno in Occidente, hanno cercato di identificare le condizioni invariabili o essenziali dell’essere un sé. Un approccio ampiamente diffuso è quello che è noto come una visione della continuità psicologica del sé, in cui il sé è una coscienza con autoconsapevolezza e ricordi personali. A volte questi approcci inquadrano il sé come una combinazione di mente e corpo, come fece Cartesio, o come coscienza primaria o esclusiva. L’esperimento mentale del principe /povero di John Locke, in cui la coscienza di un principe e tutti i suoi ricordi vengono trasferiti nel corpo di un calzolaio, è un’illustrazione dell’idea che la personalità va con la coscienza.
I filosofi hanno ideato numerosi successivi esperimenti mentali che coinvolgono trasferimenti di personalità, cervelli divisi e teletrasporti per esplorare l’approccio psicologico. I filosofi contemporanei nel campo “animalista” sono critici nei confronti dell’approccio psicologico e sostengono che i sé sono essenzialmente organismi biologici umani. (Aristotele potrebbe anche essere più vicino a questo approccio che a quello puramente psicologico.) Sia l’approccio psicologico che quello animalista sono strutture di “contenitore”, che postulano il corpo come un contenitore di funzioni psicologiche o la posizione limitata delle funzioni corporee.
Tutti questi approcci riflettono la preoccupazione dei filosofi di concentrarsi su quale sia la caratteristica distintiva o di definizione di un sé, la cosa che sceglierà un sé e nient’altro, e che identificherà i sé come sé, indipendentemente dalle loro particolari differenze. Dal punto di vista psicologico, un sé è una coscienza personale. Dal punto di vista animalista, un sé è un organismo umano o animale.
Ciò tende a portare a una visione in qualche modo unidimensionale e semplificata di cosa sia un sé, tralasciando i tratti sociali, culturali e interpersonali che sono anche distintivi dei sé e sono spesso ciò che le persone considererebbero centrali per la loro identità personale.
Proprio come i sé hanno ricordi personali e consapevolezza di sé diversi, possono avere relazioni sociali e interpersonali, background culturali e personalità differenti. Questi ultimi sono variabili nella loro specificità, ma sono altrettanto importanti per essere un sé quanto la biologia, la memoria e la consapevolezza di sé.
Riconoscendo l’influenza di questi fattori, alcuni filosofi si sono opposti a tali approcci riduttivi e hanno sostenuto un quadro che riconoscesse la complessità e la multidimensionalità delle persone. La visione di sé della rete emerge da questa tendenza. È iniziato alla fine del XX secolo ed è continuato nel XXI, quando i filosofi hanno iniziato a muoversi verso una più ampia comprensione di sé.
Alcuni filosofi propongono visioni narrative e antropologiche dei sé. I filosofi comunitaristi e femministi sostengono punti di vista relazionali che riconoscono il radicamento sociale, la relazione e l’intersezionalità dei sé. Secondo le visioni relazionali, le relazioni sociali e le identità sono fondamentali per comprendere chi sono le persone.
Le identità sociali sono tratti del sé in virtù dell’appartenenza a comunità (locali, professionali, etniche, religiose, politiche) o in virtù di categorie sociali (come razza, genere, classe, appartenenza politica) o relazioni interpersonali (come essere un coniuge, fratello, genitore, amico, vicino).
Queste opinioni implicano che non è solo l’incarnazione e non solo la memoria o la coscienza delle relazioni sociali, ma le relazioni stesse che contano anche per chi è il sé. Quelle che i filosofi chiamano “visioni 4E” della cognizione (embodied, embedded, enactive and extended cognition) per la cognizione incarnata, incorporata, enattiva ed estesa, sono anche un movimento nella direzione di una visione del sé più relazionale, meno ‘contenitore’.
Le visioni relazionali segnalano un cambiamento di paradigma da un approccio riduttivo a uno che cerca di riconoscere la complessità del sé. La visione del sé in rete sviluppa ulteriormente questa linea di pensiero e afferma che il sé è relazionale in tutto e per tutto, costituito non solo da relazioni sociali ma anche fisiche, genetiche, psicologiche, emotive e biologiche che insieme formano un sé in rete. Anche il sé cambia nel tempo, acquisendo e perdendo tratti in virtù di nuovi luoghi e relazioni sociali, anche se continua come quel sé.
Come ti identifichi? Probabilmente hai molti aspetti di te stesso e resisteresti all’essere ridotto o stereotipato come uno di essi. Ma potresti ancora identificarti in termini di eredità, etnia, razza, religione: identità che sono spesso prominenti nella politica dell’identità. Potresti identificarti in termini di altre relazioni e caratteristiche sociali e personali : ‘Sono la sorella di Mary.’ “Sono un amante della musica.” “Sono il relatore di tesi di Emily.” “Sono di Chicago.”
Oppure potresti identificare le caratteristiche della personalità: “Sono un estroverso”; o impegni: “ci tengo all’ambiente”. ‘Sono onesto.’ Potresti identificarti relativamente: “Sono la persona più alta della mia famiglia”; o in termini di convinzioni o affiliazioni politiche: “Sono un indipendente”; o temporalmente: “Sono la persona che viveva in fondo al tuo corridoio al college” o “Mi sposo l’anno prossimo”. Alcuni di questi sono più importanti di altri, alcuni sono fugaci. Il punto è che chi sei è più complesso di qualsiasi tua identità. Pensare al sé come una rete è un modo per concettualizzare questa complessità e fluidità.
Facciamo un esempio concreto. Considera Lindsey: è sposa, madre, scrittrice, madrelingua inglese, cattolica irlandese, femminista, professoressa di filosofia, automobilista, organismo psicobiologico, introversa, timorosa delle altezze, mancina, portatrice della malattia di Huntington (HD), residente a New York City.
Questo non è un insieme esaustivo, solo una selezione di tratti o identità. I tratti sono collegati tra loro per formare una rete di tratti. Lindsey è una rete inclusiva, una pluralità di tratti legati tra loro. Il carattere complessivo, l’integrità, di un sé è costituito dall’interrelazione unica dei suoi particolari tratti relazionali, psicobiologici, sociali, politici, culturali, linguistici e fisici.
La Figura 1 di seguito si basa su un approccio alla modellazione delle reti ecologiche; i nodi rappresentano i tratti e le linee sono le relazioni tra i tratti (senza specificare il tipo di relazione).

Notiamo subito la complessa interrelazione tra i tratti di Lindsey. Possiamo anche vedere che alcuni tratti sembrano essere raggruppati, cioè legati più ad alcuni tratti che ad altri. Proprio come un corpo è una rete altamente complessa e organizzata di sistemi organismici e molecolari, il sé è una rete altamente organizzata. I tratti del sé possono organizzarsi in cluster o hub, come un cluster corporeo, un cluster familiare, un cluster sociale. Potrebbero esserci altri cluster, ma tenerlo a pochi è sufficiente per illustrare l’idea. Una seconda approssimazione, la Figura 2 di seguito, cattura l’idea del clustering.

Le figure 1 e 2 (entrambe dal mio libro, The Network Self) sono semplificazioni delle relazioni corporee, personali e sociali che compongono il sé. I tratti possono essere strettamente raggruppati, ma si incrociano e si intersecano anche con tratti in altri hub o cluster. Ad esempio, un tratto genetico, ‘portatore della malattia di Huntington’ (HD nelle figure 1 e 2), è correlato a tratti biologici, familiari e sociali. Se si conosce lo stato di portatore, esistono anche relazioni psicologiche e sociali con altri portatori e con le comunità familiari e mediche. I cluster o le sottoreti non sono isolati o hub chiusi in se stessi e potrebbero raggrupparsi man mano che il sé si sviluppa.
A volte la sua esperienza potrebbe essere fratturata, come quando altri prendono una delle sue identità come la definizione di tutta lei. Alcuni tratti potrebbero essere più dominanti di altri. Essere un coniuge potrebbe essere fortemente rilevante per chi è Lindsey, mentre essere una zia debolmente rilevante. Alcuni tratti potrebbero essere più salienti in alcuni contesti rispetto ad altri. Nel quartiere di Lindsey, essere un genitore potrebbe essere più importante dell’essere un filosofo, mentre all’università essere un filosofo è più importante.
Lindsey può avere un’esperienza olistica della sua identità di rete multiforme e interconnessa. A volte, però, la sua esperienza potrebbe essere fratturata, come quando altri considerano una delle sue identità come la definizione di tutta lei. Supponiamo che, in un contesto lavorativo, non sia promossa, guadagni uno stipendio più basso o non sia considerata per un lavoro a causa del suo genere.
La discriminazione si verifica quando un’identità — razza, genere, etnia — diventa il modo in cui qualcuno viene identificato dagli altri, e quindi potrebbe sperimentare se stesso come ridotto o oggettivato. È la rilevanza inappropriata, arbitraria o sleale di un tratto in un contesto. Lindsey potrebbe sentire un conflitto o una tensione tra le sue identità.
Potrebbe non voler essere ridotta o stereotipata da nessuna identità. Potrebbe sentire il bisogno di dissimulare, sopprimere o nascondere una certa identità, nonché sentimenti e credenze associati. Potrebbe sentire che alcuni di questi non sono essenziali per chi è veramente. Ma anche se alcuni sono meno importanti di altri, e alcuni sono fortemente rilevanti per chi è e come si identifica, sono ancora tutti modi interconnessi in cui Lindsey è.
Le figure 1 e 2 sopra rappresentano il sé della rete, Lindsey, in una sezione temporale, diciamo tra la prima e la metà dell’età adulta. E la mutevolezza e la fluidità del sé? E le altre fasi della vita di Lindsey? Lindsey all’età di cinque anni non è un coniuge o una madre, e le fasi future di Lindsey potrebbero includere anche tratti e relazioni diverse: potrebbe divorziare o cambiare carriera o subire una trasformazione dell’identità di genere. Anche il sé della rete è un processo.
All’inizio potrebbe sembrare strano pensare a te stesso come a un processo. Potresti pensare che i processi siano solo una serie di eventi e il tuo sé si sente più sostanziale di così. Forse pensi a te stesso come a un’entità distinta dalle relazioni, che il cambiamento è qualcosa che accade a un nucleo immutabile che sei tu. Saresti in buona compagnia se lo facessi. C’è una lunga storia in filosofia che risale ad Aristotele che sosteneva una distinzione tra una sostanza e le sue proprietà, tra sostanza e relazioni e tra entità ed eventi.
Tuttavia, l’idea che il sé sia una rete e un processo è più plausibile di quanto si possa pensare. Le sostanze paradigmatiche, come il corpo, sono sistemi di reti che sono in costante processo anche quando non lo vediamo a livello macro: le cellule vengono sostituite, i capelli e le unghie crescono, il cibo viene digerito, i processi cellulari e molecolari sono in corso come finché il corpo è vivo. La coscienza o il flusso della consapevolezza stessa è in costante flusso. Le disposizioni o gli atteggiamenti psicologici possono essere soggetti a variazioni nell’espressione e nell’occorrenza. Non sono fissi e invariabili, anche quando sono aspetti in qualche modo stabilizzati di un sé.
I tratti sociali si evolvono. Ad esempio, Lindsey-come-figlia si sviluppa e cambia. Lindsey-come-madre non è solo legata ai suoi tratti attuali, ma anche al suo passato, a come ha vissuto l’essere figlia. Molte esperienze e relazioni passate hanno modellato il modo in cui è ora. Si potrebbero acquisire nuove credenze e atteggiamenti e rivedere quelli vecchi.
C’è anche costanza, poiché i tratti non cambiano tutti allo stesso ritmo e forse alcuni non cambiano affatto. Ma la diffusione temporale, per così dire, del sé significa che il modo in cui un sé nel suo insieme è in qualsiasi momento è un risultato cumulativo di ciò che è stato e di come si sta proiettando in avanti.
Ancoraggio e trasformazione, identità e cambiamento: la rete cumulativa è sia-e, non sia-o-o
Piuttosto che una sostanza sottostante e immutabile che acquisisce e perde proprietà, stiamo facendo un cambio di paradigma per vedere il sé come un processo, come una rete cumulativa con un’integrità mutevole. Una rete cumulativa ha struttura e organizzazione, come fanno molti processi naturali, sia che si pensi agli sviluppi biologici, ai processi fisici o ai processi sociali. Pensa a questa costanza e struttura come fasi del sé che si sovrappongono o si mappano l’una sull’altra.
Per Lindsey, essere un fratello si sovrappone da Lindsey a sei anni alla morte del fratello; essere un coniuge si sovrappone da Lindsey-at-30 alla fine del matrimonio. Inoltre, anche se suo fratello muore, o il suo matrimonio si sgretola, fratello e coniuge sarebbero ancora tratti della storia di Lindsey Lind- historyuna storia che le appartiene e modella la struttura della rete cumulativa.
Se il sé è la sua storia, significa che non può davvero cambiare molto? Che dire di qualcuno che vuole essere liberato dal suo passato o dalle sue circostanze presenti? Chi emigra o fugge dalla famiglia e dagli amici per iniziare una nuova vita o subisce una trasformazione radicale non cessa di essere quello che era. Infatti, le esperienze di conversione o trasformazione sono di quell’io, di colui che si converte, si trasforma, emigra.
Allo stesso modo, immagina l’esperienza del rimpianto o della rinuncia. Hai fatto qualcosa di cui ora ti penti, che non rifaresti mai più, che senti fosse un’espressione di te stesso quando eri molto diverso da quello che sei ora. Tuttavia, il rimpianto ha senso solo se sei la persona che in passato ha agito in qualche modo. Quando ti penti, rinunci e chiedi scusa, riconosci il tuo sé cambiato come continuo e proprietario del tuo passato come autore dell’atto. Ancoraggio e trasformazione, continuità e liberazione, identità e cambiamento: la rete cumulativa è sia-e, non sia-o.
La trasformazione può accadere a un sé o può essere scelta. Può essere positivo o negativo. Può essere liberatorio o decrescente. Prendi una trasformazione scelta. Lindsey subisce una trasformazione di genere e diventa Paul. Paul non cessa di essere Lindsey, il sé che ha sperimentato una discrepanza tra il genere assegnato e il proprio senso di autoidentificazione, anche se Paul potrebbe preferire che la sua storia come Lindsey sia una dimensione non pubblica di se stesso.
La rete cumulativa ora conosciuta come Paul conserva ancora molti tratti, biologici, genetici, familiari, sociali, psicologici, della sua precedente configurazione come Lindsey, ed è modellata dalla storia di essere stata Lindsey. Oppure considera l’immigrato. Non cessa di essere la persona la cui storia include l’essere stata residente e cittadina di un altro paese.
Il sé della rete è mutevole ma continuo in quanto mappa su una nuova fase del sé. Alcuni tratti diventano rilevanti in modi nuovi. Alcuni potrebbero cessare di essere rilevanti nel presente pur rimanendo parte della storia del sé. Non c’è un percorso prescritto per il sé. Il sé è una rete cumulativa perché la sua storia persiste, anche se ci sono molti aspetti della sua storia che un sé rinnega andando avanti o anche se cambia il modo in cui la sua storia è rilevante. Riconoscere che il sé è una rete cumulativa ci consente di spiegare perché la trasformazione radicale riguarda un sé e non, letteralmente, un sé diverso.
Ora immagina una trasformazione che non è stata scelta ma che capita a qualcuno: per esempio a un genitore con il morbo di Alzheimer. Sono ancora genitore, cittadino, coniuge, ex professore. Sono ancora la loro storia; sono ancora quella persona che sta subendo un cambiamento debilitante. Lo stesso vale per la persona che sperimenta un drammatico cambiamento fisico, qualcuno come l’attore Christopher Reeve che ha avuto la tetraplegia dopo un incidente, o il fisico Stephen Hawking le cui capacità sono state gravemente compromesse dalla SLA (malattia del motoneurone).
Ognuno era ancora genitore, cittadino, coniuge, attore / scienziato ed ex atleta. Il genitore con demenza sperimenta la perdita della memoria e delle capacità psicologiche e cognitive, una diminuzione in un sottoinsieme della sua rete. La persona con tetraplegia o SLA sperimenta la perdita delle capacità motorie, una diminuzione del corpo. Ciascuno porta indubbiamente all’alterazione dei tratti sociali e dipende dall’ampio sostegno degli altri per sostenersi come sé.
A volte le persone dicono che la persona con demenza che non conosce più se stessa o gli altri non è davvero la stessa persona che era, o forse non è nemmeno una persona. Ciò riflette un appello alla visione psicologica — che le persone sono essenzialmente coscienza. Ma vedere il sé come una rete ha una visione diversa. L’integrità del sé è più ampia della memoria e della coscienza personali. Un sé diminuito potrebbe avere ancora molti dei suoi tratti, tuttavia la storia di quel sé potrebbe essere costituita in modo particolare. Platone, molto prima di Freud, riconobbe che la conoscenza di sé è una conquista faticosamente e provvisoria
Il toccante racconto “Still Gloria” (2017) della bioeticista canadese Françoise Baylis sull’Alzheimer di sua madre riflette questa prospettiva. Quando visita sua madre, Baylis aiuta a sostenere l’integrità di sé di Gloria anche quando Gloria non può più farlo da sola. Ma è ancora se stessa. Questo significa che la conoscenza di sé non è importante? Ovviamente no. Le capacità diminuite di Gloria sono una contrazione del suo sé e potrebbero essere una versione di ciò che accade in una certa misura per un sé che invecchia che sperimenta un indebolimento delle capacità.
E qui c’è una lezione per ogni sé: nessuno di noi è completamente trasparente a se stesso. Questa non è un’idea nuova; anche Platone, molto prima di Freud, riconobbe che esistevano desideri inconsci e che la conoscenza di sé è una conquista faticosamente conquistata e provvisoria. Il processo di auto-interrogazione e scoperta di sé è in corso nella vita perché non abbiamo identità fisse e immutabili: la nostra identità è multipla, complessa e fluida.
Questo significa che neanche gli altri ci conoscono perfettamente. Quando le persone cercano di fissare l’identità di qualcuno come una caratteristica particolare, può portare a incomprensioni, stereotipi, discriminazioni. La nostra retorica attualmente polarizzata sembra fare proprio questo: bloccare le persone in categorie ristrette: “bianco”, “nero”, “cristiano”, “musulmano”, “conservatore”, “progressista”. Ma i sé sono molto più complessi e ricchi.
Vederci come una rete è un modo fertile per comprendere la nostra complessità. Forse potrebbe anche aiutare a rompere gli stereotipi rigidi e riduttivi che dominano l’attuale discorso culturale e politico e coltivare una comunicazione più produttiva. Potremmo non comprendere perfettamente noi stessi o gli altri, ma spesso abbiamo identità e prospettive sovrapposte. Piuttosto che vedere le nostre identità multiple come separanti l’una dall’altra, dovremmo vederle come basi per la comunicazione e la comprensione, anche se parziali.
Lindsey è una filosofa bianca. La sua identità di filosofa è condivisa con altri filosofi (uomini, donne, bianchi, non bianchi). Allo stesso tempo, potrebbe condividere un’identità di filosofa con altre filosofe le cui esperienze come filosofi sono state modellate dall’essere donne. A volte la comunicazione è più difficile di altre, come quando alcune identità vengono rifiutate ideologicamente o sembrano così diverse che la comunicazione non riesce a decollare. Ma le identità multiple del sé della rete forniscono una base per la possibilità di un terreno comune.
In quale altro modo l’auto della rete potrebbe contribuire alle preoccupazioni pratiche e viventi? Uno dei più importanti contributori al nostro senso di benessere è il senso di avere il controllo delle nostre vite, di essere auto-diretti. Potresti preoccuparti che la molteplicità del sé della rete significhi che è determinato da altri fattori e non può essere autodeterminante. Il pensiero potrebbe essere che la libertà e l’autodeterminazione inizino da zero, con un sé che non ha caratteristiche, relazioni sociali, preferenze o capacità che lo predeterminano.
Ma un tale sé mancherebbe di risorse per darsi una direzione. Un tale essere sarebbe sballottato da forze esterne piuttosto che realizzare le proprie potenzialità e fare le proprie scelte. Sarebbe casualità, non autodeterminazione. Al contrario, piuttosto che limitare il sé, la visione della rete vede le identità multiple come risorse per un sé che sta attivamente impostando la propria direzione e facendo scelte per se stesso.
Lindsey potrebbe dare la priorità alla carriera rispetto alla genitorialità per un periodo di tempo, potrebbe impegnarsi a finire il suo romanzo, mettendo da parte il lavoro filosofico. Nulla impedisce a un sé di rete di scegliere liberamente una direzione o di crearne di nuove. L’autodeterminazione esprime il sé. È radicato nell’auto-comprensione.
La visione del sé della rete prevede un sé arricchito e molteplici possibilità di autodeterminazione, piuttosto che prescrivere un modo particolare che i sé dovrebbero essere. Ciò non significa che un sé non abbia responsabilità verso e per gli altri. Alcune responsabilità potrebbero essere ereditate, sebbene molte siano scelte. Fa parte del tessuto della convivenza con gli altri. I sé non sono solo ‘in rete’, cioè nei social network, ma sono essi stessi reti. Abbracciando la complessità e la fluidità dei sé, arriviamo a una migliore comprensione di chi siamo e di come vivere bene con noi stessi e gli uni con gli altri.
Per saperne di più sul sé, visita la rivista digitale internazionale AEON che si occupa della condizione umana pubblicando articoli in lingua inglese di psicologia, filosofia, arti e scienza.
Originally published at https://aeon.co on May 18, 2021.

May 17, 2021
“Una rosa è una rosa, una rosa …”
Sta per finire questo mese di maggio, un altro mese dedicato alle rose. Il mese delle rose. Un fiore sul quale gli uomini proiettano i loro sogni, il loro io emotivo, spirituale e sessuale. Nasce da sempre e si rinnova di anno in anno, il racconto di questo fiore che ha dentro di sè qualcosa di magico.
La rosa venne creata da Dio per dar vita al simbolismo, alla metafora, alle allusioni. La rosa non è un fiore, ma tanti fiori, in tante forme e colori. Petali a cinque a cinque che fioriscono intorno a delle spine. Una delizia alla vista, al profumo, al tatto e perfino al gusto. Manca soltanto la musica a questo fiore quanto mai misterioso che per millenni ha catturato la fantasia degli esseri umani.
Rose che sono diventate versi, musica, colori, immagini nella storia dell’arte, della fotografia e del cinema, della moda e dello stile. Un fiore che nel corso della sua storia millenaria ha subito trasformazioni e metamorfosi. Da semplice fiore selvaggio si è trasformato in fiore sofisticato da laboratorio.
La storia di questo fiore è narrata come simbolo sacro e simbolo di femminilità, la rosa unisce Venere e la Vergine Maria, il sangue di Cristo e il sudore di Maometto, il sacro e il profano, la vita e la morte, la rosa bianca della castità e la rosa rossa del compimento. Un fiore che manifesta il suo potere e la sua presenza in tutte le società umane.
La rosa viaggia dal tempo degli antichi greci e dell’impero romano verso l’Europa, il Medio oriente, l’Asia e le Americhe per far conoscere la sua evoluzione da semplice fiore di selva dell’emisfero nord fino alla sua massima perfezione raggiunta nei giardini di oggi diventati laboratori di esperienze celesti.
Fiore sessuale e letterario, affiliato alle società segrete e legato alla Terra Santa, la rosa si conferma regina dei fiori e della natura. Mi ha sempre colpito una frase, un pensiero, un verso, non so come definirlo, di Gertrude Stein quando scrive: “Una rosa è una rosa, una rosa”. Può significare niente o tutto. Dipende da chi la vede, la guarda e osserva le sue infinite varietà.
Forse l’interpretazione di questo verso sta proprio in questa indefinita ed infinita varietà. Dice semplicemente “Rosa è una rosa è una rosa è una rosa”, e sembra compia uno sforzo inutile. Certo che una rosa è una rosa e, all’apparenza, la ripetizione ossessiva del termine sembra avere soltanto una funzione estetica, il ripetersi nella mente il verso, come se fosse un mantra, ipnotico e bellissimo.
Invece succede che, a ogni nuova “rosa”, ci viene l’idea che il senso del discorso si faccia via via più grande, più misterioso e carico di significati che la semplice parola “rosa” non contiene. Che cosa succede? Lo spiega Umberto Eco in un saggio, La struttura assente, in cui individua addirittura cinque cose che succedono grazie a quella frase apparentemente semplice:
- c’è un eccesso di ridondanza, e la ridondanza genera tensione: la Stein ci vuole dire qualcosa;
- il principio di identità (“una rosa è una rosa”) è così marcato e ripetuto che diventa ambiguo: è davvero una rosa, quella di cui parla Stein? La terza volta che nomina la rosa intende la stessa rosa della prima volta?
- perché Stein ci dice questa cosa in questo modo? Che cosa vuole dire davvero?
- forse ripete ossessivamente la parola “rosa” perché vuole alludere ai suoi significati simbolici: ci sta parlando dell’amore senza nominarlo? Vuole solo suggerirlo? Dunque sì: la prima rosa è una rosa, la seconda forse è già l’amore… e la terza? (Tenete poi conto che, nella poesia, si nomina a un certo punto un certo Jack Rose…);
- che cosa capisco io di quello che mi sta dicendo Stein? Lei dice soltanto “rosa”, e mi lascia libero di riempire quella parola dei significati che più mi appartengono e sento vicini. Chiama in causa letture, sentimenti, congetture. Chiama in causa me.
Che dire poi delle domande che si pone Pablo Neruda in questa sua poesia che ve la propongo in tre versioni:
Tell me, is the rose naked
or is that her only dress?
Why do trees conceal
the splendor of their roots?
Who hears the regrets
of the thieving automobile?
Is there anything in the world sadder
than a train standing in the rain?
— -
Dime, Ia rosa està desnuda
0 solo tiene ese vestido?
Por que los àrboles esconden
el esplendor de sus raices?
Quien oye los remordimientos
del automovil criminal?
Hay ago mas triste en el mundo
que un tren inmovil en Ia lluvia?
— -
Dimmi, la rosa è nuda
o quello è il suo abito?
Perchè gli alberi nascondono
lo splendore delle loro radici?
Chi sente i lamenti
dell’auto rubata?
C’è qualcosa al mondo più triste
di un treno fermo sotto la pioggia?
Quest’anno pandemico ci ha proibito di prendere parte alla tradizionale potatura del roseto al Giardino Segreto dell’Anima in quel di Campinola, una frazione del Comune di Tramonti, in Costa d’Amalfi. Enza Telese e Antonio De Marco non hanno potuto rinnovare il loro tradizionale invito a partecipare a questo evento che si rinnova ogni anno nel mese di maggio. Antonio lo chiama Il piacere delle spine, una metafora poetica naturale di grande impatto per un fiore che è “una rosa, una rosa …”
[image error]May 15, 2021
I 50 libri che hanno cambiato il mondo? Leggere è sempre un punto di vista personale.
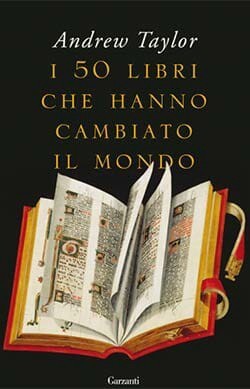 Il libro
Il libro
Per rispondere ad una domanda come questa bisognerebbe conoscere innanzitutto l’importanza dell’oggetto chiamato libro, non prima però di avere stabilito le caratteristiche del contenuto.
Se già Qohelet, un paio di millenni fa, si poneva la domanda se fosse proprio necessario avere tanti libri, (a quel tempo!), oggi, che ai libri cartacei si sono affiancati quelli digitali, è legittimo continuare a chiederselo.
Considerato anche i grandi cambiamenti che si sono avuti dopo l’invenzione della stampa a caratteri mobili con Gutenberg, la scomparsa degli amanuensi e la comparsa dei tipografi, oggi la digitalizzazione è destinata ad operare una più che certa e straordinaria trasformazione nel mondo della comunicazione.
Con questa parola si intende il processo che inizia con il pensare, si materializza con la scrittura, si realizza con la lettura e si trasforma in conoscenza e sapere. Se la prima copia a stampa della Bibbia e tutti i libri successivi che affollano le biblioteche del mondo, nelle tante lingue degli uomini, hanno cambiato almeno una parte del pianeta e alimentato i pensieri degli abitanti nel corso dei secoli, si spera che questi intelligenti «oggetti» chiamati libri, continuino a farlo anche in bits & byte, in positivo. Nonostante tutti i possibili Hitler scrittori non manchino.
E allora, quali sono i libri che hanno costruito la realtà in cui viviamo? Con originalità e arguzia, Andrew Taylor raccoglie la difficile sfida di elencare le cinquanta opere che hanno modificato per sempre il corso della storia, scegliendo di raccontare le vicende dell’uomo attraverso quei testi che, nei secoli e nelle epoche più diverse, ci hanno arricchiti, hanno reso il mondo un posto migliore, ma spesso sono anche diventati il pretesto di guerre e di tragiche divisioni.
In un percorso affascinante e mai scontato che parte dall’Iliade fino ad arrivare alla fortunata saga di Harry Potter, incontriamo così il Kamasutra e il Manifesto del partito comunista, la Bibbia e il Corano, ma anche Niccolò Machiavelli, Galileo Galilei e Primo Levi, senza dimenticare quell’indispensabile volume che per anni non è mai mancato nelle nostre case: l’elenco telefonico, ormai scomparso. È’ stato sostituito da Google, sempre disponibile e a portata di mano.
Di ogni opera Taylor ci racconta la genesi, le peculiarità, i sogni o gli incubi che hanno suscitato. Il risultato è uno straordinario inno alla forza della parola scritta e una celebrazione unica del potere della lettura: un’opera ricca e per molti aspetti provocatoria dedicata a tutti coloro che sono ancora convinti che con i libri sia possibile cambiare il mondo.
Se ci credete, continuate a leggere ed acquistare libri come e dove vi pare. In cartaceo, digitale, video audio, dalla A alla Z. Tra qualche giorno, Amazon sarà in grado di fornircelo anche in pillole. Qui di seguito la lista di Taylor, la sua lista, ovviamente, che non può essere di tutti. Leggere è sempre un punto di vista personale.
Ecco i 50 libri scelti dall’autore:
1. Iliade di Omero (VIII secolo a.C.)
2. Le Storie di Erodoto (V secolo a.C.)
3. Dialoghi di Confucio (V secolo a.C.)
4. La Repubblica di Platone (IV secolo a.C.)
5. Bibbia (II secolo a.C. — II secolo d.C.)
6. Odi di Orazio (23–13 a.C.)
7. Geografia di Tolomeo (ca. 100–170 d.C.)
8. Kama Sutra di Vatsyayana–(II o III secolo d.C.)
9. Corano (VII secolo d.C.)
10. Il canone della medicina di Avicenna (1025)
11. I racconti di Canterbury di Geoffrey Chaucer (1380–1390)
12. Il Principe di Niccolò Machiavelli (1532 75)
13. L’Atlante, o Meditazioni cosmografiche di Gerardo Mercatore (1585–1595)
14. Don Chisciotte della Mancia di Miguel de Cervantes (1605–1615)
15. First Folio di William Shakespeare (1623)
16. Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus di William Harvey (1628)
17. Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo di Galileo Galilei (1632)
18. Principia mathematica di Isaac Newton (1687)
19. A Dictionary of the English Language di Samuel Johnson (1755)
20. I dolori del giovane Werther di Wolfgang Goethe (1774)
21. La ricchezza delle nazioni di Adam Smith (1776)
22. Senso comune di Thomas Paine (1776)
23. Ballate liriche di William Wordsworth e Samuel Taylor Coleridge (1798)
24. Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen (1813)
25. Canto di Natale di Charles Dickens (1843)
26. Il manifesto del partito comunista di Karl Marx (1848)
27. Moby Dick di Herman Melville (1851)
28. La capanna dello zio Tom di Harriet Beecher Stowe (1852)
29. Madame Bovary di Gustave Flaubert (1857)
30. L’origine delle specie di Charles Darwin (1859)
31. Saggio sulla libertà di John Stuart Mill (1859)
32. Guerra e pace di Lev Tolstoj (1869)
33. Elenco abbonati del distretto telefonico di New Haven (1878)
34. Le mille e una notte (XV secolo d.C.versione del 1885 di Sir Richard Burton)
35. Uno studio in rosso di Arthur Conan Doyle (1888)
36. L’interpretazione dei sogni di Sigmund Freud (1899)
37. I protocolli dei savi di Sion (1905)
38. Poesie di Wilfred Owen (1920)
39. Teoria speciale e generale della relatività di Albert Einstein (1920)
40. Ulisse di James Joyce (1922)
41. L’amante di Lady Chatterley di D.H. Lawrence (1928)
42. Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta di John Maynard Keynes (1936)
43. Se questo è un uomo di Primo Levi (1947)
44. 1984 di George Orwell (1949)
45. Il secondo sesso di Simone de Beauvoir (1949)
46. Il giovane Holden di J.D. Salinger (1951)
47. Il crollo di Chinua Achebe (1958)
48. Primavera silenziosa di Rachel Carson (1962)
49. Libretto rosso di Mao Tse-tung (1964)
50. Harry Potter e la pietra filosofale di J.K. Rowling (1997)

May 11, 2021
L’effetto “random” …

Può essere facile. Può essere un attimo o solo una cattiva abitudine. Non importa. È anche facile pensare di poter gestire questa faccenda della vita, perché siamo sopravvissuti a passate grandi avversità. In verità, siamo tutti vulnerabili. Alle nostre abitudini. Alle debolezze inaspettate.
“Grandi cose possono uccidere un uomo, ma se non accade, buon per loro”, ha scritto una volta John Steinbeck . “Un uomo può essere distrutto dai morsi di fastidiose papere, da pochi spiccioli, da telefoni, da un piede d’atleta, dall’ambrosia, da un raffreddore, dalla noia. Piccoli insignificanti aspetti negativi, le piccole frustrazioni e nessuno è più forte“.
Dai greci ci ricordiamo del “tallone d’Achille” . Un uomo grande e potente, disfatto dal suo unico punto debole. Da Zenone ci viene ricordato che i piccoli passi, non sono cosa da poco. Lo stesso vale per l’elenco dei disturbi e dell’entropia menzionata da Steinbeck.
Cicerone è stato distrutto, a pensarci bene, da un semplice atto di indecisione. Marco Aurelio è stato torturato da un mal di stomaco. Zenone ha visto arrivare la fine quando si è rotto un dito!
Dobbiamo stare attenti alle piccole cose. Non siamo invincibili. Non dovremmo dare per scontata la nostra salute, la ricchezza vera o apparente, le forza evidente o apparente. Dobbiamo essere consapevoli dei nostri punti deboli.
Dovremmo stare attenti alle piccole frustrazioni, ai piccoli accadimenti, a meno che non si uniscano e cessino di essere così piccoli. Impariamo a progettare la vita e organizzare le difese non solo contro un nemico invisibile quanto diabolico come il Covid 19 ma anche contro la imprevedibilità del vivere. L’effetto random incombe sempre su ognuno di noi …

L’effetto “random” … was originally published in Lo Stoico del terzo millennio on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.
May 8, 2021
La “fragile perfezione del sistema …”
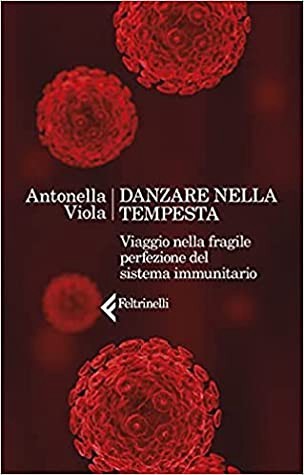
Quando ho visto sul bancone del giornalaio questo libro non sapevo quello a cui sarei andato incontro leggendolo.
Avevo avuto modo di vedere l’autrice in tv durante una delle tante trasmissioni dedicate al “viaggio” che stiamo facendo ormai da un anno e più. Sapevo molto, anzi direi troppo, nel senso di troppo poco, della “tempesta” e del viaggio ai quali il libro si riferiva, ma poco o niente del sistema immunitario.
Avrei dovuto sapere cosa sono gli anticorpi, i linfociti, le citochine, chemochine, istamina, neutrofili, linfociti B, linfociti T, linfociti NK, macrofagi, fagociti, granulociti, basofili, interferoni, prostaglandine, cellule staminali ematopoietiche pluripotenti, interleuchina 1 e molto altro ancora.
Sono circa trecento i tipi di cellule immunitarie, anche se alcuni studiosi sostengono che il numero è di fatto incalcolabile. Il colpo definitivo me lo dato poi la notizia che sono incalcolabili anche i sistemi immunitari, essendo unici come gli individui. Difficile, se non impossibile, quindi, generalizzarli, comprenderli e curarli. Capirete, allora, con quale animo mi sono dato alla lettura del libro.
Devo dire, comunque, che l’immunologa Antonella Viola, professoressa ordinaria di Patologia generale presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Padova, scrive non come una scienziata ma come una vera scrittrice, per comunicare e per far capire qual è il senso della “tempesta” che ci ha colpiti. Nel prologo al libro, la scienziata scrive:
“Nessuno ci ha avvertito, ma il mondo è già cambiato. Di fronte ad una trasformazione epocale e definitiva come quella che stiamo vivendo, le reazioni possibili sono tante. Le abbiamo davanti agli occhi: la maggior parte delle risposte provenienti dalla politica e anche dai cittadini è dettata dallo sgomento e dalla paura, dalla difficoltà di rinunciare alle vecchie abitudini e alla forma che il mondo aveva prima. E così che si generano mostri ed è così che, anche senza volerlo, partecipiamo al divenire danneggiando noi stessi.”
Il suo viaggio inizia cercando di introdurre il lettore a pensare cos’è il nostro sistema immunitario in termini di immunità ed evoluzione. Darwin, ovviamente, ha la sua parte, secondo lei uno dei più grandi geni che l’umanità abbia avuto. In tale ambiente si annida il nemico, anzi i nemici, l’ultimo arrivato è il Covid 19. Ma per fare una operazione del genere bisogna prima conoscere veramente se stessi.
Qui inizia la “danza” tra sensibilità e specificità, freni e stimoli, un vero e proprio “tango” con le cellule. Puoi incontare di tutto in un ambiente del genere, chimere e tumori che operano sfruttando tutto il tempo necessario per diffondersi. Una possibile speranza di difesa è il vaccino un’arma in grado di ristabilire l’equilibrio perduto del sistema ed arrestare l’infiammazione.
Il nostro sistema di vita gioca un ruolo decisivo, in un mondo caratterizzato dalla imperfezione, in continua ricerca dell’equilibrio. Servirebbe tempo per acquisirlo ma quello che sappiamo è sempre poco di fronte a quello che ignoriamo. La scienziata scrive:
“La corsa scomposta con cui abbiamo affrontato quest’ultimo anno deve lasciare il posto ad una danza armoniosa guidata dalla razionalità e dalla cooperazione, dalla verifica e dal confronto basato sui fatti. Perchè se c’è una lezione che abbiamo imparato è che, come le cellule del nostro sistema immunitario, siamo tutti collegati e il benessere di ognuno di noi dipende dal benessere che siamo in grado di costruire come società, ascoltando e proteggendo l’ambiente che ci circonda”.
Potrei dire questo punto “niente di nuovo sotto il sole”. Il poeta inglese John Donne, fin dal seicento, nella sua poesia metafisica aveva brillantemente intuito la necessità del “tutto”, ovvero della necessità di tenere uniti gli uomini visti come “pezzi” costitutivi di un “continente, del “tutto”, cioè dell’umanità.
“Nessun uomo è un’isola, intero per se stesso;
Ogni uomo è un pezzo del continente,
parte della Terra intera ; e se una sola zolla vien portata via
dall’onda del mare, qualcosa all’Europa viene a mancare,
come se un promontorio fosse stato al suo posto,
o la casa di un uomo, di un amico o la tua stessa casa ”
Ma il tempo e la imperfezione continuano ad essere una minaccia per la nostra umana evoluzione. Se il primo con i suoi errori e con la selezione naturale genera diversità, l’evoluzione che continua misteriosamente a procedere determina l’inevitabile invecchiamento e la fine. Prima della conclusione del libro, la scrittrice e scienziata scrive un capitolo intitolato: “Quello che non sappiamo”. Lo dice chiaramente:
“La pandemia di Covid 19 ha avuto tra gli altri, l’effetto di mostrarci chiaramente quante cose ancora non sappiamo del nostro sistema immunitario”.
Possiamo anche allegramente imparare a danzare con il nostro sistema immunitario per attraversare la tempesta guardando in noi stessi e prendendo la grande lezione di convivenza fra le parti e il tutto, fra gli individui e l’ambiente che ci circonda. Resterà, comunque, un ossimoro, un mistero sia del singolo (o dell’isola) che del tutto: “la fragile perfezione del sistema…”

Il mio “coccodrillo” è pronto …
 Zafferano News
Zafferano News
ZAFFERANO NEWS è un settimanale gratuito online che ha lanciato l’idea ai lettori di scrivere il proprio coccodrillo. Anche io ho scritto il mio che avete letto qui sopra a firma Galloway. L’ho anticipato su MEDIUM in un precedente post …
“Una ventina di persone, uomini liberi che campano del proprio lavoro in aree lontane dal giornalismo, amiamo la lettura e ci piace scrivere (ed essere letti). Abbiamo trasformato la nostra “competenza di lettori” in una “competenza dell’execution giornalistica”, attingendo a principi e valori delle nostre passate esperienze professionali. Sappiamo di essere nulla più che degli artigiani del giornalismo, e come tali ci proponiamo. Le persone ricche e potenti, fra i tanti privilegi, hanno pure quello che un giornalista celebre scriva un articolo sul quotidiano per ricordarlo il giorno della sua morte. Essendo tutte le morti improvvise, per definizione, il pezzo viene scritto in anticipo, e costantemente aggiornato per essere pronto alla bisogna. In termini tecnici si chiama “coccodrillo”.

May 4, 2021
Quali Santi pregare per difenderci dalla Pandemia?
 La Chiesa di San Bartolomeo Apostolo a Novella di Tramonti, Costa d’Amalfi
La Chiesa di San Bartolomeo Apostolo a Novella di Tramonti, Costa d’Amalfi
 Quotidiano “Libero” 3 maggio 2021
Quotidiano “Libero” 3 maggio 2021Da un anno e mezzo gli abitanti del pianeta Terra lottano globalmente contro un nemico tanto invisibile quanto implacabile.
Nessuno sembra essere in grado di trovare un sistema efficace che possa arrestare la strage di innocenti effettuata da questo virus chiamato Covid 19 per il quale ritorna un antico termine: un flagello pandemico.
Nessuno è riuscito finora a trovare un rimedio sicuro, non solo per curare questo morbo, ma anche un sistema che riesca a fermare la sua inarrestabile ed irresistibile diffusione.
Ormai i morti si contano a milioni. È vero che in fretta e furia sono stati creati diversi vaccini che fanno da protezione e barriera. Ma è anche vero che questo ignobile nemico riesce ad essere mutante, si adatta non solo nello spazio dove si diffonde, ma anche a trasformarsi a seconda dell’ambiente in cui penetra. Le previsioni sulla sua scomparsa sono piuttosto pessimistiche.
Attila venne definito “flagello di Dio". Forse non è un caso che un Centro Studi e Ricerche Internazionale abbia pensato di fare una ricerca. Hanno, forse, pensato che a fermare questo flagello, possa essere un antico strumento, spesso rivelatosi risolutivo: la preghiera.
Hanno deciso di condurre una indagine su chi pregano i seguaci, i credenti e i fedeli della comunità religiosa cristiana cattolica, a quali Santi si rivolgono. A tale scopo è stata svolta una ricerca online su un campione di 1158 adulti.
Ne è venuto fuori un serio studio medico-antropologico che ha messo in luce gli aspetti psicologici di come questi credenti/fedeli si confrontano di persona con mali letali quali quelli di un virus come il Covid 19, in un contesto epidemico/pandemico globale.
Il rapporto tra medicina e religione non è da considerarsi un fatto risibile, leggero o di poco conto. Lo si conosce sin dai tempi antichi. La medicina medievale si basava sugli studi di Ippocrate e le dottrine Galeniche, ma era anche caratterizzata da influenze spirituali. Nei paesi europei, nel Medio Evo, ci si rivolgeva ai Santi invocando il loro intervento per la cura e la soluzione delle malattie e epidemie. Sono state sempre tante.
Anche dopo il Rinascimento e l’Illuminismo è continuato il richiamo ad un intervento religioso negli eventi umani sia nella chiesa cattolica che in quella ortodossa. Nel Chiesa di Roma i Santi hanno fatto da tramite ed intercessione con la divinità per la soluzione dei mali terreni.
La pandemia oggi ha coinvolto, come mai prima, l’intero pianeta nella nuova forma globalizzata in tempo reale. Tutti i territori e le varie culture sono stati coinvolti, la reazione non poteva essere ovviamente la stessa, sia dal punto di vista sanitario che da quello religioso.
Lo studio, però, si è limitato solo al contesto europeo utilizzando i social Facebook e Twitter tra il 21 e 25 agosto dello scorso anno. Ogni ricercatore partecipante ha posto questa domanda sul social:
“Quale Santo pregheresti per non ammalarti di Covid 19?”.
15,840 persone hanno risposto, il 92% europei, in prevalenza francesi e italiani anonimi. Nessuna richiesta di fornire età, sesso, religione o cultura.
Santa Rita voti 558
San Rocco 268
San Sebastiano 95
Sant’ Antonio il Grande 89
Sant’Adriano di Nicomedia 54
Sant’Agricola di Avignone 32
Sant’Edmondo martire 26
San Quirino di Neuss 17
Santa Corona 3
Vergine Maria 3
Sant’Emilione 2
San Giuseppe1
Gesù 1
Sant’Espedito1
Santa Genevieve 1
San Roul 1
San Biagio 1
San Raven e San Raffaele 1
San Didier 1
San Rieul 1
Sant’Antonio di Padova 1
San Giovanni Gabriele Perboyre 1
Se si analizzano i risultati in dettaglio, Santa Rita risulta essere la più invocata. E’ considerata la Santa delle “cause perse”, come si suole dire. La sua esistenza fu molto travagliata sotto vari aspetti, in qualità di donna, moglie, madre e monaca. La sua scelta da parte dei partecipanti sta a significare, secondo i ricercatori, una situazione ritenuta senza dubbio molto difficile in cui siamo venuti a trovarci, pregnante di serio pessimismo, da “causa persa”.
Se incuriosisce l’unico voto dato a Gesù, anche gli immediati successori nella classifica, San Rocco e San Sebastiano, sono considerati protettori contro le epidemie. Il culto di questi due Santi si sviluppò nel tardo Medio Evo e Rinascimento, quando ci furono diverse epidemie in Europa.
San Rocco (135–1378) di Montpellier, Francia, distribuì le sue ricchezze tra i poveri evenne in pellegrinaggio a Roma durante una epidemia. Si fermò ad Acquapendente, a pochi km da Roma, aiutando i malati, operando molte guarigioni miracolose.
Sulla strada per Piacenza anche lui si ammalò e fu costretto a andare via. Si segregò volontario in un bosco fuori città, evitando ogni contatto umano. Un cane scoprì il suo rifugio, ogni giorno gli portava da mangiare. Un nobile del luogo seguì il cane e divenne un seguace di Rocco e lo assistette fino alla guarigione.
San Sebastiano non ebbe contatti con epidemia, lo si associa soltanto in maniera simbolica. Ma fu un martire per mano di Diocleziano. Da ricordare anche Sant’Antonio il Grande, noto da noi come Sant’Antonio Abate (251–356), fu un asceta monaco egiziano, anche lui associato alla difesa della salute.
Questo studio, tra la medicina e l’antropologia, conferma la tendenza che hanno i fedeli cristiani e cattolici a rendere partecipi dei loro problemi figure di persone che per la loro esperienza di vita hanno umanizzato il dolore e la sofferenza condividendone i problemi, provocando molto spesso misteriosi ed inspiegabili fenomeni chiamati “miracoli” che soltanto la “fede” riesce a spiegare. La stessa identica fede che in questo lungo periodo pandemico sembra far diventare sempre più fioca. Covid 19 cambierà anche il nostro modo di “credere”?
[image error]May 2, 2021
Miserie umane oltre ogni “speranza” …

Stamattina, dal porto di Maiori, durante il mio mattutino footing, ho postato questa foto poco dopo il sorgere del sole da dietro il Monte dell’Avvocata. Per il commento mi è venuta una frase che soltanto dopo mi sono ricordato era solito ripetere mio Padre. Anche lui si chiamava Antonio, lo si poteva fare a quel tempo, dare al figlio il proprio nome. Ora non più, per ovvie ragioni. Anche il nonno materno si chiamava Antonio.
Quella frase la ricordo bene, la ripeteva ogni qualvolta veniva a confrontarsi con la nuda, e a volte anche crudele faccia della realtà che doveva affrontare. Lui, insieme a mia Madre, di “miserie” ne vissero diverse. A partire dalla prima alla seconda guerra mondiale, dal fascismo al dopoguerra, dal terremoto alle Frane di Sarno, tra tante traversie personali e familiari, sono scampati alla pandemia, ma ebbero un “assaggio” di asiatica, colera, mucca pazza e non sono sicuro di ricordare tutto.
Dopo un anno e passa di pandemia, di “miserie umane”, ognuno di noi ne ha viste e vissute molte. Se volessimo fare un elenco delle vicissitudini passate in questo anno e mezzo, ognuno ne farebbe un elenco tanto lungo quanto diverso.
Mi piace vivere e trascrivere la quotidianità quanto mai “liquida” di oggi, trascrivendo le mie impressioni su FB, in attesa di un riscontro da parte di qualche amico/a che possa favorire un pensiero “pensato”, non solo “liquido” da finire tra il “liquame” e le scorie della vita. Un pensiero da poter poi essere trasformato in una scrittura degna di una futura memoria su questo blog.
Se faccio una ricerca per tag/etichetta in questo blog e digito covid, virus, coronavirus, pandemia e quant’altro, scopro che sono molti i post che ho scritto su questo evento planetario che è destinato a cambiare il mondo. Anzi, senza accorgercene, siamo già cambiati.
Quando si fermerà la conta di coloro i quali sono passati a miglior vita a causa di questo invisibile e diabolico nemico della razza umana che va sotto il nome di Covid 19, conta fatta in centinaia di migliaia di morti da noi, in milioni di vittime sul pianeta, allora avremo una visione chiara di quello che possiamo definire “miserie umane”.
Una “miseria” che desidero qui ricordare è quella che riguarda la storia di un libro. In un post del 25 ottobre qui al link , sotto questa foto, scrissi:
 Oltre ogni “speranza”
Oltre ogni “speranza”
Il Ministro della Sanità italiana scrive un libro mentre combatte il virus, gli dà quel titolo, lo passa a Feltrinelli che lo stampa e inizia a diffonderlo. Il Ministro, vista la piega che ha preso il Covid 19 nonostante il suo impegno, si rende conto che avrebbe fatto meglio a non scriverlo e decide di bloccarlo dicendo “adesso non posso impegnare tempo nelle presentazioni”. Si ferma la diffusione, almeno così dicono, ma io lo trovo stamattina sul bancone del mio giornalaio. Ovviamente non l’ho comprato e mi vergogno di avere un ministro del genere che si chiama pure “speranza”. “Dai giorni più duri a una nuova idea di salute oltre ogni speranza …”
E’ diventato un “caso” questo libro. Mi dispiace non averlo comprato per pochi euro. Adesso su ebay ne vale cinquecento almeno. Ma lui, sta sempre lì e nessuno riesce a mandarlo via. Se questa non è una “miseria” mi sapete dire cos’è?
Non vorrei prendermi una querela per dire e sostenere che il sole sorge ancora e nonostante tutto. Noi felici e fortunati superstiti del virus, vediamo sorgere il sole anche su questo “sfortunato” ministro-scrittore mancato. Oltre ogni possibile speranza guariremo …

Tutto il “bene” e tutto il “male” tra Dio, Arte e Scienza
Un libro ambizioso, come ambizioso è ogni essere umano che cerca di dare un senso alla sua esistenza.
I due autori di questo libro senza dubbio lo sono. Uno continua ad esserlo, giocando in vari ruoli grazie alla propria intelligenza. L’altro, ormai, ha avuto la possibilità di capire tutto quanto c’è da capire, oltre la linea del mistero umano. Vale a dire il “Bene e il Male” e pure “Dio, Arte e Scienza”.
Mi riferisco a Vittorio Sgarbi e Giulio Giorello. Due grandi figure della cultura italiana, in poco più di 150 pagine hanno cercato di proporre a se stessi e ai lettori del libro una meditazione intorno ai rapporti tra l’Arte, la Scienza e Dio, tutti con la maiuscola!
Ambiziosa idea costruita su un confronto di pensieri ed esperienze tanto solidi e precisi, quanto volatili e personali. Ovvio che sia così. Il pensiero umano nasce, si crea, si confronta e finisce in questa misteriosa circolarità.
Un libro strano e originale, allo stesso tempo forma letteraria di dialogo e di saggio, un confronto tra filosofia e scienza, reso possibile dalla intelligenza di entrambi i protagonisti i quali, pur nella loro grande ed inarrestabile sete di conoscenza, non hanno timore o paura di confrontarsi con il possibile e l’impossibile.
Il possibile è l’Arte, la capacità tutta umana di osare per conoscere l’impossibile: Dio. Mentre per Giorello questa entità rimane improbabile, per Sgarbi è una certezza, ma soltanto se lo si realizza in maniera umana e concreta, nella visione storica della figura nella persona umana del Cristo, in un possibile equilibrio tra fede e ragione.
Sia con l’una che l’altra gli uomini possono riuscire a comprendere il senso di un sapere universale che possa diventare patrimonio di ognuno di noi. Non possono farlo le bestie.
Anche se non è possibile dire con precisione quale sia questo patrimonio, forse è possibile acquisirlo attraverso una dottrina che può essere ritenuta anche negativa, ma non lo è affatto: il relativismo. Scrive Sgarbi:
“Il relativismo è l’unica cosa universale che abbiamo; non c’è niente di più universale del relativo. Il relativo è la nostra unica vera dottrina. individuare qualcuno che sia un punto di riferimento per tutti è un sogno che coltivo da bambino, poi ho capito che era impossibile”.
Belle le pagine del libro in cui Vittorio Sgarbi coglie il significato estetico della Pietà di Giovanni Bellini, del Cristo morto di Andrea Mantegna, di Ecce Homo di Antonello da Messina.
Giulio Giorello, nel suo intervento, scritto prima della sua scomparsa, opera un confronto tra la Madonna con il bambino di Andrea Mantegna, e la Pietà di Giovanni Bellini.
Nel primo dipinto la madre, guancia a guancia con il bambino, ha il presagio del destino doloroso di suo figlio, che verrà crocefisso. Nel secondo dipinto, Maria, diventata vecchia, medita, soffrendo, sulla sorte di suo figlio; le sue lacrime inconsolabili sono lo specchio in cui la croce di suo figlio continua a riflettersi.
Pur non credente, nel suo intervento Giorello propone una interpretazione magistrale della Trinità, l’affresco realizzato da Masaccio a Firenze in Santa Maria Novella.
Nel libro scorrono anche pensieri e opinioni di particolare rilievo storico ed intellettuale sui testi sacri, il Vecchio ed il Nuovo Testamento, e gli scritti che si devono alla ricerca intellettuale di Galileo Galilei, Newton, Berkeley, Spinoza, fino ad arrivare a Kant e Nietzsche.
E’ come una rilettura critica del cammino dello sviluppo della filosofia, lo studio della corporeità, che fa della filosofia una disciplina che si occupa della trasfigurazione. Anche se Dio, per Nietzsche è morto, per millenni gli uomini lo continuano a rincorrere, non solo nella sua immagine.
Nel libro, scritto durante la prima parte della pandemia, Giorello e Sgarbi parlano anche di questa calamità globale inserendo questo teribile evento nel rapporto tra la verità, la metafisica e la scienza.
Per Giorello, soltanto con la piena consapevolezza della corporeità e del primato della materia ci si può liberare per sempre dalla illusione idealistica. Per Sgarbi prevale l’idea di quel relativismo al quale si è fatto cenno innanzi.
Il libro si chiude in una maniera che considero come “tronca”, forse dovuto alla improvvisa scomparsa di Giorello. Resta, comunque un libro che è un grande documento del pensiero umano, che continua da sempre a dibattersi tra il Bene e il Male.[image error]

MEDIUM
- Antonio Gallo's profile
- 52 followers



