L'ambizione dell'aforisma: da Confucio a Twitter
 L'aforisma-orizzonte a Maiori (foto Gallo)
L'aforisma-orizzonte a Maiori (foto Gallo)Questo post riguarda un libro che esplora circa 2500 anni di letteratura in meno di 250 pagine per stabilire una teoria dell’aforisma. Da Confucio a Eraclito, dal Vangelo (apocrifo) di Tommaso a Erasmo, Bacone, Pascal, Nietzsche sino ad arrivare, niente di meno che, a Twitter, a Zengo ( in giapponese “illuminazione progressiva”) e Sutra (i discorsi del Buddha).
Andrew Hui ci dice che non che ha intenzione di scrivere una storia sull’aforisma, cosa che lui ritiene lunga e noiosa. Dice che vuole elaborare invece una teoria. Quale teoria?
Verificare se gli aforismi sono “prima”, “contro” e “dopo” la filosofia. Con questo intende che a volte gli aforismi sono cronologicamente precedenti a una filosofia più sistematica; a volte sono cronologicamente successivi a una filosofia più sistematica; ma, ovunque siano posizionati in ordine cronologico, si trovano sempre in qualche relazione con una filosofia più sistematica.
La sua teoria rivela che l’aforisma spesso è un antenato, a volte un alleato e, talvolta, un antagonista per una filosofia sistematica. Le lingue citate in questo originale ed importante studio includono il cinese, il greco, il latino, il francese, il tedesco, il copto, il giapponese, il sanscrito e il pali. Un intento che rivela un’ambizione di scrittura davvero impressionante. Alla fine del libro c’è anche un breve saggio bibliografico con il quale l’autore dà ragione del suo lavoro. Segue poi una esaustiva bibliografia.
Ho letto il libro in versione cartacea, dopo di avere letto alcuni estratti in versione digitale. Mi sono reso conto che l’argomento mi interessava molto, (le ragioni vanno ritrovate nella stesura di questo post). Per questo motivo mi sono procurato la versione cartacea.
Un argomento del genere, che spazia in tremila anni di storia della comunicazione, non può che essere studiato in maniera “fisica”, oltre che “mentale”, sulle pagine a stampa di un libro tradizionale. La ragione per la quale, (lo faccio raramente), ho riempito le pagine del volume di numerosi segni, sottolineature e annotazioni.
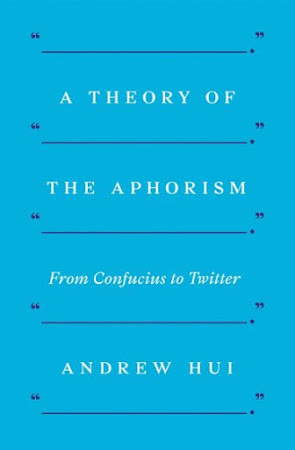 Il libro
Il libroMa che cos’è un “aforisma”? La radice della parola è la stessa di “orizzonte”. Il verbo greco “horizo” significa “delimitare”. Orizzonte è in origine il cerchio che si apre allo sguardo. Francesco da Buti, commentatore trecentesco di Dante, ci offre una definizione precisa:
“L’orizzonte è circulo terminativo de la nostra vista”.
Non meno preciso è il Tasso nel “Mondo creato”:
“Quel che terminò l’umana vista / ne i tenebrosi e lucidi confini / orizonte fu detto”.
Ne ho scritto in una breve recensione dei due strepitosi volumi dedicati agli aforismi italiani nelle edizioni Mondadori dei Meridiani. Ma la storia degli aforismi che scrive Andrew Lui, giovane e brillante studioso di origini orientali, professore alla Standford University, è per un altro verso tutta un’altra ambiziosa storia.
Hui lo definisce come “un breve detto che richiede interpretazione” e lo distingue dai generi correlati come proverbi, massime ed epigrammi. Mentre i proverbi e i detti sono “vicini all’estremo banale” e “facili da capire” (ad es. “L’assenza rende il cuore più affezionato”), le massime e gli epigrammi sono “da qualche parte nel mezzo”, contenenti “un’acuta sintesi” (ad es. “Una colpa quasi universale degli innamorati è non capire quando si è più amati”).
Gli aforismi, al contrario, hanno un “fine filosofico o teologico” e “più nascosto”. I migliori aforismi ammettono un’infinità di interpretazioni, un’inesauribilità ermeneutica”. Quindi, ciò che viene detto “richiede interpretazione” che deve essere compresa secondo precise linee tenendo presente che l’aforisma offre la massima condensazione e promette un infinito di significato (“infinito” è la parola preferita di questo libro). Ma quanto più breve è l’aforisma, tanto più tempo ci si impiega a capirlo.
Nel capitolo 1, “Confucio: il maestro silenzioso” si esaminano gli analisti, gli aneddoti e le conversazioni tra il maestro e lo studente risalenti al V secolo a.C. al I secolo d.C. Viene discussa la tradizione di raccolta, interpretazione e commento che cresce attorno a questi frammenti, così come la graduale evoluzione della raccolta in un “insieme ideologico” sponsorizzato dallo stato. Come dovrebbero essere letti tali frammenti di conversazioni? Zhu Xi (1130–1200) offre consigli: “leggi e rileggi” e “immergiti nelle parole”.
Nel capitolo 2 “Eraclito: cosa è nascosto”, Hui sostiene che il “linguaggio laconico di Eraclito è tratto dalle oscurità degli oracoli”. Questi aforismi sono detti filosofici perché credono nella verità derivata dall’intelletto umano piuttosto che dalla rivelazione divina. Sono quindi “dopo e contro” Omero ed Esiodo, ma “prima e contro” i “sistemi di Platone e Aristotele”. Dopo aver discusso dell’antica divinazione, Apollo, degli oracoli e di Delfi, Hui difende gli oscuri aforismi di Eraclito contro l’argomentazione più sistematica della filosofia platonica. Egli dice che una volta che si inizia a interpretare i frammenti oscuri, si è già sulla buona strada per la saggezza.
Nel capitolo 3 “Il Vangelo di Tommaso: ciò che è rivelato” l’autore segue il modello ermeneutico del capitolo precedente: mentre per “Eraclito, la verità si trova nel logos”, per “Il Vangelo di Tommaso, la verità si trova in se stessi, poiché Gesù dimora in essa“. Hui discute della scoperta di Nag Hammadi, della relazione del testo con i tradizionali quattro vangeli e del messaggio di Thomas, che è uno di “indipendenza radicale”. Egli sostiene che “i lettori devono decifrare per se stessi il significato del testo piuttosto che fare affidamento su qualsiasi dottrina settaria … “. Questo spiega perché Thomas non è mai entrato a far parte del canone ortodosso.
Il capitolo 4 “Erasmo e Bacone: l’antichità e la nuova scienza”. Il racconto delle rivoluzioni intellettuali del XVI-XVII secolo come spiegazione e reazioni all’aforisma. Gli argomenti includono la diffusione dei libri di Erasmo con i suoi “Adages”, le immagini che lui usa delle “gemme”, dei “semi di senape” in forma di pensieri, le “scatole” di Sileno, tutto serve come ad esempio e modo per “guardare nell’ano di un cane”. Grande fatica comunicare in questo modo per collezionare “troppo da sapere”. Si crea così quella crisi che Bacone manifesterà con i suoi aforismi: forniscono “un orizzonte aperto di indagini piuttosto che un sistema chiuso di conoscenza accumulata”.
Il capitolo 5 “Pascal: I Frammenti dell’Infinito” Hui sostiene che i “Pensieri” di “Pascal sono un ripudio della filosofia cartesiana. Poiché questi scritti sono stati trovati in fasci disorganizzati quando è morto, il problema è come organizzare questi “frammenti irrimediabilmente disordinati ed enigmatici”. Diverse edizioni hanno tentato di mettere ordine in questo disordine dove l’ordine non è mai stato voluto. Piuttosto, l’enigmatica instabilità del testo genera molteplicità di pensiero. Ricordando il capitolo di Thomas, “la poetica dell’aforisma di Pascal”, secondo Hui, consiste nella “scrupolosa decifrazione dei segni di Dio”.
Il capitolo 6 “Nietzsche: I Frammenti del Non-finito” considera la straordinaria svolta di Nietzsche nella scrittura di aforismi, a partire dai 638 aforismi di “Umano, troppo umano” (1878), che “segnò una rottura con i suoi primi studi filologici”. Hui esplora diverse ragioni per questa svolta aforistica, dalla debilitante salute, a uno stile di vita peripatetico, alla macchina da scrivere. Il valore degli aforismi per Nietzsche consiste nel fatto che “sono veloci da leggere”. Invece di debilitare la “capacità di pensiero originale” dei suoi lettori con troppe letture, Nietzsche vuole una forma di interpretazione che sia “interna, silenziosa e vissuta”.
Nell’epilogo, non a caso, Hui sceglie l’idea del cerchio per concludere il suo viaggio negli aforismi. Si rivolge brevemente prima a Twitter e dice: “Secondo la mia teoria dell’aforisma, i tweet vengono prima, dopo e contro ogni forma di comunicazione di lungo respiro”. Ma poi, con una svolta sorprendente, chiude il suo libro con una visione autobiografica. In una sezione intitolata: “Esaurimento-Exhaustion”, Hui discute dei due aforismi ai quali si è sempre rifatto scrivendo il libro. Il primo è di Nietzsche:
“A che serve un libro che non riesce a portarci nemmeno oltre tutti i libri?”
Ci sono troppi libri, molto più di quanto riusciremo mai leggere. Questo crea “frustrazione” e “disperazione” riguardo a “tutti gli oceani di testi e montagne di libri che non avrò mai tempo di leggere”.
Qual è la risposta? Offre la meditazione Zen come “contrasto con la miriade di interpretazioni discorsive che abbiamo incontrato nelle pagine precedenti”. Tale pratica è “in fin dei conti non-ermeneutica, ma solo un sistema per svuotare la mente”. È come se, per Hui, il fascino dell’aforisma fosse questa possibilità di andare “oltre tutti i libri”, come se si potesse scoprire la verità, e quindi interrompere la ricerca libresca.
“Una volta attraversato il fiume, la proverbiale zattera, messa insieme dal traballante legname di aforismi, non è più necessario. Resta il silenzio”.
Questa seria ma calda conclusione del libro, così come il capitolo finale di Nietzsche, rivela la grande attenzione di Hui per la scrittura di aforismi nel grande calderone del contesto della moderna comunicazione mediatica. Sin dall’inizio del resto, sono state queste le dichiarate intenzioni del libro: trovare una risposta alla domanda: “Può l’aforisma risolvere il problema della lettura e dare un senso ad essa?” Quando Hui sostiene che l’aforisma viene “prima”, “dopo” e “contro” la filosofia, “alleata” e allo stesso tempo “antagonista” sta nel vero.
L’aforisma è una risposta antica, seria e meditata alla babele logorroica mediatica nella quale la moderna tecnologia ci sta lentamente e fatalmente spingendo a vivere. Se il destino della scrittura e della lettura consiste nella ricerca del senso e del significato della comunicazione umana, l’aforisma può aiutarci a fare piazza pulita di tutte quelle scorie e trivia di cui è capace di creare la mente degli uomini. Possiamo benissimo concludere parafrasando il pensiero di Nietzsche dicendo:
“A che serve una parola se non ci conduce oltre tutte le altre parole?”.
 L'aforisma-orizzonte a Stonehenge (foto Gallo)
L'aforisma-orizzonte a Stonehenge (foto Gallo)
Published on August 04, 2020 09:42
No comments have been added yet.
MEDIUM
Nessuno è stato mai me. Può darsi che io sia il primo. Nobody has been me before. Maybe I’m the first one.
- Antonio Gallo's profile
- 52 followers



