Giovanni De Matteo's Blog: Holonomikon, page 48
February 26, 2012
Let's talk about… communication
Forse i più assidui tra i lettori dello Strano Attrattore ricorderanno che un po' di tempo fa avevo sperimentato un breve ciclo di articoli incentrati su letture tematiche, dedicato ai racconti di SF: avevamo cominciato con il sesso, proseguito con… il sesso, e poi avevamo parlato di inner space. Non sarebbe male riprendere prima o poi il tentativo e svilupparlo, magari verso altre direzioni inaspettate. Nell'attesa provo a recuperare il formato di quei post per parlarvi di una strana convergenza emersa da due letture di quest'ultimo periodo.
Quello della comunicazione è uno dei temi caldi della fantascienza. Dopotutto far interagire tra loro civiltà diverse o addirittura specie aliene pone dei problemi che costituiscono l'impalcatura ideale per lo sviluppo drammatico di storie e racconti. E in effetti sarebbe lungo e difficile ripercorrere il filone senza dimenticanze rilevanti, per cui mi limito a citare solo le prime letture che mi vengono in mente: I linguaggi di Pao di Jack Vance (1957), Una rosa per l'Ecclesiaste di Roger Zelazny (1963), Babel 17 di Samuel R. Delany (1966) e Il linguaggio segreto di Ruth Nestvold (2003), tutte opere in cui il linguaggio esercita qualche forma di controllo. Freschissima aggiunta al novero dei romanzi sull'argomento è da considerarsi Embassytown di China Miéville (2011), che sta già facendo molto parlare di sé. Un sottofilone della fantascienza dedicata al primo contatto si occupa nello specifico del problema legato a individuare una base comune per poter instaurare una forma di dialogo: dalla comunicazione "lenta" de Gli ascoltatori di James E. Gunn (1972) a quella tecno-metafisica di Contact di Carl Sagan (1985), diventato anche un film di successo con Jodie Foster, dal molto simile a quest'ultimo I transumani di Robert J. Sawyer (1998) a I protomorfi di Joe Haldeman (2004). L'approccio predominante è di natura matematica, anche se non mancano originali varianti basate sulla manipolazione biochimica da parte degli extraterrestri, come accade sia in Mai più umani di Nancy Kress (2003) che nella spettacolare miniserie I figli della Terra di Torchwood (2009), trasmessa in chiaro solo qualche settimana fa da Rai4.
Questa panoramica vuole servire solo a dare uno spaccato della varietà di opere che si sono confrontate con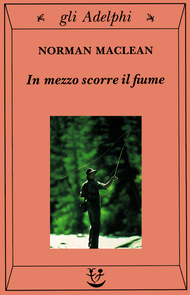 il tema. In questa sede mi interessa invece mettere a confronto due lavori molto diversi tra loro, per estrazione e per intenzioni. Mi è capitato di leggere un paio di mesi fa il romanzo In mezzo scorre il fiume (A River Runs through It, 1976) di Norman Maclean. Qualcuno forse ricorderà il film tutt'altro che memorabile che ne ricavò Robert Redford venti anni fa, pallida ombra del capolavoro che lo ispirò. In mezzo scorre il fiume è un breve romanzo composto da Maclean come atto riconciliatorio con il proprio passato: ambientato nel Montana di inizio '900 e nella smisurata vastità dei suoi panorami, popolati di solitudine e silenzi interrotti solo dal fluire dell'acqua sulle rocce e dal soffio del vento tra gli alberi e sui campi, la storia si dipana come un fiume di ricordi (emblematico il passaggio che ha ispirato il titolo dell'opera: "Alla fine tutte le cose si fondono in una sola, e un fiume la attraversa"), occupato quasi per intero dalla memoria dell'estate del 1937. La prosa di Maclean è densissima, stratificata, cesellata fino all'ultima parola. Trasmette un senso di equilibrio che emerge forse anche dalla prospettiva temporale e, sebbene l'impianto del libro sia piuttosto tradizionale, riesce a concedersi con assoluta naturalezza delle digressioni paleontologiche che forse non hanno lasciato del tutto indifferente il Terence Malick di The Tree of Life, così come pure delle parentesi umoristiche dalla carica folgorante (particolarmente riusciti sono due siparietti che vedono protagonista e vittima il cognato del narratore, il primo in una bettola chiamata Black Jack e ricavata in un vagone ferroviario, il secondo in compagnia di una puttana chiamata da tutti Vecchia Pellaccia per una disavventura che li coglie alla sprovvista nel corso di una battuta di pesca).
il tema. In questa sede mi interessa invece mettere a confronto due lavori molto diversi tra loro, per estrazione e per intenzioni. Mi è capitato di leggere un paio di mesi fa il romanzo In mezzo scorre il fiume (A River Runs through It, 1976) di Norman Maclean. Qualcuno forse ricorderà il film tutt'altro che memorabile che ne ricavò Robert Redford venti anni fa, pallida ombra del capolavoro che lo ispirò. In mezzo scorre il fiume è un breve romanzo composto da Maclean come atto riconciliatorio con il proprio passato: ambientato nel Montana di inizio '900 e nella smisurata vastità dei suoi panorami, popolati di solitudine e silenzi interrotti solo dal fluire dell'acqua sulle rocce e dal soffio del vento tra gli alberi e sui campi, la storia si dipana come un fiume di ricordi (emblematico il passaggio che ha ispirato il titolo dell'opera: "Alla fine tutte le cose si fondono in una sola, e un fiume la attraversa"), occupato quasi per intero dalla memoria dell'estate del 1937. La prosa di Maclean è densissima, stratificata, cesellata fino all'ultima parola. Trasmette un senso di equilibrio che emerge forse anche dalla prospettiva temporale e, sebbene l'impianto del libro sia piuttosto tradizionale, riesce a concedersi con assoluta naturalezza delle digressioni paleontologiche che forse non hanno lasciato del tutto indifferente il Terence Malick di The Tree of Life, così come pure delle parentesi umoristiche dalla carica folgorante (particolarmente riusciti sono due siparietti che vedono protagonista e vittima il cognato del narratore, il primo in una bettola chiamata Black Jack e ricavata in un vagone ferroviario, il secondo in compagnia di una puttana chiamata da tutti Vecchia Pellaccia per una disavventura che li coglie alla sprovvista nel corso di una battuta di pesca).
Il libro è il mantenimento di una promessa fatta al padre, un rito laico dalla duplice valenza catartica e mitopoietica, come scopriremo arrivati all'ultima pagina (la traduzione, qui e nel seguito, è di Marisa Caramella):
Allora lui mi chiese: «Quando avrai finito di raccontare tutte le storie vere che conosci, però, perché non ne inventi una, e anche i personaggi?
«Solo allora capirai cos'è successo e perché.
«Sono proprio le persone con cui viviamo, che amiamo e che dovremmo conoscere meglio, a eluderci.»
All'epoca Norman, che rievoca i fatti in prima persona, è da poco rientrato in Montana dopo gli studi a Chicago, alle prese con le prime incombenze della vita matrimoniale, e ritrova il fratello minore, al quale è legato da un vincolo difficile da rendere a parole: complicità, rispetto reciproco, stima, amore. Non lo esprimono a parole loro, che si accontentano di vivere questo rapporto fatto di lunghi silenzi, non lo faremo nemmeno noi. La storia si svolge tra Wolf Creek, dove Norman vive con la moglie, Helena, capitale dello stato, dove Paul esercita la professione di giornalista, e Missoula, la città (per quanto possa parlarsi di città in Montana, e nel Montana ancora semi-pionieristico di inizio secolo in particolare) in cui sono nati e cresciuti e in cui vivono ancora i loro genitori. I momenti chiave del loro rapporto sono scanditi dalle battute di pesca che organizzano insieme, essendo stati istruiti dal padre nell'arte della pesca a mosca, di cui Paul è diventato un'autorità universalmente riconosciuta. Le discese al Big Blackfoot River diventano l'occasione per il narratore di riannodare i fili del passato, con l'autoritaria ma benevola figura del padre, un pastore presbiteriano in pensione, e con l'ombra luminosa ma controversa di Paul, refrattario alle convenzioni ma anche facile preda dei vizi dell'alcol e del gioco d'azzardo.
Paul e Norman sono come due microcosmi gemelli ma distanti e la pesca a mosca è il canale attraverso cui riescono a rivelarsi ed entrare davvero in contatto, perché sul fiume sono loro due soli e tutto il resto del mondo può essere escluso dal loro rapporto, insieme al rumore che quotidianamente riversa su di loro, soffocando il silenzio di cui hanno entrambi bisogno per svelarsi nella rispettiva essenza. Sempre dalle pagine finali estraggo questi due passaggi che si illuminano a vicenda:
Ci fermammo e guardammo giù per l'argine. Io chiesi a mio padre: «Ricordi quando abbiamo raccolto tutti quei sassi rossi e verdi là sotto, per fare un fuoco da campo? Alcuni erano di fango pietrificato, rossi, pieni di increspature».
«Portavano ancora i segni della pioggia» disse lui. La sua immaginazione si scatenava sempre, all'idea di quell'antica pioggia che colpiva il fango prima che si trasformasse in pietra, e fantasticava di starci sotto.
«Quasi un miliardo di anni fa» dissi io, che sapevo cosa stava pensando.
Lui tacque per un po'. Aveva rinunciato a credere che Dio avesse creato tutto l'esistente, compreso il Blackfoot River, nello spazio di sei giorni, ma non credeva nemmeno che l'impresa della creazione l'avesse messo a così dura prova da costringerlo a impiegare tutto quel tempo per portarla a termine.
«Quasi mezzo miliardo di anni fa» disse poi, nel tentativo di contribuire alla riconciliazione tra scienza e religione.
Per inciso, le riflessioni sul tempo nel romanzo di Maclean mi hanno richiamato alla memoria l'operazione analoga compiuta in quegli stessi anni da Breece D'J Pancake nei suoi straordinari racconti. E poi:
«Che cosa stavi leggendo?» gli chiesi. «Un libro» disse lui. L'aveva posato a terra, dall'altro lato. Perché non fossi costretto a sporgermi sopra le sue ginocchia e guardare, mi disse: «Un buon libro».
Poi continuò: «Nella parte che stavo leggendo dice che in principio era il Verbo, ed è proprio così. Un tempo credevo che l'acqua fosse venuta per prima, ma se la si ascolta attentamente, ci si rende conto che sotto ci sono le parole».
«Questo perché tu sei prima un predicatore e poi un pescatore» gli dissi. «Se chiedi a Paul, ti dirà che le parole si formano con l'acqua».
«No,» disse mio padre «è che tu non ascolti attentamente. L'acqua scorre sopra le parole. Paul ti direbbe la stessa cosa [...]»
 La comunicazione (o la difficoltà di instaurarne una) e l'acqua. Strano connubio, si penserà. Non però se si è appassionati di fantascienza e di SETI. La banda di frequenze in cui si concentra la ricerca di segnali di natura extraterrestre è infatti chiamata in gergo water hole, ovvero "polla d'acqua". Intorno ai 1420 GHz, frequenza compresa tra quella di emissione dell'idrogeno e quella del gruppo ossidrilico (le due molecole dalla cui reazione si origina l'acqua, da cui il nome), si riscontra il minor rumore di fondo della galassia: la scelta dei radioastronomi che scandagliano il cielo alla ricerca di possibili segnali di origine aliena è quindi motivata. La "polla d'acqua" ha in realtà anche un altro significato, rappresentando il punto nella banda di frequenze possibili in cui potrebbero incontrarsi le civiltà interstellari per comunicare tra loro, proprio come branchi di specie diverse a un fiume nella savana. Un racconto che ne parla con cognizione di causa è Il muro di idrogeno (The Hydrogen Wall, 2003) di Gregory Benford, che oltre a essere un apprezzato esponente della cosiddetta hard sci-fi è anche un astrofisico presso l'Università della California di Irvine.
La comunicazione (o la difficoltà di instaurarne una) e l'acqua. Strano connubio, si penserà. Non però se si è appassionati di fantascienza e di SETI. La banda di frequenze in cui si concentra la ricerca di segnali di natura extraterrestre è infatti chiamata in gergo water hole, ovvero "polla d'acqua". Intorno ai 1420 GHz, frequenza compresa tra quella di emissione dell'idrogeno e quella del gruppo ossidrilico (le due molecole dalla cui reazione si origina l'acqua, da cui il nome), si riscontra il minor rumore di fondo della galassia: la scelta dei radioastronomi che scandagliano il cielo alla ricerca di possibili segnali di origine aliena è quindi motivata. La "polla d'acqua" ha in realtà anche un altro significato, rappresentando il punto nella banda di frequenze possibili in cui potrebbero incontrarsi le civiltà interstellari per comunicare tra loro, proprio come branchi di specie diverse a un fiume nella savana. Un racconto che ne parla con cognizione di causa è Il muro di idrogeno (The Hydrogen Wall, 2003) di Gregory Benford, che oltre a essere un apprezzato esponente della cosiddetta hard sci-fi è anche un astrofisico presso l'Università della California di Irvine.
Il racconto in questione, pubblicato in Italia nell'antologia Venti Galassie (Millemondi, estate 2007), descrive gli sforzi di una futura civiltà postumana di decodificare, all'alba del Quarto Millennio, le trasmissioni ricevute da una varietà di civiltà aliene. Queste trasmissioni hanno rivelato di racchiudere delle menti digitali codificate al loro interno (Compositi, Molteplicità, Architetture, etc.) e la missione della Biblioteca è la decodifica di questi costrutti, noti come Artificiali. Ruth Angle sbarca sulla Luna con il proposito di occuparsi del più enigmatico e inafferrabile dei cyber-alieni, l'Architettura del Sagittario, "un esempio del più alto ordine di Informazione senziente". Quello che non può sapere, al momento di imbarcarsi in un'impresa in cui si sono cimentati senza risultati predecessori ben più illustri e quotati di lei, è che la missione è destinata a cambiarla, mettendola di fronte alla vera sostanza dei suoi desideri e obbligandola in ultima istanza a fare i conti con la propria natura umana. Facendolo, scoprirà che la stessa Architettura del Sagittario, a cui l'umanità si rivolge per scongiurare un cataclisma cosmico che rischia di sterilizzare il sistema solare, devastando tutte le colonie umane, nasconde una natura inizialmente insospettabile.
Metafisica e scienza si fondono nello splendido racconto di Benford con un'efficacia che lascia ammirati, in un tentativo che probabilmente avrebbe saputo soddisfare le aspirazioni più alte del reverendo Maclean, rivelando una matrice essenzialmente connettivista, come talvolta capita alla fantascienza migliore.
In mezzo scorre il fiume
Ormai tutte le persone che ho amato senza capirle quand'ero giovane sono morte, ma posso ancora ricreare la loro presenza.
Naturalmente, ormai sono troppo vecchio per essere un gran pescatore, e naturalmente di solito vado a pesca nel grande fiume da solo, anche se certi amici pensano che non dovrei. Come molti pescatori a mosca del Montana occidentale, dove le giornate estive hanno una lunghezza quasi artica, spesso comincio a pescare solo col fresco della sera. Allora, nella mezza luce artica del canyon, tutta l'esistenza si riduce a un essere con la mi anima e i miei ricordi e ai suoni del Big Blackfoot River e al ritmo in quattro tempi e alla speranza di vedere un pesce.
Alla fine tutte le cose si fondono in una sola, e un fiume la attraversa. Il fiume è stato creato dalla grande alluvione del mondo e scorre sopra rocce che sono le fondamenta del tempo. Su alcune di queste rocce sono impresse gocce di pioggia senza tempo. Sotto le rocce ci sono le parole, e alcune delle parole appartengono alle rocce.
Sono ossessionato dalle acque.
Da In mezzo scorre il fiume (A River Runs through It, 1976) di Norman Maclean. Traduzione di Marisa Caramella.
February 17, 2012
Il mondo che Dick creò
Ormai Philip K. Dick è diventato praticamente un'istituzione. L'editore attuale dell'opera di Dick non perde occasione per rivendicarne la "trascendenza" rispetto ai confini del genere di appartenenza, illustri filosofi si occupano del suo pensiero e non passano inosservati sul Corriere della Sera, fioriscono i distinguo tra la letteratura alta e la massa indistinta della fantascienza, Hollywood continua ad attingere in maniera più o meno diretta ai suoi lavori e la ricaduta sul genere è ai minimi storici.
Di fronte al moltiplicarsi delle sfaccettature di un mondo sempre più dickiano, da appassionato del genere scopritore di Dick in tempi meno sospetti, penso che gli appassionati di SF come me dovrebbero rivendicare, ora più che mai, prima che si scateni il probabilissimo bailamme per le commemorazioni del trentesimo anniversario della sua scomparsa all'approssimarsi del 2 marzo prossimo, due condizioni fondamentali:
1. l'appartenenza di Dick al genere: al di là di tutti i difetti che si possono imputare alla sua tecnica, la grandezza della sua visione e la toccante sincerità delle sue preoccupazioni non avrebbero trovato un'espressione altrettanto efficace all'esterno del solco scavato dall'immaginario del genere: al fiume immenso che ha scavato l'antica valle, le opere di Dick hanno sicuramente tributato un contributo importantissimo, incrementandone la portata fino a rompere gli argini e a determinarne la conseguente irruzione nel nostro panorama culturale contemporanaeo tout-court;
2. la giusta collocazione di Dick all'interno della storia del genere; sostenere il suo primato equivale a commettere un torto a tutti gli altri scrittori che hanno saputo coniugare maturità tematica e padronanza stilistica, esprimendosi ai suoi stessi livelli se non anche meglio, e non sono affatto pochi: da Alfred Bester a Samuel R. Delany, da Fritz Leiber a Ursula K. Le Guin, da J.G. Ballard a William Gibson, Dick non rappresenta affatto l'eccezione nell'economia storica della fantascienza.
Negli ultimi tempi, lo stream del blog HyperNext ha fortemente risentito delle intuizioni di Dick, proprio per la loro persistenza e attualità nell'ambito del pensiero e delle inquietudini contemporanee. Due post per tutti: Il dilemma etico del male minore e Ma gli androidi sognano pecore elettriche?. Da oggi, per tre venerdì di seguito, riproporremo a puntate un mio articolo apparso in una versione precedente su Next 4. Si comincia da qui.
February 9, 2012
Visualizzazioni remote di una tavola da surf spaziale
C'è una scena, in Dark Star, spericolata pellicola d'esordio di John Carpenter che traspone nello spazio le ossessioni per l'armageddon atomica del Dottor Stranamore e rappresenta una delle rare performance d'attore del grande e compianto Dan O'Bannon (sceneggiatore versatile e mente eclettica nascosta dietro una pietra miliare del perturbante come Alien, un valido blockbuster del calibro di Atto di forza, uno straordinario B-movie come Screamers - Urla dallo spazio, nonché della bande dessinée The Long Tomorrow, annoverata da Ridley Scott tra le fonti di ispirazione per l'estetica noir di Blade Runner), in cui un superstite di un cataclisma spaziale cavalca un detrito dell'astronave come una tavola da surf, concedendosi un ultimo brivido prima della fine certa, abbandonato a se stesso nella solitudine della notte siderale.
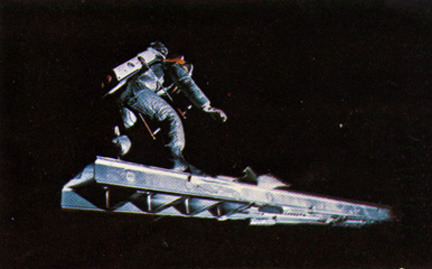
La fascinazione per la disciplina della tavola e la magia delle onde non è un mistero per chi frequenta queste pagine, che al surf hanno dedicato in passato ampio spazio. D'altro canto, la fantascienza è il nostro pane quotidiano, e se siete capitati qui non c'è bisogno di aggiungere altro. Surf e fantascienza: uno strano connubio? Non più di tanto, a giudicare dalle reiterate risonanze tra i due immaginari, dal Silver Surfer ai surfisti del cyberspazio (che arrivano ad omaggiare l'araldo di Galactus in un bellissimo racconto di Rudy Rucker e Marc Laidlaw, Condotto di probabilità), passando appunto per l'opera prima di Carpenter che tuttavia, contrariamente a quanto avevo sempre pensato, non rappresenta il primo flirt tra SF e surf. Un insospettabile precursore, stando a quanto suggerisce Tommaso Pincio, sarebbe stato proprio un altro capolavoro di Stanley Kubrick, a cui abbiamo dedicato in passato ripetuti interventi: 2001 - Odissea nello Spazio.

L'imprevista connessione passa attraverso l'artista John McCracken, che frequentava le spiagge californiane durante i suoi anni al college. Espressione dell'arte minimalista, la sua opera irrompe iconicamente nel panorama del Novecento nel 1966, con due anni di anticipo sul monolito spaziale: una tavola monocromatica, lunga e sottile, di perfetta foggia rettangolare, che sfonda la barriera delle due dimensioni e invade lo spazio psichico dell'osservatore. Visionario e intriso di cultura new age, McCracken colse la carica metafisica di quella geometria essenziale nello stesso periodo in cui Kubrick e Clarke cedevano alla medesima seduzione, trasformando il tetraedro del racconto originario del maestro britannico (La sentinella, 1953) in un parallelepipedo enigmatico e indecifrabile. Se ci fu vero contatto tra le visioni dell'artista e la sontuosa epopea kubrickiana, forse non lo si saprà mai con certezza.

Ci restano le risonanze che attraversano le installazioni di McCracken, evocando nello spettatore di 2001 associazioni tanto immediate e spontanee quanto nitide, e il sospetto di un episodio di retrocausalità di fronte alle annotazioni di quelle che McCracken soleva definire "viaggi psichici" o "visualizzazioni remote", con passaggi folgoranti come questo, datato 24/3/97:
Mi trovo in un altro sistema solare della nostra galassia e vedo un complesso di stazioni spaziali che circondano un pianeta. Ho una sensazione di familiarità, una bella percezione. C'è tanta gente qui che conosco, un viavai, molta agitazione relativa a qualcosa.
February 7, 2012
Le strade al neon che portano a Neuromante
La prima volta che ho collegato un modem analogico alla rete telefonica e al vecchio cassone che usavo come PC, nell'adrenalina del cinguettio elettronico dell'apparecchio che cercava di agganciare una linea, non potei fare a meno di immaginarmi il cyberspazio descritto da William Gibson. Ricorderete forse le immagini evocate da questo passaggio seminale di Neuromante:
Cyberspazio. Un'allucinazione consensuale condivisa ogni giorno da miliardi di operatori legittimi, in ogni nazione, insegnando ai bambini concetti matematici [...] Una rappresentazione grafica di dati ricavati dalle memorie di qualsiasi computer e inviata al "sistema uomo". Impensabile complessità. Linee di luce distribuite nel non-spazio della mente, ammassi stellari e costellazioni di dati. Come luci di città che si allontanano.
L'idea che dietro la sagoma di plastica grigia del modem e oltre il confine segnato dal doppino si nascondesse un'universo di luci al neon era una valida astrazione delle architetture di dati che mi aspettavano nella rete, e rendevano decisamente più interessante l'esperienza di una connessione a 56k, che implicava qualche minuto per il caricamento di una pagina e - tipicamente - un'altrettanto prosaica resa grafica della stessa.

Molti passi in avanti sono stati compiuti da allora. Ma restano ampi margini di miglioramento, specie se ci si prefigge come punto di arrivo la realtà virtuale interattiva, comprensiva di tutte le architetture di dati del genere umano, che è la matrice presentata da Gibson. Tra i punti deboli che ancora resistono, l'organizzazione dei contenuti resta uno dei principali problemi (se non il principale in assoluto) con cui deve confrontarsi chiunque voglia cimentarsi con la realizzazione di un sito web. Il web design non è una banalità e spesso impone dei compromessi. Se in genere il webmaster può imparare a convivere piuttosto bene con questi compromessi, purché rispondano alla propria idea del sito web, per l'utente il discorso è un po' più delicato: siti con ottimi contenuti ma mal strutturati possono scoraggiare l'utente dall'esplorazione/fruizione degli stessi, vanificandone di fatto la bontà, a meno che non si abbia a che fare con utenti dalla forte vocazione all'avventura e alla scoperta, o semplicemente muniti di una pazienza divina. D'altro canto, siti estremamente complessi potrebbero non valorizzare il complesso dei contenuti per via delle inevitabili asimmetrie di esposizione e visibilità degli stessi, occultando di fatto agli utenti risorse di utilità potenzialmente elevata.
In questi anni il web si è evoluto. Ha attraversato il tumulto del 2.0, della condivisione dei contenuti, della loro moltiplicazione multimediale: blog, Wikipedia, YouTube, Second Life, MMORPG, social network. Si affaccia gradualmente verso i nuovi scenari del web semantico, del geoweb, dell'augmented reality. E in attesa esalta il lato più sociale: dopo i tempi di Usenet, dei gruppi e dei forum di discussione, il web sociale ha esordito mappando in rete le relazioni personali esterne alla rete, e molto presto si è trasformato in qualcosa di più: uno strumento per sviluppare collaborazioni, consentire nuovi contatti e amicizie, condividere con loro risorse di comune interesse, attingendo alla rete (link a siti, blog, piattaforme di condivisione) oppure alla vita esterna (foto, note, video dall'altra parte dello specchio). Quello che forse finora è mancato in questo senso, è stato uno sviluppo delle potenzialità implicite nel social web: la possibilità di propiziare a monte l'incontro tra individui accomunati da passioni e interessi.

Riepilogando, due delle cose che ancora mancano alla rete sono:
a. un metodo per svincolare i contenuti dalla progettazione del sito;
b. uno strumento d'ingegneria sociale che superi i limiti dell'attuale sistema di social networking.
A questo scopo nasce Volunia, il motore di ricerca messo a punto dallo specialista Massimo Marchiori (già ricercatore al MIT, collaboratore di Tim Berners-Lee, ideatore dell'algoritmo alla base del PageRank implementato da Larry Page e Sergey Brin per Google) nel segno del motto Seek & Meet. I motori di ricerca stanno consolidando in questi anni il loro ruolo di veri e propri "motori del web", crocevia della rete. Non solo per via del successo di Google, presto seguito da Bing e altri strumenti via via meno popolari e potenti. Ma soprattutto perché è ormai improponibile anche solo pensare di esplorare il web senza uno strumento di ricerca. Le directory possono funzionare ancora per il deep web, ma nel mare magnum di superficie l'utilità del search engine è irrinunciabile. E così anche i motori di ricerca si moltiplicano, diversificandosi per target e funzionalità. Dopo Wolfram Alpha, il primo motore di conoscenza computazionale del web, Volunia si propone come un assistente di navigazione web con funzioni di mappatura dei siti web, estrazione delle risorse multimediali e costruzione di occasioni sociali.
La presentazione del prodotto, tenutasi lunedì 6 febbraio e trasmessa in diretta streaming dall'Università di Padova, è ancora accessibile in differita dal sito dell'ateneo (qui una versione concentrata e più fruibile). Le reazioni della rete, dopo la spasmodica attesa che ha salutato l'evento, si sono rivelate nel complesso abbastanza tiepide, se non proprio deluse e scettiche. Rispetto alle stesse, mi ritrovo scettico a mia volta, consapevole dell'effetto amplificante delle opinioni negative che in genere seduce i commentatori, sul web in modo particolare. E gli italiani sfiorano sempre vette d'eccellenza quando c'è da esercitare l'ars destruens, che si sia competenti in materia o meno (anzi, secondo l'implacabile logica della legge di Benford, l'accanimento cresce a dismisura quanto più si è ignoranti in materia).
Tra gli articoli che potete trovare in rete, ne segnalo uno positivo (dal Corriere.it), uno assolutorio (da Repubblica.it) e uno severo ma documentatissimo (da Punto Informatico). Ovviamente, si può dire ciò che si vuole sulla presentazione come pure sulla strategia di comunicazione (a parte la scelta dell'italiano e malgrado gli intoppi tecnici, a me non è sembrata affatto sottotono, sarà che sono stato forgiato nella fucina di aule universitarie mediamente molto, molto più noiose, in anni in cui l'uso dei lucidi era ancora un'abitudine dura da estirpare dal corpo docente). La prova del fuoco si avrà quando Volunia sarà messa a disposizione degli utenti, che potranno testarne da sé le caratteristiche.

Per il momento, già solo l'idea di avere sempre a disposizione una riproduzione della struttura dei siti indicizzati mi sembra un'ottima cosa. Mi richiama l'ebbrezza di quei primi giorni di navigazione in una banda aghiforme, a cavallo di un modem cinguettante e scricchiolante. Le possibili evoluzioni dell'interfaccia web, a partire da quel volo d'uccello richiamato da Marchiori più volte nel corso della sua presentazione, mi ricorda troppo l'immagine primordiale del cyberspazio evocata da Neuromante, tradotta in estetica di uso popolare da film (Tron Legacy e Matrix, ma prima ancora Johnny Mnemonic, Il Tagliaerba, Hackers e il primo Tron) e videoclip. E pazienza per i neon, elemento imprescindibile dell'atmosfera cyberpunk: magari si accenderanno tremuli appena sul cyberspazio di Volunia calerà la notte. Anche per questo basterà aspettare.
February 5, 2012
Italia, 2012
Post ad altissima concentrazione polemica, proseguite a vostro rischio e pericolo. Che è un po' quello che ha fatto il sindaco di Roma nei giorni scorsi, sospendendo l'attività didattica ma lasciando le scuole aperte a beneficio dei genitori che volessero depositarvi i figli a tempo indeterminato, lasciando ingombre di neve le strade ma avvisando i cittadini di non mettersi in marcia senza catene, distribuendo pale per liberare i marciapiedi dalla neve e soprattutto ribaltando sulla Protezione Civile la mancata preparazione della Capitale all'arrivo della perturbazione…
Lo spettacolo che l'Italia sta dando di sé al mondo dall'inizio dell'anno riflette in maniera incantevole lo stato di confusione mentale in cui è precipitata. Siamo un Paese che merita un'accurata indagine psicopatologica. Qualcuno dice che il governo Monti ci sta aiutando a uscire dal baratro, secondo me restiamo invece ancora aggrappati oltre il bordo, in attesa di una mano provvidenziale che venga a porgerci l'agognata salvezza.
Procediamo per gradi.
La più grande nave da crociera italiana viene guidata contro gli scogli da un comandante in piena fregola e ancora non ho sentito un solo commentatore, nella pur ricca copertura mediatica dell'evento, interrogarsi su come abbia fatto una persona del genere a ottenere il comando di una nave come quella: nemmeno un segno di instabilità? Bene. Quanto all'efficienza, alle competenze, alla preparazione: davvero l'intera catena gerarchica che collega la sua posizione ai vertici aziendali così come i responsabili dell'ufficio del personale avrebbero messo uno per uno, tutti, già prima della tragedia, la mano sul fuoco sulle qualità del loro comandante? La speranza è che la magistratura accerti tutte le responsabilità in tal senso. Intanto godiamoci lo spettacolo del relitto incagliato di fronte al porto del Giglio, come la triste sagoma di una balena spiaggiata, un gigante annegato o un MegaMall naufragato.
Il gesto di un singolo in questi giorni si perde però nell'inefficienza del sistema.
Ha dello straordinario l'incapacità del Paese di fronteggiare un allarme meteo come quello di questo autunno-inverno. A partire dall'alluvione di Genova, che già riassumeva bene gli episodi simili occorsi in Sicilia e in Veneto negli scorsi anni: non un'istantanea isolata, ma un film intero e inequivocabile sullo stato di dissesto idrogeologico in cui versa il nostro territorio. Tutto merito di decenni di espansione edilizia scriteriata, selvaggia, sprezzante di ogni forma di sostenibilità ambientale e di sicurezza. Per finire con l'ondata di gelo di queste settimane. Che la neve, in pieno inverno, riesca a sorprendere e quasi paralizzare una nazione avanzata quale si vuole sia l'Italia, a partire dalla sua Capitale, ha sinceramente dell'incredibile. La situazione sarà stata pure più grave della media degli ultimi anni, però lo scaricabarile che si è subito innescato grazie ai vertici capitolini di fronte all'inadeguatezza delle contromisure predisposte è emblematico e molto più esplicativo di qualunque commento (anche se il fake del sindaco su Twitter merita una visita, se non altro per risollevarsi il morale).
E sorvoliamo sulle periodiche recrudescenze dell'emergenza rifiuti (dopo Napoli e Palermo, si attende la volta di Roma, e con queste premesse l'apocalisse è una promessa facile da rispettare) e le responsabilità politiche ancora tutte da accertare da parte degli inquirenti, sulle navi dei veleni dimenticate sui nostri fondali, sui disastri ambientali denunciati e quelli ancora da scoprire, sulle ricostruzioni solo mediatiche a uso e consumo della platea elettorale e delle consuete convergenze politico-affaristiche.
Probabilmente è vero, siamo usciti dalla demokratura che ha segnato la vita politica del paese per quasi un ventennio, ma la nottata non è ancora passata. Stiamo ancora pagando lo scotto del malaffare tollerato così a lungo, della loro impunita arte predatoria e della nostra connivente disattenzione. Ha del paradossale lo stesso governo Monti: nella Roma repubblicana, modello di diritto ancora nell'epoca moderna, le istituzioni elette delegavano l'esercizio del potere a un dittatore a tempo determinato in casi di particolare gravità. Nell'Italia degli ultimi vent'anni, invece, il potere viene delegato dal dittatore a un tecnico con l'incarico a termine di salvare il paese dalla rovina in cui è stato guidato dal suo predecessore. L'apoteosi dello stato-azienda, a quanto pare.
Raddrizzare le storture, mai come in questa fase, è un impresa titanica. E forse è inevitabile che da un'élite di tecnocrati, provenienti in numero significativo dal top management del settore bancario, quando si arriva al succo delle misure da adottare ai fini dello sviluppo, si giunga alla proposta di ritoccare lo statuto dei lavoratori. Quello che mi domando io, in tutta la partigianeria che mi contraddistingue e che non nascondo, è: davvero abbiamo bisogno di questo? Davvero, con un paese che dà continuamente prova delle sue carenze strutturali e della fragilità sistematica determinata dall'incompetenza e/o dall'inefficienza delle figure che ricoprono ruoli chiave nella sua amministrazione, basta una modifica all'Articolo 18 per rilanciare la crescita?
Qualsiasi ricetta per lo sviluppo, a mio parere, dovrebbe presupporre un requisito fondamentale: un controllo certo, insindacabile, sull'operato dei nostri amministratori pubblici. Nell'assenza certificata di ogni forma di decenza e coscienza (mettiamo a confronto il caso Guttenberg oppure il caso Huhne con il caso Conti o il caso Lusi, senza scomodare forme d'incompatibilità più illustri e ingombranti, e ne abbiamo a sufficienza per vergognarci da qui alla fine della legislatura), solo un organo di controllo che non rischia l'inibizione costante da parte del Parlamento può veramente tutelare qualsiasi piano di sviluppo nazionale, nonché l'immagine del Paese e la dignità dei suoi cittadini. Piuttosto che parlare di mobilità e flessibilità dei lavoratori, spostiamo l'obiettivo sui nostri rappresentanti, eletti o nominati: siamo proprio sicuri che siano i primi a scoraggiare investimenti stranieri, e non questi ultimi, continuamente al centro di scandali o protagonisti, come il summenzionato sindaco della capitale, di figure barbine di risonanza mondiale?
A giudicare dalle condizioni penose in cui versa l'infrastruttura del paese (trasporti, telecomunicazioni, energia, salvaguardia del territorio e del suo patrimonio artistico e archeologico), sono certo che poi si troveranno margini a sufficienza per sviluppare il potenziale di crescita capace di far riguadagnare all'Italia il posto che finora ha dimostrato di non meritare tra le nazioni sviluppate. Ma solo dopo, e non senza, aver risolto il nodo ormai colossale e imbarazzante delle responsabilità civili e morali.
January 29, 2012
HyperNext
Oggi nasce ufficialmente HyperNext, un nuovo blog connettivista. Informazioni, riflessioni, discussioni sull'immaginario a 360°, con un occhio di riguardo per le intersezioni con la scienza, la società, la tecnologia e la politica. HyperNext è un blog collettivo e a farlo ci saranno insieme al sottoscritto Sandro Battisti, Francesca Fuochi, Fernando Fazzari e Umberto Pace. Per le presentazioni di rito, rimando al primo post. E intanto eccovi il teaser preparato da Oedipa Drake:
HyperNext from Oedipa Drake on Vimeo.
January 28, 2012
Un grappolo di segnalazioni
 Come avrete notato dalla barra dei widget qui a destra, dopo un lungo periodo di acclimatamento mi sono convinto a usare Twitter. Potete trovarmi sotto le credenziali di NovaXpress, che è un omaggio autoreferenziale alla rivista pubblicata da Errico Chianese in Sezione π² e Corpi spenti, ma è anche un richiamo diretto a W.S. Burroughs. D'altro canto, già ne avevo adottato la scrittura proprio su queste pagine, per identificare la categoria sotto cui vado raccogliendo i miei articoli di commento politico-sociale-culturale (una sorta di op-ed, se questo blog fosse una rivista). In una sorta di zona franca tra il blog e il mio profilo Facebook, su Twitter troverete un flusso di segnalazioni e retweet delle cose più interessanti in cui mi capita di imbattermi in rete, intercalati da segnalazioni che mi riguardano direttamente (come per esempio i nuovi post del blog) e da momenti diciamo pure più disimpegnati.
Come avrete notato dalla barra dei widget qui a destra, dopo un lungo periodo di acclimatamento mi sono convinto a usare Twitter. Potete trovarmi sotto le credenziali di NovaXpress, che è un omaggio autoreferenziale alla rivista pubblicata da Errico Chianese in Sezione π² e Corpi spenti, ma è anche un richiamo diretto a W.S. Burroughs. D'altro canto, già ne avevo adottato la scrittura proprio su queste pagine, per identificare la categoria sotto cui vado raccogliendo i miei articoli di commento politico-sociale-culturale (una sorta di op-ed, se questo blog fosse una rivista). In una sorta di zona franca tra il blog e il mio profilo Facebook, su Twitter troverete un flusso di segnalazioni e retweet delle cose più interessanti in cui mi capita di imbattermi in rete, intercalati da segnalazioni che mi riguardano direttamente (come per esempio i nuovi post del blog) e da momenti diciamo pure più disimpegnati.
L'idea saliente è che periodi di apparente inattività del blog potrebbero essere compensati dalla mia presenza dall'altra parte. Si vedrà.
Intanto, una segnalazione ben più importante riguarda il movimento connettivista. Da alcuni giorni è stato pubblicato il nuovo numero della rivista accademica digitale California Italian Studies Journal, dedicata alle ricerche più avanzate sul fronte dell'italianistica, ideata e curata da un comitato intercollegiale dell'Università della California (per maggiori informazioni vi rimando al comunicato pubblicato su Italianistica.info e al sito che la ospita: eSchoolarship). La seconda uscita della rivista è una monografia dedicata agli Italian Futures e comprende un articolo di Arielle Saiber che dedica ampio spazio ai connettivisti, citando Next, Next International e Next Station, oltre a una serie di titoli (di articoli, antologie, racconti e romanzi) che ci riguardano direttamente: Flying Saucers Would Never Land in Lucca: The Fiction of Italian Science Fiction. Saiber è una docente del Bowdoin College e devo ringraziarla per la cura e l'attenzione con cui si è dedicata all'esplorazione del nostro movimento, e per aver coniato un neologismo per tradurre connettivismo in inglese: nextilism.
Troppo prematuro per parlare in alcun modo di spaghetti sci-fi, ma che il primo studio che abbia affrontato il ruolo del connettivismo nell'ambito della fantascienza italiana arrivi dagli Stati Uniti e sia maturato nell'ambito di una rivista di critica accademica è un buon segnale, no?
January 27, 2012
Il furto del futuro
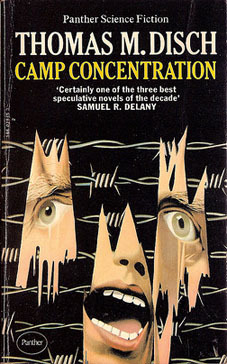
Oggi ricorrono i 67 anni dell'arrivo ad Auschwitz dei soldati dell'Armata Rossa e la scoperta di ciò che il Terzo Reich aveva significato per milioni di ebrei. Sei per l'esattezza. Oltre che per un numero inferiore ma comunque rilevante di prigionieri sovietici (almeno due milioni), polacchi non ebrei (circa due milioni), slavi (1-2,5 milioni), dissidenti politici (1-1,5 milioni), zingari (forse mezzo milione), omosessuali (5-15 mila), portatori di handicap o di malattie mentali (duecentomila). Secondo stime variabili, un numero di vittime complessivamente compreso tra i 12 e i 17 milioni furono eliminate dalla Storia con una furia sistematica. E la fluttuazione dei dati serve a rendere ancora più terribile l'orrore, per quanto possibile, conferendo alle proporzioni dell'Olocausto un carattere di incertezza. Per ricordare i caduti dello sterminio, nel 2005 la risoluzione 60/7 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha istituito il Giorno Internazionale della Memoria.
Altre nazioni, come l'Italia (fin dal 2000), avevano adottato la commemorazione del 27 gennaio già da tempo. D'altro canto, non so quanto possa giovare effettivamente un "giorno della memoria", al di là del ricordo in sé di quanti caddero vittime della follia. La notizia che un quinto dei ragazzi tedeschi tra i 18 e i 30 anni ignori la reale entità dell'orrore consumatosi ad Auschwitz allunga un'ombra inquietante su questa data. E' la dimostrazione pratica che non bastano tutte le istituzioni del mondo, la concordanza d'intenti internazionale, il martellare mediatico, a sostenere la prova della Storia. Occorrerebbe al contrario un lavoro sistematico di formazione. Probabilmente, portare le scolaresche in gita presso i campi di sterminio in Polonia o anche solo i diversi centri di internamento allestiti lungo l'asse della penisola, potrebbe servire altrettanto alla loro crescita umana quanto la vista di un affresco o di un museo di storia naturale. Ma riuscirci presupporrebbe un paese con una sua coscienza, che riesca a tutelare gli scavi di Pompei dai crolli e le sue città dalle ritorsioni della natura, e che sappia valorizzare un patrimonio storico vastissimo, che forse non tutti hanno l'interesse di considerare.
pratica che non bastano tutte le istituzioni del mondo, la concordanza d'intenti internazionale, il martellare mediatico, a sostenere la prova della Storia. Occorrerebbe al contrario un lavoro sistematico di formazione. Probabilmente, portare le scolaresche in gita presso i campi di sterminio in Polonia o anche solo i diversi centri di internamento allestiti lungo l'asse della penisola, potrebbe servire altrettanto alla loro crescita umana quanto la vista di un affresco o di un museo di storia naturale. Ma riuscirci presupporrebbe un paese con una sua coscienza, che riesca a tutelare gli scavi di Pompei dai crolli e le sue città dalle ritorsioni della natura, e che sappia valorizzare un patrimonio storico vastissimo, che forse non tutti hanno l'interesse di considerare.
Il Ventennio Fascista, tanto rimpianto nell'ondata di disorientato qualunquismo che si avverte montare negli ultimi tempi, significò oltre a tante altre indecenze anche e questo (una lista sola non basta, e anche questo è significativo). In periodi di crisi come questo, il malumore galoppante si trascina purtroppo dietro tutto uno strascico di rigurgiti pseudofascisti, razzisti, nazionalisti, e il passo da lì al neonazismo è breve. La teorizzazione di una qualche forma di superiorità, per diritto naturale o acquisito, è un viatico verso lo sprofondamento. Fortunatamente, la letteratura e il cinema ci hanno fornito materiale di eccellente qualità per propagare la memoria, rinsaldandone la tenuta. Lasciando da parte i classici e il mainstream, anche nell'ambito della fantascienza possiamo trovare opere di prima grandezza e di estrema utilità ai nostri scopi.
 Basti pensare a La svastica sul sole (romanzo del 1962, vincitore del Premio Hugo), in cui Philip K. Dick immagina uno scenario ucronico nato dalla vittoria delle potenze dell'Asse nella Seconda Guerra Mondiale e dalla loro conseguente spartizione del mondo; oppure ai bestseller Fatherland (1992), serratissimo thriller di storia alternativa di Robert Harris, e Il complotto contro l'America (2004), acclamata sintesi di bildungsroman e fantapolitica di Philip Roth. O ancora L'arcobaleno della gravità (1973), che valse a Thomas Pynchon il National Book Award, che si svolge nelle concitate fasi finali della caduta (ma sarà davvero caduta?) del Terzo Reich, e Il sindacato dei poliziotti yiddish (2007), notevolissima detective story di Michael Chabon che si riallaccia direttamente al filone delle ucronie, proponendo sulla Shoah un punto di vista obliquo. Charlie Stross sceglie al contrario di esaminare il genocidio dalla prospettiva del futuro profondo, ne L'alba del disastro (2004), dove l'incubo proviene da pianeti remoti oppressi sotto il tallone di ferro di una setta di cyborg neonazisti. Ma l'affresco più efficace di ciò che significa l'odio, dedicato agli effetti devastanti a cui può condurre se seminato nel suolo sempre fertile dell'ignoranza, ce lo offre forse Thomas Disch, che nel suo terribile e toccante Campo Archimede (1968), realizza con grazia straordinaria una perfetta attuazione del teorema ballardiano dell'inner space, risalendo concentricamente la gerarchia delle dimensioni dal microcosmo personale del protagonista (un poeta comunista imprigionato nel campo del titolo per la sua renitenza alla leva, in un'America totalitaria e bigotta del prossimo futuro) alla sfera universale del genere umano.
Basti pensare a La svastica sul sole (romanzo del 1962, vincitore del Premio Hugo), in cui Philip K. Dick immagina uno scenario ucronico nato dalla vittoria delle potenze dell'Asse nella Seconda Guerra Mondiale e dalla loro conseguente spartizione del mondo; oppure ai bestseller Fatherland (1992), serratissimo thriller di storia alternativa di Robert Harris, e Il complotto contro l'America (2004), acclamata sintesi di bildungsroman e fantapolitica di Philip Roth. O ancora L'arcobaleno della gravità (1973), che valse a Thomas Pynchon il National Book Award, che si svolge nelle concitate fasi finali della caduta (ma sarà davvero caduta?) del Terzo Reich, e Il sindacato dei poliziotti yiddish (2007), notevolissima detective story di Michael Chabon che si riallaccia direttamente al filone delle ucronie, proponendo sulla Shoah un punto di vista obliquo. Charlie Stross sceglie al contrario di esaminare il genocidio dalla prospettiva del futuro profondo, ne L'alba del disastro (2004), dove l'incubo proviene da pianeti remoti oppressi sotto il tallone di ferro di una setta di cyborg neonazisti. Ma l'affresco più efficace di ciò che significa l'odio, dedicato agli effetti devastanti a cui può condurre se seminato nel suolo sempre fertile dell'ignoranza, ce lo offre forse Thomas Disch, che nel suo terribile e toccante Campo Archimede (1968), realizza con grazia straordinaria una perfetta attuazione del teorema ballardiano dell'inner space, risalendo concentricamente la gerarchia delle dimensioni dal microcosmo personale del protagonista (un poeta comunista imprigionato nel campo del titolo per la sua renitenza alla leva, in un'America totalitaria e bigotta del prossimo futuro) alla sfera universale del genere umano.
Ispirato dal famigerato furto dell'iscrizione posta sull'ingresso di Auschwitz, non si può dimenticare il racconto di Stefano Di Marino La memoria rende liberi, riuscitissima incursione dell'autore nei territori della fantascienza, incluso nell'antologia Sul filo del rasoio (2010), curata per il Supergiallo Mondadori da Gianfranco de Turris (a riprova, una volta ancora se necessario, della pretestuosità infondata di certe accuse che hanno investito - anche di recente - il suo lavoro nell'ambito del fantastico).
Di Fatherland nel 1994 fu anche tratta una trasposizione televisiva per la HBO, con Rutger Hauer nei panni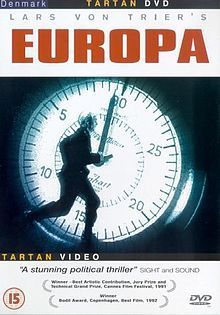 del protagonista. E un paio d'anni fa circolò la notizia che la BBC avesse messo in cantiere una miniserie in quattro episodi tratta da La svastica sul sole, con Ridley Scott nel ruolo di produttore esecutivo, di cui si sono purtroppo perse le tracce. Ma per venire a incubi cinematografici già trasposti su celluloide, vanno segnalati Europa (1991), capitolo finale del trittico del danese Lars von Trier dedicato al vecchio continente, tra toni surreali e seduzioni ucroniche. Più recentemente, il regista inglese Dennis Gansel ha delineato nel suo L'Onda (2008) il pericolo di un riflusso autocratico, sorto in seno a un esperimento scolastico e presto degenerato in incubo. Il fascino dei totalitarismi - è questo il teorema che emerge da entrambi i film citati - attecchisce nel disagio, soprattutto in periodi di smarrimento storico e di apparente disaffezione alla politica.
del protagonista. E un paio d'anni fa circolò la notizia che la BBC avesse messo in cantiere una miniserie in quattro episodi tratta da La svastica sul sole, con Ridley Scott nel ruolo di produttore esecutivo, di cui si sono purtroppo perse le tracce. Ma per venire a incubi cinematografici già trasposti su celluloide, vanno segnalati Europa (1991), capitolo finale del trittico del danese Lars von Trier dedicato al vecchio continente, tra toni surreali e seduzioni ucroniche. Più recentemente, il regista inglese Dennis Gansel ha delineato nel suo L'Onda (2008) il pericolo di un riflusso autocratico, sorto in seno a un esperimento scolastico e presto degenerato in incubo. Il fascino dei totalitarismi - è questo il teorema che emerge da entrambi i film citati - attecchisce nel disagio, soprattutto in periodi di smarrimento storico e di apparente disaffezione alla politica.
Un quadro fin troppo familiare. Presidiare il passato, anche attraverso le forme di riscrittura critica operate dall'ucronia, è una valida strategia per difendere il futuro. Almeno mi piace crederlo, specie di questi tempi.
January 8, 2012
Titano: il prodigio alchimistico di John Varley
John Varley profonde sense of wonder a piene mani in questo classico della fantascienza, precursore della new space opera di cui oggi tanto si parla. Tanto da lasciarmi incollato addosso l'entusiasmo ancora a distanza di qualche giorno dalla fine della lettura e da rendermi pressoché impossibile organizzare questo post nella forma di una recensione canonica. Quindi mi limito a raccogliere un po' di suggestioni, che potrebbero tornare utili anche in futuro, visto che il Curatore di Urania Giuseppe Lippi ha già annunciato che nel 2012 verranno pubblicati anche gli altri due volumi della trilogia di Gea.
 Titano (Titan) è un romanzo del 1979 (gli altri due titoli del ciclo sono Nel segno di Titano - Wizard, 1980 e Demon, 1983), opportunamente ristampato negli anni da Urania e finalmente approdato anche nella spettacolare Urania Collezione, una collana che non dovrebbe mancare nella libreria dell'appassionato. A rendergli lustro una meravigliosa copertina di Franco Brambilla e la traduzione integrale di Vittorio Curtoni. Anche per questo, a maggior ragione nelle nostre biblioteche non dovrebbe risultare assente questo libro, che come accennavo poc'anzi rappresenta un ideale tramite tra la space opera classica (quella di Van Vogt e Asimov, per intenderci, nelle sue espressioni migliori) e la nuova space opera degli universi della Cultura di Iain M. Banks, di Hyperion di Dan Simmons, di Paul J. McAuley, Ken MacLeod, Alastair Reynolds. Una space opera innestata di hard sci-fi e dotata di una particolare cura stilistica nella scia della new wave, che porta a termine l'opera di innovazione iniziata dagli inglesi e che attraversa tutto il decennio: il ponte lanciato da Incontro con Rama di Arthur C. Clarke (1973) e prolungato da The Centauri Device di M. John Harrison (1975), raggiunge qui il completamento della sua campata.
Titano (Titan) è un romanzo del 1979 (gli altri due titoli del ciclo sono Nel segno di Titano - Wizard, 1980 e Demon, 1983), opportunamente ristampato negli anni da Urania e finalmente approdato anche nella spettacolare Urania Collezione, una collana che non dovrebbe mancare nella libreria dell'appassionato. A rendergli lustro una meravigliosa copertina di Franco Brambilla e la traduzione integrale di Vittorio Curtoni. Anche per questo, a maggior ragione nelle nostre biblioteche non dovrebbe risultare assente questo libro, che come accennavo poc'anzi rappresenta un ideale tramite tra la space opera classica (quella di Van Vogt e Asimov, per intenderci, nelle sue espressioni migliori) e la nuova space opera degli universi della Cultura di Iain M. Banks, di Hyperion di Dan Simmons, di Paul J. McAuley, Ken MacLeod, Alastair Reynolds. Una space opera innestata di hard sci-fi e dotata di una particolare cura stilistica nella scia della new wave, che porta a termine l'opera di innovazione iniziata dagli inglesi e che attraversa tutto il decennio: il ponte lanciato da Incontro con Rama di Arthur C. Clarke (1973) e prolungato da The Centauri Device di M. John Harrison (1975), raggiunge qui il completamento della sua campata.
La storia in breve. Una spedizione esplorativa approda nel sistema di Saturno per compiere una missione di ricognizione nella sua vasta corte di satelliti, ma ben presto s'imbatte in un'anomalia: nell'orbita del signore degli anelli il Ringmaster, al comando del capitano Cirocco Jones, localizza infatti una megastruttura che non dovrebbe trovarsi lì e che, a ragion di logica umana, non potrebbe nemmeno esistere. Temi, così viene denominato questo Big Dumb Object, è un habitat grande come una luna, formato da un anello e da sei raggi che lo collegano a un mozzo. Avvicinandosi all'oggetto, la nave spaziale subisce un improvviso quanto ineludibile attacco e il suo equipaggio si risveglia - giorni o forse anni interi più tardi - all'interno del corpo stesso di Temi. E tutti, in un modo o nell'altro, scopriranno nel corso della storia di essere stati cambiati. Cirocco Jones, comandante senza più una nave, si ritrova a fare i conti con una situazione disperata: in un ambiente alieno, alle prese con una fauna bizzarra (composta da immensi dirigibili senzienti, centauri che comunicano cantando, angeli demoniaci con l'unico obiettivo di dare battaglia ai centauri e vermi delle sabbie che sembrano usciti dalle pagine di Dune), con le insidie nascoste in un ecosistema apparentemente idilliaco e con gli enigmi di una struttura immensa, si avventurerà con pochi superstiti in un'odissea volta a chiarire e comprendere i misteri di Temi e di Gea, la divinità che controlla l'habitat e che forse la compenetra a un livello ancora più pervasivo.
Nella sua recensione per Fantascienza.com, Giampaolo Rai segnala un sito straordinario dedicato alla trilogia di Varley: assolutamente fondamentale per comprendere i dettagli della sua immensa costruzione. Guardate un po' questo filmato e giudicate da voi se non basta per accostare il lavoro di world-building operato da Varley alle meraviglie fatte da James Cameron con Avatar:
A short flying thru Titan from Jean-Paul Têtu on Vimeo.
Ma John Varley conferisce alle sue pagine anche uno spessore letterario estraneo tanto alla space opera quanto all'hard sci-fi tradizionali. Pur rifacendosi agli schemi del racconto avventuroso, Varley delinea con accuratezza le psicologie dei suoi personaggi e in modo particolare della protagonista, conferendole una personalità tridimensionale, mai posticcia, naturale espressione di una storia personale che viene ricostruita in pochi flashback, essenziali e mirati. Le stesse relazioni tra i personaggi vengono investigate con attenzione puntigliosa, anche attraverso la metafora del sesso, che l'autore utilizza in maniera coraggiosa soprattutto per la sua epoca, mostrando relazioni omosessuali e senza lesinare dettagli nella scena dello stupro subito dalla protagonista (descritta senza indulgere in lungaggini compiaciute né in un'altrettanto spiacevole e insulsa pruderie, e, cosa ben più importante, mediandola attraverso il punto di vista della vittima).
Il percorso di Cirocco Jones e della sua pard (se mi concedete di mutuare dal western l'espressione per indicare il loro sodalizio, che si fa via via sempre più intimo e profondo) Gaby Plauget assume i connotati di un'impresa epica sufficiente a giustificare l'accesso alla conoscenza, la conquista dell'ultima verità sulla natura del mondo artificiale in cui i naufraghi del Ringmaster sono rimasti intrappolati. E proprio la scalata al cielo, la sfida improponibile per qualsiasi titanide (la specie dei centauri, la più evoluta tra quelle incontrate su Temi) viene trasfigurata in un'esperienza metafisica che a un certo punto mi ha richiamato alla mente uno strano parallelo con l'esperienza del traduttore, il grande Vittorio Curtoni, maestro e amico scomparso di recente. Complice anche la postfazione di Giuseppe Lippi, che puntualmente si sofferma sul ruolo di un artista "costretto" a rendere nella propria lingua il parto della creatività di un collega straniero, ho trovato una particolare assonanza con le vicissitudini di Cirocco, che all'improvviso si riscopre dotata del dono, insospettato e incomprensibile, di poter comunicare con una specie aliena come i titanidi capendo ed esprimendosi nella loro stessa lingua. Proprio in virtù di questa facoltà, unica tra i naufraghi del Ringmaster Cirocco osa lanciare la scalata al mozzo, dove si annida il segreto di Gea.
E così, mentre lei e Gaby giungevano al cospetto di Gea, ricevute dal Titano in una sala rococò che ricordava la stanza oltre l'Infinito di 2001: Odissea nello Spazio, mi si è formata in testa l'immagine del lettore, che grazie agli sforzi del traduttore può arrivare a decodificare l'opera nativa dell'autore, che forse è sempre un po' un Big Dumb Object.
Nel caso di Titano, insomma, la realtà si ripiega sull'immaginario e le due dimensioni si compenetrano a livelli sempre più profondi, come in una costruzione frattale. C'è l'opera mitopoietica di Gea che riflette l'opera creativa di Varley fin nel processo stesso della costruzione narrativa, con il Titano che si nutre di immaginario terrestre e Varley che dà fondo all'immaginario fantascientifico (dal citato duo Kubrick/Clarke a Herbert, ma i riferimenti sono numerosi, basti pensare che uno dei comprimari è un lettore accanito di science fiction, e che a un certo punto non manca di interrogarsi ricorsivamente sul genere e sul suo legame con il mondo artificiale e con l'avventura che sta vivendo). Ci sono le riflessioni sulla comunicazione che si adattano alla perfezione al ruolo del traduttore di un'opera letteraria, chiamato in questo caso a svolgere un'impresa titanica, come il Vic, tra i pochi in Italia, poteva essere in grado di svolgere. E c'è l'avventura che si trasforma in impresa epica e solo in virtù di questa sua statura concede alla protagonista il diritto di comprendere la natura dei Titani e ciò che è veramente accaduto a lei e ai suoi compagni, che trasfigura l'esperienza di ogni lettore, che solo in virtù dell'empatia innescata da una storia ambiziosa come questa può coglierne e apprezzarne appieno le sfumature e i risvolti.
E di sicuro è bello - anzi, di più, entusiasmante! - ritrovarsi dopo tante letture fantascientifiche a provare ancora lo stupore e la meraviglia che rendevano così straordinarie (ma per fortuna non irripetibili) le mie primissime letture di A.E. van Vogt e Isaac Asimov. Non fatevi sfuggire questo capolavoro, che trovate in edicola ancora per qualche giorno: mi impegno a rimborsare gli insoddisfatti.



