Lorenzo Trombetta's Blog, page 18
December 4, 2014
Nihad Sirees, Il suono del silenzio

(di Caterina Pinto). Il 15 giugno 2011 a Damasco i sostenitori del presidente Bashar al Asad organizzarono un’imponente manifestazione – masira in arabo – durante la quale fu srotolata una bandiera siriana lunga oltre 2 chilometri e larga 18 metri. Solo pochi mesi prima erano iniziate le allora inedite manifestazioni contro il regime – muzaharat stavolta, le parole sono importanti! –, i rivoluzionari avevano preso a usare una nuova bandiera a tre stelle, per contrapporla al tricolore ufficiale imposto dal Baath al suo avvento al potere, i morti incominciavano già a superare il migliaio e così sventolare “la più grande bandiera siriana” era un segno di patriottismo.
Il 15 giugno 2011 io ero a Damasco. E decisi di andare a dare un’occhiata alla manifestazione. Sin dal mattino pullman, minivan e macchine carichi all’inverosimile, trasportavano manifestanti vocianti verso l’autostrada di Mezze, file di persone scandivano slogan in onore del presidente. Bandierine, striscioni, cartelli, urla, canzoni, si sovrapponevano agli applausi, ai volti sorridenti dipinti col tricolore, alle mani alzate, agli spintoni che arrivavano da una parte e dall’altra. Una sorta di isterica euforia collettiva si sprigionava dalla folla. E io provavo una strisciante sensazione di disagio insopportabile, mi sembrava di essere l’unica a non partecipare.
Ho ripensato a quel giorno di tre anni fa quando ho iniziato a leggere Il silenzio e il tumulto di Nihad Sirees. Perché il romanzo si apre con il protagonista che in una caldissima giornata estiva in un Paese senza nome esce di casa durante le celebrazioni per il ventennale della salita al potere del Leader e si ritrova schiacciato e sovrastato dalla folla in delirio, “una massa compatta, ondeggiante, urlante” (p. 8).
È il “tumulto” del potere evocato dal titolo, il clamore assordante degli slogan, degli inni patriottici e delle parate immortalate da radio e televisione per poter essere trasmesse e ritrasmesse senza posa. “Mentre la calma e la tranquillità inducono le persone alla riflessione, attirare periodicamente le folle in questi cortei tumultuosi è indispensabile al fine di lavare il cervello e di impedire di commettere l’orrendo crimine di pensare” (p. 15). E Fathi Shin, scrittore trentunenne, ha commesso proprio questo crimine, ha osato pensare e dissentire. Così il potere l’ha accusato di tradimento e gli ha imposto il silenzio, proibendogli di scrivere e pubblicare i suoi libri.
Fathi è il narratore del racconto che si svolge nell’arco di ventiquattro ore e invita il lettore a seguirlo durante la sua giornata, mostrando i dettagli di una società che fa inevitabilmente pensare a quella di 1984 di Orwell, in cui le vite dei cittadini sono dominate dal sopruso e dalla paura, oltre che dal culto della personalità del Leader. Una società in cui persino le canzoni d’amore sono bandite, a meno che non cantino l’amore per il Leader.
La trama del romanzo, che scorre fluida nella prosa piana e ironica di Sirees (resa in italiano da Federica Pistono) è piuttosto scarna e si dipana in una serie di incidenti e di incontri più o meno fortuiti che capitano al protagonista. I vari episodi forniscono tutti insieme diverse sfaccettature del potere e i modi in cui esso controlla, manovra e si insinua nelle vite dei cittadini. Fino alla parte finale del libro e della giornata di Fathi che si ritrova nella sede della Sicurezza militare, faccia a faccia con il signor Ha’il, il capo, che gli chiede di diventare responsabile dell’ufficio propaganda del regime, se non vuole rischiare un silenzio definitivo e molto meno invitante dell’attuale: quello della tomba.
Autobiografia e finzione si fondono in questo romanzo di Sirees: le subdole manovre dei funzionari, i cinici meccanismi dell’apparato di sicurezza non possono non far pensare ai tristemente famosi esempi siriani, così come Fathi Shin rappresenta tutti gli intellettuali e Sirees stesso, costretti a subire le pressioni del potere, il controllo della censura, a rischiare il carcere, o a scegliere l’esilio. In una situazione di questo genere sono due le uniche armi possibili per rimanere in vita, è Fathi stesso a dirlo: il sesso e il riso. E il finale tragicomico sotto le simboliche spoglie di un sogno è lì a dimostrarlo.
Il riso è un’arma magica e strana, che non causa spargimento di sangue ma protegge,
così come sovverte l’equilibrio tra vincitore e vinto.
Radwa Ashur da Atyàf
November 29, 2014
L’onere della prova e gli eroi bambini
 (di Lorenzo Declich, per Nazione Indiana). Ci sono volte in cui la semplice esposizione di cose presenti lancia messaggi molto chiari. In principio, dunque, vi racconterò cosa ho nel mio computer, nella cartella “hero boy”, dove ho messo diversi video scaricati da YouTube. Aggiungerò a questa descrizione alcuni dettagli, facilmente reperibili in rete.
(di Lorenzo Declich, per Nazione Indiana). Ci sono volte in cui la semplice esposizione di cose presenti lancia messaggi molto chiari. In principio, dunque, vi racconterò cosa ho nel mio computer, nella cartella “hero boy”, dove ho messo diversi video scaricati da YouTube. Aggiungerò a questa descrizione alcuni dettagli, facilmente reperibili in rete.
Nel primo video un bambino si trova sotto il fuoco dei cecchini. Fa finta di cadere, colpito, poi si rialza e va a salvare una bambina. Si intitola “Eroe siriano: un ragazzo salva una ragazza”. Il titolo è in inglese e in arabo.
Nel secondo video, taggato “BBC trending”, si scopre che il video precedente è un falso, che la scena è stata girata su un set. La didascalia spiega che: “il video dell’eroe bambino siriano è un falso costruito da filmakers norvegesi”. Apprenderemo poi che la scena è stata girata lo scorso agosto a Malta. I titoli, qui, sono in inglese.
Il terzo video contiene una sorta di rassegna stampa intitolata, in inglese: “la NATO usa un falso video virale su un eroe bambino siriano per invadere la Siria”.
Il quarto video, in inglese, è un’intervista al regista del video, Lars Klevberg, che: “non si pente riguardo al video falso”. In un dispaccio che ha diffuso via twitter, spiega che col suo lavoro voleva porre l’attenzione sui bambini nella guerra siriana.
L’”opera” di Klevberg ha raggiunto milioni di persone ma, nonostante questo “non pentimento” pubblico, animato dal desiderio di “accendere i riflettori” sui bambini siriani, il video originale è stato cancellato da Youtube: ne abbiamo oggi solo copie. Una di esse, postata dal network Sham, ha oggi 4.600.000 visualizzazioni.
Abbiamo solo copie anche del secondo video, anch’esso è stato cancellato, anch’esso era molto popolare. L’originale complottardo, invece, rimane online, è stato visto da più di centomila persone.
Ho un quinto, un sesto e un settimo video nel mio computer. Nel quinto (12 marzo 2012) andiamo a Homs. Un ragazzo salva un altro ragazzo, ferito, mettendo a rischio la propria vita. 1.100 visualizzazioni. Nel sesto (28 aprile 2012) un bambino di Dera’a corre in mezzo alla strada con una borsa in spalla. Si sente un forte brusio e poi un’esplosione. Il bambino continua a correre, irrompe correndo un ragazzo, che lo prende in braccio e lo porta via. 350.000 visualizzazioni. Nel settimo (3 novembre 2012) ci sono quattro ragazzini che corrono in direzione della telecamera su una strada che, secondo le indicazioni, si trova nelle campagne di Aleppo, Khan al-Asal. Sullo sfondo c’è un carro armato. Si sentono rumori di spari. Le voci fuori campo si fanno sempre più concitate. I ragazzini fanno una cinquantina di metri, in ordine sparso, si mettono tutti in salvo. L’ultimo a trovare riparo porta in braccio un quinto bambino, piccolissimo. 4.700 visualizzazioni.
Ho trovato i video su un blog. Facendo ricerche incrociate su Youtube li ho ritrovati con difficoltà. E’ vero, sono relativamente vecchi e portano titoli in arabo, ma l’ostacolo più grande è stato un altro. Per scovarli ho dovuto scorrere decine e decine di pagine di ricerca, tutte dominate dall’onnipresente vera-falsa storia del “bambino eroe” siriano. Sempre gli stessi quattro fotogrammi, presentati in tutte le salse, un elenco che non è tale perché ripropone continuamente la stessa cosa. Pochi sono i click su queste copie secondarie, ma il loro numero provoca un effetto di saturazione, l’attenzione inesorabilmente cade. Il falso eroe è ovunque.
Bellingcat, un sito che si occupa di fact checking partecipato, ha diffuso nei giorni scorsi questo comunicato:
Noi sottoscritti esprimiamo la nostra condanna sul carattere ingannevole del film diretto da Lars Klevberg e finanziato dal Norwegian Film Institute e l’Arts Council Norway sulla Siria. È incosciente e irresponsabile distribuire una fiction come se fosse una ripresa reale perché ciò sminuisce la reale sofferenza dei bambini della Siria e il duro lavoro svolto dai giornalisti professionisti e dai cittadini all’interno della Siria.
I bambini siriani sono stati il bersaglio di cecchini, barili-bomba e di atrocità di massa per oltre tre anni. Gran parte di queste cose sono state documentate, faticosamente, da giornalisti-cittadini e giornalisti professionisti in circostanze pericolose e terribili. Questo film mina il lavoro delle persone che continuano a documentare questi crimini contro l’umanità. Piuttosto che impegnarsi in un dibattito, utilizzando elementi esistenti, di cui vi è abbondanza, il film invita a mettere in discussione, sia eticamente che professionalmente, il lavoro svolto per documentare questi crimini all’interno della Siria.
Il modo in cui questo film è stato presentato al pubblico è volutamente fuorviante. In un tale conflitto, decifrare il vero dal falso è un compito difficile e molti attivisti, giornalisti e analisti trascorrono ore e ore spulciando tra i video al fine di fornire informazioni accurate al pubblico. Il metodo volutamente ingannevole col quale il video è stato diffuso ha provocato maggiore disinformazione sulla Siria.
Questo video non farà che alimentare i tentativi di diffondere dubbi su storie reali provenienti dalla Siria, prodotte da giornalisti-cittadini e giornalisti professionisti. La vicenda dimostra che i filmakers, e coloro che li hanno finanziati, hanno poca comprensione della complessità del conflitto e non hanno riguardo per il rischio che la gente prende su di sé per documentare la violenza e il conflitto.
In un conflitto così crudele e incerto come quello in Siria, ci sono storie vere di eroismo quotidiano che testimoniano la sofferenza di un popolo. Molti hanno pagato con la vita.
Invece di far luce su una generazione perduta, il film ha messo in pericolo vite, ha posto l’onere della prova a chi soffre piuttosto che su quelli che causano la sofferenza, ha sminuito il coraggio delle persone che lavorano in zone di conflitto.
Ci ho pensato a lungo, poi ho deciso di postare almeno uno dei video che ho descritto. Eccolo, non è fiction.
November 26, 2014
“È meglio lo Stato islamico o Asad?” 3/3
 (di Alberto Savioli). La domanda che spesso viene posta a chi continua a denunciare i crimini di Asad è: “È meglio lo Stato islamico o Asad?”, è una domanda retorica di facile soluzione. Questo pezzo (il terzo di tre) vuole dare risposta alle questioni poste anche da chi sostiene Asad, non presentando solo opinioni ma fatti documentati accaduti negli ultimi quattro anni. Si presenta come un ampio dizionario di testimonianze video delle atrocità siriane.
(di Alberto Savioli). La domanda che spesso viene posta a chi continua a denunciare i crimini di Asad è: “È meglio lo Stato islamico o Asad?”, è una domanda retorica di facile soluzione. Questo pezzo (il terzo di tre) vuole dare risposta alle questioni poste anche da chi sostiene Asad, non presentando solo opinioni ma fatti documentati accaduti negli ultimi quattro anni. Si presenta come un ampio dizionario di testimonianze video delle atrocità siriane.
Questo pezzo è la terza parte di un lungo articolo le cui prime due puntate sono apparse nelle settimane precedenti (parte 1 e parte 2). Prendetevi il vostro tempo, ma guardate i video, alla fine sarà impossibile riproporre la domanda: “Meglio lo Stato islamico o Asad?”.
Fondamentalismo costruito a tavolino.
Molti estremisti arruolati dallo Stato islamico (Is), facevano parte di quei gruppi sunniti creati da Asad in funzione anti-americana e mandati a combattere in Iraq nel 2004-07 secondo una nota strategia.
Mentre Mazen Darwish, giornalista e direttore del Centro per i media e la libertà di espressione, così come centinaia di attivisti finivano in carcere, il regime con le amnistie liberava fondamentalisti e tagliagole. Alcuni capi delle brigate ribelli sono usciti di prigione con le amnistie di Assad nel luglio 2011: Zarhan Allush, Hassan Abbud e al Jolani (di Jabhat al Nusra).
Questa prassi è confermata anche dalla scrittrice siriana Samar Yazbek, alawita come il presidente siriano e finita in carcere come oppositrice. Quando si trovava nel nord della Siria per dare sostegno alle donne dei campi profughi racconta di avere parlato con diversi jihadisti: “Ho parlato con loro per un anno intero sulla linea del fronte… alcuni mi hanno detto che erano in prigione con me e che Bashar li aveva rilasciati nel mese di aprile 2011”.
Per lei, i jihadisti “sono i figli della politica di Asad”. “(Asad) è il primo assassino nel Paese”, continua, ricordando il bombardamento incessante del regime contro il suo stesso popolo: “nei villaggi del nord, ti fa impazzire, non si può fare nulla”.
 Un presidente non confessionale ordina un massacro confessionale.
Un presidente non confessionale ordina un massacro confessionale.
Una delle domande frequentemente poste dal geo-politologo riguarda la sorte delle minoranze: cosa ne sarebbe dei cristiani e degli sciiti se cadesse Asad e il paese venisse conquistato dallo Stato islamico?
È innegabile che nell’attuale situazione di guerriglia in un territorio frazionato tra diversi contendenti – in alcune zone a macchia di leopardo – molte persone e non solo tra le minoranze si sentano tutelate dal regime e sarebbero in pericolo sotto lo Stato islamico o altri gruppi ribelli. Nessuna persona sana di mente considera l’Is un’alternativa.
È evidente che solo una situazione politica può porre fine a questo conflitto. Ma il conflitto non può avere fine per paura dell’Is, e per questa paura non si può riabilitare Asad, che è l’origine prima di questo disastro.
Sono state le “squadracce” di Asad a compiere il massacro confessionale a danno dei sunniti di Banyas e al Beida nel maggio 2013, come documentato anche da Human Rights Watch, 248 persone (tra cui donne e bambini) sono state uccise a sangue freddo, alcuni di loro sgozzati. Ma allora nessun geo-politologo ha denunciato il fatto o si è “stracciato le vesti” per quelle morti.
Il massacro era anche stato annunciato e pianificato in un video (video 1 al min. 4.21, 2) da Mihrac Ural, chiamato Ali al Kayali, un alawita turco comandante di una milizia forte di 2000 uomini, la Resistenza siriana (Ssi). Ali Kayali usa i termini “liberare” e “purificare” per intendere: uccidere i civili di un’enclave sunnita (Banyas), in una zona a maggioranza alawita. Molti sostenitori di Asad in Italia utilizzano termini simili: liberare e derattizzare.
I fatti di allora c he in altri contesti verrebbero chiamati genocidio, sono ben illustrati nei video che seguono (1, 2, 3, 4, 5, 6). L’immagine a sinistra è stata volutamente distorta per il contenuto forte, per chi volesse approfondire con ulteriori immagini rimando ai link (1, 2, 3).
he in altri contesti verrebbero chiamati genocidio, sono ben illustrati nei video che seguono (1, 2, 3, 4, 5, 6). L’immagine a sinistra è stata volutamente distorta per il contenuto forte, per chi volesse approfondire con ulteriori immagini rimando ai link (1, 2, 3).
I soldati governativi festeggiavano l’esito della “purificazione” al grido di “Dio, la Siria, Bashar e basta” e “Bashar non ti preoccupare siamo i tuoi uomini, noi beviamo il sangue” (video). Prima di trucidarli calpestavano gli abitanti della città (video), ed infine hanno lasciato uno scempio fatto di cadaveri di uomini, donne e bambini (video).
Un errore che – a mio avviso – compie il geo-politologo ponendo la domanda: “È meglio lo Stato Islamico o Asad?” sta nel fatto che considera Asad il male minore, facendo una distinzione tra l’orco buono e l’orco cattivo. Lo sbaglio è porre come unica alternativa Asad o l’Is: la Siria non è Asad, il pluralismo politico e il laicismo esistevano in Siria prima del colpo di stato di Hafez al Asad.
Perché non è possibile concepire una Siria senza chi si è macchiato di gravi crimini contro l’umanità? Una soluzione politica che prevede l’allontanamento di Asad (anche se non è in agenda) senza la caduta del sistema statale siriano, servirebbe a coagulare contro l’Is quelle forze sunnite che inevitabilmente vedono Asad come il nemico ma che non si identificano nello Stato islamico.
Il mantra ripetuto da una certa stampa occidentale, di Asad protettore delle minoranze, è vero fintanto che quelle minoranze riconoscono il rais come loro legittimo capo, come dimostrano i molteplici episodi di oppositori e attivisti cristiani, alawiti, sciiti arrestati o uccisi per essersi opposti alla dittatura. Questo aspetto è spiegato chiaramente dall’attrice cristiana May Skaaf, più volte arrestata, nel documentario Farewell to Damascus: “Sono molto preoccupata per gli alawiti in Siria, non è colpa loro, per quarant’anni sono stati portati a credere che se Hafez al Asad e il regime che ha ereditato Bashar al Asad fossero stati spazzati via, i sunniti sarebbero venuti per macellarli [non si riferisce qui allo Stato islamico o ai gruppi salafiti n.d.r.]. Hanno lavorato sodo per fissare questa idea nelle loro teste. Ho davvero paura per loro, perché questo regime ha lavorato così duramente per trasformare questa rivolta in una guerra civile, perché un gran numero di milizie pro-regime appartengono alle minoranze (…). Sto parlando di politica, la politica di terrorizzare le minoranze, una politica che questo regime ha imposto alla società. Che senza il regime, i sunniti vengono a massacrare le minoranze. Poi ci sono i benefici, un gran numero di coloro che è nell’esercito gode di notevoli privilegi. Tutto questo serve a legarli al regime, sono diventati regime. Si tratta di un arazzo marcio che il regime ha tessuto al fine di raggiungere questo momento, e sa esattamente dove questo lo sta portando. Essi non si preoccupano dello stato di diritto, né della difesa delle minoranze, perché le minoranze non sono il problema. Si tratta di una rete di mafie che provengono da tutti i diversi gruppi. Si sono messi assieme solo per questo momento. Nel momento in cui avrebbero perso la loro immoralità…”.
 La società civile ignorata per dare forza alla tesi complottista.
La società civile ignorata per dare forza alla tesi complottista.
Chi sostiene la tesi del complotto destabilizzatore ai danni della Siria, parla di disegno globale e di primavere arabe tout court, di Siria, Libia mettendoci dentro anche l’Ucraina. Ma omettono sempre di parlare di Tunisia, dove tutto è cominciato con un dittatore rimosso immediatamente senza portare il Paese nel baratro siriano con uno scontro fratricida e dove alle recenti elezioni ha vinto un partito sostanzialmente laico. Dimenticano anche di dire che in Egitto c’è stata una restaurazione dell’esercito. E non parlano nemmeno dello scoppio delle manifestazioni di piazza e pacifiche in Paesi alleati dei destabilizzatori americani, come la Giordania e il Bahrein.
Il tentativo di rendere lineare il corso degli eventi, viene fatto da chi sposa la tesi complottista, negando le manifestazioni di piazza pacifiche, tacendo di arresti e torture, tacendo dell’opposizione politica interna che non chiedeva la caduta del regime ma è stata costretta ugualmente all’esilio o alla prigione.
Quella società civile che protestava pacificamente nel 2011 esiste ancora anche se minoritaria o silente, denuncia a rischio del carcere o della vita le violazioni del regime e dei ribelli (a seconda di dove vive), sviluppa progetti locali di solidarietà tra comunità, sostiene progetti legati all’informazione, all’istruzione o agli aiuti materiali.
Continuiamo a ignorarla come abbiamo fatto nel 2011, ma nel 2015 o nel 2016 non lamentiamoci per la nascita del nuovo mostro peggiore dello Stato islamico. Lo Stato islamico è percepito da molti elementi sunniti combattenti come una possibilità di rivalsa dopo anni di dominio politico sciita in Siria e Iraq.
 Come sconfiggere lo Stato islamico.
Come sconfiggere lo Stato islamico.
I recenti bombardamenti degli Usa hanno preso di mira anche due gruppi salafiti (Jabhat al Nusra e Ahrar al Sham) che combattevano contro lo Stato islamico soprattutto nella zona di Idlib. Il primo risultato è stato che la Nusra avrebbe dichiarato di essere pronta a combattere assieme all’Is.
Anche qui si registra il solito “effetto collaterale” dei bombardamenti, come si vede in questo recente video che documenta la morte di bambini a Harem (Idlib), il 6 novembre. Dopo questo fatto le loro famiglie sosterranno maggiormente lo Stato islamico.
Questo aspetto è evidente nell’interessante documentario del giornalista di origine svedese, Tam Hussein, che ha parlato con jihadisti olandesi all’interno del battaglione Jund al Aqsa e che dice che “quando gli americani bombardano, la gente esce in sostegno dello Stato islamico, dicendo: Siamo tutti Is”.
La giornalista Zaina Erhaim che twitta da Aleppo (nella foto sopra accanto a un murales), scrive: “Un emiro che ha defezionato dall’Is mi ha confessato che il numero di nuovi jihadisti è aumentato dall’inizio dei bombardamenti della Coalizione”.
Domandare in modo retorico: “È meglio Asad o il terrorismo (lo Stato islamico)?”, oppure: “Cosa ne sarebbe della Siria se cadesse Asad con tutti i terroristi che hanno invaso il Paese”, che valore ha, se si omette di dire che il dittatore è corresponsabile di questi eventi? La repressione violenta del 2011 non era indirizzata contro la Nusra o lo Stato islamico (che non esistevano ancora), ma contro manifestanti pacifici, contro oppositori e giornalisti, mentre le amnistie liberavano i comandanti di Ahrar ash Sham, del Fronte Islamico e della Nusra.
Che valore ha questa domanda retorica quando si omette di dire che giornalmente muoiono civili sotto le bombe del regime di Asad?
Possiamo anche parlare solo dello Stato islamico che ci fa paura (come “Occidente”), ma fino a un anno e mezzo fa questo non esisteva, c’era Asad che massacrava e arrestava (oltre a combattere contro la galassia dei ribelli), e quattro anni fa non c’erano nemmeno i ribelli, ma c’era sempre Asad che sparava sulla folla, arrestava e torturava.
La lotta allo Stato islamico non può che passare per una parola: giustizia. Le persone che non hanno desiderio di rivalsa non andranno con l’Is. Che ci piaccia o meno, per sconfiggere lo Stato islamico è necessario sostenere quella popolazione sunnita, la maggioranza, che non condivide l’estremismo di questo e che è costretta a convivere – pena la morte – con le vessazioni e le imposizioni dell’Is.
Nel mese di agosto, nei pressi di Deir az Zor, sono stati uccisi dallo Stato islamico 700 membri del clan Sweitat (della tribù degli Aghedaat) in un tentativo di ribellione contro l’Is – si erano già ribellati ad Asad in passato. Sconfiggere il Califfato e la sua forza attrattiva, è possibile solo con il sostegno di quest’elemento sunnita che non accetterà mai di ritornare sotto l’ala “sciita” di Asad.
Riabilitare il rais per paura del fondamentalismo e riconsegnare l’intero Paese a chi ha creato tutto ciò, vuol dire spingere anche gli elementi moderati tra le braccia dello Stato islamico nell’immediato e posticipare la risoluzione di un problema che si ripresenterà in futuro.
Una persona intelligente, arrivata alla fine della lettura di questi tre pezzi, dopo aver visto tutti i video, penso non abbia più voglia di chiedere: “È meglio lo Stato Islamico o Asad?”. La scelta che poi faranno gli Stati con la loro realpolitik è altra cosa, ma questa spesso non contempla la giustizia e nemmeno i crimini contro l’umanità.
November 19, 2014
“È meglio lo Stato islamico o Asad?” 2/3
 (di Alberto Savioli). La domanda che spesso viene posta a chi continua a denunciare i crimini di Asad è: “È meglio lo Stato islamico o Asad?”, è una domanda retorica di facile soluzione. Questo pezzo (il secondo di tre) vuole dare risposta alle questioni poste anche da chi sostiene Asad, non presentando solo opinioni ma fatti documentati accaduti negli ultimi quattro anni. Si presenta come un ampio dizionario di testimonianze video delle atrocità siriane.
(di Alberto Savioli). La domanda che spesso viene posta a chi continua a denunciare i crimini di Asad è: “È meglio lo Stato islamico o Asad?”, è una domanda retorica di facile soluzione. Questo pezzo (il secondo di tre) vuole dare risposta alle questioni poste anche da chi sostiene Asad, non presentando solo opinioni ma fatti documentati accaduti negli ultimi quattro anni. Si presenta come un ampio dizionario di testimonianze video delle atrocità siriane.
Questo è il seguito di un pezzo precedente: prendetevi il vostro tempo, ma guardate i video, alla fine sarà impossibile riproporre la domanda: “Meglio lo Stato islamico o Asad?”.
La rivoluzione. Anime nere e anime bianche.
C’erano diverse anime allora (2012) in seno alla rivoluzione oramai militarizzata. Lo si poteva vedere anche nei cortei e nelle manifestazioni ancora pacifiche.
Un esempio lampante di ciò è stato “l’uomo magro”, Abu Maryam (questi video aiutano a capire chi fosse e qual era il suo pensiero: 1, 2).
In una manifestazione ad Aleppo, nel febbraio 2013, accanto alle bandiere della rivoluzione viene sventolata la bandiera di Jabhat al Nusra e viene srotolato un manifesto di stampo confessionale. Abu Maryam (l’uomo al centro con la tuta nera e i baffi) che si opponeva a questa deriva estremista e confessionale della rivoluzione, strappa il manifesto e lo lancia lontano (video al min. 0.30 vengono srotolati gli striscioni, al min. 0.45 lui li toglie).
Nell’aprile 2014 Abu Maryam è stato ucciso dalle bande criminali dello Stato islamico dell’Iraq e del Levante (Isis) (1,2).
L’errore dell’occidente è stato quello di non aver sostenuto o protetto in vari modi e forme quest’anima non confessionale e non jihadista. Qualche nostro alleato del Golfo invece ha finanziato l’anima nera della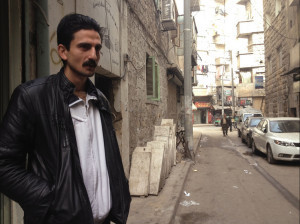 rivoluzione.
rivoluzione.
Anti-imperialismo e complotto globale, una panacea per tutti i mali.
Una volta stufatosi della Siria, il geo-politologo esperto di tutti i conflitti, cambierà il canale Tv e si occuperà di Ucraina, domani di una nuova guerra, ma sempre con la stessa sicurezza di avere ragione: “Il colpevole è l’imperialismo americano e le rivolte sono un complotto internazionale contro le dittature (che lui chiamerà governi)”, colpevoli secondo lui, non di reprimere il popolo ma di opporsi all’espansionismo americano.
Per lui è un dettaglio il fatto che queste dittature siano alleate della Madre Russia e/o dell’Iran, Paesi – al pari degli Usa – con una politica imperialista.
Il geo-politologo assieme al “comunista duro e puro”, all’antimperialista e ai pacifisti nostrani, scende in strada per manifestare a favore del popolo palestinese contro l’occupante israeliano.
Durante la recente campagna militare di Israele contro Ghaza, queste persone hanno denunciato e si sono indignate per l’uso del fosforo bianco da parte di Israele ignorando completamente l’utilizzo del fosforo bianco da parte di Asad contro la popolazione civile: ad Erbeen nel dicembre 2012, a Talbise nel marzo 2013, febbraio 2013, novembre 2012, a Deir ez Zor nel febbraio 2013.
Dall’inizio del conflitto nella Striscia di Ghaza, gli uccisi nella vicina Siria sono stati più del doppio di quelli caduti in territorio palestinese.
 La carta dei curdi giocata a piacere.
La carta dei curdi giocata a piacere.
Con la stessa incoerenza il geo-politologo sostiene i miliziani curdi dell’Ypg assediati a Kobane dallo Stato islamico, sostenuti dalla coalizione internazionale e sostenuti da combattenti dell’Esercito siriano libero che tanto deplorano (gli anti-imperialisti hanno manifestato domenica 2 novembre a favore dell’enclave curda).
Ma quando i curdi manifestavano contro Asad nella stessa Kobane nel 2011, a Qamishli nel gennaio 2012, e i ragazzi curdi delle scuole di Kobane davano il loro sostegno ai combattenti arabi di Baba Amr (Homs), queste persone voltavano la testa dall’altra parte.
Vittime collaterali o volute?
Il regime ha considerato i territori liberati come territori terroristi tout court, la popolazione di queste zone è colpevole di aver sostenuto la rivolta e di appoggiare i ribelli, per questo motivo va colpita e punita al pari di chi combatte. Per il regime non ci sono civili e belligeranti ma una popolazione pro-regime e una contro.
Non si spiega altrimenti l’uso indiscriminato di bombe al fosforo, bombe a grappolo e barili bomba sui certi abitati e missili scud, non certo armi raffinate che distinguono chi colpire, come quelle lanciate su Daraya (video 1, 2, 3), su Aleppo a una manifestazione in cui il canto di una bambina viene interrotto dallo scoppio dell’ordigno (video, min. 1.21), o su Jobar (Damasco).
Gli esiti sono evidenti a tutti quelli che non vogliono chiudere gli occhi e ignorare i fatti: ad Aleppo sono morte donne e bambini (video), a Duma (Damasco) dei bambini sono stati straziati dai bombardamenti (video), a Binnish (Idlib) dei bambini sono stati feriti dalle bombe a frammentazione (video), nella Ghuta (Damasco) dopo l’attacco con il gas i bambini boccheggiano come pesci fuor d’acqua (video 1, 2, 3).
Civili e bambini sono le vittime maggiormente colpite a Talbise (Homs), a Qabun (Damasco), a Daraa; anche il recente bombardamento con barili bomba di un campo di sfollati ad Abdin (Idlib) che ha ucciso 70 civili è un atto volontario non un effetto collaterale (video 1, 2).
Quotidianamente vengono estratti dalle macerie delle case dei bambini (video 1, 2) come ad Aleppo, oppure vengono colpite aree dove i bambini giocavano come a Deir Assafer, o a Hassake.
 Nessun altro conflitto ha visto un così alto numero di bambini (video 1, 2, 3) e civili (video 1, 2) presi di mira, feriti o uccisi dai colpi dei cecchini dell’esercito siriano: la loro colpa è quella di trovarsi dalla parte sbagliata del conflitto non avendo sostenuto il regime.
Nessun altro conflitto ha visto un così alto numero di bambini (video 1, 2, 3) e civili (video 1, 2) presi di mira, feriti o uccisi dai colpi dei cecchini dell’esercito siriano: la loro colpa è quella di trovarsi dalla parte sbagliata del conflitto non avendo sostenuto il regime.
Questo video che mostra dei bambini di 4-5 anni che scappano mentre un cecchino del regime tenta di colpirli è emblematico: non si tratta di vittime collaterali del conflitto, ma di omicidi mirati.
Possiamo parlare di vittime collaterali o di atto voluto?
Qualcuno pensa che questi siano terroristi o esista una logica di guerra per cui due bambini debbano venire uccisi volontariamente da un cecchino di un esercito nazionale? Quale altra logica esiste se non quella di considerare terrorista tutta la popolazione non più residente nei territori controllati dal regime?
Secondo il geo-politologo l’esercito siriano è impegnato in una lotta contro i ribelli e i fondamentalisti, in un conflitto sono inevitabili quindi le vittime civili e i danni collaterali. In fondo sono i ribelli a nascondersi tra le case, come fare per ucciderli se non colpendo anche la casa e i suoi occupanti? Seguendo questa logica tutta la popolazione che si trova in zone non controllate da Asad merita di morire, o perlomeno la loro morte è un atto secondario di un tentativo di riconquista.
Un concetto questo molto pericoloso, che lascerei alla logica dei regimi. Se il nostro pensiero “occidentale” sdogana questo crimine “in funzione di”, possiamo stracciare la carta dei diritti dell’uomo.
Però vorrei che il geo-politologo facesse queste considerazioni dopo aver visto tutti questi video, dal primo all’ultimo minuto, dopo aver sentito le grida di dolore delle madri e aver visto le teste squarciate dei bambini o le loro convulsioni. È troppo facile giocare a fare geopolitica giocando a Risiko sulle vite degli altri.
Con la repressione del 2011 Asad ha rotto il patto con il suo popolo. Una famiglia che si è ritrovata un figlio ucciso, un marito che ha avuto la moglie violentata dai servizi segreti, o i bambini uccisi, ha smesso di riconoscere come tale il presidente siriano. Da quel momento per loro è diventato un criminale.
Asad potrà anche riconquistare i territori persi, ma non potrà mai riconquistare quelle persone. Legittimare nuovamente il presidente siriano per paura dell’Is, vuol dire rimandare il problema. La domanda retorica “è meglio lo Stato islamico o Asad” è mal posta. Si tratta di due facce della stessa medaglia, che si sono alimentate e legittimate vicendevolmente.
(continua…)
November 14, 2014
“È meglio lo Stato islamico o Asad?” 1/3
 (di Alberto Savioli). La domanda che spesso viene posta a chi continua a denunciare i crimini di Asad è: “È meglio lo Stato islamico o Asad?”. È una domanda retorica di facile soluzione. Questo pezzo (il primo di tre) vuole dare risposta alle questioni poste anche da chi sostiene Asad. Non sono presentate solo opinioni, ma fatti documentati accaduti negli ultimi quattro anni. Vuole essere un ampio dizionario di testimonianze video delle atrocità siriane.
(di Alberto Savioli). La domanda che spesso viene posta a chi continua a denunciare i crimini di Asad è: “È meglio lo Stato islamico o Asad?”. È una domanda retorica di facile soluzione. Questo pezzo (il primo di tre) vuole dare risposta alle questioni poste anche da chi sostiene Asad. Non sono presentate solo opinioni, ma fatti documentati accaduti negli ultimi quattro anni. Vuole essere un ampio dizionario di testimonianze video delle atrocità siriane.
Leggete pure a puntate questo lungo pezzo: prendetevi il vostro tempo. Ma guardate i video. Alla fine vi sarà impossibile riproporre la domanda: “Meglio lo Stato islamico o Asad?”.
Dallo scoppio della primavera araba in Siria e dalle prime manifestazioni di protesta ne è passata di acqua sotto i ponti. Ora l’attualità parla solo di Stato islamico e su tutto il resto è stato steso un velo di silenzio.
Il geo-politologo esperto di tutti i conflitti che è possibile incontrare alle conferenze o sui blog in Internet, quando non è travestito da giornalista fazioso, è infastidito e considera inutile parlare adesso delle proteste di piazza del 2011, degli attivisti arrestati e delle torture. Ripete una sola domanda retorica: “Ma è meglio lo Stato islamico (Is) o Asad?”.
Solo un folle potrebbe rispondere: “È meglio lo Stato islamico”.
Ma la visione manichea buono-cattivo, brutto-bello, noi-loro, la lascio a chi della cattiva conoscenza fa la sua arma, a chi attraverso la semplificazione o il qualunquismo e con la teoria sempre pronta del complotto globale, risolve problemi e situazioni difficili da capire, che necessitano di approfondimento e comprensione, tutte cose faticose.
 Le proteste pacifiche del 2011: verità o menzogna?
Le proteste pacifiche del 2011: verità o menzogna?
Torniamo per un attimo a quelle proteste di piazza del 2011 e 2012.
Quelle proteste per qualcuno non ci sono mai state, “un complotto esterno”, “esagerate dalle tv pan-arabe come Al Jazeera”, “tra loro vi erano infiltrati armati”, oppure secondo altri “nessuno avrebbe sparato sulla folla, ma anzi qualche facinoroso ha cominciato a colpire l’Esercito siriano”.
Ho affermato di non essere manicheo, quindi è possibile dire che degli infiltrati possano esserci stati. Che anche l’Esercito possa essere stato colpito, che le tv pan-arabe abbiano esagerato a volte i numeri dei manifestanti, senza nulla togliere al gran movimento di protesta pacifico che forse nessuna rivoluzione ha mai visto. Un movimento della società civile talmente grande da rendere incredibile il silenzio di chi non l’ha sostenuto e la malafede o l’ignoranza di chi lo nega.
Di quelle proteste non metterò video: il geo-politologo da salotto è prontoa dirmi “li hai scelti ad hoc”. Voglio inondare voi e quel geo-politologo di ciò che secondo qualcuno, non è mai stato. Alcuni video sono molto forti, capisco se qualcuno non se la sentirà di guardarli, ma il geo-politologo da salotto o il supporter di Asad li devono guardare tutti dal primo all’ultimo minuto, altrimenti non accetterò di rispondere alla loro domanda retorica: “Meglio lo Stato islamico o Asad?”.
Tra il marzo 2011 e il corso del 2012, quando non esisteva ancora il Califfato, l’Isis, i salafiti o il grande numero di jihadisti stranieri che stanno convincendo il mondo a riabilitare il presidente siriano Bashar al Asad, la gente manifestava chiedendo riforme, maggiore libertà, e poi, dopo la reazione violenta del regime, la caduta di Asad (video 1, 2, 3).
Si riversarono nelle strade fiumi di persone a Hama. In questa città nel luglio 2011 la gente manifestava con la bandiera nazionale siriana prima dell’adozione della bandiera della rivoluzione dal colore verde-bianco-nero (video 1, 2). A Homs nell’aprile 2011 nel quartiere di Khaldiya (agosto 2011) dicevano: “Chiediamo l’intervento della comunità internazionale per proteggere il popolo siriano dal genocidio”.
Quasi tutte le città siriane ebbero le loro manifestazioni di piazza, a Daraya (Damasco) nel dicembre 2012, un corteo di studentesse gridava in coro: “Hafez al Asad è il cane delle nazioni arabe”, a Homs un’altra manifestazione femminile protestava pacificamente.
Anche i curdi di Kobane, divenuti ora il baluardo contro lo Stato islamico e gli eroi di anti-imperialisti e sostenitori del regime, nel febbraio 2012 manifestavano contro Asad e nessuno li ascoltava (video 1, 2). In queste manifestazioni sventolava anche anche la bandiera dei cristiani assiri (video al min. 0.18), per cui molti ora si preoccupano chiedendo: “Se cadesse Asad cosa sarebbe delle minoranze?”. A Qamishli, nel febbraio 2012, sventolavano assieme la bandiera della rivoluzione, quella dei curdi siriani e la bandiera dei cristiani assiri.
Per i curdi allora, uniti agli arabi nella protesta contro Asad, nessuno manifestava e nessun geo-politologo da salotto chiedeva interventi della coalizione. Lo Stato islamico non esisteva ancora!
Le prime manifestazioni : complotto globale o dura repressione?
: complotto globale o dura repressione?
In quella fase storica della rivoluzione il geo-politologo era silente, anche di fronte alle uccisioni quotidiane e agli spari sulla folla disarmata da parte delle milizie e degli shabbiha del presidente. A Homs (video al min. 4.30, aprile 2012), una folla seduta a terra fu oggetto di colpi da arma da fuoco da parte delle milizie governative.
Questi fatti erano la prassi in molte città (1, 2, 3, 4): ad al Sanamin nel marzo 2011, a Daraa nell’aprile 2011 – un uomo a terra ferito si chiede “Perché?… era pacifica (la manifestazione), pacifica”, ad Abu Kamal nel maggio 2011, a Hama nel giugno 2011 (video 1, 2), come a Idlib nell’agosto 2011, o a Daraya nel febbraio 2012.
Al cantore di quelle proteste di piazza nella città di Hama, Ibrahim Qashush, che coniò lo slogan “Bashar vattene, hai perso la tua legittimità”, le forze di sicurezza tagliarono la gola e strapparono le corde vocali. Al disegnatore satirico Ali Ferzat spezzarono le mani (1, 2, 3). Al pianista dissidente Malik Jandali picchiarono brutalmente gli anziani genitori (1, 2, 3).
Al pari di questi noti “personaggi”, il regime trattò anche comuni cittadini disarmati e manifestanti che vennero arrestati, picchiati (video 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), torturati (video 1, 2, 3, 4) o uccisi dai soldati del regime (uso il termine “soldati del regime” perché queste operazioni non venivano affidate ai soldati siriani di leva, spesso confinati nelle caserme per paura che disertassero).
Nemmeno alle donne venne risparmiato questo trattamento: furono arrestate (video 1, 2), torturate e violentate in carcere o nelle loro case da miliziani del regime (video 1, 2), come denunciava anche l’organizzazione internazionale per i diritti umani, Human Rights Watch (1, 2).
Qualche rappresentante della comunità siriana in Italia, sostenitore di Asad, arrivò allora a dire che la parola shabbiha (1, 2), usata per definire dei gruppi paramilitari fedeli ad Asad (quasi tutti i suoi membri hanno l’immagine del presidente siriano tatuata sul bicipite: 1, 2, 3, 4, 5), era un neologismo coniato dall’occidente: loro gli shabbiha non li avevano mai sentiti nominare. Nello stesso momento in Siria i soldati governativi cantavano un inno al presidente, definendosi shabbiha, di fronte a un uomo “crocifisso” su un carro armato.
Tutti questi video non sono uno stucchevole amarcord, ma servono a mettere i puntini sulle “I”, se si omette un particolare fondamentale non solo non si è obiettivi nella ricostruzione dei fatti, ma questi non sono comprensibili nella loro complessità.
 Il fondamentalismo. Di chi è la responsabilità?
Il fondamentalismo. Di chi è la responsabilità?
Qualcuno dice: “Noi lo sapevamo, senza il dittatore laico il Paese sarebbe sprofondato nel caos”.
È aver lasciato un popolo disarmato al giornaliero massacro del regime ad aver causato tutto questo.
Fin dal maggio 2011 il regime parlava di terroristi: i manifestanti disarmati erano terroristi, gli attivisti erano terroristi, così come i giornalisti che denunciavano quanto avveniva. Il 16 febbraio 2012 veniva arrestato a Damasco assieme al suo staff Mazen Darwish, direttore del Centro siriano per i media e la libertà di espressione. L’accusa era di “aver pubblicizzato atti terroristici”. Chi si è opposto anche pacificamente al regime siriano è stato accusato di terrorismo, opporsi a un regime in una dittatura è atto di terrorismo.
Secondo Human Rights Watch (Hrw), l’organizzazione internazionale basata a New York e la cui legittimità è riconosciuta dallo stesso presidente siriano Bashar al Asad (in un’intervista alla tv russa nel 2012 ha citato come autorevoli dei reports di Hrw), il tribunale speciale utilizza le disposizioni della legge antiterrorismo per condannare gli attivisti pacifici con l’accusa di favoreggiamento al terrorismo. Le accuse contro gli attivisti fanno riferimento formalmente ad “atti di terrorismo”, ma di fatto vengono applicate a una sorta di “reati” che nulla hanno di terroristico, come distribuzione di aiuti nelle zone liberate, partecipazione alle proteste e documentazione delle violazioni dei diritti umani.
L’immobilismo americano e occidentale non ha riempito il vuoto creatosi in alcuni territori persi dal regime, in quelle aree conquistate inizialmente dall’Esercito libero siriano (Esl). Il sostegno a quello che era principalmente un esercito a-confessionale è stato blando, il sostegno anche morale alla società civile che resisteva, agli attivisti e agli organismi di denuncia delle violazioni è stato nullo.
Allora, il geo-politologo nostrano dormiva, quando non sosteneva esplicitamente Asad.
Quel vuoto tuttavia è stato riempito velocemente grazie agli ingenti finanziamenti dei sostenitori privati dei Paesi del Golfo, che hanno fatto la loro scelta, i loro cavalli vincenti non erano i pacifisti e gli attivisti, nemmeno alcune brigate laiche dell’Esl, ma salafiti e jihadisti pronti a imporre in Siria un Islam di stampo wahhabita o estremista.
Alcune premesse si erano già avute durante l’assedio di Baba Amr, a Homs (gennaio-febbraio 2012). Nel suo “Taccuino siriano” Jonathan Littell riporta un discorso con un combattente, racconta Muhannad: “Ci sono dei morti tutti i giorni. La posizione della Lega araba è debole, la posizione internazionale è debole, quindi tra noi prende piede l’idea del jihad… Vogliamo che tutti i combattenti del mondo arabo vengano a combattere con noi… Se si passa al jihad, si passa alla fase della rivoluzione militarizzata”.
Ma un altro combattente replicava: “No, se lo si fa, si passa a una guerra generalizzata”.
Scrivevo allora che il massacro continuo dei siriani e il mancato appoggio alla società civile non violenta, avrebbe causato una confessionalizzazione del conflitto e un maggiore rischio in futuro per le minoranze.
(continua…)
November 7, 2014
“Medio Oriente senza cristiani”?
 (di Riccardo Cristiano, per SiriaLibano). Presentare a un sito di studiosi e specialisti delle questioni mediorientali un libro sul Medio Oriente scritto da un non specialista è materia delicata. Un’intrusione? Non penso, dal momento che “Medio Oriente senza cristiani?” è in realtà un libro che cerca una risposta a una domanda per me abusata ma importante:”i cristiani hanno un ruolo da svolgere nel Medio Oriente d’oggi?”. Dunque il libro non è sul Medio Oriente, ma sui cristiani.
(di Riccardo Cristiano, per SiriaLibano). Presentare a un sito di studiosi e specialisti delle questioni mediorientali un libro sul Medio Oriente scritto da un non specialista è materia delicata. Un’intrusione? Non penso, dal momento che “Medio Oriente senza cristiani?” è in realtà un libro che cerca una risposta a una domanda per me abusata ma importante:”i cristiani hanno un ruolo da svolgere nel Medio Oriente d’oggi?”. Dunque il libro non è sul Medio Oriente, ma sui cristiani.
Da vaticanista ha seguito le elaborazioni, sovente davvero illuminanti, che il mondo cristiano ha prodotto sull’arabismo. Il rifiuto, ad esempio, di considerarsi una minoranza, è stato l’architrave di questo pensiero, visto che da anni per le chiese orientali nella cultura e società arabe “l’islam appartiene ai cristiani quanto il cristianesimo appartiene ai musulmani.” E’ partendo di qui che ho voluto spiegare il mio convincimento: i cristiani hanno un ruolo, in quanto cristiani, e cioè quello di fare di tutto per evitare una guerra civile tra sunniti e sciiti.
Che ad iniettare la violenza produttrice di questa guerra civile non siano sunnismo e sciismo, ma gli artefici di piani politici egemonici o imperiali, è una costante storica. Ma la necessità resta e forse è anche un’urgenza perché nella devastazione sociale prodotta dai regimi totalitari, panarabisti e panislamisti, e aggravata dalla guerra del 2003, in campo è rimasto solo il settarismo. Si può uscire da questo vicolo cieco senza coinvolgere o ricorrere alle comunità?
Ecco, i cristiani come comunità a mio avviso hanno il vantaggio di essere comunità arabe senza eserciti, potenze, milizie di riferimento. Questa apparente debolezza può essere la forza per dire agli altri arabi e alla comunità internazionale: “vogliamo fare qualcosa?” L’idea-base per un negoziato di pace regionale, capace di mettere in crisi tutti gli egemonismi e tutti i terrorismi, di Stato e di stati, esiste, è l’idea che ha salvato il Libano, l’idea elaborata a Taif.
Molti, lo so, storcono il naso, dicendo che Taif è il comunitarismo; io non la vedo così. Taif è innanzitutto un progetto, basato in realtà su tre gambe: una formula per i vertici delle istituzioni che ponga fine all’egemonia di una sola comunità, qualunque essa sia, una camera eletta con sistema di rappresentanza diretta “one man one vote” che apra finalmente il confronto politico tra partiti politici e offra quindi i diritti agli individui, liberandoli dalla caserma delle appartenenze settarie, e un Senato eletto su base paritaria tra le confessioni in modo da rasserenarle tutte, garantire alle Comunità, tutte, che nessuno potrà più progettare di annientarle.
Questi ragionamenti sono il frutto di colloqui con arabi cristiani, che rifiutano di definirsi o farsi definire specie in via di estinzione e quindi da “proteggere”. Spero possa interessarvi leggerle. Per queste riproduco qui un breve capitolo del libro, quello sulle tribù di Karak; perché è troppo comodo pensare che con i musulmani esista solo il sistema delle minoranze protette. E’ una scorciatoia e una bugia. E la storia delle tribù di Karak lo dimostra.
«Nelle steppe isolate di Karak, in Transgiordania, un sistema sociale originale è perdurato dai tempi antichi fino al XX secolo», ha scritto su «L’Orient-Le Jour» Antoine Courban. «Lì l’ordine ottomano non aveva nulla di ottomano e ignorava la norma che stabilisce una stretta gerarchia tra “credenti” e genti del libro (ebrei e cristiani) ridotti a dhimmis, cioè minoranze protette. Le tribù di Karak erano organizzate in una federazione governata da un’assemblea formata da rappresentanti delle tribù federate. I rappresentanti potevano indifferentemente essere cristiani o musulmani.
Il parametro era il lignaggio e non l’appartenenza confessionale. La preminenza sociale era retta da un sistema fondato su origine e onore, senza alcun legame all’appartenenza confessionale. Alla base sociale del sistema c’erano gli esclusi, i nomadi e i neri. Costoro non potevano entrare nel gioco politico delle alleanze, né condividere il potere. Gli era proibito portare armi e possedere terre [...]. L’ordine politico e quello tribale coincidevano in questa strana società. La convivenza, o il vivere insieme di Karak, andava ancor più lontano di quel che è andato dall’Andalusia al cuore della terra dell’islam. [...] Non esiste alcuna coesione propriamente cristiana, generata dall’identità collettiva in quanto comunità religiosa, ma piuttosto una competizione permanente dove cristiani e musulmani giocano secondo le stesse regole di un gioco sociale nel quale le tribù, e non i gruppi confessionali, sono considerate come i soggetti concorrenti».
Molto spesso in questo sistema tribale erano i preti a svolgere le funzioni di qadi, giudici islamici, essendo tra i pochi alfabetizzati. Non c’è forse in questo strano sistema tribale una traccia del «vivere insieme» mediterraneo?
Le tribù e il tribalismo sono una realtà sociale di cui bisognerebbe tenere maggiormente conto quando si parla di Oriente. Anche per questo il passaggio dall’urlo «Dio è più grande» a quello «il popolo vuole» appare davvero epocale. Più che la supposta immodificabilità dell’islam sono state le atrocità della storia e la forza delle mitologie a rinviare questo appuntamento fino ai giorni nostri, tarpando le ali del riformismo sociale mediorientale. Cancellando dalla realtà storica dell’Oriente il costituzionalismo ottomano, una visione tanto ideologica quanto metastorica dell’islam ci ha convinto che con i musulmani sia possibile solo la formula delle minoranze protette.
Protette dal «Sultano», ma inferiori alla comunità musulmana, la cui legge ovviamente prevale quando un membro delle minoranze protette viene a contatto con un musulmano. Questo sistema ovviamente pone anche dei limiti ai cittadini di «serie b», impedendo loro di assumere alti incarichi o di svolgere determinate funzioni. Ma li fa «sopravvivere».
È davvero una dimensione «eterna e consustanziale» non all’«islam reale», quello di ieri o di oggi, ma anche a qualsiasi ipotetico islam di domani? Lo slogan «il popolo vuole» è il no più chiaro, e più forte, che sia stato detto, la risposta naturale e sincera a questa domanda.
Sebbene nessuno potesse sognarsi una rivoluzione che capovolgesse il mondo arabo in poche settimane, quel grido ha detto che un meccanismo si è rotto. Il fanatismo salafita da una parte, il nazional-socialismo dei regimi militari dall’altra (e il khomeinismo nel campo sciita) non riuscivano più a interpretare i poli della politica araba.
November 5, 2014
Nihad Sirees al Pisa Book Festival
 Nihad Sirees, scrittore, drammaturgo e sceneggiatore originario di Aleppo, sarà tra gli ospiti del Pisa Book Festival di quest’anno e presenterà in anteprima nazionale la traduzione italiana del suo famosisssimo romanzo al Samt wa’l sakhab (Il silenzio e il tumulto), edito da il Sirente.
Nihad Sirees, scrittore, drammaturgo e sceneggiatore originario di Aleppo, sarà tra gli ospiti del Pisa Book Festival di quest’anno e presenterà in anteprima nazionale la traduzione italiana del suo famosisssimo romanzo al Samt wa’l sakhab (Il silenzio e il tumulto), edito da il Sirente.
Pubblicato nel 2004 a Beirut e circolato per anni in Siria solo in modo clandestino, “Il silenzio e il tumulto” è stato per la prima volta tradotto in tedesco e lanciato alla Fiera del libro di Francoforte nel 2008 e poi è arrivato anche in francese e in inglese.
Sirees è diventato celebre in tutto il Medio Oriente quando ha sceneggiato la popolarissima serie tv Khan al harir (Il mercato della seta), trasmessa per la prima volta nel 1996. Poi due anni fa ha deciso di lasciare la Siria per sfuggire alla pressione e alla sorveglianza del regime siriano. 
“Il silenzio e il tumulto” è una allegoria politica ambientato in una dittatura senza nome. Racconta una giornata della vita di Fathi Shin, uno scrittore di 31 anni, ben noto personaggio pubblico, cui le autorità hanno proibito di scrivere e pubblicare perché ha osato sfidare l’autorità.
In questa giornata - che sarà un importante punto di svolta nella vita di Fathi - tutto il Paese è in festa per il ventesimo anniversario dalla presa del potere del dittatore. Raduni, parate, marce militari e discorsi si svolgono dovunque. Ma Fathi non festeggia. Esce di casa per far visita alla madre Ratiba e alla sensualissima fidanzata Lama e cammina coraggioso contro il flusso della folla. Questa giornata deciderà il futuro di Fathi: passerà la sua vita ad ascoltare “il silenzio” del carcere o “il tumulto” del potere? Oppure lui e Lama sceglieranno ancora un’altra strada, quella dell’amore e delle risate?
Nihad Sirees incontrerà il pubblico del festival sabato 8 novembre alle ore 17.00 in Sala Pacinotti.
October 31, 2014
Bombe di Asad su siriani sfollati
 Il massacro documentato di decine di circa 70 civili siriani, sfollati nel nord-est del Paese e nelle ultime ore uccisi da barili-bomba dell’aviazione del regime di Damasco, è rimasto sullo sfondo delle notizie sull’ingresso di una primo gruppo di miliziani curdo-iracheni a Kobane/Ayn Arab, la cittadina siriana alla frontiera con la Turchia e assediata dai jihadisti dello Stato islamico (Isis).
Il massacro documentato di decine di circa 70 civili siriani, sfollati nel nord-est del Paese e nelle ultime ore uccisi da barili-bomba dell’aviazione del regime di Damasco, è rimasto sullo sfondo delle notizie sull’ingresso di una primo gruppo di miliziani curdo-iracheni a Kobane/Ayn Arab, la cittadina siriana alla frontiera con la Turchia e assediata dai jihadisti dello Stato islamico (Isis).
Gli Stati Uniti si sono detti “inorriditi” dall’uccisione ieri di circa 70 civili siriani, tra cui minori e donne, originari della Siria centrale ma sfollati al confine turco nella regione nord-occidentale di Idlib. Il massacro è stato documentato dall’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus) e da numerose fonti locali che hanno pubblicato in rete riprese video girate poco dopo il bombardamento.
L’aviazione di Damasco, che a bassa quota continua a operare indisturbata nella stessa area di operazioni della Coalizione anti-Isis guidata dagli Usa, ha sganciato il suo carico di morte contro civili del campo profughi improvvisato di Abdin, a sud di Idlib.
Per la comunità internazionale il pericolo numero uno in Siria rimane l’Isis. Da New York, l’inviato speciale Onu sulla Siria, Staffan De Mistura, ha affermato al Palazzo di Vetro che “per fermare l’Isis è necessario creare alcune zone franche in Siria, e uno di questi luoghi è Aleppo”. Per il diplomatico italo-svedese, queste in queste zone franche deve essere “imposto un cessate il fuoco da attuare progressivamente”. La soluzione politica, ha affermato, è il passo successivo.
Proprio in queste settimane Aleppo, un tempo prima metropoli siriana, sta venendo accerchiata dalle truppe lealiste che stringono la morsa attorno ai quartieri orientali sotto il controllo del variegato fronte di insorti. Sul lato orientale, l’Isis è minaccioso, ma non attacca le forze del regime che proseguono la loro avanzata anche nella Siria centrale, nel nord-ovest, nel sud e attorno a Damasco.
Dalla capitale, le autorità siriane hanno oggi accusato la Turchia di “complottare” contro la Siria e di aver “violato la sovranità territoriale” del Paese consentendo “a forze straniere e a elementi terroristi” di entrare a Kobane. Il riferimento può sembrare diretto ai peshmerga curdo-iracheni, ma per decenni il regime di Damasco ha sostenuto e protetto le milizie curde in funzione anti-Ankara.
Più probabile che l’accusa del regime siriano sia stato all’ingresso, ieri, sempre tramite la Turchia, di un centinaio di miliziani di quel che rimane dell’Esercito libero, la piattaforma di disertori e civili siriani che dalla fine del 2011 hanno preso le armi contro le forze del presidente Bashar al Assad.
Questo manipolo di insorti hanno preceduto l’ingresso oggi di una “delegazione” di una decina peshmerga a Kobane. Il grosso del mini-contingente curdo-iracheno (150 unità) da stamani è in attesa di varcare il confine. Il lato nord di Kobane è stato però bombardato a più riprese dall’Isis che assedia la cittadina sugli altri. Per tentare di facilitare l’ingresso dei rinforzi curdi, il comando militare Usa ha riferito che la Coalizione ha oggi compiuto tre raid contro postazioni dello Stato islamico (30 ottobre 2014).
October 30, 2014
Anche gli americani colpiscono un sito archeologico
 (di Alberto Savioli). Anche la Coalizione guidata dagli Stati Uniti partecipa alla distruzione del patrimonio archeologico siriano. E’ quanto emerso dalle immagini dei bombardamenti su Tell Sheir, vicino Kobane.
(di Alberto Savioli). Anche la Coalizione guidata dagli Stati Uniti partecipa alla distruzione del patrimonio archeologico siriano. E’ quanto emerso dalle immagini dei bombardamenti su Tell Sheir, vicino Kobane.
Il patrimonio storico artistico e archeologico siriano sta subendo ingenti danni da quattro anni. I recenti bombardamenti americani a Kobane contro i miliziani dello Stato Islamico hanno colpito il sito archeologico di Tell Sheir. Alle distruzioni compiute dall’aviazione siriana e dalle postazioni militari governative sui siti archeologici, si sono aggiunti trafugamenti di opere d’arte vendute all’estero per conto di privati cittadini e di miliziani anti-regime che in questo modo hanno trovato una fonte di auto-finanziamento. Con la formazione dello Stato islamico anche i jihadisti hanno partecipato a questo saccheggio, distruggendo luoghi di culto e di venerazione di particolari personalità dell’Islam, ora sono arrivati anche i danni arrecati dalla coalizione.
Nel dramma che vivono i milioni di siriani sfollati, espatriati, sotto assedio (per tacere dei morti), il patrimonio artistico del Paese finisce inevitabilmente in secondo piano, ma i beni culturali di una nazione sono patrimonio dell’umanità, quindi di tutti, e secondo le direttive impartite dall’Unesco, l’agenzia Onu per la salvaguardia del patrimonio, questi vanno tutelati, salvaguardati e protetti.

Il 23 ottobre, i media di tutto il mondo hanno riprodotto un video (della AFP, Agence France Press) realizzato dal villaggio turco di Yumurtalik, mostra una collina dall’altra parte del confine dove si vedono due combattenti dello Stato Islamico (Is) uccisi da un fitto bombardamento americano, subito dopo aver issato su una collina la bandiera nera dell’Is. Così ha scritto il Corriere della Sera: “Un manipolo di jihadisti issa il vessillo: sventola per qualche istante, viene subito cancellato dal raid della coalizione”.
Quella che genericamente i media hanno definito “una collinetta” o la “collina di Tilsheir”, è il sito archeologico di Tell Sheir/Tell Shair che si trova 4 km a ovest dell’enclave curda di Kobane (Ayn al-’Arab). La parola araba tell, significa collina, ma è utilizzata per tutti i monticoli di natura antropica che costituiscono il paesaggio archeologico del Vicino Oriente. Gli archeologi hanno adottato questo termine; sotto ad ogni tell frutto dell’accumulo stratificato di centinaia di anni, si nascondono antiche città.
Dal video si contano cinque esplosioni (ma sono stati lanciati 10 ordigni) che colpiscono il sito archeologico. Va premesso che in una situazione di guerra, la strategia militare spesso non tiene conto dei siti archeologici e che i bombardamenti della coalizione a Kobane servono per indebolire i combattenti dell’Is. Tuttavia sulla collina di Tell Sheir non si vedono postazioni militari e da lì non veniva bombardata Kobane, anche se un video successivo mostra segni di trincee sulla sommità, non è chiaro se realizzate dall’Is o presenti da prima.
In un arco di 10 km attorno a Kobane ci so no i siti archeologici di Tell Korkah, Tell Arab Pinar, Tell Hajib e il sito di Arslantaş (l’antica Hadattu).
no i siti archeologici di Tell Korkah, Tell Arab Pinar, Tell Hajib e il sito di Arslantaş (l’antica Hadattu).
Sono inutili i richiami dell’Unesco al regime siriano per la salvaguardia del patrimonio culturale del Paese, così come le denunce verso le distruzioni dei monumenti storici operate dallo Stato islamico, se gli attacchi della coalizione non tengono conto del patrimonio archeologico della Siria mettendo questo in secondo piano rispetto alla strategia di guerra.
La responsabilità della distruzione del patrimonio storico artistico e archeologico siriano ha diversi attori con differenti colpe (1, 2). Da una parte vi è il regime, che sin dal 2011 ha danneggiato diversi siti archeologici nello scontro con i ribelli con colpi di mortaio e con l’aviazione, e ha utilizzato fortezze e siti archeologici come avamposti militari. L’Unesco, il 30 marzo 2012, aveva pubblicamente chiesto alle autorità di Damasco di vigilare sui siti presenti sul territorio.
I danneggiamenti ai siti più significativi compiuti dall’esercito governativo siriano riguardano il bombardamento aereo della fortezza crociata dell’ordine degli Ospitalieri, il Krak de Chevalier (1, 2, 3), e i danneggiamenti al sito archeologico di Palmira usato come avamposto militare (1, 2, 3), assieme alla vicina fortezza islamica di Qalaat ibn Maan (XVI-XVII sec.).
Se da una parte il regime ha danneggiato parte del patrimonio storico del paese, dall’altra parte i funzionari della Direzione generale delle antichità e dei musei di Siria (DGAM), diretta da Maamun Abdel Karim, hanno ben operato mettendo in salvo i reperti conservati al Museo nazionale di Damasco e instaurando contatti diretti con con chi di fatto controlla ora le zone non controllate dal regime siriano, è il caso del museo di Maarrat an Nouman in ottimo stato e minimamente danneggiato.
D’altra parte, del danneggiamento dei siti archeologici e della vendita illegale di opere d’arte sono responsabili anche privati cittadini: gruppi organizzati di scavatori clandestini e alcune brigate ribelli in questo modo hanno trovato una ulteriore entrata economica. Incredibili sono i danni causati dagli scavi illegali nella città di Apamea, fondata nel 300 a.C. da Seleuco I Nicatore e chiamata così in onore della moglie persiana Apame, e nel massiccio calcareo ai danni delle “città morte” bizantine (1, 2, 3), così come nel sito archeologico di Tell Hariri, l’antica città di Mari, capitale di un esteso regno amorreo tra il XIX e il XVIII sec. a.C., solo per citare alcuni casi emblematici.
Gli oggetti trafugati vengono poi portati illegalmente in Libano e Turchia (1, 2, 3) per essere rivenduti nei circuiti del mercato clandestino internazionale.
Con la comparsa dell’Isis (Stato Islamico dell’Iraq e del Levante) poi diventato Stato islamico, un nuovo attore è comparso a condividere la responsabilità della distruzione del patrimonio storico artistico siriano oltre che iracheno.
Stando ad alcune testimonianze, lo Stato islamico (1, 2) si autofinanzia anche tramite il mercato clandestino di oggetti d’arte, anche se al momento le considerazioni di questi articoli non hanno trovato riscontro. Quel che è certo è l’avvenuta distruzione di alcuni importanti monumenti, come i leoni dell’VIII sec. a.C., della porta della città neo-ittita di Hadattu (la moderna Arslantaş) che si trovavano in un parco di Raqqa e sono stati distrutti con un bulldozer.
Oppure le splendide statue provenienti da uno scavo clandestino di Tell Ajaja (l’antica Shadikanni, I millennio a.C.), intercettate dall’Isis e distrutte prima della loro vendita in Turchia.
Scavi clandestini accanto alla bandiera nera dell’Is sono stati fatti nella regione da Hassakah a Tell Hamidiya e Tell Tcholema Fowqani, ma soprattutto sono stati distrutti volontariamente luoghi di culto legati a personalità dell’Islam sunnita o sciita o della storia islamica, come il piccolo mausoleo che si trovava nella moschea di Raqqa, il mausoleo sufi di Abu Qalqal a Membij (Aleppo), il mausoleo sufi di Nebi Daud nella regione di Azaz (Aleppo), il mausoleo del califfo Omayyade Sulayman ibn Abd al-Malik a Dabiq (Aleppo), la Moschea di Giona (1,2,3), noto come Nebi Yunis, a Mossul in Iraq, al di sotto della quale si trova un palazzo assiro da cui provengono due splendidi tori alati (detti lamassu) rinvenuti nel 1990.
Molti altri monumenti sono stati distrutti dallo Stato Islamico in Iraq, e altri ancora si trovano in una situazione di pericolo.
In questo sconsolato panorama è arrivato purtroppo anche il contributo degli Stati Uniti, speriamo limitato a questo singolo episodio.
Il 25 ottobre si è tenuta a Venezia la prima edizione del Cultural Heritage Rescue Prize (Premio Internazionale per la salvezza del Patrimonio Culturale), un premio di 10.000 euro è stato assegnato a un’istituzione che si è impegnata per proteggere la cultura e l’arte nel corso del conflitto in Siria, si è discusso della “drammatica attualità della distruzione del patrimonio culturale nel conflitto in corso in Siria e Iraq”; sarebbe un paradosso parlare e assegnare premi se poi come coalizione partecipiamo in qualche modo a quella stessa distruzione.
October 23, 2014
Guardar l’Isis per non guardar la luna
 (di Salam al Kawakibi, per al Nahar. Traduzione dall’arabo di Khouzama Reda). All’ultima conferenza cui ho partecipato, tutti blateravano dello “Stato islamico” come chi, chiamando la persona amata, ripete incessantemente il suo nome, in questo caso l’acronimo “Isis”. L’Isis compare decine e decine di volte in ogni intervento che abbia come oggetto la situazione in Medioriente – qualsiasi esso sia – e sembra sia diventato opportuno aggiungere qua e là qualche riferimento a esso.
(di Salam al Kawakibi, per al Nahar. Traduzione dall’arabo di Khouzama Reda). All’ultima conferenza cui ho partecipato, tutti blateravano dello “Stato islamico” come chi, chiamando la persona amata, ripete incessantemente il suo nome, in questo caso l’acronimo “Isis”. L’Isis compare decine e decine di volte in ogni intervento che abbia come oggetto la situazione in Medioriente – qualsiasi esso sia – e sembra sia diventato opportuno aggiungere qua e là qualche riferimento a esso.
Oltre a questa ridondante prassi verbale, sembra ci sia un profondo sbigottimento cognitivo. Chiunque si avvicini all’argomento, aggiunge in maniera “scientifica” – dunque senza lasciar spazio ad alcun dubbio – che “sappiamo poco su questa nuova organizzazione sul fronte terroristico”. In questo modo, si dà l’impressione di oggettività lasciando la porta aperta a molteplici interpretazioni, per poi spostarsi – en passant – nel vivo del proprio argomento d’interesse, anche se quest’ultimo è ben lontano dal riguardare l’Isis in sé.
Dentro e fuori dalle sale ove avvengono queste discussioni pseudo-scientifiche piovono analisi su questo nuovo “extraterrestre”. Abbondano specialisti ed esperti di Islam e di cellule jihadiste di tutti i tipi. Costoro non temono di cadere in alcun errore storico, d’analisi, o persino linguistico, in quanto confidano nell’ignoranza – in questo come in altri casi – di quanti ricevono le informazioni.
E nonostante non si possa non riconoscere l’importanza di questo fenomeno e la gravità delle sue conseguenze, qualora si desiderasse uscire dal seminato, magari suggerendo un altro argomento che riguardi la Siria che umilmente si considera altrettanto importante, la propria argomentazione viene considerata debole, di scarsa eco, di poco impatto, carente di informazioni, in fuga dalla realtà, nonché preda della superficialità eccetera. Ergo, non si può parlare di comunità locali, né di organizzazioni civili, di attività umanitarie, di dialoghi politici, oppure di programmi di transizione, poiché è considerata una perdita di tempo.
E allora perché tanti traggono vantaggio dal trascinare il discorso esclusivamente sull’Isis?
Quando il movimento di protesta è cominciato in Siria nel 2011 e per un bel po’ di tempo si è sviluppato in modo pacifico, i media del regime hanno intrapreso – assieme ai loro alleati in Iran, Russia, Cina e ai media di quella che nel caso siriano viene chiamata “la sinistra Pavloviana” ma che è un fenomeno mondiale – una campagna volta a esagerare la minaccia terroristica di “jihadisiti” e “fondamentalisti islamici”. Non era accettabile per alcune autorità della carta stampata e dei media occidentali, come Robert Fisk ad esempio, parlare di proteste popolari, di rivendicazioni sociali, economiche e politiche legittime da parte di un popolo che ha vissuto per oltre quarant’anni sotto un regime dittatoriale con le sue leggi ingiuste.
Quando, a causa della sanguinosa repressione contro civili disarmati, una parte dei manifestanti ha imbracciato le armi, cosa che è avvenuta in concomitanza con numerose defezioni di soldati dell’esercito, le trombe politiche e mediatiche pro-regime se ne sono servite per rivendicare la validità della loro tesi iniziale. L’evolversi dell’azione militare e l’intervento di forze regionali, ciascuna con una propria agenda diversa e in contraddizione con l’altra, insieme con le dimissioni della cosiddetta comunità internazionale dal proprio ruolo – per lo meno umanitario – congiunti all’ipocrisia diplomatica occidentale in generale, e statunitense in particolare, hanno portato poi alla diffusione del fenomeno religioso che è sfociato nell’estremismo.
Questo fondamentalismo religioso è stato accompagnato da vari fattori interconnessi che hanno fatto pensare a un “matrimonio di convenienza” tra il regime e le forze estremiste – prima e dopo che diventassero ciò che sono diventate. Oggi è diventato “legittimo” dire che il regime sta affrontando terroristi di varie nazionalità, in seguito al silenzio generale di fronte ai soprusi di questo stesso regime nei confronti di tutto il popolo. Così l’attenzione si è completamente riversata su questa nuova “creatura” pericolosa per tutti e al contempo si è imposta la frase che esonera tutti da una doverosa empatia: “Non ve l’avevamo detto?”.
L’opposizione d’altra parte, nelle sue varie forme, componenti, differenze e appartenenze ideologiche, ha trovato nel pericolo dello “Stato islamico” il pretesto per le responsabilità mancate, per i conflitti crescenti, per la dispersione e per le contraddizioni, sia sul fronte nazionale che su quello internazionale. Essa, a torto o a ragione, pone la minaccia dello “Stato islamico” come premessa alle sue argomentazioni e alla denuncia persistente di emarginazione o di assenza di aiuti.
L’opposizione dimentica che alcuni dei suoi simboli “laici” hanno in precedenza lodato dei focolai “estremisti” che sono stati i nuclei iniziali nella formazione di questa organizzazione fascio-terrorista. Dimentica anche che alcuni dei suoi leader religiosi “moderati” hanno criticato la decisione di inserire la Jabhat al Nusra tra i movimenti terroristici, per conservare quella che hanno allora chiamato “l’unità”. In aggiunta a questo, una parte significativa dell’opposizione dovrebbe assumersi una responsabilità politica, dal momento che non è stata in grado di svolgere quel ruolo che ci si aspettava: indirizzando la mobilitazione politica e militare e offrendo un programma nazionale chiaro da seguire. Per non parlare poi delle “star” tra le file dell’opposizione, il cui ego ha ucciso qualunque possibilità di lavoro di squadra oltre alla coerenza e alla chiarezza delle loro posizioni.
L’Isis ha fatto la sua comparsa anche per salvare l’impotenza occidentale incoronata dagli Stati Uniti, che sin dall’inizio del massacro siriano non hanno saputo svolgere un ruolo politico chiaro e risoluto. E adesso tutto si limita ad affrontare un terrorismo islamico radicale.
A tutto questo, per rendere il piatto “più gustoso”, va aggiunta anche un po’ di preoccupazione per il destino delle minoranze, in un revival della teoria coloniale orientalista. Si tralascia di comprendere, così, l’evoluzione dei concetti di maggioranza e minoranza, nella loro dimensione politica, economica, culturale e religiosa sotto governi autoritari, dal momento che questi governi hanno rapito le minoranze convincendo parte di esse di esserne gli unici protettori e hanno oscurato la cultura della cittadinanza nella teoria e nella pratica e diffuso una cultura di subordinazione e obbedienza.
Tale atteggiamento è stato accompagnato dall’idea occidentale un po’ “naive” che queste dittature fossero laiche e moderne. Certo, pur con la timida ammissione di una tendenza autoritaria, tendenza tuttavia “necessaria” in una regione problematica e instabile. Tutto ciò, nonostante tanti studiosi occidentali abbiano ampiamente dimostrato come la libera vita intellettuale sia stata depauperata e siano state incoraggiate pratiche religiose oscurantiste purché restassero confinate agli atti di devozione e rimanessero ben lontane dall’attività politica. Dunque, la possibilità di allearsi con Satana per scacciare questo pericolo imminente diventa un “punto di vista” che può essere studiato e analizzato. Nella storia recente non mancano esempi numerosi di alleanze simili tra Paesi democratici del “mondo libero” e regimi tirannici che – forse vincenti nel breve periodo – hanno portato a disastrose conseguenze nel lungo termine.
I media occidentali dal canto loro hanno iniziato a cercare “jihadisti” mesi prima della loro comparsa in Siria, trovando così un argomento che “vende” e attira lettori e spettatori. E oggi sono all’apice di quest’attività. Tanti reporter di varie nazionalità, da ultimo James Foley, hanno cercato di trasmettere tutta la complessità della situazione nella sua realtà variegata, soffrendo le limitazioni e le persecuzioni del regime da un lato, e rischiando il rapimento e le azioni criminali dei terroristi dall’altro. Tuttavia, nel giro dei media vengono il più delle volte ignorati, e si preferiscono invece notizie piene di cadaveri e teste tagliate. A chi interessa la vita di milioni di rifugiati, l’attività delle centinaia di consigli locali, delle migliaia di associazioni civili e il lavoro dei media locali, nonché l’attività medica e scolastica nelle varie zone? Pochissimo di tutto questo trapela a beneficio dello spettatore occidentale.
La priorità è dunque la strana creatura chiamata Isis e le organizzazioni terroristiche hanno capito la logica dei media occidentali e hanno sviluppato delle strategie per appagarli.
Volente o nolente, lo “Stato islamico” è alla fin fine il partner di più di uno schieramento. Il maggior beneficiario della presenza di questo mostro rampante è chi è interessato al perdurare del massacro siriano. Chi crede di poter affrontare questa crisi complessa semplicemente trovando soluzioni parziali, temporanee o selettive, si sbaglia di grosso ed è responsabile delle morti passate e di quelle a venire.
Lorenzo Trombetta's Blog



