Antonio Gallo's Blog: MEDIUM, page 71
September 5, 2022
La “favola” della vita non come “stupido intento”
 Foto@angallo
Foto@angalloStamattina ho fatto la foto che vedete qui durante il mio solito footing. Ogni mattina ho l’opportunità di svelare il mistero della vita. Ognuno di noi lo fa come può: chi non sa farlo, chi non vuole farlo, chi non se ne rende conto, chi se ne frega, chi lo legge come mistero, chi come una favola. Io lo faccio da mattiniero, camminando per scoprire “il miracolo di vivere”.
Dopo aver fatto la foto, ho aperto il giornale e ho letto che un giovane di soli 27 anni ha vinto il Premio Campiello con un libro intitolato I miei stupidi intenti. Si chiama Bernardo Zannoni. Credo che leggerò il suo libro, anche se la narrativa non è il mio forte. Lo farò perchè, in una sua intervista, ha detto che il suo libro è “una favola su Dio, la scrittura e la morte”.
La parola chiave è proprio quella: “favola” che mi riporta a quella mia con la quale ho commentato la foto di cui ho parlato all’inizio del post: . “Favola” e “Miracolo” possono essere benissimo due sinonimi per i quali la vita merita di essere vissuta. Onore a questo giovane che “legge” la vita in questi termini facendola rivivire, parlandone e scrivendone, in forma di una autobiografia di un animale. La storia dei viaggi di un animale, la faina, che ha una coscienza e attraversa le tre principali illusioni: Dio, la scrittura e la morte. A mio modesto parere per niente “illusioni”. Alla domanda della giornalista perchè “illusioni”, il giovane Bernardo risponde:
“La prima cosa che arriva è la morte. Poi ci siamo inventati Dio, che non so se esista o non esista e non voglio fare quello che la sa più lunga perchè è solo fiction. Dopo arriva la scrittura, che promette non dico la salvezza dell’anima, ma di riuscire a sopravvivere oltre la nostra vita. Illusioni perchè il tempo è talmente ampio che la pietra si erode, la carta si scioglie, la memoria si perde e Dio non si sa. La morte è l’illusione che raccoglie tutti, perchè tempo è talmente infinito e vasto che le nostre vite sono un battito di cigli. Siamo già morti mentre sto parlando”.
Non c’è che dire, il giovane Bernardo sembra saperla già lunga la storia della vita e decide di intendere il tutto come “favola”. Devo dire che io, i miei 27 anni, li ricordo come una “favolosa” realtà che si è dissolta nella infinita, misteriosa illusione del tempo che non ha ancora segnato la sua fine, almeno per quanto mi riguarda. Lui ha tutto il tempo per fare in modo che la sua esistenza non continui ad essere soltanto una “favola”.
Leggerò, comunque, il suo libro e gli consiglio di coltivare, accanto a questa idea, anche quella che riguarda una possibile “divinità” dell’esistenza. Gli auguro di capire che l’esistenza è non solo il mistero dei misteri ma anche il dono dei doni, la cosa più sbalorditiva e inspiegabile che ci sia nella sua elementare semplicità.
[image error]September 4, 2022
“Il mondo è il libro dove il senno eterno
scrisse i proprii concetti …”
scrisse i proprii concetti …”

Il 5 SETTEMBRE 1568 nacque Tommaso Campanella, Domenicano, teologo, filosofo e poeta. Fu pazzo per non morire. Nel 1599 viene arrestato. Aveva ordito una strana congiura di carattere politico-religioso, mirante a liberare la Calabria dal malgoverno spagnolo per farne il centro di uno Stato teocratico universale.
Il nuovo secolo è alle porte e il frate domenicano assume toni profetici nel delineare una nuova organizzazione sociale priva di conflitti, corruzione, ingiustizie, povertà. Durante il processo adotta una ardita strategia di difesa: si finge pazzo. Resiste ad atroci torture che lo lasciano semivivo, simulando comportamenti folli mentre gli slogano a una a una le ossa. Riesce così a convincere i giudici e a evitare la pena di morte.
Tommaso Campanella era nato a Stilo, in Calabria, il 5 settembre 1568, ed era entrato giovanissimo nell’ordine domenicano, spinto, più che da sincera vocazione, dal desiderio di studiare. Spirito curioso e inquieto, va alle fonti del pensiero filosofico leggendo i testi greci e gli autori del neoplatonismo rinascimentale, si interessa alla «nuova scienza» galileiana e si entusiasma per il naturalismo di Bernardino Telesio.
Da questo mutua l’idea della natura come un tutto organico animato. Venuto in sospetto di eresia a causa dei suoi scritti, aveva già subìto, tra il 1591 e il 1597, una serie di processi, con esiti alterni. Rimane in carcere a Napoli per ventisette anni, nei quali continua a scrivere, tra l’altro una coraggiosa Apologia in difesa di Galileo e poesie di forza visionaria. Ma l’opera più famosa è La città del Sole, un dialogo che si inserisce nella corrente della letteratura utopica e che disegna uno Stato ideale teocratico e comunistico.
Dal profondo del buco nero dove è stato gettato immagina una città radiosa: una repubblica governata da saggi, in cui proprietà privata e famiglia sono abolite, con una religione naturale estranea a ogni confessione, una organizzazione politico-sociale egualitaria, felice e armoniosa. La città, di cui l’autore descrive minuziosamente il disegno urbanistico, è difesa da sette cinta di mura, tutte affrescate a comporre un’immensa enciclopedia del sapere, ed è dominata dal tempio del Sole.
Riacquistata la libertà, Campanella sarà consigliere di papa Urbano VIII per le questioni astrologiche. Minacciato di un nuovo arresto dagli spagnoli, riparerà in Francia, dove verrà accolto benevolmente da Luigi XIII e dove rimarrà fino alla morte. L’utopista merita un posto di riguardo nel gruppo dei folli che hanno «superato la realtà».
Il mondo è il libro dove il Senno Eterno
scrisse i proprii concetti, e vivo tempio
dove, pingendo i gesti e ‘l proprio esempio,
di statue vive ornò l’imo e ‘l superno;
perch’ogni spirto qui l’arte e ‘l governo
leggere e contemplar, per non farsi empio,
debba, e dir possa: — Io l’universo adempio,
Dio contemplando a tutte cose interno. –
Ma noi, strette alme a’ libri e tempii morti,
copiati dal vivo con più errori,
gli anteponghiamo a magistero tale.
O pene, del fallir fatene accorti,
liti, ignoranze, fatiche e dolori:
deh, torniamo, per Dio, all’originale!
— — — — — — — — — — — — —
The world’s the book where the eternal Sense
Wrote his own thoughts; the living temple where,
Painting his very self, with figures fair
He filled the whole immense circumference.
Here then should each man read, and gazing find
Both how to live and govern, and beware
Of godlessness; and, seeing God all-where,
Be bold to grasp the universal mind.
But we tied down to books and temples dead,
Copied with countless errors from the life, –
These nobler than that school sublime we call.
O may our senseless souls at length be led
To truth by pain, grief, anguish, trouble, strife!
Turn we to read the one original!
Tommaso Campanella, Modo di filosofare (ca. 1620)
(J.A. Symonds transl. 1899)
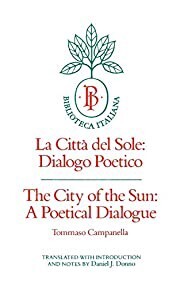 @“Almamatto. Un matto al giorno. 365 tipi strani (+1) che hanno cambiato il mondo” by Giampietro Savuto[image error]
@“Almamatto. Un matto al giorno. 365 tipi strani (+1) che hanno cambiato il mondo” by Giampietro Savuto[image error]
Shelley, il poeta “matto” nelle “nuvole” della Rete
 — -
— -Nei giorni scorsi e’ stato il compleanno di Percy Bysshe Shelley, il poeta inglese morto a soli 29 anni, nato duecento anni fa nel 1792. Un vero e proprio rivoluzionario avanti lettera. Suo padre era un ricco esponente dell’aristocrazia e membro del Parlamento. Aveva messo da parte per suo figlio una grossa fortuna, ma lui non ne volle sapere di studiare e si fece espellere dall’università di Oxford per avere scritto un libello che fece scalpore intitolato Necessità dell’ateismo.
Gli venne offerta la possibilità di ritrarre quello che aveva scritto ma egli rifiutò e a soli 19 anni se ne scappo’ con una ragazza di 16 anni, figlia di un semplice oste. Fu diseredato e da quel punto ebbe iniziò la sua vita avventurosa che, come i romantici dell’epoca, fu tutto un romanzo.
Non sembri strano l’accostamento che sto per fare per l’occasione di questo anniversario, ma questa poesia di Shelley che ho scelto per ricordarlo e che spesso proponevo ai miei studenti, mi offre la possibilità di parlare di un aspetto caratteristico della Rete e quindi dei siti sociali: la loro mutabilità. Come quella che, appunto, il giovane poeta Shelley intravede nelle “nuvole”.
Esse appaiono nel cielo scintillanti di giorno per poi scomparire nella notte. Il tutto avviene improvvisamente, alla stessa maniera in cui appare e scompare la vita umana. Esse sono simili ai suoni, alle melodie di uno strumento, la lira, che emette toni diversi per diverse esperienze.
Le nuvole scorrono sullo schermo del cielo, sia che noi siamo svegli o addormentati. Pensieri vaganti e volubili ci accompagnano e interferiscono nella nostra mente, spesso alterando anche la nostra felicità. Esse, nell’apparire e scomparire, ci somigliano, siamo come loro. Mutevoli e sfuggenti.
Non pensate, allora, che le nuvole siano come i “post” che appaiono in Rete, che scorrono incessantemente sullo stream del Web? Proprio come le “nuvole”. Ecco la poesia:
We are as clouds that veil the midnight moon;/How restlessly they speed, and gleam, and quiver,/Streaking the darkness radiantly! — yet soon/Night closes round, and they are lost forever:/Or like forgotten lyres, whose dissonant strings/Give various response to each varying blast,/To whose frail frame no second motion brings/One mood or modulation like the last./We rest. — A dream has power to poison sleep;/We rise. — One wandering thought pollutes the day;/We feel, conceive or reason, laugh or weep;/Embrace fond woe, or cast our cares away:/It is the same! — For, be it joy or sorrow,/The path of its departure still is free:/Man’s yesterday may ne’er be like his morrow;/Nought may endure but Mutability.
Mutabilità
Noi siamo come nuvole che velano la luna a mezzanotte;/Così irrequiete sfrecciano, sfavillano, fremono,/striando l’oscurità radiosamente! — eppure, subito/la notte si richiude intorno e le cancella:/o come dimenticate lire, le cui corde dissonanti/danno, a ogni diverso soffio del vento, una risposta nuova,/alla cui fragile struttura nessuna vibrazione nuova apporta/un tono o una modulazione simile all’ultimo./Noi riposiamo, e un sogno ha la forza di avvelenarci il sonno./Ci alziamo, e un pensiero errante può inquinare il giorno./Sentiamo, concepiamo o ragioniamo, ridiamo o piangiamo,/ci disperiamo, o gettiamo via ogni affanno:/è tutto uguale! Sia una gioia che un dolore,/il percorso da compiere dal suo abbandono non si è ancora concluso:/l’ieri dell’uomo non può mai essere simile al domani;/niente nel mondo può durare, eccetto la Mutabilità.
Alla tipica maniera romantica, il giovane poeta Shelley subito colloca l’uomo nella sua giusta dimensione: “Siamo nuvole”, egli dice. E poi subito aggiunge qualcosa alla caratteristica di essere umani quando paragona gli uomini a cose inventate, usando la similitudine delle “lire dimenticate”.
L’eterna condizione umana soggetta al mutamento, al cambiamento. Una condizione sia naturale, come le nuvole che ora sono qui, ora altrove, ora in una forma, in un momento in un’altra, pronte anche a sparire per sempre. E poi, quella lira, dai toni mutevoli, soggetta a stimoli diversi.
Tutto è cambiamento. Proprio come i post, i messaggi, le comunicazioni che scorrono sullo schermo del pc, del cell e di tutti gli altri gadget dedicati alla comunicazione. Tutto si trasforma, si confonde, si disperde in una “nuvola” che fa “memoria”, si gonfia sempre di più, inconstante, incontrollata e incontrollabile.
Nell’universo romantico di Shelley le nuvole assumono la dimensione dei pensieri e delle emozioni che appaiono e scompaiono nella mente degli uomini. Nell’universo digitale della Rete, nella grande “bolla” di Google che tutto inghiotte e tutto restituisce, vera e propria “world wide mind”, una Rete che diventa Mente. Sempre eguale a se stessa, ma sempre diversa, Proprio come la mente umana. Condannata alla “mutabilità”.
Che dire poi di Shelley nel suo sonetto Ozymandias , sulla statua in rovina del Faraone Ramses a Tebe, con i suoi ricordi che nulla è per sempre e che anche il più grande potere deve svanire? Potrebbe trattarsi del principe reggente (la poesia fu scritta nel 1817–1818), o semplicemente motivata dall’acquisizione da parte del British Museum della testa e del busto della statua, nota come Younger Memnon: sebbene Shelley avrebbe scritto il sonetto prima di vedere la statua. La durezza del suo ritmo accentua la vividezza della sua dizione:
OZYMANDIAS
I met a traveller from an antique land
Who said: Two vast trunkless legs of stone
Stand in the desert… Near them on the sand,
Half sunk, a shattered visage lies, whose frown
And wrinkled lip, and sneer of cold command
Tell that its sculptor well those passions read
Which yet survive, stamped on these lifeless things,
The hand that mocked them, and the heart that fed.
And on the pedestal these words appear:
“I am Ozimandias, King of Kings.
Look on my works ye Mighty, and despair.”
Nothing besides remains. Round the decay
Of that colossal wreck, boundless and bare,
The lone and level sands stretch far away.
OZYMANDIAS
Un viaggiatore ho incontrato, giunto da un paese antico,
mi disse: “Due immense gambe di pietra prive di tronco
si ergono nel deserto…Vicino ad esse sulla sabbia,
mezzo sepolto, giace un volto in frantumi, il cui cipiglio
e il corrugato labbro, e il ghigno di freddo comando,
rivelano che lo scultore assai bene colse quelle passioni
che ancora sopravvivono -impresse in quegli oggetti senza vita-
a quella mano che le raffigurò e all’anima che le nutrì.
E sopra il piedistallo stanno incise queste parole:
“Ozymandias è il mio nome, il Re dei Re:
guardate alle mie opere, o potenti, e disperate!”
Null’altro rimane. Attorno allo sfacelo
di quel rudere immenso, sconfinato e nudo,
si stende delle sabbie, solitario, il piano.
Questo può essere vero per il potere mortale, ma non per i poeti immortali. L’appello alla non violenza, confrontato con la sfacciata sete di sangue del potere, è formulato nel contesto delle antiche libertà dell’Inghilterra e del pericolo di un governo che le smantelli. È rilevante oggi come ieri. Il giovane poeta continua ad essere “matto” oggi.
[image error]September 3, 2022
“Prima di Mussolini gli Italiani non si capivano tra di loro”
 Il Libro
Il Libro
Un bibliomane che si rispetti, sia cartaceo che digitale, è sempre a caccia di nuovi libri. Ho letto la fantastica notizia che nel mondo si pubblicano circa 400 mila libri al giorno. Quanti libri al minuto allora? Il conto fatelo voi. A me basta saper scegliere, a seconda dei propri interessi e bisogni. L’immagine che correda questo post vi propone un libro che non è stato ancora pubblicato in cartaceo, ma di imminente uscita in versione digitale Kindle. L’ho prenotato dopo di aver letto la notizia sulla rivista inglese The Spectator. Leggete la presentazione editoriale e la traduzione della recensione in anteprima. Quando mi arriva la copia digitale, a lettura del libro completata, ne discuteremo.
Dove, o cos’è casa? Che cosa ha significato, storicamente e personalmente, essere ‘italiano’ o ‘inglese’, o entrambi in una cultura che preferisce che siamo noi a scegliere? Cosa significa avere radici? O aver lasciato un pezzo di sé in un posto abbandonato da tempo? In Dandelions, il suo straordinario debutto, Thea Lenarduzzi ricostruisce la storia della sua famiglia attraverso quattro generazioni di migrazioni tra Italia e Inghilterra, e le storie sparse come semi lungo il percorso. Al centro di questo libro traboccante della vita di persone straordinarie e apparentemente insignificanti c’è la nonna di Thea, Dirce, un’ex sarta, che, ora vicina ai 100 anni, è una depositaria di racconti che sono a loro volta imprevedibili, inaffidabili, significativi. E questo ci porta più in profondità. C’è quello sul moderno Icaro di Mussolini che si schiantò nell’oscurità di un lago; sull’operaio di Manchester che voleva solo essere visto; sul demone oscuro che ti visita nel sonno; e il monumento a un politico assassinato che, quando piove, si colora del sangue. Attraverso i viaggi di Dirce e dei suoi parenti, dal Friuli a Sheffield e Manchester e ritorno, emerge una storia diversa, in cui sé e luogo sono ordito e trama, intessuti, con fili lasciati pericolosamente indietro. Un libro di memorie di famiglia ricco di leggende popolari, cibo, arte, politica e letteratura, Dandelions annuncia l’arrivo di una scritttice eccezionale: audace, gioiosa e saggia.
 The Spectator
The Spectator
Verso la fine di “Dandelions”, il libro di memorie ispirato e profondamente toccante di Thea Lenarduzzi, l’autrice cita l’osservazione della nonna secondo cui ci sono tante Italie, tante Italie. “La mia è diversa dalla sua, che è diversa da quella di mia madre, che è diversa da quella di mio padre, e così via”, scrive. Queste Italia, del fascismo, di Garibaldi, di emigranti che vivono a Sheffield e Manchester, di 31 dialetti, non sono stranezze storiche lontane confinate a documentari o libri di testo ma sono, nel racconto di Lenarduzzi, la storia patchwork di una famiglia.
Seduta al tavolo di sua nonna con “le persiane abbassate contro il sole mattutino e il resto della famiglia scacciato via”, diventa una “archivista della tradizione familiare”. Attraverso conversazioni su cose semplici come passioni infantili (“Chi era il tuo scrittore preferito quando eri giovane?”) o dolorose come la dittatura di Mussolini (il nonno di Lenarduzzi non si opponeva al regime fascista; sua nonna afferma che “non aveva scelta ‘), si dipana una storia complicata di amore, immigrazione e guerra e le tante Italia in cui si è svolta.
L’autrice, sulla trentina, è lei stessa ‘50–50 italo-inglese’, anche se lotta con questo modo ‘biometrico, certificabile’ di guardare alla sua eredità. Il movimento tra l’Italia e l’Inghilterra muove il libro. Sua nonna (il cui nome, Dirce, significa giustamente “spaccatura” o “doppio”) ha “vissuto due vite”, con due diverse migrazioni dall’Italia all’Inghilterra. Lasciò per la prima volta Maniago, una cittadina nel nord-est del Friuli, per trasferirsi a Sheffield nel 1935, quando “la Grande Depressione stava montando” e Mussolini stava per consolidare il suo potere. Questa migrazione fallì quando suo padre, Angelo, morì due mesi dopo (è sepolto nel cimitero di Sheffield’s City Road). Ma Dirce lasciò di nuovo l’Italia nel 1950, questa volta per Manchester, con marito e figlio.
Questi viaggi, affrettati, difficili e pieni del dolore della nostalgia di casa, qualcosa a cui secondo Lenarduzzi gli italiani sono ‘particolarmente sensibili’ spiegano il titolo del libro. I denti di leone, le loro “teste cariche di semi in attesa di prendere una brezza, stabilirsi e mettere radici”, sono un “regalo di un motivo” quando si pensa all’immigrazione. La loro fragilità completa la metafora: ‘Per gli immigrati, la precarietà fa sempre parte della disposizione.’
Lenarduzzi è molto brava quando scrive di migrazioni internazionali, ritorno a casa e appartenenza (‘Lo vedo come un processo di prosciugamento, come se l’italianità mi stesse esaurendo ogni anno trascorso all’estero’); ma le sue storie sui movimenti e le tensioni all’interno della stessa Italia sono ancora più potenti.
Il libro è costellato di frammenti dei dialetti parlati dalla sua famiglia. Suo nonno era trilingue e parlava “friulano con la moglie, veneto con i figli e italiano con i nipoti, che lo parlavano da soli”. Negli anni ’20, tale varietà costituiva una “minaccia diretta” all’omogenea italianità in cui credevano i fascisti. Per 20 anni, le molte lingue “reciprocamente incomprensibili” d’Italia furono soppresse a favore dell’italiano, una lingua che, all’epoca dell’unificazione , parlava solo il 2% della popolazione.
Ma il Duce non lasciò in pace nemmeno la lingua. Nel 1938, mise fuori legge l’uso del “lei” come versione educata di “tu” (simile a vous in francese) e lo sostituì con “voi”. Sessant’anni dopo, tornato in Italia dall’Inghilterra, il padre di Lenarduzzi in una riunione vine rimproverato per aver ancora usato questo tipo di indirizzo imposto dal fascismo. Nelle pagine di chiusura del libro, l’autrice cita sua nonna dicendo: ‘Sono solo parole’, solo parole. Ma in Italia sembra che nulla possa essere più lontano dalla verità.
Natalia Ginzburg, la saggista e scrittrice ebrea-italiana che ha scritto sull’Italia in tempo di guerra, aleggia in tutto “Dandelions”. Lenarduzzi cita il suo romanzo-memoir “Lessico di Famiglia” quando parla di storie di famiglia. ‘Se io e i miei fratelli dovessimo trovarci in una grotta buia… solo una di quelle frasi o parole ci permetterebbe immediatamente di riconoscerci’. C’è qualcosa di narrativa consapevole in molti passaggi del libro. Nel descrivere i suoi nonni che si innamorano, scrive: “Mentre la storia di Leo e Dirce si svolgeva, gli Alleati invasero la Sicilia”. Non è una scelta gratuita o un cliché. Lenarduzzi si interroga continuamente su cosa significa scrivere un libro di memorie, impacchettare vite in parole e creare una narrazione coerente al di là di ogni forma di “deviazione e digressione”: “Mi chiedo quali siano le motivazioni della nonna e le mie”.
Ci sono momenti in cui la narrazione sfocia nell’auto-indulgenza, Lenarduzzi elabora persino una meditazione filosofica sull’amore di sua nonna per il paracetamolo, ma, nonostante questo, “Dandelions” è ancora libro che coinvolge. Così come descrive di molte Italia, parla anche molti libri, e questa insolita combinazione di memorie di famiglia, indagine letteraria e storia politica è un trionfo.
Originally published at https://www.spectator.co.uk .
[image error]September 2, 2022
Un libro o un “coitus interruptus”
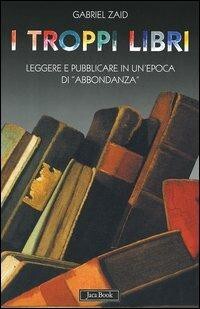 Il Libro
Il Libro
Dedico questo post ad un amico che preferisce avere tra le mani il libro cartaceo piuttosto che leggerne uno in digitale. In diverse occasioni ho cercato di far capire che il contrasto, il dissidio, il confronto tra libro cartaceo e libro digitale è tutto un fraintendimento, una non-conoscenza, se non ignoranza, di come stanno le cose e di quello che realmente sta accadendo nel mondo della comunicazione moderna.
La realtà cartacea e quella digitale sono destinate e procedere in parallelo. L’una ha bisogno dell’altra. Intendiamoci, non faccio il tifo per nessuno, ho imparato a leggere e scrivere in una piccola tipografia post-gutenberghiana. So bene come si fa un libro, ne leggo e ne scrivo ogni giorno, in rete, ne posseggo a migliaia, sia cartacei che in versione digitale.
Alla mia biblioteca cartacea si è affiancata quella digitale. Anzi, per essere più precisi, quella cartacea si “scioglie”, giorno dopo giorno, in quella digitale. A questo punto mi rendo conto che devo chiarire il significato di questa parola: “sciogliere”. Ricordate quello che ha scritto il filosofo Zygmund Bauman e la sua “società liquida”? Bene, in sintesi: “La modernità è la convinzione “che il cambiamento è l’unica cosa permanente e che l’incertezza è l’unica certezza”.
Il risultato è che ogni trenta secondi viene pubblicato un libro. Qualcuno si è posto la domanda se ne vale la pena. Io penso di si, ma penso anche di no. Come dire? Sono indeciso e per questa ragione ho deciso di scrivere questo post. Onestamente davvero non so dove andrò a parare. Ad ogni modo eccomi qua, da vero bibliomane, a parlarne. Quante volte abbiamo sentito dire “compro questi libri perché i miei figli si trovino una bella biblioteca”, “una casa senza libri è una casa vuota”, “un libro è un amico per sempre” e via librando.
Eppure, oggi, enciclopedie e libri, anche di autori classici, diventano superati in poco tempo. Grazie, infatti, alle strategie di marketing si portano in libreria o in edicola edizioni nuove e migliori, mentre i ragazzi hanno ormai sostituito la classica enciclopedia con Internet . E non hanno neanche torto, se si pensa che Wikipedia , l’enciclopedia redatta coi contributi volontari è considerata più autorevole dell’ Enciclopedia Britannica o della Treccani.
Io stesso, nel mio studio, ho tutta una parete tappezzata dai volumi dell’Enciclopedia Britannica aggiornata coi i volumi annuali fino all’anno 2002. Solo venti anni fa. Una parete imponente, elegante, robusta, fatta di volumi-mattoni rilegati in pelle con incisioni in oro. Un mare di conoscenze sempre a portata di mano, disponibile, affidabile, in attesa di essere aperta, sfogliata, consultata.
Non sto qui a ricordare quanto mi sia stata utile una enciclopedia del genere, vero e proprio strumento di lavoro indispensabile per chi vuole conciliare la conoscenza con l’affidabilità del sapere, senza trascurare la profondità. Ebbene detto questo, devo anche riconoscere che sono anni ormai che non prendo tra le mani un suo volume e non ricerco una voce né nei volumi per soggetto né tanto meno in quella per ordine alfabetico.
Ho detto forse da una decina di anni e non a caso. Da quando il web è entrato a far parte della nostra vita. D’allora tutto è cambiato. E così si spiega e si capisce perché Gabriel Zaid , in un suo libro dedicato all’argomento, (ancora un altro!), dice chiaro e tondo che “la creazione di una biblioteca obsoleta per i propri figli è giustificabile solo nella misura in cui è giustificabile la tutela delle rovine, in nome dell’archeologia. Ci sono scuse migliori per collezionare libri”.
Questo scrittore messicano afferma che ci sono “troppi libri” (il titolo del suo libro) in giro oggi. Il fatto non è poi del tutto nuovo se si pensa che anche nella Bibbia , e precisamente nell’ Ecclesiaste , si afferma “i libri si moltiplicano senza fine e il molto studio affatica il corpo”. Qualche tempo dopo, la stessa cosa ripeteva Seneca , facendoci sapere che “la moltitudine di libri dissipa lo spirito”.
Oggi, però, i libri non sono più i libri di una volta, quelli che per trovarli dovevi entrare in una libreria, prenderli in mano, sfogliarli, portarteli a casa, copiarli, fotografarli, trascriverli e tutto il lavoro che per anni si è fatto con le pagine stampate. Oggi il libro, oltre che di carta, di pagine e di inchiostro, è fatto anche di “bits & bytes” . Il che vuol dire che se non posso averlo tra le mani, posso leggerlo al pc, sul tablet o notebook, leggermelo in treno o in montagna, gestirlo come mi pare, manipolarlo, trasformarlo sia nel testo che nelle immagini, riutilizzarlo ed usarlo per i fini che mi propongo.
Ed allora scopro che non mi è più economico, cioè pratico e veloce prendere il volume dallo scaffale, sfogliarlo, scovare la voce che mi interessa, isolare i contenuti utili alle mie ricerche, copiare o fotocopiare. Tutto così è più rapido, economico, funzionale se, oltre ad averlo tra le mani, me lo “scarico” e ne faccio ciò che voglio. Posso addirittura farmelo leggere da qualcuno, se pensiamo che ci sono libri che si ascoltano e possono anche vedersi se il libro stesso è supportato da file video.
Sembra, allora, inutile continuare ad aggiornare la biblioteca con l’acquisto di libri. Se ogni 25 secondi se ne pubblica uno, significa che in un anno possono esserci 25 km di scaffali. Leggendo anche un libro al giorno trascureremmo gli altri 4000 pubblicati nello stesso giorno. Se a partire da questo momento non venisse più pubblicato alcun libro, ci vorrebbero comunque 250.000 anni per arrivare a conoscere i libri già scritti. Potremmo accontentarci di leggere solo autore e titolo di ogni libro e ci basterebbero 15 anni. Quando si dice allora che tutti dovrebbero leggere libri non sappiamo quello che diciamo e non consideriamo che per ogni libro pubblicato rimangono inediti 9 manoscritti.
E allora qual è il senso del mio discorso? Sto forse sostenendo che i libri non si devono più scrivere, stampare, vendere e leggere? No, non dico questo. Dico che i libri ormai sono gli uomini e con essi si identificano. Cioè, detto in sintesi: “Ogni libro è un uomo”. Il che significa che se gli uomini continuano a nascere e a riprodursi, se ogni uomo è un libro, non si capisce perché si debbano “leggere” tutti i libri e tutti gli uomini che vengono stampati o generati.
Allora vuol dire che a chi piacciono i libri come piacciono gli uomini, si sceglieranno i libri e gli uomini che piacciono. Il resto resterà un manoscritto o un “coitus interruptus”.
[image error]August 31, 2022
Leggere la biblioteca digitale …
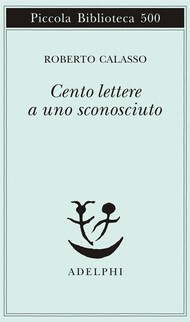
Quando scomparve Roberto Calasso scrissi su FB che usciva di scena “un genio della scrittura e dell’editoria”. Ed è vero. Ho ritrovato nella mia biblioteca cartacea questo suo preziosissimo libro, con questo strano titolo. “Lettere” che poi non sono altro che “risvolti” di cento libri da lui pubblicati. Tutte le etichette che gli ho assegnato quando l’ho inserito nella mia biblioteca digitale caratterizzano questo libro che ricordo di avere comprato a Bologna in una antica, piccola libreria in via Andrea Costa. Testimonia l’amore per i libri di Calasso, tanto amore che sfocia certamente nella bibliomania e nel business.
Potete trovare di tutto e tutti nel lungo elenco dei “risvolti”: da Erewhon a Eliogabolo, dal libro di Giobbe alle “memorie di un malato di nervi”, passando per Casanova e il giorno del giudizio, la Patagonia di Chatwin, i Quaderni di Simon Weil, gli ultimi giorni di Kant e la tentazione di esistere di Cioran. Non poteva mancare “L’insostenibile leggerezza dell’essere” di Kundera e il “Cardillo Addolorato” di Anna Maria Ortese per finire con gli Editti di Asoka.
Chi legge e sa leggere capirà allora il valore e il significato della comunicazione nel lavoro che ha svolto Calasso nel campo della editoria e anche dell’economia. Una guida, una identità per chi cerca nei libri la sua identità, unendo lavoro, lettura e letteratura in un percorso mediatico nel quale il pensiero pensato fa da guida e riferimento per chi crede nella scrittura come avventura. Questo era Roberto Calasso che ha saputo scrivere la sua “lettera” a chi sa leggere, per non passare alla storia come uno “sconosciuto”.
@@@@@@
Leggere la biblioteca. Sì, come un libro. Leggere la propria biblioteca. Anche questo è “lettura”. Io credo che questa sia una “cosa” interessante, utile e anche più necessaria che leggere un libro. Mi spiego. Sono diverse settimane che procedo a mettere online i libri della biblioteca personale che non è soltanto mia. Ovviamente, mi limito a catalogarli, recensirli, condividerli con altri, collegarli a biblioteche digitali, partecipare a discussioni social e tante altre cose interessanti. La biblioteca da cartacea così diventa sociale e digitale.
In essa confluiscono libri di varia provenienza. I pochi libri, dei tanti dispersi nel tempo della biblioteca personale di mio padre, formata negli anni della sua gioventù, gli anni trenta. Chi sa leggere il tempo, può comprendere la differenza con quella che era la cultura e la lettura di allora e quella di oggi. Poi vennero i libri che lui stampava in quella piccola tipografia artigianale di provincia. Stampavano e vendevano i quattro fratelli per vivere. C’era poco tempo per leggere. Stampavano non solo per il piccolo paese ma anche per la grande Napoli.
Quella mitica strada, chiamata Via Mezzocannore, la strada delle librerie dell’Università. I volumi che uscivano da macchine gutenberghiane apparivano spesso nelle vetrine di quegli antichi librai oggi scomparsi. Di questi volumi ne sono sopravvissuti pochi, ma tanti se ne sono aggiunti alla mia biblioteca. Oltre quelli miei, ci sono quelli di mio fratello, quelli di mia moglie, fino a quelli di mio figlio.
Una biblioteca, oltre ad avere una dimensione temporale, ne ha una anche spaziale, a volte per necessità, altre volte per dilatazione esistenziale. Quando lo spazio in casa è diventato insufficiente, allora i libri hanno esteso la loro presenza in mansarda e poi anche in garage. Ovviamente i più preziosi hanno il loro posto d’onore, come ad esempio la raccolta della “Folio Society” di Londra, una casa editrice inglese della quale sono stato socio per lungo tempo. In garage trovano posto i tanti volumi per lo più saggi ed omaggi di editori scolastici e non.
La mansarda è stato sempre il mio luogo ideale per creare questa biblioteca. Al quarto piano della casa dove abbiamo vissuto per oltre tre decenni, il palazzo si affaccia sulla grande antica Valle dei Sarrasti, guarda verso Pompei. In fondo, il mare di Castellammare, si può vedere, quando il cielo è limpido, il campanile della chiesa Pompei che si staglia contro la sagoma dell’isola di Capri. Spostando lo sguardo verso destra si presenta agli occhi di chi guarda, “sterminator Vesevo” con a fianco il monte Somma.
Dall’altro lato della biblioteca-mansarda si ammira il monte Saro, ai piedi del quale si distende silenzioso Episcopio, l’antico villaggio, oggi decaduta frazione della Città di Sarno, tutto raccolto intorno alla sua splendida cinquecentesca “Cattedrale degli Angeli” dedicata a San Michele Arcangelo. Spostando lo sguardo verso destra si vede la collina del monte Saretto, sul quale si ergono le antiche rovine di quello che fu il Castello degli Aragonesi a Sarno …
Ecco, questo è l’ambiente, l’ “habitat”, della mia biblioteca. Ho creduto opportuno fare questa descrizione perchè credo che il contesto sia importante. Ogni biblioteca degna di questo nome, ha una sua storia, una propria identità, una sua ragion d’essere. Le biblioteche, pubbliche o private, piccole o grandi, non nascono a caso e senza una ragione. Questa mia che ho deciso di “fotografare” in questa memoria ha una sua “dependence”, un’appendice, per così dire, in Costa d’Amalfi.
Seguendo la descrizione della Valle che ho fatto innanzi, dal balcone della stessa mansarda, posso osservare, a sinistra della sagoma dell’Isola di Capri, il monte del valico di Chiunzi. Al di là del complesso montuoso di quei monti chiamati Lattari, nel villaggio di Novella, uno dei tredici del Comune di Tramonti, dove sono nato, a poca distanza dal mare di Maiori, in una casetta materna, appesa tra terrazze di ulivi e vigneti di uva tintore, ho dato vita ad un’appendice di questa biblioteca. Altri volumi, altri ricordi, altre memorie che confluiscono in uno “spazio” culturale che può essere letto ed interpretato alla stessa maniera di come si legge un libro.
E’ il titolo, infatti, che dà la giusta identità ad un libro. Non sempre è quello giusto, ma è quello che spesso decide il suo destino futuro. Se non tanto il successo per il contenuto, quanto per la curiosità che suscita nel lettore non informato o sprovveduto che l’acquista. Perchè ce ne sono di libri col titolo abbastanza strano come ad esempio: “Le balene restino sedute”, “Ero una brava mamma prima di avere figli”, “Anche le formiche nel loro piccolo s’incazzano”.
Solo tre esempi che magari sono stati pensati per attirare l’attenzione del lettore distratto. Ma ci sono anche titoli come il famoso “L’insostenibile leggerezza dell’essere”, “Il castello dei destini incrociati”, “Esercizi di stile”. Questi ultimi tre hanno un’aria decisamente intellettuale, non caso gli autori sono in ordine: Milan Kundera, Italo Calvino, Raymond Queneau.
Sono arrivato al punto cruciale di questa “lettura” dei titoli dei libri della mia biblioteca che probabilmente ammonta a diverse migliaia di titoli. Quattro, cinque mila, non so ancora dire. Man mano che prendo tra le mani ognuno di questi libri, li sfoglio in cerca dei dati necessari per compilare la scheda digitale della sua identità, scopro di meravigliarmi per varie ragioni.
Lo prendo tra le mani, lo guardo, lo sfoglio e mi accorgo di non ricordare nulla di lui. Se fosse mio, o di chi altro, come sia finito qui, e poi quel titolo tanto strano. Prendiamo questo: “The old noise of truth”, un libro di poesie inglesi: “L’antico rumore della verità”. Lo apri e scopri una dedica con la data di ventisei anni fa. Improvvisamente si accendono le luci del ricordo e cominci a ricordare …
“Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei”, forse è vero. Come può essere vero “dimmi cosa leggi e ti dirò chi sei”. Inevitabilmente i titoli di questi libri, che si distendono nel tempo e nello spazio di una vita, raccontano a chi li legge, sin dai titoli, chi sei, non solo oggi, ma anche chi sei stato nel passato. Già, perchè quest’ultimo si legge sin dai titoli dei tuoi libri.
Arte, storia, cucina, lingue, filosofia, musica, santi e peccatori, scienze e sogni, fantasie, sesso, illusioni, scorrono sin dai titoli. Romanzi, manuali, saggi, biografie, fantasie, disegni, a fascicoli, a dispense, in brossura o rilegati, fanno il tuo identikit di lettore. Sembra quasi che ti interroghino, se li hai letti, perchè li hai lasciati, ignorati, cosa hai capito, perchè non li hai ascoltati. E tu continui a leggerli, sfogliarli, catalogarli … Ogni uomo è un libro, ogni libro è un uomo …
@@@@@@
Il risvolto è un’umile e ardua forma letteraria che non ha ancora trovato il suo teorico e il suo storico. Per l’editore, spesso offre l’unica occasione per accennare esplicitamente ai motivi che lo hanno spinto a scegliere un certo libro. Per il lettore, è un testo che si legge con sospetto, temendo di incontrarvi un subdolo imbonimento. Eppure il risvolto appartiene al libro, alla sua fisionomia, come il colore e l’immagine della copertina, come i caratteri in cui è stampato. Eppure, una civiltà letteraria si riconosce anche dal modo in cui i libri si presentano.
Lunga e tortuosa è stata la via percorsa dalla storia del libro prima di far nascere il risvolto. Suo nobile antenato è l’epistola dedicatoria: altro genere letterario, fiorito a partire dal Cinquecento, dove l’autore (o lo stampatore) si rivolgeva al Principe che aveva protetto l’opera. Genere non meno imbarazzato del risvolto, poiché qui la funzione dell’allettamento commerciale veniva assunta dall’adulazione. Eppure, quante volte, e in quanti libri, fra le righe dell’epistola dedicatoria l’autore (o lo stampatore) ha lasciato trasparire la sua verità — e anche stillare il suo veleno. Rimane da constatare, comunque, che nel momento in cui il libro entra nel mondo sembra obbligato a passare da una forma che suscita diffidenza.
In età moderna, non vi è più un Principe a cui rivolgersi, ma un Pubblico. Avrà forse un volto più netto e riconoscibile? Chi crede di poterlo affermare s’inganna. Per alcuni può addirittura essere questo l’inganno su cui si fonda la loro professione. Ma la storia dell’editoria, a guardarla da vicino, è una storia di perenni sorprese, una storia dove regna l’imprevisto. Al capriccio del Principe si è sostituito un altro, diffuso capriccio, non meno potente. E le possibilità di equivoco si sono moltiplicate. Cominciamo dalla parola: chi dice pubblico pensa generalmente a un’entità ingombrante e informe. Ma la lettura è solitaria, come il pensiero — e presuppone l’oscura e isolata scelta di un singolo. Il capriccio implicito nella scelta del mecenate che dall’adulazione. Eppure, quante volte, e in quanti libri, fra le righe dell’epistola dedicatoria l’autore (o lo stampatore) ha lasciato trasparire la sua verità — e anche stillare il suo veleno. Rimane da constatare, comunque, che nel momento in cui il libro entra nel mondo sembra obbligato a passare da una forma che suscita diffidenza. In età moderna, non vi è più un Principe a cui rivolgersi, ma un Pubblico. Avrà forse un volto più netto e riconoscibile? Chi crede di poterlo affermare s’inganna. Per alcuni può addirittura essere questo l’inganno su cui si fonda la loro professione. Ma la storia dell’editoria, a guardarla da vicino, è una storia di perenni sorprese, una storia dove regna l’imprevisto. Al capriccio del Principe si è sostituito un altro, diffuso capriccio, non meno potente. E le possibilità di equivoco si sono moltiplicate. Cominciamo dalla parola: chi dice pubblico pensa generalmente a un’entità ingombrante e informe. Ma la lettura è solitaria, come il pensiero — e presuppone l’oscura e isolata scelta di un singolo. Il capriccio implicito nella scelta del mecenate che dopo tutto minore, perché più fondato, del capriccio di un ignoto lettore che si avvicina a un’opera e a un autore di cui nulla sa.
Osserviamo un lettore in libreria: prende in mano un libro, lo sfoglia — e, per qualche istante, è del tutto separato dal mondo. Ascolta qualcuno che parla, e che gli altri non sentono. Accumula casuali frammenti di frasi. Richiude il libro, guarda la copertina. Poi, spesso, si sofferma sul risvolto, da cui si aspetta un aiuto. In quel momento sta aprendo — senza saperlo — una busta: quelle poche righe, esterne al testo del libro, sono di fatto una lettera: la lettera a uno sconosciuto.
Per molti anni, dopo che Adelphi cominciò a pubblicare, ci è capitato di sentirci rivolgere una domanda: «Qual è la politica della casa editrice?». Era una domanda colorata da un certo periodo, quello in cui la parola «politica» stingeva su tutto, anche sul caffè che si beveva in un bar. Nella sua goffaggine, era però una domanda giusta. Sempre più, nel nostro secolo, l’editore è diventato una figura occulta, un invisibile ministro che dispensa immagini e parole seguendo criteri non immediatamente chiari, che suscitano l’universale curiosità. Pubblica forse per fare denaro, come tanti altri produttori? Nel profondo, pochi ci credono, se non altro per la fragilità del mestiere e del mercato. Appare così spontaneo il dubbio, in questo caso, che il denaro basti a rendere ragione di tutto. C’è sempre un di più che viene attribuito all’editore. Se esistesse (e non l’ho mai incontrato) un editore che pubblica soltanto per fare denaro, nessuno gli darebbe ascolto. E probabilmente fallirebbe presto, confermando gli increduli nella loro convinzione.
Nei primi anni, colpiva nei libri Adelphi innanzitutto una certa sconnessione. Nella stessa collana, la «Biblioteca», apparvero in sequenza un romanzo fantastico, un trattato giapponese sull’arte del teatro, un libro popolare di etologia, un testo religioso tibetano, il racconto di un’esperienza in carcere durante la seconda guerra mondiale. Che cosa teneva insieme tutto questo? Paradossalmente, dopo un certo numero di anni, lo sconcerto dinanzi alla sconnessione si è rovesciato nel suo opposto: il riconoscimento di una connessione evidente. In alcune librerie, dove gli scaffali sono divisi per materia, ho incontrato — accanto alle etichette Cucina, Economia, Storia, ecc. — un’altra etichetta, di uguale impostazione grafica, che diceva semplicemente: Adelphi. Questo singolare rovesciamento, che si è imposto nella percezione di qualche libraio e di molti lettori, non era ingiustificato. Si può fare una casa editrice per le ragioni più diverse, e seguendo i criteri più diversi. Quello che oggi sembra più normale, in una grossa casa editrice, si potrebbe formulare così: pubblicare libri che corrispondano ciascuno a uno spicchio di quell’immenso ventaglio che è il pubblico. Ci saranno così libri rozzi per i rozzi e libri squisiti per gli squisiti, in proporzione all’ampiezza che si attribuisce a ciascuno di quegli spicchi.
Ma si può costruire un programma editoriale anche seguendo un criterio palesemente contrario. Che cos’è una casa editrice se non un lungo serpente di pagine? Ciascun segmento di quel serpente è un libro. Ma se si considerasse quella serie di segmenti come un unico libro? Un libro che comprende in sé molti generi, molti stili, molte epoche, ma dove si continua a procedere con naturalezza, aspettando sempre un nuovo capitolo, che ogni volta è di un altro autore. Un libro perverso e polimorfo, dove si mira alla poikilía, alla «variegatezza», senza rifuggire i contrasti e le contraddizioni, ma dove anche gli autori nemici sviluppano una sottile complicità, che magari avevano ignorato nella loro vita. In fondo, questo strano processo, per cui una serie di libri può essere letta come un unico libro, è già avvenuto nella mente di qualcuno, per lo meno di quell’entità anomala che sta dietro i singoli libri: l’editore.
Questa visione comporta alcune conseguenze. Se un libro è innanzitutto una forma, anche un libro composto di una sequenza di centinaia (o migliaia) di libri sarà innanzitutto una forma. All’interno di una casa editrice della specie che sto descrivendo, un libro sbagliato è come un capitolo sbagliato in un romanzo, una giuntura debole in un saggio, una chiazza di colore urtante in un quadro. Criticare quella casa editrice non sarà, a questo punto, nulla di radicalmente diverso dal criticare un autore. Quella casa editrice è paragonabile a un autore che scriva solo centoni. Ma i primi classici cinesi non erano forse tutti centoni?
Non vorrei però essere frainteso: non intendo pretendere da qualsiasi editore che diventi un classico cinese arcaico. Sarebbe pericoloso per il suo equilibrio mentale, già minacciato da tanti agguati e seduzioni. Non ultima fra queste, e destinata ad avere fortuna, la seduzione che è il perfetto rovescio speculare di quella che potremmo chiamare la tentazione del classico cinese. Intendo con ciò la possibilità di diventare come il «povero ricco» di cui scrisse Adolf Loos, che volle abitare in un appartamento ideato in ogni minimo dettaglio dal suo architetto, e alla fine si sentì totalmente estraneo e vergognoso a casa sua. L’architetto lo rimproverò perché aveva osato mettersi un paio di pantofole (anch’esse disegnate dall’architetto) nel soggiorno e non in camera da letto.
No, la mia proposta è che agli editori si chieda sempre il minimo, ma con durezza. E qual è questo minimo irrinunciabile? Che l’editore provi piacere a leggere i libri che pubblica. Ma non è forse vero che tutti i libri che ci hanno dato un qualche piacere formano nella nostra mente una creatura composita, le cui articolazioni sono però legate da un’invincibile affinità? Questa creatura, formata dal caso e dalla ricerca testarda, potrebbe essere il modello di una casa editrice — e per esempio di una che già nel suo nome rivela una propensione per l’affinità: Adelphi, appunto.
Di tutto questo i risvolti qui pubblicati portano traccia. Fin dall’inizio, obbedivano a una sola regola: che noi stessi li prendessimo alla lettera; e a un solo desiderio: che anche i lettori, contrariamente all’uso, facessero lo stesso. In quella angusta gabbia retorica, meno fascinosa ma altrettanto severa di quella che può offrire un sonetto, si trattava di dire poche parole efficaci, come quando si presenta un amico a un amico. E superando quel lieve imbarazzo che c’è in tutte le presentazioni, anche e soprattutto fra amici. Oltre che rispettando le regole della buona educazione, che impongono di non sottolineare i difetti dell’amico presentato. Ma c’era, in tutto questo, anche un pungolo: si sa che l’arte della lode precisa non è meno difficile di quella della critica devastante. E si sa inoltre che il numero di aggettivi adatti per lodare gli scrittori è infinitamente minore di quello degli aggettivi disponibili per lodare Allah. La ripetitività e la limitazione sono parte della nostra natura. Dopo tutto, non riusciremo mai a variare più che tanto i gesti che compiamo per alzarci da un letto.
Venendo a coincidere il quarantesimo anno dell’uscita del primo libro Adelphi e il numero cinquecento della «Piccola Biblioteca», abbiamo pensato di raccogliere in un libro cento tra i 1068 risvolti che ho scritto fra il 1965 e oggi. In un certo periodo — fra il 1967 e il 1992 — tendevo a scriverli tutti, con rarissime eccezioni. In seguito ne ho scritti sempre meno e oggi, salvo qualche occasionale soprassalto, mi dedico piuttosto a rivedere e, se è il caso, rielaborare testi messi insieme da una squadra redazionale: questo spiega l’assottigliarsi dei risvolti tratti da libri degli ultimi anni.
I motivi che hanno guidato la scelta dei cento risvolti potevano essere — e sono stati — molteplici. Nessuno però tale da dominare. Ci siamo presto resi conto che, se avessimo voluto comporre un libro che rispecchiasse con qualche pretesa di precisione la rappresentatività o l’importanza di certi titoli nel programma della casa editrice, immediatamente ci saremmo trovati ad affrontare dilemmi insensati. Sono state invece preziose e decisive le indicazioni di dieci lettori affini — interni ed esterni alla casa editrice –, secondo i loro gusti e inclinazioni. Così alla fine due soli criteri sono rimasti inflessibili: l’arbitrio e l’idiosincrasia. Arbitrio perché di ogni autore si è stabilito di non scegliere più di un titolo. Idiosincrasia perché la decisione ultima è stata affidata al minor dispiacere dell’autore nel rileggere i singoli pezzi. E a questo punto era fatta la scelta, le cui manchevolezze vanno imputate soltanto all’autore stesso.
Alla luce di tutto questo, non ci sarà ragione di meravigliarsi se alcuni libri essenziali nella casa editrice qui non appariranno. E neppure se salterà all’occhio l’assenza di certi autori (Brodskij o la Campo o la Bachmann o Colli o Baltrušaitis o Berlin potrebbero essere gli esempi più evidenti). È facile sentirsi insoddisfatti quando dobbiamo presentare qualcosa che ci sta particolarmente a cuore.
Tutti i testi sono riprodotti esattamente come sono apparsi, includendo anche un certo numero di virgolette alte che oggi senz’altro abolirei, ma che non posso non guardare con affetto, perché erano immancabilmente dovute ad accorti interventi cautelativi di Luciano Foà. Sono stati invece eliminati, quando vi fossero, i ragguagli funzionali all’edizione di cui, volta a volta, si trattava. A partire da un primo e drastico lavoro di sfoltimento sino agli ultimi tocchi redazionali ha vegliato sapientemente su questo libro Maddalena Buri, a cui va la mia gratitudine. Infine un’osservazione che è un sottinteso di tutto: questi risvolti hanno avuto per vari decenni, come primo lettore e interlocutore, Luciano Foà. Con lui ho soppesato innumerevoli dubbi. A lui il libro è naturalmente dedicato.
La presentazione di Roberto Calasso: “Cento lettere a uno sconosciuto. Il risvolto dei risvolti”, Piccola Biblioteca 500, Adelphi Edizioni, 2003
Tutti i risvolti di questi cento libri si possono leggere qui su Librarything una delle mie (due) biblioteche digitali.
[image error]August 29, 2022
Cuori di carta o cuori digitali?

Osservate bene l’immagine che correda questo post. Da sinistra a destra, una tavoletta risalente al 2400–2200 a. C. un rotolo del 2100 a.C. un codice del secondo secolo, un manoscritto del quinto secolo, un libro del 1900, un tablet contemporaneo. Potrei facilmente fare dell’ironia dicendo che almeno nel lessico c’è un ritorno alle origini.
Non è ovviamente questo il caso, ma l’occasione per una seria considerazione c’è. Me la offre la pubblicazione di un articolo nel quale si lancia un allarme per la mancanza di carta e le relative difficoltà che scaturiscono da questa situazione nella quale vengono a trovarsi tutti coloro che sono coinvolti nell’uso ed impiego della carta. L’autore è un giovane brillante giornalista, scrittore ed anche editore.
La storia della carta è simile a quella dell’Araba fenice: data per morta in più occasioni, risorge sempre. Solo, a differenza del mitologico uccello, non è in grado di controllare il fuoco che rimane il suo grande nemico come insegna monito per l’eternità la storia della Biblioteca di Alessandria. Dopo aver superato il requiem recitato dall’ebook che in un primo momento sembrava dovesse soppiantare il libro cartaceo, passata indenne la nascita degli smartphone e dei social network, ora la carta si trova ad affrontare una nuova crisi connessa all’aumento del costo dell’energia per la sua produzione.
L’Italia ha una storica tradizione di aziende cartarie e, sebbene negli ultimi anni molte delle carte utilizzate in ambito editoriale siano importate in prevalenza dal Sud-est asiatico, il settore continua ad essere importante da un punto di vista economico e rappresenta un’eccellenza per il nostro Paese.
Secondo Assocarta, nel 2021 operavano in Italia 119 imprese con 154 stabilimenti dando lavoro a 19.050 addetti con una produzione di 9,6 milioni di tonnellate di carta di cui 4,1 milioni di export per un fatturato totale di oltre 8 miliardi di euro. I numeri sono ancora più alti se si include il settore del riciclo e i non associati ad Assocarta, arrivando addirittura a 22 miliardi di euro di fatturato (1,4% del Pil).
Cifre significative che rischiano di essere messe in discussione dal boom del prezzo dell’energia; già a marzo l’associazione di categoria aveva messo in guardia dai pericoli per il settore ma la situazione è precipitata nelle ultime settimane: “Saranno inevitabili fermate produttive delle cartiere italiana” ha affermato il Presidente di Assocarta Lorenzo Poli. “In questo scenario continua Poli si inserisce anche la difficoltà delle aziende industriali nel definire i contratti di fornitura gas per il prossimo anno termico dato che i principali fornitori non si impegnano a garantire contrattualmente la consegna del gas. Purtroppo, noi industriali stiamo invece già prendendo impegni commerciali con i nostri clienti, anche nel prossimo trimestre, assumendoci di conseguenza un rischio elevato”.
Chi è stato costretto a fermare la produzione nel mese di agosto è Pro-Gest, gruppo del settore cartario che conta 1400 dipendenti, un fatturato di 747 milioni e 28 sedi in tutta Italia. Non usa giri di parole per descrivere la situazione il presidente Bruno Zago: “Lavorare con questi costi dell’energia non ha senso”. Ora all’azienda non resta che ritoccare i listini aumentando i prezzi del 20–30%.
Un destino simile è toccato alle Cartiere del Polesine in Veneto con un incremento del costo di gas ed elettricità quattro volte superiore allo stesso periodo dello scorso anno passando da 11 milioni di euro in sei mesi a 44 milioni. Stessa situazione per le Cartiere di Trevi in Umbria dove la bolletta del mese di agosto è passata da 581.000 euro del 2021 a 2,6 milioni del 2022. Ai problemi energetici e di approvvigionamento della materia prima, si aggiunge la riconversione di molte cartiere nella produzione di carta da imballaggi a causa del forte incremento dell’e-commerce e della richiesta di cartone ondulato.
Gli aumenti del prezzo della carta incidono a cascata sull’intera filiera editoriale colpendo le tipografie, gli editori, le librerie e infine i lettori. Le tipografie ricevono la carta per stampare i libri non solo a prezzi maggiorati ma con scadenze sempre più lunghe, anticipando i pagamenti per forniture che arriveranno dopo mesi e scaricando il costo sugli editori che, a loro volta, sono costretti ad aumentare il prezzo di copertina. I librai, già duramente provati dai lockdown, oltre a dover fronteggiare come tutti i negozianti i costi più alti delle bollette, rischiano di subire un calo delle vendite a causa dell’incremento dei prezzi dei libri.
Secondo Ricardo Franco Levi, presidente dell’Associazione italiana editori “Per gli editori di libri il costo della carta in un anno è passato da 120 a 200 milioni”. E non va meglio per i giornali, come spiega il presidente della Federazione italiana editori giornali Andrea Riffeser Monti: “A partire dal secondo semestre dello scorso anno il prezzo della carta su cui si stampano i giornali è cresciuto di oltre il 100% e ulteriori aumenti sono in corso”.
Eppure la carta rimane un bene di cui non possiamo fare a meno, non solo per la necessità negli imballaggi e in altri ambiti ma per il suo valore culturale. La produzione di carta fa parte della nostra storia e identità, cartiere come Fabriano e Fedrigoni hanno una storia secolare e città come Venezia — lo racconta Alessandro Marzo Magno nel suo L’alba dei libri. Quando Venezia ha fatto leggere il mondo (Garzanti, 2013) — hanno costruito la propria grandezza anche per merito dell’industria tipografica. Ian Sansom per il suo libro L’odore della carta (Tea, 2013) ha scelto il sottotitolo “una celebrazione, una storia, un’elegia”, mentre Mark Kurlansky in Carta. Sfogliare la storia (Bompiani, 2016) ha scritto: “Nessun dubbio: la carta è qui per restare”. Sta a noi difenderla dall’ennesima crisi della sua secolare storia.I libri sono specchi, finestre, porte scorrevoli, pietre miliari, soprabiti, ancore, trampolini, nascondini, angoli tranquilli, coperte calde, tappeti volanti, fari di luce … e chissà quante altre cose ancora. Per chi come me che ho imparato a leggere e scrivere in una tipografia, i libri sono molte altre cose ancora. (Il Giornale — Francesco Giubilei)
Scrivo in Rete ormai da molti anni, questa mia volontaria ed indipendente attività giornaliera testimonia, con migliaia di articoli (si chiamano post da queste parti) pubblicati, mi ha portato a capire le molte cose che la scrittura può essere per quanto riguarda l’esperienza di vita e di lavoro di uno che, nato e cresciuto in una famiglia di tipografi, continua a cercare di capire, scrivendo, quello che pensa, non più sulle pagine di un diario di carta, ma sulla tastiera di un pc, un iPad o uno smartphone.
Aveva ragione Marshall McLuhan quando disse, senza sapere troppo quello che diceva cinquanta anni fa, ben prima che la nostra vita diventasse digitale, “il mezzo è il messaggio”. Mi piaceva aiutare mio Padre a lavorare nella sua piccola tipografia di provincia.
Lui era un grande tipografo, “don Antonio o’ stampatore”, così lo chiamavano nel paese della Valle dei Sarrasti. Lui stampava di tutto: manifesti di lutto e partecipazioni di nozze, manifesti elettorali e giornali parrocchiali, libri e libretti, testi universitari e memorie personali, biglietti da visita e storie di paese.
Le lettere di piombo prendevano forma, diventavano pagine e poi libri. Lui, quelle pagine le cuciva, perchè era pure un legatore. Il libro prendeva forma e nasceva nelle sue mani. Li rilegava e li restaurava quando il tempo li aveva consumati.
Se le cose stanno così, allora posso dire che il libro non è soltanto quello che dice questa immagine ma molte, molte altre cose ancora. La pagina che sto scrivendo sul mio Chromebook è una pagina molto diversa dalla sua. E’ una pagina-web.
Pagine di libri molto, molto diversi da quelli che mio padre ha stampato per tutta la sua vita. Questa “pagina” ha una “forma” imprevista. Non è come quelle “forme” che i giovani compositori allineavano nella stanza della composizione, una dopo l’altra, prima che venissero poi messe in macchina per essere “stampate”.
Questa pagina è scritta in “bits & bytes”, non fa parte di un libro come quelli, ha una natura “digitale”. Il termine deriva dall’inglese “digit”, che significa “cifra”, che in questo caso si tratta di un codice, un sistema numerico che contiene solo i numeri 0 e 1, che a sua volta deriva dal latino “digitus”, che significa “dito”: con le dita infatti si contano i numeri.
Un determinato insieme di informazioni viene rappresentato in forma digitale come sequenza di numeri presi da un insieme di valori discreti, ovvero appartenenti a uno stesso insieme ben definito e circoscritto.
Anche mio Padre usava le dita della mano per prendere le lettere di piombo dalle casse per formare le righe della forma che dava vita alla pagina. Una ad una, maiuscola e minuscola, in tondo o in corsivo, corpo otto o corpo dieci, carattere di piombo o in legno.
Le dita sporche d’inchiostro, le mie dita sulla tastiera, fanno la differenza. Quei caratteri impressi sulla carta davano vita alle pagine, le quali una volta cucite, facevano nascere il libro.
La pagina di questo post scorre sotto le mie dita e tra poco verrà trasmessa alla memoria digitale di Google per essere letta in Rete ed entrare a far parte della biblioteca digitale del mondo. I libri di mio Padre entravano in biblioteche molto diverse.
Quelle avevano un cuore di carta, queste hanno un cuore di “bits & bytes”. Sarei potuto diventare un libraio. Sono diventato, invece, un blogger. Ma di cosa è fatto il cuore di un libro? Un cuore di carta o di bits & bytes?
Che cos’è un bit’? Cosa significa? Qual è la sua forma completa? Bit sta per cifra binaria. Questa è la forma completa di Bit. È binario 0 o 1. Solo le due cifre. Non sono necessarie altre cifre.
I nostri dispositivi informatici sono abbastanza intelligenti da dare un senso alla combinazione di queste due cifre per elaborare enormi quantità di informazioni.
Un bit è l’unità atomica, più piccola, più elementare di dati/informazioni che viene espressa e comunicata nell’informatica.
Anche nelle telecomunicazioni. I nostri computer eseguono le istruzioni della macchina ed elaborano i dati sotto forma di bit.
La maggior parte dei dispositivi tratta 1 come un valore logico vero e 0 come un valore logico falso. Un cuore che dice il falso e uno che dice il vero.
Va bene, andiamo avanti… Ok, ora sappiamo cos’è un bit. Che cos’è poi esattamente un byte? E quanti bit in un byte? Un byte è una raccolta di 8 bit. Ma perché 8 bit?
Storicamente, byte è stato utilizzato per rappresentare/codificare un singolo carattere di testo in un computer. Di conseguenza, le architetture dei computer hanno preso il byte come la più piccola unità di memoria indirizzabile nell’informatica.
Nei computer, l’unità di archiviazione più comune è un byte. I dispositivi di archiviazione come dischi rigidi, DVD, CD, chiavette USB hanno tutti capacità sotto forma di byte anziché di bit. È anche molto più facile gestire unità di livello superiore che denotare le cose in bit ogni volta.
Da qui sono arrivati kilobyte, megabyte, gigabyte ecc. La maggior parte dei linguaggi di programmazione utilizza i byte per memorizzare i tipi di dati primitivi. Ad esempio Java.
Ecco, due cuori a confronto. Il vostro cuore è di carta o digitale? Io non posso dimenticare quello di carta, ma è quello digitale che mi tiene in vita …[image error]
August 28, 2022
“Cambierebbe la Russia se Putin morisse?”
 The Spectator
Ma, secondo voi, se Putin morisse la Russia cambierebbe? L’autore di questo articolo e del libro qui recensito ritengono che non cambierebbe un bel nulla. Non si può fare a meno di pensare che se Vladimir Putin uscisse di scena domani qualcuno come lui prenderebbe il potere. “La tradizione di tutte le generazioni morte pesa come un incubo nel cervello dei vivi”, scrisse Karl Marx. E da nessuna parte quell’incubo è più spaventoso che in quello che una volta era il primo stato marxista del mondo. Se avete voglia di leggere e conoscete l’inglese questo articolo recensione di un libro sulla storia della Russia vi chiarirà le idee …
The Spectator
Ma, secondo voi, se Putin morisse la Russia cambierebbe? L’autore di questo articolo e del libro qui recensito ritengono che non cambierebbe un bel nulla. Non si può fare a meno di pensare che se Vladimir Putin uscisse di scena domani qualcuno come lui prenderebbe il potere. “La tradizione di tutte le generazioni morte pesa come un incubo nel cervello dei vivi”, scrisse Karl Marx. E da nessuna parte quell’incubo è più spaventoso che in quello che una volta era il primo stato marxista del mondo. Se avete voglia di leggere e conoscete l’inglese questo articolo recensione di un libro sulla storia della Russia vi chiarirà le idee …Suppose Vladimir Putin drops dead tomorrow — he has to drop dead one day, after all. Will a chastened Russian elite and public decide to abandon dreams of empire and vow never again to fall for the lure of the autocratic strongman?
Putin will leave a sick country that ought to be yearning for change. The myth that Russia is a military superpower, which did so much to intimidate its neighbours, lies broken amid the burned-out ammunition dumps. Putin’s unprovoked attack on Ukraine provoked Finland and Sweden to join Nato. His aggression has reinvigorated the West and pushed it into supplying Ukraine with advanced weaponry. Russia is poorer, weaker and looking to a future as a Chinese client state condemned to pay homage to the Middle Kingdom as it once paid homage to the Mongol empire.
Unverified Russian sources claim that Vladimir Putin himself is sick: suffering from either cancer or Parkinson’s disease. The CIA doesn’t believe them, and says the dictator is ‘entirely too healthy’.
But just suppose he’s gone by tomorrow. According to Orlando Figes’ The Story of Russia (out this week from Bloomsbury) the chances of the Ukraine disaster pushing Russia towards liberalism when Putin belatedly takes his leave of us vary from the faint to the non-existent. Despite its grim themes, I need to say before I go any further that this is a wonderfully generous book. Figes has distilled a lifetime of scholarship on Russian history to produce a sweeping account of the burden of its past.
As Stalin rewrote history in the 1930s, the Soviet joke went that ‘the past changes so often you don’t know what’s going to happen yesterday’. In the 21st century it is dispiritingly clear that the worst aspects of Russia’s past have not changed. Imperial nationalists can always revive them. They mythologise them for their own purposes, of course, and wrench them out of their context, but there is always enough in Russian political culture to justify violence, self-pity, exceptionalism, paranoia, autocracy and wars of imperial aggrandisement.
Take today’s oligarchs, who once seemed to be leaders in modern excess and vulgarity. For all their success in seducing western bankers and politicians in the 2010s, they were not powerful, independent figures, which is why western sanctions against them have not changed Russian policy. Their wealth was always dependent on Putin. Since he forced Boris Berezovsky into exile in 2000 and arrested Mikhail Khodorkovsky in 2003, Putin has delivered an old and blunt message. As long as the oligarchs’ interests remain subjugated to those of the regime, he would allow them to enjoy their fortunes. If they crossed him by supporting opposition politicians, or by refusing to pay the required bribes, he would destroy them.
Little has changed since the tsar told the boyars of Muscovy that their wealth and power depended on his whims. Early modern Russia never developed concepts of private property or of strong independent institutions that might have tamed autocracy, and their absence is felt to this day.
Figes makes the controversial argument for Russian nationalist historians that the domination of Moscow by the Mongol empire from the thirteenth to the fifteenth centuries did more than any other factor to ‘fix the basic nature of its politics’. First Moscow’s princes and then the Tsars emulated the Mongol khans and ‘demanded and mercilessly enforced complete submission to their will from all classes of society’.
In this reading of Russian history, Soviet communism was not a complete break with the past. The Communist strongman was different from the khan or the tsar only in the extent of his power, and Stalin knew it. He berated Sergei Eisenstein for showing Ivan the Terrible as haunted by the consequences of his violence. ‘This is not a film, it is some kind of nightmare,’ he complained in 1947. Eisenstein should have realised that the trouble with Ivan was not that he was cruel but that he was not cruel enough. A mistake Stalin never made.
‘When Ivan had someone executed, he would spend a long time in repentance and prayer. God was a hindrance to him in this respect. He should have been more ruthless.’
Putin’s rule has reinforced the view of Russia as an ‘Asiatic despotism’ that was so popular among nineteenth century liberals and socialists. (Alexander Herzen described Tsar Nicholas I as ‘Chingiz Khan with a telegraph’.) The toadying Patriarch Krill’s blessings of Putin’s war crimes in Ukraine and Syria follows a millennia of religious subservience to the state that the orthodox believed could make Moscow ‘the third Rome’ with the messianic right to dominate all orthodox peoples. Of the 800 saints the church created between the conversion of the Rus to Christianity at the end of the first millennium until the eighteenth century over 100 were princes or princesses. ‘No other country in the world has made so many saints from its rulers,’ Figes says. ‘Nowhere else has power been so sacralised.’ Maybe one day we will see the church venerate St Vladimir the patron saint of saturation bombers.
Putin’s 2021 essay ‘On the Historical Unity of Russians and Ukranians’ portrayal of Ukrainians as ‘little Russians’ was a prelude to the war. It showed where the combination of a bitter nostalgia for lost imperial grandeur and messianic fantasy lead. Little Ukrainian children have no right to escape Big Brother, and if they try they must be punished.
Although Russian liberals hate the denial of its European traditions for good reason, Russian imperialists have always seen the empire as a supranational civilisation defined by its opposition to the secular and liberal West. Apart from brief moments in its history, that view has always triumphed.
In the 1980s, I was lucky to be taught by Archie Brown, a specialist on the Soviet Union. One day he suggested to his students that, even if communism fell, Russia’s history meant that its peoples would accept a new form of dictatorship. We were young and idealistic and rebelled against the notion. Was it not determinist, almost racist, to suggest that Russians were programmed to reject freedom? The subsequent decades have not vindicated us,
Figes hates the idea too, while offering no plausible escape from it. You cannot help but think that if Vladimir Putin drops dead tomorrow someone like him will take power. ‘The tradition of all dead generations weighs like a nightmare on the brains of the living,’ wrote Karl Marx. And nowhere is that nightmare more lurid than in what was once the world’s first Marxist state.
Maybe one day we will see the church venerate St Vladimir the patron saint of saturation bombers
Originally published at https://www.spectator.co.uk .
[image error]August 24, 2022
“ A Thing of Beauty is a Joy for Ever”
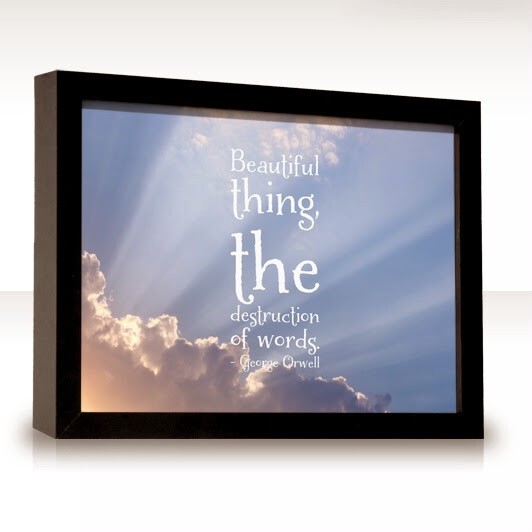 Foto@angallo
Foto@angalloIt is August 24, 1770. A seventeen-year-old boy lies lifeless in an attic in Brook Street, London. He took opium and arsenic and fell into an eternal sleep.
Three days earlier he was walking in the cemetery of Saint Pancras with a friend and, absorbed in his own thoughts, he did not notice an open tomb and fell into it: the friend, playing down the incident, said he was happy to witness the resurrection of a genius. The boy’s response was not in the same tone: “My dear friend, I’ve been fighting with the grave for some time now.”
The genius in question is the very young and talented poet Thomas Chatterton, known in those decades that preceded the full rise of Romanticism. He was one of the clearest examples of how a strong interest in the ancient poetic style was gradually growing.
He was in fact obsessed with the Middle Ages and the poetry of that time. He strove to write in an English that could resemble the language of the fifteenth century as closely as possible, composing verses that one could believe belonged to three centuries ago.
Born in Bristol in 1752, Chatterton always had a certain fascination with the ecclesiastical and ancient world. He grew up in the aisles of the church of Saint Mary Redcliffe, learning to read from an old musical folio. He was always disinterested in purely childish activities.
His sister in fact narrated how, when asked what he wanted painted on a bowl, he replied: “An angel with wings and a trumpet, so that he can make my name resound on the world.” He spent his childhood locked up in the archive of Saint Mary Redcliffe, imagining that he lived in the Middle Ages, at the time of Edward IV (mid-15th century).
His literary work revolved around the name of Thomas Rowley, a 15th-century monk he imagined: this was the pseudonym he adopted in composing his own poems. Not finding a patron in Bristol, he turned to Horace Walpole, the famous author of the gothic novel The Castle of Otranto, but when he discovered that the poet was sixteen, he chased him away.
In London he began to collaborate with some magazines, even if this activity did not allow him to live an economically serene condition. He wrote eclogues, lyrics, operas and satires, both in prose and in verse.
In Holborn (London) he shared his room with a companion who was able to notice how he spent the night writing non-stop. He composed a novel that he pretended to have transcribed from a parchment, Excelente Balade of Charitie, which was rejected by the publishers. He ended his days as already mentioned, between starvation and poverty, refusing the offers of food that were made to him by his neighbor.
A couple of days after Chatterton’s death, Dr. Thomas Fry was able to recompose (from some fragments found scattered on the floor of the room and collected by the owner in a box, with the hope that there might be a note written there before the suicide ) the piece from one of the poet’s last lyric compositions: an alternative ending of Aella, A Tragical Enterlude, the tragedy that tells of Aella’s battle against the Danes and the betrayal of her faithful knight Celmonda, who tries to abuse Birtha, wife of the protagonist.
Aella, having returned to the castle wounded after the battle, and discovering that his wife has run away with a “stranger” (Celmonda had thus presented himself taking advantage of Aella’s absence to kidnap Birtha), stabs himself, dying as soon as his wife — in meanwhile saved by the Danes — she crosses the threshold of the building. Birtha collapses on the body of her deceased husband.
This tragedy contains the song of a minstrel that seems to foretell the end of the couple. Here is a fragment:
“His hair is black like a winter night.
Her skin is white as snow in summer,
Vermilion like the morning light on her face,
Cold he lies down there in the grave:
My love is dead,
He went to his deathbed
Under the weeping willow “
Despite the sad end of the young poet, posterity has made his figure immortal: famous is the picture painted by the painter Henry Wallis, which portrays Chatterton in his deathbed. It was also an inspiration for romantic poets such as William Blake and John Keats, who was united to him by the untimely and tragic death of him and who dedicated Endymion to him in 1818.
“A thing of beauty is a joy forever”: this is how Endymion opens, to celebrate the beauty that never dies out.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
“Una cosa di bellezza è una gioia per sempre” Henry Wallis: “ the death of chatterton”
Henry Wallis: “ the death of chatterton”È il 24 agosto 1770. Un ragazzo di diciassette anni giace senza vita in una soffitta di Brook Street, a Londra. Prese oppio e arsenico e cadde in un sonno eterno.
Tre giorni prima stava passeggiando nel cimitero di Saint Pancras con un amico e, assorto nei propri pensieri, non si accorse di una tomba aperta e vi cadde dentro: l’amico, sdrammatizzando l’accaduto, si disse felice di assistere alla resurrezione di un genio. La risposta del ragazzo non è stata nello stesso tono: “Mio caro amico, è da tempo che combatto con la tomba”.
Il genio in questione è il giovanissimo e talentuoso poeta Thomas Chatterton, conosciuto in quei decenni che hanno preceduto la piena ascesa del Romanticismo. Fu uno degli esempi più chiari di come un forte interesse per lo stile poetico antico andasse via via crescendo.
Era infatti ossessionato dal Medioevo e dalla poesia dell’epoca. Si sforzò di scrivere in un inglese che potesse assomigliare il più possibile alla lingua del XV secolo, componendo versi che si poteva credere appartenessero a tre secoli fa.
Nato a Bristol nel 1752, Chatterton ha sempre avuto un certo fascino per il mondo ecclesiastico e antico. È cresciuto tra le navate laterali della chiesa di Saint Mary Redcliffe, imparando a leggere da un vecchio foglio musicale. Era sempre disinteressato alle attività puramente infantili.
La sorella infatti raccontò come, alla domanda su cosa volesse dipinto su una coppa, rispose: “Un angelo con le ali e una tromba, perché possa far risuonare il mio nome nel mondo”. Trascorse la sua infanzia rinchiuso nell’archivio di Santa Maria Redcliffe, immaginando di vivere nel Medioevo, al tempo di Edoardo IV (metà del XV secolo).
La sua opera letteraria ruotava attorno al nome di Thomas Rowley, un monaco del XV secolo che aveva immaginato: questo era lo pseudonimo che adottò per comporre le proprie poesie. Non trovando un mecenate a Bristol, si rivolse a Horace Walpole, il famoso autore del romanzo gotico Il castello di Otranto, ma quando scoprì che il poeta aveva sedici anni, lo cacciò.
A Londra iniziò a collaborare con alcune riviste, anche se questa attività non gli permetteva di vivere una condizione economicamente serena. Ha scritto egloghe, testi, opere e satire, sia in prosa che in versi.
A Holborn (Londra) ha condiviso la sua stanza con un compagno che ha potuto notare come ha passato la notte a scrivere senza sosta. Compose un romanzo che finse di aver trascritto da una pergamena, Excelente Balade of Charitie, che fu rifiutato dagli editori. Finì i suoi giorni come già accennato, tra fame e povertà, rifiutando le offerte di cibo che gli erano state fatte dal suo vicino.
Un paio di giorni dopo la morte di Chatterton, il dottor Thomas Fry riuscì a ricomporsi (da alcuni frammenti trovati sparsi sul pavimento della stanza e raccolti dal proprietario in una scatola, con la speranza che ci fosse un biglietto scritto lì prima del suicidio) il brano tratto da una delle ultime composizioni liriche del poeta: un finale alternativo di Aella, A Tragical Enterlude, la tragedia che racconta la battaglia di Aella contro i danesi e il tradimento del suo fedele cavaliere Cemonda, che cerca di abusare di Birtha, moglie di il protagonista.
Aella, tornato al castello ferito dopo la battaglia, e scoprendo che la moglie è scappata con uno “straniero” (Celmonda si era così presentato approfittando dell’assenza di Aella per rapire Birtha), si accoltella, morendo non appena la moglie — nel frattempo salvata dai danesi — valica la soglia del palazzo. Birtha crolla sul corpo del marito defunto.
Questa tragedia contiene il canto di un menestrello che sembra preannunciare la fine della coppia. Ecco un frammento:
“I suoi capelli sono neri come una notte d’inverno.
La sua pelle è bianca come la neve d’estate,
Vermiglio come la luce del mattino sul suo viso,
Freddo si sdraia laggiù nella tomba:
Il mio amore è morto,
Andò sul letto di morte
Sotto il salice piangente”
Nonostante la triste fine del giovane poeta, i posteri hanno reso immortale la sua figura: famoso è il quadro dipinto dal pittore Henry Wallis, che ritrae Chatterton in punto di morte. Fu anche fonte di ispirazione per poeti romantici come William Blake e John Keats, che fu unito a lui dalla sua morte prematura e tragica e che gli dedicò Endymion nel 1818.
“Una cosa di bellezza è una gioia per sempre”: così si apre Endymion, per celebrare la bellezza che non si estingue mai.
[image error]August 22, 2022
Così muore un poeta …
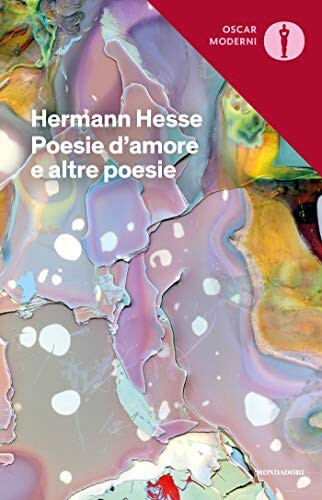
“La sera dell’8 agosto 1962 lesse alla moglie, Ninon, la terza stesura di una poesia, l’ultima, la più rassegnata, “Scricchiolìo di un ramo spezzato”:
“Ramo spezzato e scheggiato, / che ormai pende anno dopo anno / e asciutto scricchiola al vento il suo canto, / senza più fogliame nè scorza, / spelato, scialbo, di lunga vita / di lunga morte stanco. Secco risuona e tenace il suo canto, / caparbio risuona e in segreto angoscioso / ancora per tutta un’estate, per tutto un inverno ancora”.
Era una poesia legata ad un’esperienza tipicamente hessiana: in una passeggiata al mattino con Ninon il poeta riconosce un ramo di una robinia, spezzato, ma ancora in vita. La giornata gli riserva la visita della traduttrice francese con cui Hesse, più che ottantenne, si intrattiene in un vivace colloquio con Sartre, Camus, Beckett. A sera il poeta posa nella camera della moglie la nuova stesura della lirica. Alla donna piace; lui ne è soddisfatto, come ricorda Ninon: “Dissi o balbettai: “E’ una delle tue poesie più belle!”. Ascoltano ancora alla radio la “Sonata n.7 in Do Maggiore K 309” di Mozart, il suo autore preferito. Infine si ritira nella sua camera (dormivano separati). Al mattino, allarmata perchè Hermann non compare, Ninon entra nella stanza. Hesse è morto. Così muore un poeta.”
(Marino Freschi: “Sessant’anni senza Hesse …”)[image error]
MEDIUM
- Antonio Gallo's profile
- 52 followers



