Antonio Gallo's Blog: MEDIUM, page 23
October 5, 2024
In guerra non c’è il pareggio …
 Zafferano News
Zafferano News
Il concetto che “in guerra non c’è il pareggio” è una riflessione profonda sulle dinamiche dei conflitti armati, evidenziando l’assenza di una vera equità e giustizia in tali situazioni.
Questo pensiero invita a considerare la guerra non solo come un confronto tra forze militari, ma come un contesto in cui le vite umane e i principi morali vengono spesso sacrificati.
1. L’Illusione del Pareggio
La guerra è intrinsecamente asimmetrica; non esiste un “pareggio” nel senso tradizionale. Ogni conflitto porta con sé perdite umane e devastazione, e le conseguenze si ripercuotono su intere popolazioni. Come sottolinea un’analisi recente, le guerre tendono a essere caratterizzate da una ricerca di vittoria a tutti i costi, dove il concetto di “pareggio” è più una costruzione retorica che una realtà.
2. La Necessità di Umanità
In questo contesto, la richiesta di umanità e buon senso diventa cruciale. Le guerre spesso si alimentano di odio e vendetta, ma l’umanità può fungere da contrappeso. La capacità di riconoscere la sofferenza altrui e di cercare soluzioni pacifiche è fondamentale per prevenire l’escalation dei conflitti. L’umanità non è solo un valore morale, ma anche una strategia pragmatica per ridurre i danni collaterali e promuovere la pace.
3. Il Ruolo della Diplomazia
La diplomazia deve essere vista come un’alternativa alla guerra. L’idea che la forza sia l’unico mezzo per risolvere i conflitti è una visione limitata. La storia insegna che i conflitti possono essere risolti attraverso il dialogo e il compromesso, anche se ciò richiede tempo e pazienza2. La pace non deve essere vista come un semplice cessate il fuoco, ma come un processo continuo che richiede impegno e cooperazione.
La guerra, con tutte le sue complessità e sfide, non dovrebbe mai essere considerata una soluzione definitiva ai problemi umani.
Invece, la ricerca di umanità e buon senso deve guidare le azioni dei leader e delle nazioni nel tentativo di costruire un futuro migliore, dove il dialogo prevalga sulla violenza.
La vera vittoria risiede nella capacità di prevenire la guerra stessa, piuttosto che nel trionfo su un avversario.
— —
In guerra non c’è il pareggio, sarebbero gradite umanità e buon senso
“Dobbiamo vincere perché non abbiamo altra scelta” è la frase che Benjamin Netanyahu usa da dopo il 7 Ottobre 2023. Questo mantra negli ultimi duemila anni è stato ripetuto da un’infinità di leader. A proposito di frasi mantra, recentemente ho apprezzato la risposta che il generale israeliano Herzl Halevi, capo staff dell’esercito, ha dato ai diplomatici americani che protestavano per le troppe vittime civili a Gaza: “Tutto quello che facciamo lo abbiamo appreso nelle vostre accademie militari”.
Lo stesso Halevi ricorda quando, giovane allievo in una prestigiosissima accademia militare americana, aveva chiesto al generale-docente: “Quante vittime civili ritenete giustificate nella caccia al nuovo capo di Al Queda, Al Zarqawi?” Fu liquidato con un secco: “Non capisco la domanda”. Per carità di patria, immagino abbia evitato di citare, a fronte dei 2.408 americani massacrati a Pearl Harbour dai giapponesi, quanti milioni di giapponesi furono uccisi, atomiche di Hiroshima e Nagasaki comprese.
Molto meno diretta, più elegante, ma altrettanto chiara la proposta del “Piano della Vittoria” di Volodymiyr Zelens’kyj che già nel titolo contiene sia l’obiettivo sia la decisione. Stante che l’Ucraina è stata invasa dai russi, questo non poteva essere un piano di pace, infatti lo chiama “Piano della Vittoria” (in guerra si vince o si perde, non c’è il pareggio). Però uno Stato senza le atomiche non può vincere contro uno dallo sterminato arsenale atomico, quindi deve cercare di coinvolgere nella guerra alleati (disponibili a farlo) che però siano anche potenze atomiche. Per l’Europa, in questo senso, contano solo Francia e UK. É il disegno che giustamente persegue Zelens’kyj. America, UK, Francia, accetteranno questa logica?
Mi pare invece che presso l’opinione pubblica italiana ci sia scarsa consapevolezza della potenziale gravità della situazione, oggi parlare, sia pure in termini teorici e prospettici, di guerra atomica è ancora considerata una boutade, e lo è nei due luoghi estremi della nostra società civile, i salotti delle ZTL e i tinelli delle case popolari di periferia. Non essendo l’Italia una potenza atomica, non essendoci il pericolo dell’art. 5 perché l’Ucraina non fa parte della Nato, protetti come siamo dall’art. 11 della Costituzione, dalla presenza del Vaticano e dalla ferma posizione di Papa Bergoglio, ci sentiamo semplicemente fuori dai giochi, quindi dal pericolo atomico.
Come vecchio “scenarista di business” mi piacerebbe conoscere i diversi “Scenari del Pentagono” e relativa strategia nel caso in cui, messo con le spalle al muro, Vladimir Putin non avesse altra alternativa che suicidarsi nel bunker oppure mettere il dito sul pulsante rosso. Un aspetto di cui non mi risulta si sia mai parlato, pur essendo certo che il Pentagono e la CIA abbiano sviscerato chissà quanti Piano B della Russia. Provo a ipotizzarne uno: sparigliare le carte, spostando il problema altrove, come si fa spesso nel business. Per esempio, spostare la guerra nel quadrante mediorientale. Ripeto, piuttosto di suicidarsi nel bunker o premere il pulsante rosso, Putin potrebbe informare l’America della sua decisione di fornire un pacchetto di atomiche all’Ayatollah Ali Khamenei, of course per la sua difesa antisionista.
Comunque vada, che tristezza! Siamo all’inizio del terzo millennio, quattrocento anni dopo la speranzosa Pace di Westfalia, e oltre otto miliardi di persone, a est come a ovest, al sud come al nord, sono governati da élite speculari nelle loro miserabili incapacità di farli uscire dallo schema perverso e ignobile della guerra, che ormai è dimostrato: nulla risolve ma tutto distrugge.
[image error]
Originally published at https://zafferano.news .
October 4, 2024
Il mondo come cloaca …
 LIBERO 05/10/2024
LIBERO 05/10/2024Stamani il mio calendario riporta questo pensiero mattutino: “La vita è un lungo cammino dove sei maestro e allievo. A volte insegni, ma ogni giorno impari.” Poi accendi il pc, sfogli i giornali e scopri che il mondo, cioè la vita, è una cloaca … La giornata è lunga e questo post è soggetto a cambiare, datemi tempo per riflettere, cercherò di essere nè un maestro nè un allievo. Sarò soltanto un essere umano in balìa della vita …[image error]
October 3, 2024
La “follia” del “giullare di Dio”
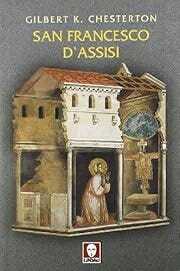 Il Libro
Il Libro
“Giullare di Dio Francesco, «giullare di Dio», è rimasto nella memoria popolare per i gesti con i quali ha costruito la sua leggenda, fissati da Giotto nei mirabili affreschi della basilica di Assisi o narrati nella semplice prosa dei Fioretti: Francesco che si denuda sulla piazza di Assisi davanti al padre e al vescovo, Francesco che ammansisce il lupo di Gubbio, Francesco che predica agli uccelli, Francesco che dona il mantello a un povero, Francesco che abbraccia il lebbroso, Francesco che predica il Vangelo davanti al sultano d’Egitto, Francesco e il presepe vivente di Greccio, Francesco che riceve le stigmate, Francesco che sposa Madonna Povertà…
Questo è il santo che la devozione popolare ci ha consegnato e che mantiene ancor oggi intatto il suo fascino. Un frate che mette in pratica il Vangelo. I suoi precetti sono semplici: ripercorrere la vita di Cristo e degli apostoli, spogliarsi di ogni bene e ricchezza per amare e capire la sofferenza degli ultimi, degli emarginati, dei reietti, dei perdenti. La conversione di Francesco avvenne verso i 24 anni, dopo una giovinezza spensierata, quando sceglie di vivere da «semplice», da «pazzo».
La Regola dell’Ordine da lui fondato è chiara: seguire le orme di Gesù, «spogliarsi di tutto, andare raminghi a predicare la conversione in vista del Regno di Dio, chiedere sostentamento al lavoro, anche il più umile, e in mancanza di questo, all’elemosina. Ma né come compenso al lavoro né per elemosina i fratelli devono accettare denaro. Dovunque si trovino si devono considerare sempre come ospitati, pellegrini e stranieri, mai padroni, e devono essere pronti a cedere il loro giaciglio a chi lo richiede.
Devono accogliere tutti, anche i nemici, i ladri e i masnadieri e se qualcuno li colpisce gli porgano anche l’altra guancia, e se qualcuno strappa loro la veste, gli consegnino anche la tunica». Una esistenza, la sua e dei suoi seguaci, che comporta scelte radicali, tuttavia Francesco non è uno di quei predicatori arcigni dai toni apocalittici, che parlano di peccato e penitenza evocando le pene infernali, la sua vita di povertà l’ha vissuta in armonia con tutte le creature in serenità di spirito, il suo è un messaggio di gioia e di perfetta letizia.
Oggi per la prima volta nella storia della Chiesa, abbiamo un papa, il cardinale Jorge Mario Bergoglio, che ha scelto come nome pontificale Francesco. Ci auguriamo sia capace di scatenare la stessa «febbre d’amore» che animò quel piccolo grande frate che predicava agli uccelli.” (Almamatto)
Francesco d’Assisi è sicuramente uno dei “matti” più celebrati nel libro “Almamatto. Un matto al giorno. 265 tipi strani che hanno cambiato il mondo”. La sua vita e la sua figura rappresentano un esempio emblematico di come l’eccentricità e la devozione possano avere un impatto profondo e duraturo sulla società.
Un eccentrico con una missione. Francesco, nato Giovanni di Pietro di Bernardone, ha vissuto una trasformazione radicale da giovane ricco a santo povero. La sua decisione di abbandonare i beni materiali per dedicarsi ai poveri e alla predicazione del Vangelo è un atto di ribellione contro le convenzioni sociali del suo tempo. Questo gesto, considerato folle da molti, ha ispirato generazioni di seguaci e ha dato vita all’Ordine dei Francescani.
La sua figura è diventata simbolo di umiltà, amore per la natura e compassione verso gli altri. La famosa frase “Tu vieni trasformato in ciò che ami” riassume il suo ideale di vita, dove l’amore per Cristo e per le creature è al centro della sua esistenza. Francesco ha anche composto il “Cantico delle Creature”, un inno alla bellezza del creato, che continua a essere celebrato nel mondo intero.
La canonizzazione di Francesco avvenne solo due anni dopo la sua morte nel 1226, a testimonianza della sua influenza immediata e duratura. Oggi, è considerato il santo patrono degli animali e dell’ambiente, e il suo messaggio di pace e rispetto per tutte le forme di vita risuona ancora fortemente nella società contemporanea.
Francesco d’Assisi incarna perfettamente l’idea che la “follia” possa portare a cambiamenti significativi nel mondo. La sua vita dimostra che gli individui che si discostano dalla norma possono avere un impatto profondo sulla cultura e sulla spiritualità collettiva.
[image error]October 2, 2024
Tempo d’autunno, tempo di transizione
 L’autunno dalla mia finestra
L’autunno dalla mia finestraDa qualche giorno è cominciato l’autunno, la stagione di transizione per eccellenza. Tutta la vita potrebbe essere considerata un “transito”, un passaggio nella realtà della vita. Un viaggio che inizia da qualche parte lontano e finisce in un altrove che tutti andremo a conoscere.
Season of mists and mellow fruitfulness,
Close bosom-friend of the maturing sun;
Conspiring with him how to load and bless
With fruit the vines that round the thatch-eaves run;
To bend with apples the moss’d cottage-trees,
And fill all fruit with ripeness to the core;
To swell the gourd, and plump the hazel shells
With a sweet kernel; to set budding more,
And still more, later flowers for the bees,
Until they think warm days will never cease;
For Summer has o’erbrimm’d their clammy cells.
Stagione di nebbie e di molle fecondità,
amica fidata del cuore e del maturante sole;
che cospiri con lui per caricare e benedire
di frutti le viti che intorno alle grondaie corrono;
per piegare sotto le mele i muscosi alberi della capanna,
e colmare tutti i frutti di maturità fino al torso,
per gonfiare la zucca, e arrotondare i gusci delle nocciuole
con un dolce nòcciolo; per dare vita ad altri
e ancora altri, più tardivi fiori per le api,
finché esse possano pensare che i giorni tiepidi non finiranno mai,
perché l Estate ha colmate fino all’orlo le loro ricche celle
Who hath not seen thee oft amid thy store?
Sometimes whoever seeks abroad may find
Thee sitting careless on a granary floor,
Thy hair soft-lifted by the winnowing wind;
Or on a half-reap’d furrow sound asleep,
Drowsed with the fume of poppies, while thy hook
Spares the next swath and all its twinèd flowers:
And sometimes like a gleaner thou dost keep
Steady thy laden head across a brook;
Or by a cyder-press, with patient look,
Thou watchest the last oozings, hours by hours.
Chi non t’ ha veduto spesso fra la tua abbondanza?
Talvolta chiunque va fuori in cerca può trovar
te a sedere senza pensieri su d’ un’ aia,
i tuoi capelli mollemente sollevati dal soffio del vento;
o su un solco mietuto, mezzo addormentato,
assopito dai fumi dei papaveri, mentre il tuo falcetto
risparmia il prossimo mannello, e tutti i suoi fiori intrecciati
e talvolta come uno spigolatore tu tieni
fermo il tuo capo carico attraversando un ruscello;
o presso un torchio da sidro, con sguardo paziente,
tu osservi gli ultimi trasudamenti per ore ed ore.
Where are the songs of Spring? Ay, where are they?
Think not of them, thou hast thy music too, —
While barrèd clouds bloom the soft-dying day
And touch the stubble-plains with rosy hue;
Then in a wailful choir the small gnats mourn
Among the river-sallows, borne aloft
Or sinking as the light wind lives or dies;
And full-grown lambs loud bleat from hilly bourn;
Hedge-crickets sing; and now with treble soft
The redbreast whistles from a garden-croft;
And gathering swallows twitter in the skies.
Dove sono i canti della Primavera? Sì, dove sono?
Non pensare ad essi; tu possiedi la tua musica,
mentre nuvole a banchi fioriscono il giorno che lento muore,
e fanno i piani di stoppie di una rosea tinta;
allora in lamentoso coro i moscerini gemono
tra i salici del fiume, portati in alto
o affondano, come il lieve vento vive o muore;
e adulti agnelli belano a lungo di là della collina;
siepi di grilli cantano; ed ora con soave tenore
il pettirosso camta dal recinto d’un giardino;
e le rondini si raccolgono trillando nei cieli.
Il poeta inglese John Keats, morto a Roma a soli 26 anni, ha scritto una famosa poesia dedicata a questa stagione. Tre stanze formate da undici versi in rima, di cui la prima in forma ABABCDEDCCE, la seconda e la terza ABABCDECDDE. La poesia, come tutte le poesie, va letta ed apprezzata nella lingua originale.
Ogni traduzione, anche se eccellente, è una trascrizione e tradisce il testo orginale. Il ritmo, la musicalità, le forme, le risonanze, le immagini vengono alterate. Restano solo le parole, le quali da sole, non potranno mai essere poesia.
Nella prima stanza Keats descrive in forma quasi drammatica l’autunno e ciò che accade durante quel periodo dell’anno. L’autunno è visto “cospirare” con il sole per far sì che l’uva e gli altri frutti vengano a maturazione. Tutta la natura in tal modo si trasforma e preannuncia il grande cambiamento.
Nella seconda stanza l’osservazione del poeta si sposta direttamente sulla stagione. Parla dell’autunno come se fosse una persona seduta ad aspettare, mentre il vento le fa scompigliare i capelli. Più che una figura maschile, qui è l’immagine di una donna ricurva su se stessa, presa nei suoi segreti pensieri.
La portano come a sognare mentre inala, portati dal vento, i profumi dei papaveri, quasi come la droga dei ricordi e dei pensieri futuri. Questa figura di autunno la si trova dappertutto, lungo un ruscello, presso un cedro, accanto ad un albero di mele.
Nella terza stanza il poeta cambia ancora una volta il suo punto di osservazione. Continua a rivolgersi all’autunno mettendo la sua figura a confronto con quella della primavera. Le chiede, quasi come e provocarla, dove sono le canzoni della primavera. Glielo chiede invano, ripetutamente.
Ma poi le dice di lasciar perdere perchè l’autunno ha anche la sua musica, senza dubbio diversa, ma è la sua musica. Le offre allora una serie di suoni in uno scenario naturale fatto di nuvole e di colori indefiniti che riportano a cori variegati di animali di cielo e di terra.
Qui la poesia improvvisamente si conclude lasciando lo smarrito lettore alle immagini che i versi del poeta hanno hanno generato nella sua durante la lettura dei versi. Sembra quasi come una sospensione voluta, come per far nascere presenze e far risuonare melodie e lamenti che non possono essere messi in versi. Una poesia molto amata, ma anche molto discussa dalla critica.
Il grande critico Harold Bloom pensa ddirittura che sia una delle poesie più perfette mai scritte nella lingua inglese. Un altro critico e poeta, Allen Tate, afferma che la poesia dice ben poco. Io penso che la composizione debba essere valutata, come spesso accade con i poeti, nel complesso della produzione poetica di Keats.
Manca questa volta la spinta poetica e sognatrice che il poeta manifesta in altre occasioni. Non sfugge alla realtà e resta legato alla concretezza della scena, coinvolto com’è tra suoni, sensazioni e colori. Va messo in evidenza la sua costante tendenza a voler cogliere il processo di cambiamento e trasformazione che accade in questo passaggio del tempo.
Questa è la sua spiccata caratteristica, la sua qualità poetica migliore, quella sensualità materiale che si consuma e che fatalmente porta alla fine. Alla morte naturale delle cose e degli uomini. Al poeta interessa non tanto la figura, la presenza e il passaggio dell’autunno, quanto lo scorrere inesorabile del tempo.
A mio parere, nessun’altra stagione descrive meglio di quanto riesca a fare l’autunno il trascorrere del tempo. In effetti mi sento di dire che Keats non ha voluto tanto scrivere una poesia sull’autunno, quanto sul tempo e sul suo scorrere fatale ed inarrestabile.
[image error]October 1, 2024
Questo è il “mio punto di vista”: un monumento …
 “Punto di vista” è una scultura pubblica in bronzo di James A. West; si trova in un parco che prende il nome dall’opera d’arte, Point of View Park, a Pittsburgh, Pennsylvania. L’opera raffigura George Washington e il capo indiano Seneca Guyasuta, con le armi abbassate, in un incontro faccia a faccia nell’ottobre del 1770, quando i due uomini si incontrarono mentre Washington si trovava nella zona per esaminare i terreni per un futuro insediamento lungo il fiume Ohio.
“Punto di vista” è una scultura pubblica in bronzo di James A. West; si trova in un parco che prende il nome dall’opera d’arte, Point of View Park, a Pittsburgh, Pennsylvania. L’opera raffigura George Washington e il capo indiano Seneca Guyasuta, con le armi abbassate, in un incontro faccia a faccia nell’ottobre del 1770, quando i due uomini si incontrarono mentre Washington si trovava nella zona per esaminare i terreni per un futuro insediamento lungo il fiume Ohio.Cos’è un punto di vista? Il termine si riferisce alla posizione o alla prospettiva da cui viene osservata o interpretata una situazione, un evento o un’opera. In vari contesti, il punto di vista può assumere significati diversi. Va detto, innanzitutto, che questa è una vera e propria “espressione ombrello” composta da due parole, le quali a loro volta fanno da “ombrello” nel senso che possono avere un’ampia latitudine di significati.
Nel contesto della letteratura e della narrazione, il punto di vista è il modo in cui una storia viene raccontata, influenzando la percezione del lettore riguardo ai personaggi e agli eventi. I principali punti di vista narrativi includono la prima persona se è raccontata da un narratore che è anche un personaggio (es. “Io penso…”). In terza persona limitata se un narratore esterno racconta la storia focalizzandosi su un solo personaggio (es. “Lui/lei pensava…”). Ci può anche essere una terza persona onnisciente se un narratore esterno conosce i pensieri e i sentimenti di tutti i personaggi (es. “Sapeva che…”). Non manca una seconda persona se il narratore si rivolge direttamente al lettore (es. “Tu fai…”).
In filosofia e psicologia il punto di vista può anche riferirsi a una posizione filosofica o psicologica riguardo a un argomento specifico. Ogni individuo ha il proprio punto di vista influenzato da esperienze personali, cultura, educazione e valori.
Nella comunicazione, il punto di vista si riferisce all’atteggiamento o alla posizione assunta in una discussione o in un dibattito. È importante riconoscere e rispettare i diversi punti di vista per favorire un dialogo costruttivo.
Comprendere il punto di vista è fondamentale per analizzare testi letterari in quanto aiuta a interpretare le intenzioni dell’autore e le emozioni dei personaggi. Promuove empatia, fa conoscere diversi punti di vista, permette di comprendere meglio le esperienze altrui e stimola il pensiero critico. Confrontando diverse prospettive, incoraggia l’analisi e la riflessione. Il punto di vista è una lente attraverso cui osserviamo e interpretiamo il mondo, sia nella narrativa che nella vita quotidiana.
Il termine “vista” deriva dal latino vĭsĭta, participio passato femminile di videre, che significa “vedere”. La radice latina videre è collegata anche al greco antico, dove esiste un verbo simile che implica la conoscenza attraverso la visione. In italiano, “vista” si riferisce sia alla facoltà di vedere che all’atto stesso del vedere, oltre a indicare ciò che si osserva.
La parola “punto” deriva dal latino pŭnctum, participio passato di pŭngĕre, che significa “pungere” o “colpire”. Questo etimo riflette l’idea di un segno o di un’unità ben definita, come un piccolo segno lasciato da un oggetto appuntito. In italiano, “punto” ha molteplici significati, spaziando da un’entità geometrica priva di dimensioni a un segno di punteggiatura, fino a esprimere concetti più astratti come un momento cruciale o un argomento specifico in una discussione
[image error]September 29, 2024
Due neologismi: “nostalgoritmo” e “foreverismo”
 Il Libro
Il LibroGrafton Tanner è un giovane autore e accademico americano. Il suo lavoro si concentra su Big Tech, nostalgia, neoliberismo e istruzione. Tanner è un insegnante all’Università della Georgia.
Ha coniato i due neologismi nostalgoritmo e foreverismo. Il primo si riferisce a come la nostalgia viene manipolata attraverso algoritmi, mentre il foreverismo rappresenta un discorso anti-nostalgico che promuove una crescita senza cambiamento e una vita senza perdita.
Tanner esplora come la cultura contemporanea cerca di “eternizzare” eventi e oggetti per evitare il dolore della perdita, affrontando temi come l’archiviazione digitale e la cultura del reboot.
La parola “nostalgoritmo” è un neologismo che combina “nostalgia” e “algoritmo”. L’etimo di “nostalgia” proviene dal greco nostos (ritorno) e algos (dolore), indicando un dolore per la lontananza da casa.
L’uso del termine suggerisce un algoritmo che evoca o gestisce sentimenti nostalgici, probabilmente in contesti digitali o tecnologici, anche se non è ampiamente documentato in fonti etimologiche tradizionali.
Il termine “foreverismo” deriva dall’inglese “forever,” che significa “per sempre,” combinato con il suffisso “-ismo,” usato per formare nomi che indicano una dottrina o un movimento.
Il concetto di “foreverismo” potrebbe riferirsi a ideologie o pratiche che enfatizzano l’idea di eternità o permanenza, ma non ha una definizione standardizzata nelle fonti etimologiche. L’uso di “-ismo” implica una certa filosofia o approccio verso l’idea di eternità, sebbene non sia un termine comunemente riconosciuto.
Sia “nostalgoritmo” che “foreverismo” sono termini moderni che riflettono l’intersezione tra linguaggio, tecnologia e sentimenti umani, ma non hanno una radice etimologica consolidata nelle lingue classiche.
La politica della nostalgia, esplorata nel concetto di nostalgoritmo, si riferisce all’uso strategico della nostalgia da parte di politici e media per influenzare l’opinione pubblica e mobilitare le masse.
Questi fenomeni sono stati analizzati da Grafton in due suoi libri pubblicati anche in Italia dove si discute come la nostalgia possa essere deliberatamente diffusa tra gruppi eterogenei, creando una connessione emotiva che può essere sfruttata per scopi politici.
 Il Libro
Il LibroIl foreverismo, come descritto da Grafton Tanner, si relaziona in modo significativo alla nostalgia e al cambiamento, affrontando le sfide del presente e le tensioni legate alla memoria. Si propone un modo di “persemprificare” esperienze e oggetti, cercando di rianimare ciò che è stato degradato o perso.
Tanner sottolinea che questo approccio mira a eliminare la nostalgia associata alla perdita, cercando di mantenere attive nel presente le esperienze passate.
La nostalgia, in questo contesto, è vista come un sentimento che può portare a una sorta di impotenza rispetto al cambiamento, poiché si rifugia in un ideale di un passato migliore. E’ spesso descritta come una negazione del presente doloroso, un desiderio di tornare a periodi percepiti come migliori.
Questo sentimento può diventare un ostacolo all’azione e alla crescita personale, portando a una ricerca di stabilità che il foreverismo cerca di contrastare. Tanner suggerisce che la società contemporanea desideri una crescita senza cambiamento, una vita senza perdita, il che implica una certa avversione alla nostalgia stessa.
D’altra parte, la nostalgia non è intrinsecamente negativa; può fungere da strumento per rafforzare l’identità personale e sociale. Essa crea legami tra passato, presente e futuro, fornendo un senso di continuità e coesione. In momenti di cambiamento o transizione, la nostalgia può offrire conforto e resilienza, aiutando gli individui a navigare le sfide del presente.
Tanner invita a riflettere sulle conseguenze ecologiche e sociali dell’archiviazione dei dati e della cultura dei reboot, suggerendo che il desiderio di mantenere tutto attivo nel presente possa portare a una distorsione della realtà.
La nostalgia, quindi, diventa un tema centrale nella discussione su come affrontiamo il cambiamento: sebbene possa essere un rifugio emotivo, può anche impedire l’adattamento e la crescita.
Il foreverismo si confronta con la nostalgia in modi complessi. Mentre cerca di proteggere le esperienze dal deterioramento temporale, riconosce anche il potere della nostalgia come strumento di connessione e resilienza. Tuttavia, la sfida rimane: come onorare il passato senza lasciarci imprigionare da esso, per costruire il futuro.
September 28, 2024
La “saggezza e la ruota del tempo” di Tommaso Gaudiosi

Questo poeta meridionale nacque a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, ed ebbe una certa fama nell’elitario ambiente letterario napoletano per avere scritto una tragedia dal tema molto ambizioso: “La Sofia ovvero l’Innocenza ferita”. Tommaso Gaudiosi fu un poeta essenzialmente lirico, dalla ricca produzione. Nel 1671 apparve una edizione di tutte le sue poesie divisa in sette parti e intitolata “L’Arpa poetica”.
La poesia di Tommaso Gaudiosi ruota attorno al contrasto tra l’aspirazione umana alla conoscenza e il passare inesorabile del tempo. L’autore, attraverso l’immagine di un uomo che si dedica allo studio con passione e dedizione, ci presenta una riflessione profonda sulla natura della saggezza e sulla sua fragilità di fronte alla finitezza dell’esistenza.
Il poeta ci descrive un uomo che, spinto da un’insaziabile sete di sapere, si dedica allo studio assiduo di testi classici e contemporanei. La sua figura è quella del tipico intellettuale rinascimentale, che cerca nella cultura la chiave per comprendere il mondo e se stesso. Tuttavia, nonostante i suoi sforzi, il protagonista si rende conto dell’inutilità della sua ricerca di fronte alla forza inarrestabile del tempo.
L’immagine della “ruota irrevocabile degli anni” è una metafora potente che sottolinea la caducità della vita umana. Il tempo, come una ruota che gira inesorabilmente, porta con sé il cambiamento e l’inevitabile declino. Nonostante l’uomo possa accumulare conoscenza e saggezza, la morte rappresenta un limite invalicabile.
Il poeta esprime un profondo senso di delusione di fronte alla vanità dei suoi sforzi. La natura, con la sua “infedeltà”, sembra prendersi gioco delle aspirazioni umane. Tuttavia, nel finale della poesia, si avverte una nota di rassegnazione e accettazione. Il protagonista, consapevole della sua condizione di mortale, si arrende all’ineluttabilità del destino.
Lo stile di Gaudiosi è caratterizzato da un’eleganza formale e da una ricchezza di immagini. Il linguaggio, ricercato e aulico, è tipico della poesia barocca. Le figure retoriche, come le metafore e le antitesi, contribuiscono a rendere la poesia più suggestiva ed efficace.
La poesia può essere letta come una riflessione sulla vanità della conoscenza umana, che non può arrestare il corso del tempo e non può garantire la felicità. Si propone come una meditazione sulla condizione umana, caratterizzata dalla fragilità e dalla finitezza. Il contrasto tra la saggezza, intesa come qualcosa di eterno e immutabile, e il tempo, che tutto consuma, è un tema ricorrente nella letteratura di ogni epoca.
Il Marinismo è una corrente letteraria barocca, caratterizzata da un linguaggio particolarmente ricercato, ricco di metafore, similitudini e altre figure retoriche. I poeti marinisti, tra cui Gaudiosi, erano affascinati dalla bellezza formale e sonora delle parole, e spesso utilizzavano un lessico aulico e raffinato.
Perché definire Gaudiosi un poeta marinista? Come molti altri marinisti, Gaudiosi era particolarmente attento alla forma del verso e alla musicalità del linguaggio. Uso abbondante di figure retoriche. La sua poesia è ricca di metafore, similitudini, antitesi e altri artifici retorici che servono a rendere i versi più suggestivi e raffinati. Temi ricorrenti furono la vanità delle cose terrene, il passare del tempo e la condizione umana sono temi molto cari ai poeti marinisti, e ritroviamo questi stessi temi anche nell’opera di Gaudiosi. La poesia “La saggezza e la ruota del tempo” è un ottimo esempio di Marinismo:
Sotto rigida sferza, or nell’algente
rigor del verno or nell’arsure estive,
su le carte latine e su l’argive
s’affanna un uom per coltivar la mente.
E dal sol che tramonta al sol nascente,
or filosofa e legge, or detta e scrive;
abbandona talor le patrie rive
per veder nove cose e nova gente.
Ma, fatto saggio, ove di coglier spera
il frutto alfin de’ suoi sudati affanni,
vede del giorno suo subita sera.
O natura infedel, come m’inganni!
Più dell’ingegno uman vola leggiera
la ruota irrevocabile degli anni.
Tommaso Gaudiosi[image error]
September 27, 2024
Medium è la linea.“Nulla dies sine linea”
 Nulla dies sine linea
Nulla dies sine lineaTradotta letteralmente, significa “nessun giorno senza una linea”. Lo dice Plinio il Vecchio, (anno 23–79 d.C.) nella sua “Storia Naturale”, cap.35.
La frase è riferita al celebre pittore Apelle il quale, oltre duemila anni fa, non lasciava passar giorno senza tratteggiare col pennello qualche linea.
Nel significato comune vuol significare la necessità dell’esercizio quotidiano per raggiungere la perfezione e per progredire. Un invito che vale per tutte le attività umane.
Anzi mi pare utile addirittura per dare un senso ed un indirizzo all’intera esistenza. Ogni giorno della propria vita deve avere un senso.
Avere un progetto, seguire una linea, dare un significato alle cose da fare, significa dare un’idea alla propria vita.
In fondo, il titolo di questo blog racchiude questo messaggio al quale questo blogger cerca di dare contenuti da ormai da sempre.
Quindi scrivere ogni giorno dà un senso e lascia una traccia, oltre ad aiutarmi a capire quello che penso. Questo si chiama anche creatività.Ognuno di noi non conosce i limiti nei quali siamo rinchiusi.
Soltanto dando sfogo e spazio alle nostre segrete intenzioni, alle intime, nascoste capacità possiamo andare oltre quei limiti e raggiungere una possibile perfezione.
Non conta la qualità dell’impegno bensì gli interventi, i tentativi, le partecipazioni, le prove affrontate.
Quello che si sceglie di fare va fatto con un certa professionalità, serietà ed impegno. Insomma un vero e proprio “lavoro” che non va preso alla leggera, per divertimento, tanto per farlo.
La continuità è la chiave di tutto, ma non si deve essere schiavi dell’impegno preso. E, sopratutto, non innamorarsi mai di quello che si fa. Il Narciso che è in ognuno di noi ne riderebbe …
Scrivere ogni giorno è un’attività che porta con sé numerosi benefici, sia per la mente che per lo spirito. Ecco alcune ragioni che potrebbero convincerti a dedicare del tempo alla scrittura quotidiana.
Sviluppo delle Abilità di Scrittura
Scrivere regolarmente ti permette di migliorare le tue abilità linguistiche e stilistiche. La pratica costante aiuta a trovare la tua voce unica e a perfezionare la tua capacità di esprimerti chiaramente.
2. Esplorazione e Riflessività
La scrittura quotidiana offre uno spazio per riflettere sulle tue esperienze, emozioni e pensieri. Può aiutarti a comprendere meglio te stesso e il mondo che ti circonda, trasformando le tue esperienze in insegnamenti preziosi.
3. Creatività e Immaginazione
La scrittura stimola la creatività. Anche se non scrivi opere di fiction, l’atto di mettere nero su bianco le tue idee può portare a nuove intuizioni e prospettive. Questo è particolarmente utile per un bibliomane come te, che ha una vasta esperienza di vita.
4. Disciplina e Routine
Impegnarsi a scrivere ogni giorno crea una routine che può migliorare la tua produttività in altri aspetti della vita. La disciplina acquisita nella scrittura può riflettersi in altri progetti o passioni.
5. Documentazione della Vita
Scrivere ogni giorno ti permette di tenere traccia dei tuoi pensieri, delle tue esperienze e delle tue emozioni nel tempo. Questo può diventare un prezioso patrimonio personale da rileggere in futuro, offrendo una prospettiva unica sulla tua vita.
6. Condivisione e Connessione
Se decidi di condividere i tuoi scritti, potresti scoprire che le tue parole risuonano con gli altri. La scrittura può essere un modo potente per connetterti con le persone, creando un senso di comunità e comprensione reciproca.
7. Crescita Personale
Infine, la scrittura quotidiana è un mezzo per crescere come individuo. Ti sfida a pensare criticamente, ad affrontare le tue paure e a esplorare nuovi orizzonti.
Dedicare del tempo alla scrittura ogni giorno non solo arricchisce la tua vita personale ma contribuisce anche al tuo sviluppo come scrittore e come persona.
Che tu stia annotando riflessioni quotidiane o esplorando argomenti più complessi, la scrittura è un viaggio che vale la pena intraprendere. (AI)[image error]
“Silenziosi” & “Centenniali”
 I 20 anni “centenniali” di Chiara
I 20 anni “centenniali” di ChiaraQuesta è la torta con la quale Chiara ha festeggiato i suoi venti anni. Una occasione per mettere a confronto due ventenni, il mio 1939–1959 e il suo 2004–2024 con le relative generazioni. Quelli della “generazione silenziosa” per i nati 1928–45, e quella della “centenniali/generazione Z” nati 1997–2012. Un confronto generazionale, un viaggio nel tempo per comprendere le profonde trasformazioni sociali, culturali e tecnologiche che hanno modellato le esperienze di due generazioni.
Rientro nella categoria della “generazione silenziosa” (1928–1945). Il mio primo ventennio va dal 1939 al 1959. I ricordi creano un contesto storico provinciale molto sfumato, da me vissuto in un paese di provincia meridionale che seppe poco della “Grande depressione”, ma visse in maniera drammatica il dopoguerra. L’infanzia e l’adolescenza di questa generazione alla quale appartengo sono state segnate da eventi drammatici che hanno plasmato un profondo senso di responsabilità, sacrificio e frugalità.
Una società tradizionale con forti valori come famiglia, patria e lavoro che erano fondamentali. Le aspettative di genere erano ben definite e le opportunità erano limitate. Maturammo precocemente. Mi diplomai a diciotto anni, dopo traversie e incomprensioni scolastiche locali, in un Liceo locale che si ostinava a non insegnare a vivere il futuro. In molti giovani coetanei ventenni ci ritrovammo a dover affrontare sfide ben oltre la nostra età.
La mia via di fuga fu prima linguistica e culturale, poi reale. Studente emigrante lavoratore (conservo ancora il passaporto del tempo con la dizione di “lavoratore”) mi ritrovai a studiare lavorando davvero prima in Germania e poi in Inghilterra. L’obiettivo era la costruzione del futuro che lentamente, ma con decisione, da una realtà locale, falsamente classica, era diventata paradossalmente conservatrice e reazionaria.
Se questo fu il mio primo ventennio, quello di mia nipote Chiara, bolognese di nascita e di vita, “zoomer” (1997–2012) nel ventennio (2004–2024), vive in un contesto storico molto diverso, una vera e propria era globale. Cresciuti, immersi nella tecnologia, gli Zoomers sono nativi digitali. Internet, smartphone e social media hanno plasmato profondamente il loro modo di comunicare, relazionarsi e percepire il mondo. Un mondo sempre connesso, con una maggiore consapevolezza delle diversità culturali e sociali.
Vent’anni. Gli Zoomers sono abituati a un flusso continuo di informazioni e a un ritmo di vita frenetico. Vogliono essere indipendenti. Cercano esperienze autentiche e personalizzate, sfidando gli stereotipi e le convenzioni. Sono creativi, amano esprimere se stessi e sono abili nel creare contenuti digitali. Sono inclusivi, consapevoli delle questioni sociali e si battono per l’uguaglianza e la diversità. Sono intraprendenti, alla ricerca di opportunità e flessibilità, spesso intraprendendo progetti personali.
Il compleanno di Chiara cade quando è iniziato l’autunno dell’anno 2024. Con i quattro ventenni che mi ritrovo ad aver vissuto, questo quinto lo rivivo insieme a lei. E’ come se fossi io ogni momento a costruire un mio nuovo futuro. Per una strana combinazione ho ripescato in rete un mio post dedicato a questa stagione della vita illustrato con una foto di Chiara che le feci anni fa in un parco di Bologna.
Lo ripropongo con l’idea che il passare del tempo e delle stagioni non alimenta la malinconia e la tristezza della nostra esistenza destinata prima o poi a concludersi, bensì ci aiuta a comprendere il suo continuo divenire e trasformarsi altrove. Il Bardo sa quello che pensa e lo dice nell’unico modo possibile. In maniera poetica. Chiara, che conosce bene la lingua, capirà il valore di questo messaggio. Lei studia biotecnologie.
L’autunno di Shakespeare Chiara
ChiaraTra i tanti post nei quali mi sono cimentato per celebrare la stagione dell’autunno non poteva mancare un richiamo al poeta dei poeti, il sommo William Shakespeare. Il tema dell’autunno viene da lui affrontato nel sonetto 73, che inizia con questo verso:
“Quella stagione in me tu puoi vedere”.
L’autunno è sinonimo di vecchiaia e per descriverla il poeta utilizza tre diverse metafore: un albero, un giorno, il fuoco. Ma non tutto è drammaticamente pessimistico. Il suo scopo è quello di mettere in evidenza la forza dell’amore.
Nella prima quartina si rivolge alla sua amata (o amato?) alla quale egli fa notare come egli stia invecchiando. Paragona, infatti, il suo corpo all’albero che perde le foglie:
“Foglie gialle, o nessuna, o poche, che pendono”.
I suoi capelli si fanno radi e i pochi rimasti imbiancano ingrigendo. Il grigio di quei capelli un tempo era marrone, un processo di decadimento simile a quello delle foglie gialle che un tempo erano verdi. E come i rami dell’albero che tremano ai freddi venti dell’inverno imminente, le sue membra tremano al mutamento del tempo. Anche la sua poesia diventa come “spogli cori in rovina”. Un tempo non lontano quei versi risuonavano di ben altre espressioni simili a quelle di “dolci canti”.
That time of year thou mayst in me behold,
When yellow leaves, or none, or few do hang
Upon those boughs which shake against the cold,
Bare ruined choirs, where late the sweet birds sang.
Quella stagione in me tu puoi vedere
quando foglie ingiallite, nessuna, o poche, pendono
appese ai rami tremanti contro il freddo,
spogli cori in rovina dove dolci cantavano gli uccelli.
Nella seconda quartina, dall’immagine dell’albero del tardo autunno si passa al processo che subisce il giorno col trascorrere delle ore. Egli è al “tramonto del giorno”, il tempo di quando il sole “svanisce a occidente”. Come il sole affonda lentamente all’orizzonte così la notte scende e porta il sonno alle normali attività del giorno. Per lui che parla, e che è agli ultimi giorni della sua esistenza, la notte diventa “la scura notte” che spegnerà non solo la sua vita ma porterà via anche il “simulacro della morte”, vale a dire il sonno. Egli non potrà più nemmeno riposare poichè la notte scura gli ha rubato la vita.
In me thou seest the twilight of such day,
As after sunset fadeth in the west,
Which by and by black night doth take away,
Death’s second self that seals up all in rest.
In me vedi il crepuscolo del giorno
che svanisce a occidente dopo sera,
che porta via pian piano notte nera,
simulacro di morte che nel riposo ogni cosa sigilla.
Nella terza quartina il poeta introduce ancora una nuova metafora paragonando la sua vita, ormai al declino, a quella di un fuoco che “langue sulla cenere della sua gioventù”. Un tempo questa ardeva di luce, ora scema e le medesime cose che alimentarono la sua giovinezza si consumano come il fuoco malinconico e fioco della vecchiaia.
In me thou seest the glowing of such fire,
That on the ashes of his youth doth lie,
As the death-bed, whereon it must expire,
Consumed with that which it was nourished by.
In me vedi quel fuoco che sfavilla
e langue sulle ceneri della sua giovinezza,
letto di morte in cui dovrà spirare
consumato con quel che lo nutriva.
Eppure, non tutto è vano. Nel distico finale la sua amata gli offre il suo amore e questo amore è più forte, anche se è alla fine. Pur sapendo che la morte che si avvicina li separerà, essa invita gli amanti a prendersi cura di chi si ama e stare insieme perchè il tempo ormai sta per finire. Il distico suona come un’ammonizione: mano mano che il tempo passa l’amore dovrebbe aumentare.
Non è chiaro se questo invito o considerazione sia rivolta alla persona amata o in fondo a se stesso. Forse ad entrambi poichè dovranno separarsi. In ogni caso il loro destino è segnato dal fato che si caratterizza con l’età, il tempo, la morte e la separazione.
This thou perceiv’st, which makes thy love more strong,
To love that well, which thou must leave ere long.
Questo tu percepisci che rafforza il tuo amore,
per meglio amare ciò che presto dovrai abbandonare.
Si possono fare molti confronti tra le immagini ricorrenti di questo sonetto e altre di altri sonetti. Il che spiega la persistenza del simbolismo poetico di Shakespeare, la sua forza di rappresentazione figurativa e il suo determinismo linguistico. Il tema delle stagioni che passano inesorabili lo si trova anche nel sonetto 18, la metafora della vita umana in quella del sole, e quella del fuoco nella terza quartina del primo sonetto.
Il colore giallo, il colore dell’autunno, lo possiamo trovare anche in altri sonetti, il 17 ed il 104 unitamente al trascorrere del tempo. Una possibile traduzione libera del sonetto in prosa inglese moderna potrebbe meglio chiarire il discorso che il poeta svolge all’amata (o amato?) Ve la propongo per aiutare chi non ha molta dimestichezza con la lingua inglese:
“You may see that time of year in me when few, or no, yellow leaves hang on those branches that shiver in the cold bare ruins of the choir stalls where sweet birds sang so recently. You see, in me, the twilight of a day, after the sun has set in the west, extinguished by the black night that imitates Death, which closes everything in rest. You see in me the glowing embers that are all that is left of the fire of my youth — the deathbed on which youth must inevitably die, consumed by the life that once fed it. This is something you can see, and it gives your love the strength deeply to love that which you have to lose soon.”
“Puoi vedere in me quel tempo dell’anno quando le poche o nessuna foglia pende da quei rami che tremano tra le fredde spoglie del coro scomparso, là dove gli uccelli un tempo cantavano. Tu vedi in me il crepuscolo del giorno, dopo che il sole è scomparso a occidente, spento dalla scura notte che imita la morte, la quale chiude ogni cosa al riposo. Tu vedi in me le ceneri ardenti, tutto ciò che mi resta del fuoco della mia gioventù, letto di morte su cui inevitabilmente la giovinezza deve finire, consumata dalla vita che ti nutrì e che presto si dovrà lasciare. Questo è qualcosa che devi vedere e che darà forza al tuo amore di amare profondamente ora ciò che dovrai ben presto perdere.”
Se questa non è vera poesia, mi chiedo cos’è la poesia?
Antonio Gallo Published in Un mondo di poesia Sep 30, 2020
 Wikipedia[image error]
Wikipedia[image error]
September 26, 2024
Dimmi cosa leggi, ti dirò chi sei
 Foto@angallo
Foto@angalloGiorni fa mia moglie mi ha costretto a liberarci di uno scaffale di legno per i libri che un falegname mi fece nello studio nella casa di Novella. Da diverso tempo, da tanti buchini quasi invisibili, filtrava una sottile polvere, piccoli fori rotondi. Un chiaro segnale di infestazione. Polvere fine sotto i mobili. Mia moglie era esasperata. Lei sosteneva, addirittura, di sentire anche dei leggeri rumori provenire dal legno infestato, causati dalle larve che scavano le gallerie. Avrebbero attaccato anche i libri. Me ne sono liberato ed è arrivata una scaffalatura in ferro via Amazon. Made in China, ovviamente. Con l’aiuto fondamentale di Franco, mio cognato, abile ex maresciallo tuttofare dell’Aronautica Italiana, l’abbiamo montata. Spero che non esistano tarli in ferro, magari cinesi!
Dimmi cosa leggi, ti dirò chi sei. La lettura è un viaggio che ci conduce in mondi lontani, ci fa incontrare personaggi indimenticabili e ci offre nuove prospettive sulla vita. Ogni libro che scegliamo di leggere riflette non solo i nostri interessi, ma anche la nostra personalità, le nostre esperienze e le nostre aspirazioni. Ma cosa possono rivelare le nostre scelte letterarie su di noi?
Saggistica: se sei un appassionato di saggistica, probabilmente sei una persona curiosa e desiderosa di apprendere. Ami approfondire argomenti complessi e cercare risposte a domande esistenziali. La tua mente è aperta e sei sempre alla ricerca di nuove informazioni per arricchire la tua conoscenza.
Romanzi: anche se non sono il tuo genere preferito, i romanzi possono rivelare molto su chi siamo. Se ti trovi attratto da storie di fiction, potresti essere una persona empatica, capace di immedesimarsi negli altri e di esplorare emozioni profonde attraverso la narrativa.
Biografie: la passione per le biografie indica una forte ammirazione per le esperienze altrui. Sei probabilmente una persona che cerca ispirazione nelle vite degli altri e che desidera apprendere dai successi e dalle sfide affrontate da figure storiche o contemporanee.
Libri self-help (aiuto): la lettura di questo genere suggerisce che sei in un percorso di crescita personale. Hai il desiderio di migliorarti e affrontare le sfide della vita con maggiore consapevolezza.
Ogni libro che leggiamo è come un riflesso delle nostre esperienze personali. Un lettore che si immerge in testi sulla filosofia potrebbe essere qualcuno che ha affrontato domande profonde sulla vita; chi legge opere sul viaggio potrebbe essere in cerca di avventure o desideroso di scoprire nuove culture.
La lettura come specchio dell’anima, si dice. Anima. Ma esiste ancora nel mondo di oggi? Ciò che leggiamo può rivelare molto su chi siamo e su come vediamo il mondo.
La prossima volta che scegli un libro, chiediti: “Cosa dice questa scelta su di me?” Potresti scoprire aspetti inaspettati della tua personalità o trovare nuove strade da esplorare nel tuo percorso di vita.
La lettura non è solo un passatempo. E’ un modo per conoscere noi stessi e gli altri. Quindi, dimmi cosa leggi, e ti dirò chi sei! Condividi con noi i tuoi libri preferiti e scopriamo insieme il meraviglioso universo delle parole. I libri influenzano profondamente le nostre opinioni e comportamenti in vari modi.
Stimolazione mentale. La lettura attiva il cervello, migliorando la memoria e le capacità analitiche, permettendo di affrontare situazioni complesse con maggiore lucidità.
Empatia e comprensione. Attraverso le storie, sviluppiamo la capacità di comprendere le emozioni altrui, migliorando le relazioni interpersonali.
Formazione delle opinioni: I testi informativi e saggistici ampliano la nostra conoscenza, influenzando le nostre convinzioni e il modo in cui vediamo il mondo.
Riduzione dello stress. Immergersi in una storia può fungere da valvola di sfogo, riducendo l’ansia e migliorando il benessere psicologico.
Espansione delle prospettive. La lettura di opere di fiction o saggistica offre nuove idee e scenari, stimolando la nostra immaginazione e la capacità di pensare a possibilità future.
Formazione delle aspettative. Le narrazioni e le informazioni lette modellano le nostre aspettative, influenzando il modo in cui ci prepariamo ad affrontare il futuro e le decisioni che prendiamo nel presente.
Crescita personale. I libri possono ispirare cambiamenti nella vita, incoraggiando a perseguire obiettivi e a superare paure, creando così un futuro più positivo e proattivo.
Quando Elon Musk fondò SpaceX, tutti pensavano che fosse pazzo. Non solo l’esplorazione spaziale è un settore dominato dai governi, ma per qualcuno senza alcuna esperienza in tecnologia spaziale entrare con la convinzione di poter contribuire a guidare un progresso significativo era a dir poco audace.
Nel corso degli anni, tuttavia, gran parte di quel dubbio iniziale su quello che allora era visto come il progetto preferito di Musk si è placato. SpaceX ha effettivamente fatto l’apparentemente impossibile e quel dubbio si è in gran parte trasformato in curiosità.
Detto quanto Musk sia coinvolto nel lato ingegneristico delle cose, una domanda che gli viene posta di solito è come diavolo abbia imparato così tanto sui razzi. La sua risposta? “Leggo un sacco di libri”.
È una risposta che fa quasi venire voglia di ridere. Imparare la scienza missilistica come hobby, attraverso la lettura, non è ciò che le persone normali fanno. Eppure, non è del tutto incredibile.
Abbiamo tutti sentito le storie su come molte delle persone che ammiriamo attribuiscano gran parte del loro successo alla loro sete di conoscenza e al loro amore per i libri.
Anche nella nostra vita, abbiamo tutti avuto esperienze che ci hanno fatto capire l’impatto della lettura. Una storia preferita dell’infanzia. Uno scrittore stimolante. Quel romanzo.
Tuttavia, non credo che la maggior parte di noi interiorizzi quanto leggiamo e, a volte, quanto sottilmente, ciò che leggiamo determini chi diventiamo.
L’input modella il nostro output. Il linguaggio è il nostro principale strumento di comunicazione. È il modo in cui costruiamo e organizziamo la nostra conoscenza ed è ciò che ci consente di interagire tra di noi. Al di fuori dell’esperienza diretta, è anche in gran parte il modo in cui creiamo la nostra percezione della realtà.
Le informazioni che i nostri sensi assorbono attraverso l’ambiente circostante si combinano per creare modelli linguistici, anche subconsci, nella nostra mente su come funziona il mondo e sul modo migliore per interagire con esso.
Una parte di ciò avviene attraverso la conversazione verbale o l’ascolto di qualcosa in generale, ma per la maggior parte dei lavoratori della conoscenza e per la persona media nei paesi sviluppati una parte più ampia è direttamente il risultato di ciò che consumiamo.
Siamo ciò che leggiamo. Le informazioni che inseriamo nella nostra mente informano i nostri schemi di pensiero e influenzano il nostro output sotto forma di decisioni che prendiamo, lavoro che produciamo e interazioni che abbiamo.
Questo è un grande incentivo a dare priorità a un blocco di tempo per pensare a cosa e come consumiamo e se leggiamo adeguatamente rispetto ai progressi che vogliamo fare. È un motivo per fermarci e considerare se possiamo fare qualcosa per modellare intenzionalmente la direzione della nostra mente.
Naturalmente, l’input non significa necessariamente quantità. La correlazione tra quanto leggiamo o consumiamo e cosa possiamo fare o chi diventiamo inizia a livellarsi dopo un certo punto, e di più non è sempre meglio.
Questo riguarda interamente la qualità delle nostre fonti di input predominanti e la loro importanza non può essere sopravvalutata.
Non hai tempo per leggere? Molti di noi conducono vite frenetiche e, con così tanti altri impegni, è abbastanza comprensibile che non ci sia sempre tempo durante il giorno per leggere. O forse no?
Quando passiamo ore a scorrere il nostro feed di Facebook, stiamo leggendo. Quando scegliamo di cliccare su un titolo allettante da una fonte di notizie discutibile, stiamo leggendo. Quando navighiamo senza motivo, stiamo leggendo.
L’unica differenza è che questo tipo di lettura non è intenzionale. È fatto nel nostro ambiente quotidiano predefinito e non è solo una perdita di tempo, ma molto spesso distorce negativamente il modo in cui vediamo, pensiamo e analizziamo il mondo.
Leggere non dovrebbe essere qualcosa che ti capita. Dovrebbe essere qualcosa che fai attivamente. Dovrebbe essere fatto con consapevolezza. Se senti di non avere tempo per leggere, forse è il momento di pensarci due volte.
Negli ultimi anni, il numero di libri pubblicati all’anno è raddoppiato. Viviamo nell’era del sovraccarico di informazioni e la capacità di distinguere il valore dal rumore diventerà una qualità sempre più critica.
Gli effetti della lettura non sono sempre evidenti e, di conseguenza, molti di noi non prestano sempre attenzione a ciò che il nostro cervello sta elaborando e ci limitiamo a seguire qualsiasi distrazione il mondo ci guidi. Questa non è la strada da seguire.
Alla fine della giornata, una delle competenze più importanti è la tua vita è come pensi. Influisce su tutto, da ciò che produci a come vedi il mondo. Sta a te migliorarlo consumando input di valore.
Ciò non significa necessariamente che dovresti eliminare tutto ciò che non è pratico o direttamente rilevante per la tua vita. Si tratta solo di essere decisi e convinti.
Riduci la navigazione senza meta, le notizie inutili e i feed dei social media. Aggiungi alcuni classici, leggi buona narrativa e impara da persone che pensano profondamente.
La qualità della tua mente dipende da questo.[image error]
MEDIUM
- Antonio Gallo's profile
- 52 followers



