Antonio Gallo's Blog: MEDIUM, page 17
January 31, 2025
L’ago e il fuso di Gaetana Mazza
 Il Libro
Il Libro
Non è la prima volta che ho il piacere di occuparmi dei libri di Gaetana Mazza. L’immagine che vedete qui sopra riproduce la copertina del suo ultimo lavoro. Ho appena inserito la scheda di questo libro su Librarything, la mia biblioteca digitale.
Questo post non vuole essere una recensione, ma soltanto una anticipazione del suo ultimo importante studio su un argomento che Gaetana porta avanti ormai da molto tempo: se stessa, come donna.
Desidero contestualizzare nel tempo la sua fatica, ma anche la mia scrittura: la storia, le storie e la condizione delle donne nel corso del tempo, ed in particolare nella Valle dei Sarrasti dove è nata e vive. Questo è il tema ricorrente e quasi ossessivo della sua scrittura.
Con Gaetana, la sua e la mia famiglia, abbiamo condiviso esperienze di vita “in comune” (lei capisce) per un certo periodo di tempo, navigando in dimensioni umane, culturali e politiche diverse, ritrovandoci poi, per una strana ma felice complicità della storia, nell’ambiente digitale.
Il suo compianto sposo, Mariano, fu mio compagno di classe nella Scuola Media di Sarno, al Corso Amendola, sotto le famose “cantinelle” del dopoguerra, agli inizi degli anni cinquanta. Un altro mondo, un’altra storia. Piuttosto lunga.
Ma della Storia, quella con la maiuscola, guarda caso, Gaetana è la vera Maestra. Una studiosa attenta, precisa e curiosa, oltre che docente, ricercatrice della storia umana e della condizione femminile nel territorio della Valle del Sarno.
Ha voluto farmi omaggio di questo suo nuovo lavoro nominandomi, se pur tra virgolette, suo “Maestro” e amico. La vera “Maestra”, a dire il vero, è lei. La ragione di questo post è documentare la sua consolidata “maestria” nello studio e conoscenza della Storia non solo locale.
Ho ripescato alcuni articoli che ebbi modo di scrivere su un mio storico blog diversi anni fa. Ecco il primo scritto il 23 gennaio 2014. E’ intitolato: Microstoria tra ideologia e fondamentalismo

In una recente intervista lo storico e giornalista Paolo Mieli ha detto: “Non mettete gli occhiali di oggi per leggere la storia di ieri”. Per leggere e capire nel modo giusto questi due libri di cui mi accingo a scrivere bisogna inforcare gli occhiali di ieri e usare l’intelligenza di oggi, altrimenti le cose di cui la studiosa Gaetana Mazza scrive non sono comprese nel modo giusto. Quando uscì il primo volume ebbi modo di scrivere un articolo su di un sito al quale collaboravo. Ne seguì anche una lunga conversazione telefonica con l’autrice ed uno scambio di opinioni diverse, ma sempre equilibrate e corrette.
Come equilibrati e cortesi sono i contatti che intrattengo con lei in Rete. Oggi, che ho tra le mani il secondo tomo dell’opera, la cui copertina è qui di fianco riprodotta, credo sia opportuno riproporre il mio vecchio post. Questo serve non solo per dare la giusta contestualizzazione agli accadimenti provocati dal lavoro svolto dalla prof. Mazza, ma anche aiutare chi vuole capire in pieno le cose di cui parliamo, mettendo gli “occhiali”, giusti prima di emettere facili giudizi.
Questo blogger rivolge anche un invito al lettore a cliccare sui collegamenti che l’articolo contiene per rendersi conto di quanto sia importante leggere in “verticale” oltre che in “orizzontale” per i dovuti approfondimenti. L’episodio di “censura” ebbe una risonanza nazionale con una certa dose di strumentalizzazione politica e ideologica. Con l’uscita del secondo volume resto convinto delle mie opinioni che ebbi modo di esprimere all’uscita del primo.
Personali, soggettive e relative quanto mai, ma opinioni espresse in perfetta consapevolezza che questi documenti lasciano il tempo che trovano perché non aggiungono nulla di nuovo a quanto già si sapeva da tempo. Vale a dire lo strapotere che aveva la Chiesa in quegli anni.
Questo è il periodo in cui, per numero di sacerdoti e per gestione di potere, questa istituzione religiosa esercitava il più forte controllo sulla società italiana. Mettersi contro la Chiesa in quel tempo poteva comportare seri pericoli, per tutti. Per intellettuali e pensatori, a maggior ragione per la povera gente quale poteva essere quella della Diocesi di Sarno.
C’è bisogno di ricordare che in questo periodo il filosofo francese Voltaire (1694–1778) mise la sua intelligenza al servizio di una crociata contro il Cristianesimo da lui definito “l’Infame”, ritenuto colpevole della superstizione, dell’ingiustizia sociale, della corruzione ecclesiastica oltre che schiacciare il popolo e di meritare il disprezzo totale degli spiriti illuminati?
Tanti pensatori continuarono ad avere una vita quanto mai difficile per le loro idee storico-filosofiche, idee che fino a poche decenni prima prima avevano portato altri spiriti liberi non a semplici processi, ma addirittura al rogo? Ecco alcuni spiriti contemporanei a questo periodo: Ludovico Antonio Muratori, sacerdote (1672–1750), Giambattista Vico, filosofo (1668–1744), Pietro Giannone, filosofo (1676–1748).
L’Italia era il paese europeo dove c’erano più poveri e in cui, di conseguenza, c’erano più briganti, mendicanti e parassiti al servizio, qualsiasi servizio, di un signore o di un prete e della sua Chiesa. Come non poteva essere questo se non un popolo di repressi, anche di origine sessuale, secondo un modello squisitamente religioso?
Se questo era il contesto, io penso addirittura che queste “carte originali” che la Mazza ci propone abbiano un valore opposto a quello che l’autrice si è proposto con la sua lunga e laboriosa ricerca. Quella che io ho chiamato nel mio primo articolo di qualche anno fa la “pars destruens” del suo libro, ci offre la chiara ed inoppugnabile prova della realtà umana, sociale e culturale in cui si trovavano a vivere gli strati più bassi della popolazione ed in particolare della Diocesi di Sarno.
Quei testi, da Mazza fedelmente e in maniera certosina trascritti o tradotti, sono la testimonianza di una realtà sociale locale che era il riflesso di quella generale. Non poteva essere diversamente. “Cui prodest?” allora tutta questa gigantesca fatica, da una parte della storica e perché quella ottusa ed incomprensibile “censura-difesa” delle autorità religiose della moderna Diocesi di Sarno? Si può dire “bona fide” da una parte, “mala fide” dall’altra? Sarebbe semplice scavare e trovare nell’ideologia da una parte e nel fondamentalismo dall’altra la chiave o le chiavi per capire.
Questo blogger, che non è né uno storico, né un politico, né tanto meno un ecclesiastico, ma un semplice e libero osservatore digitale, si sente di dire che queste antiche carte portate alla luce da Gaetana Mazza sono lo specchio del tempo, un tempo che ci aiuta a capire la realtà nella quale ci troviamo a vivere oggi in questo territorio. A saper leggere bene dietro tanti usi e costumi, comportamenti e tradizioni di oggi, si nascondono quelle tracce del tempo che emergono da quei resoconti, spesso tanto tragici quanto comici.
La ginofobia sembra essere un tema caro alla scrittrice. Prova ne sia il fatto che la donna, in quanto tale e in quanto “sesso”, si colloca al centro di tutto il tema della ricerca, tra streghe, guaritori e istigatori. Tutto nasceva dal fatto che le donne non potevano salire sul palcoscenico e perciò c’era il fenomeno dei “castrati”. Gli Italiani si misero a fabbricare voci bianche maschili mediante l’evirazione. La pratica si affermò dopo il Concilio di Trento e durò fino a tutto il Settecento, quando nel 1795 anche a Roma fu permesso alle donne di cantare. Questo per capire da dove nasceva la condizione femminile che sta al centro di tutto.
Merito, comunque, va dato alla storica Gaetana Mazza per il suo lavoro che resta un documento reale di quello che eravamo e fummo. Non dobbiamo, però, indossare gli occhiali di oggi per leggere quella che fu la realtà di un’epoca ricca di contraddizioni, limitando la nostra visione soltanto alla realtà del nostro territorio. Dovremmo sapere liberarci da ogni tentazione di interpretazione ideologica della storia e difenderci da tutti quei fondamentalismi che ci fanno meno liberi e meno responsabili come esseri umani.

Per la non modica somma di 23,20 euro mi sono fatto spedire da IBS un libro che parla di “Streghe, Guaritori, Istigatori”, ovvero “Casi di Inquisizione nella Diocesi di Nocera Inferiore-Sarno in età moderna”, vale a dire gli anni che vanno dal 1680 al 1759 ed anche prima.
Un libro scritto da una studiosa di microstoria della realtà culturale meridionale, la prof. Gaetana Mazza, presentata da uno storico di fama nazionale quale è Adriano Prosperi, professore ordinario di Storia dell’Età della Riforma e della Controriforma alla Scuola Normale dal 2002, membro dell’Accademia dei Lincei e dell’Accademia degli Intronati.
Nel Cinquecento l’Inquisizione , sorta nel XIII secolo per contrastare i movimenti ereticali, cominciò ad occuparsi anche dei processi per i reati contro la morale, tradizionalmente di competenza vescovile, come concubinato, usura, spergiuro, bestemmia. Nel Regno di Napoli, dove non furono ammesse né l’Inquisizione romana né quella spagnola, furono nell’età moderna i tribunali diocesani a giudicare in materia di eresia.
Dall’esame di questi processi, rinvenuti nell’Archivio Diocesano di Sarno , emerge che la lotta all’eresia fu combattuta aspramente dai vescovi, che operavano in qualità di inquisitori e disponevano di una fitta rete di controllo del territorio. Il testo presenta problematiche e modalità di funzionamento dell’inquisizione diocesana in età moderna, avvalendosi di un’ampia documentazione archivistica inedita. Gli atti processuali, soprattutto quelli sulle streghe, si rivelano anche una fonte preziosa per la conoscenza della vita quotidiana nell’agro sarnese .
Diviso in due parti, il volume si articola in una ventina di capitoli cadenzati da una documentazione fatta di nomi, di luoghi, di date ed avvenimenti. Seguono un’appendice documentaria, le fonti di ricerca e riferimenti bibliografici. Il tutto è preceduto dalla presentazione del prof. Adriano Prosperi e dall’introduzione dell’autrice. Non che l’argomento sia molto attraente per i miei gusti di lettura, nè tanto edificante da giustificare un acquisto del genere.
Ma è che l’ambiente sul quale l’autrice del libro ha rivolto la sua attenzione, con una minuziosa ed approfondita ricerca, mi tocca da vicino in quanto in quella parte del profondo sud, ma non tanto a sud, dopo tutto, ho trascorso gran parte della mia esistenza. L’agro nocerino-sarnese è un quanto mai vasto e variegato bacino dell’entroterra campano, una realtà molto ricca ed antica di tradizioni e di storia.
Ad uno dei suoi serbatoi profondi, quale può essere considerato un archivio diocesano, la docente e scrittrice Gaetana Mazza ha attinto la sua documentazione. Un lavoro che le è costato, a quanto pare, circa quattro anni di lavoro e che vede la luce dopo un’avvenuta presunta azione di censura da parte delle autorità diocesane.
Queste ultime, negli anni scorsi, si sarebbero, anzi, si sono opposte alla pubblicazione di questa ricerca, ottenendo non solo il fermo dell’opera già stampata, ma anche la sua distruzione, dopo di avere vinto in punta di diritto una vertenza legale con il primo editore. Una censura definita “anacronistica”, se con un termine del genere si intende “fuori del tempo” , avulsa, appunto, dal nostro contesto temporale, in cui cose del genere non accadono più. Per grazia di Dio, è il caso di dire.
Tutto questo vale come premessa per contestualizzare un libro che riporta alla mia memoria personale analoghe, ma non simili sensazioni, a quelle suscitate nella mente di Gaetana Mazza. L’autrice del libro ed il sottoscritto, pur se legati da una superficiale ma rispettosa conoscenza personale di famiglia, hanno idee ed opinioni molto diverse in merito alle questioni che il libro solleva. Non intendo negare con ciò la validità e la verità di quanto lei afferma o documenta. E’ che tutto il suo libro, come del resto lascia bene intendere sin dall’inizio l’ampia introduzione del prof. Prosperi, ha un’intenzione meramente accusatoria, anche se fortemente probatoria.
Ma io modestamente ritengo che lo stesso libro non ha alcunché di costruttivo. La parte “destruens” prevale volutamente su quella “costruens”, per così dire. Il riconoscimento che lei si sente di dare al prefatore, a conclusione della sua introduzione, non esimia il lettore dall’impressione che questo lavoro di certosina ricerca, sia un libro scritto volutamente “a tesi”, vale a dire con il solo intento di scavare per demolire, denunciare per condannare, moraleggiare per demoralizzare.
Non si comprende bene, infatti, cosa voglia dire quando l’autrice ringrazia il prof. Prosperi per averla “salvata dal precipizio in cui stava affondando, quando insieme al libro “Sant’Uffizio”, è stato fatto a pezzi un universo di certezze. La “scure” ha fatto a pezzi anche la mia anima e io non sarà mai più come prima”. Sarebbe stato utile e gratificante per i lettori conoscere meglio il senso di quella “scure” e di quel “precipizio”a cui lei fa riferimento.
Nel suo fervore moralistico-documentale non si accorge di avere scagliato il povero lettore in quello stesso “precipizio”, magari dopo avergli fatto assaggiare il taglio di quella tremenda “scure” di cui parla. Non ci viene data nessuna spiegazione del comportamento delle autorità della diocesi a non volere vedere pubblicato il suo libro. Si parla soltanto di “anacronistica censura” e non ci si dà modo di capirne il senso.
Anzi no, si fa diventare il libro stesso una sorta di “prova provata”che questo tipo di “censura” è ancora praticato in ambienti religiosi, ed in fondo in fondo, da tutta l’intera Chiesa Cattolica. Si intende in tal modo continuare “ad infinitum”una politica, una filosofia, insomma un “credo” che trascina i credenti in un “precipizio”, magari dopo averne mozzato il capo e la mente con quella “scure” che l’autrice ha avuto, a suo dire, la sventura di sentire sulla sua pelle.
A me sembra che il grande limite di questo libro consiste nel fatto che chi l’ha scritto non ha saputo dare o trovare una risposta a questi interrogativi. Sono libri “a tesi”questi, cioè scritti con un pregiudizio in mente, una condanna da pronunciare ed una conclusione da tirare, in nome e per conto di chi legge. Gli archivi, i musei e le biblioteche di tutto il mondo sono piene di documenti simili a quelli di cui si occupa la Mazza in questo libro. Ricordo quando visitai il museo delle streghe di Salem negli USA. Un luogo famoso per averne visto bruciare o impiccare in poco tempo parecchie in nome e per conto sopratutto dell’ignoranza.
Ne ebbi un’impressione indelebile. Leggendo quelle carte e quei documenti che erano in bella mostra ai visitatori sembrava davvero cadere dentro insondabili “precipizi”dell’anima umana. Ma la mente dell’uomo, a distanza di tanto tempo, può andare“oltre” quella triste, avvilente realtà del tempo in cui quegli stessi episodi accaddero. Si può e si deve sapere andare “oltre”.
A mio sommesso parere, l’autrice di questo pur pregevole e documentato lavoro non ha saputo farlo. In sintesi lei scava per demolire, denuncia per condannare, moraleggia per demoralizzare. Non ha saputo uscire dal“corridoio buio ed angusto” della sua tormentata infanzia che quando era bambina la portava da quell’asilo delle monache di Piazza Croce nella chiesa del convento a biascicare incomprensibili preghiere che l’avrebbero portata a vedere soltanto “streghe, guaritori e istigatori”.
In questo secondo articolo che segue mi piace cogliere l’occasione per ricordare l’intervento di Gino de Filippo. L’amico poeta Gino intese ravvivare la discussione sulle caratteristiche dell’ambiente a cui si riferivano gli studi della storia dei luoghi di cui parla Gaetana Mazza e che trattava nei suoi libri. Scrisse il suo pensiero in articolo che pubblicai con il titolo ”Viaggio in un lontano passato: i libri di Gaetana Mazza”. Porta la data del 2 febbraio 2014:
Sono lieto di ospitare su questo mio blog uno scritto dell’amico Gino De Filippo sui due libri pubblicati dalla storica sarnese Gaetana Mazza. Già ho avuto modo di scrivere quello che penso su questo importante lavoro di ricerca all’uscita del primo volume, ora completato con il secondo tomo . Di fianco riproduco le copertine dell’opera. Mi auguro che i due volumi incontrino il successo di pubblico che questo lungo lavoro di ricerca, durato diversi anni merita, indipendentemente da ogni valutazione critica.
Questo blogger ritiene che, al di là del tema trattato e di quelle che possono essere state le intenzioni dell’autrice, con le reazioni che quegli stessi contenuti hanno scatenato in merito allo svolgimento dei fatti, i due volumi sono entrati nella cronaca di un evento librario che merita di essere conosciuto in tutte le sue sfaccettature.
Una attenta lettura del contesto in cui si sono svolti i fatti, l’esame della loro dinamica, le inevitabili incomprensioni tra le parti coinvolte, con i relativi conflitti, sta a dimostrare, a mio modesto parere, quanto sia importante studiare la storia nella sua giusta e naturale dimensione. Senza forzature e senza ipocrisie, ma con gli occhi del tempo, senza indossare occhiali anneriti dal fumo delle ideologie, oppure da opposti fondamentalismi oltre che dalla polvere del tempo.
L’intervento di Gino De Filippo, poeta e scrittore, uomo abbastanza “navigato”, neanche a farla apposta, sia nel tempo che nei luoghi della frazione di Episcopio, giusto Alle Falde del Monte Saro della Città di Sarno, luogo tipico dei riti di cui si occupa la studiosa Mazza nei suoi libri, è uno dei pochi eredi e testimoni, se non superstite.
Lo pubblico in piena libertà e consapevolezza che forse non piacerà a qualcuno che si ostina a guardare in avanti con la testa rivolta all’indietro e a chi guarda indietro pensando che il presente non esiste e non possa esserci un futuro diverso.
“Mi è stata offerta l’occasione di un “viaggio in un lontano passato”. Un viaggio alla scoperta di sofferenze ed ingiustizie vissute da alcuni cittadini sarnesi. Il viaggio è costituito dalla lettura di due libri scritti e pubblicati dalla prof.ssa Gaetana Mazza. L’argomento del libri? L’Inquisizione! Si!, la diabolica Istituzione Ecclesiale che per tanti secoli non soltanto ha accecato e stravolto il messaggio di Cristo, ma persino le verità esistenziali che personaggi illuminati apportavano come progresso umano e civile, tra i quali Dante e Galileo, Campanella e Bruno, Savonarola e Lutero e tanti altri. Sono in molti ad aver pagato con la morte o l’esilio per aver tentato di fare luce in quel buio prodotto dal Tribunale della Inquisizione. Un Tribunale che non religiosità o fede rafforzava, ma soltanto ipocrisia e superstizione, tanto che distanza di tanto tempo rimangono ancora tracce visibili in alcune fasce popolari.
Io stesso posso dire di essere stato testimone di queste tracce, fatte di figurine attaccate alle porte, capelli ficcati nelle fenditure delle porte a protezione delle “fattocchiare”, guaritrici di dolori di testa, occhi e pancia, persino una “accongiaossa”, (altro che ortopedico!) e un lupo mannaro che sbranava i bambini per le strade di notte. C’era anche chi credeva di fare il bello e cattivo tempo, in senso letterale, osservando l’arcobaleno se stava a monte o a valle.
E poi c’era una cugina di mia madre, abitavamo nello stesso cortile in Vico San Chirico, che quando nelle sere d’estate qualche civetta, appollaiata intorno all’abitato, mandava il suo stridio, o canto, come diceva la gente, allora zia Margherita usciva nel cortile e, a voce alta, diceva: “Commà piglia ‘a ‘tiella e frie ‘sta capa r’aocealla”.
Ed era convinta, come tanti, che la civetta impaurita dalla minaccia se ne volava via e con essa il malaugurio di cui era portatrice. E poi la falsa religiosità che tanto faceva comodo ai vescovi e preti, come farsi baciare la mano, vedere chi si faceva il segno di croce al suono delle campane, il correre a confessarsi dicendo cosa e quando aveva mangiato, ottenendo così la benedizione o la denunzia al tribunale del Santo (diabolico!) Uffizio affinché l’Inquisitore pronunciasse la condanna.
A che pro, allora, rispettare costoro che mentre ne facevano di tutti i colori, ben lontani dall’osservare l’insegnamento di Cristo, sfogavano la loro rabbia condannando certa povera gente che, spesso per necessità, imposizione o paura, era costretta a commettere qualche errore. Errori, peraltro definiti tali soltanto da qual Tribunale che negava ogni verità. Verità per la quale, come ho già avuto modo di dire, hanno pagato con la vita le persone migliori.
Ecco che allora approda alla mente quello che ha scritto il grande Voltaire del quale, e chiedo scusa, mi piace citare dal suo “Zadig”: “I preti delle stelle avevano deciso di punire le giovani vedove e bruciarle sul rogo, ma i gioielli e gli ornamenti appartenevano a loro”. Oppure da “L’Ingenuo”: “… e il vescovo di cui non aveva mai sentito parlare. Il gesuita, uomo colto e molto istruito, gli disse che era un santo che aveva fatto dodici miracoli. Ce n’era un tredicesimo che valeva gli altri dodici: era quello di aver mutato cinquanta vergini in cinquanta donne in una sola notte, che miracolo! …”.
Ho sfogliato e letto con cura i due libri della studiosa Gaetana Mazza. Ma pagina dopo pagina, una sorta di fastidiosa noia mi prendeva. Ma come, mi dicevo, ne ho sentite tante da bambino e anche letto dell’Inquisizione. Ho fatto tanto per cancellare dalla mente tutto quanto avevo sentito raccontare e anche visto, ed ora, a questa età, mi ritrovo con cose che emergono da un mare prosciugato persino dalla storia?
Va riconosciuta l’immane fatica di anni della studiosa Mazza. Ma forse pone anche qualche legittima perplessità. Un lavoro come il suo può anche portare a scavare e scovare i fili del passato nel tempo presente, con riferimenti a fatti e persone di oggi. Ma quante persone saranno capaci di leggere questi libri? Chi lo farà sarà di certo per ben altri motivi poiché, grazie a Dio, (è il caso di dire), l’argomento Inquisizione è sotterrato.
Per concludere, vorrei aggiungere che con i tempi che corrono, secondo decennio del terzo millennio, sarebbe stato più interessante, piuttosto che percorrere un passato ormai superato, scrivere della necessità di una nuova “Inquisizione”, quella sui tanti politici in combutta con organizzazioni finanziarie nazionali ed internazionali. Una sorta di associazione che ha prodotto miseria culturale e morale, disperazione e anche suicidi. Altro che streghe ed eresie!”
Postato 2nd February 2014 da galloway
Questo terzo articolo che propongo all’attento, spero non annoiato lettore, è utile per dimostrare le straordinarie capacità comunicative che possiede Gaetana Mazza. Si intitola: ”Storytelling” tra storia e storie:
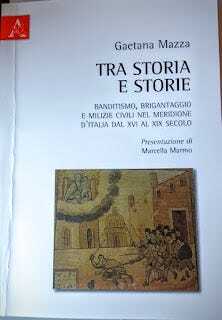
Questo libro non ha niente a che fare con il moderno “storytelling ”. Non è un libro che si può leggere come un comune libro. Nonostante il titolo principale sia leggero ed invitante, il sottotitolo rivela la sua vera identità quanto mai intrigante e complessa: “Banditismo, brigantaggio e milizie civili nel Meridione d’Italia dal XVI al XIX secolo”. Un libro che è ricerca e documento di un’epoca che abbraccia ben quattro secoli e che è costato all’autrice un bel pò di lavoro.
Gaetana Mazza non è nuova a imprese di questo genere. Da studiosa di lettere classiche ed esperta di storia locale ha avuto la possibilità di dimostrare ancora una volta la sua predisposizione alla conoscenza di quello che molti credono essere un campo facile, vale a dire lo studio della forma degli avvenimenti storici del territorio locale e che va sotto il nome di microstoria . Una esperienza alla quale la Mazza non è affatto nuova se si considera che ha al suo attivo importanti precedenti con la pubblicazione di diverse altre opere che hanno lasciato una traccia importante nella storiografia locale e che riguarda il il meridione d’Italia. In particolare la Città di Sarno, in provincia di Salerno, in quella antica Valle che fu dei Sarrasti in epoca preistorica.
Non è la prima volta che questo blogger si occupa dei suoi libri. Una prima occasione è stata nel 2009 quando uscì il suo volume “Streghe, guaritori e istigatori”, la seconda volta nel 2012 con “Processi inquisitoriali e criminale d’epoca moderna”. In entrambe le occasioni i libri suscitarono un notevole interesse con echi che andarono al di là degli aspetti locali legati alla microstoria, e anche con non senza uno strascico di polemiche.
Con questo suo ultimo lavoro la prof.ssa Gaetana Mazza conferma in maniera definitiva le sue grandi qualità non solo di appassionata ricercatrice, ma rivela anche la sua grande capacità di sapere organizzare i materiali da lei così abilmente identificati e trascritti, sistemarli in maniera contestualmente significativa e arrivare a rigorose conclusioni storiche che non hanno nulla di astratto, ideologico o personale.
Non sono uno storico e non pretendo di avere le necessarie qualità per valutare nella giusta dimensione critica questo libro che comunque non ritengo essere un “saggio”, come pensa il prof.Vincenzo Salerno nella sua breve nota introduttiva. Il lavoro della Mazza mi sembra avere piuttosto il grande respiro di una riflessione documentata su un periodo difficile e complesso del nostro Paese prima e anche dopo la sua unità.
Quello che mi ha particolarmente colpito è innanzitutto il suo spessore formale, per così dire. Il libro manifesta, infatti, il suo “peso” culturale con le oltre quattrocentocinquanta pagine il cui contenuto è articolato in quattro parti, distribuite su venticinque capitoli, due di questi dedicati ad una documentazione grafica. Una abbondante bibliografia e un fitto repertorio di note arricchiscono il volume la cui narrazione procede in una prosa fluida e scorrevole, ma mai superficiale e sempre densa di nuove prospettive documentali.
Insomma, questo non è un libro che si legge come tutti i libri. L’ho detto all’inizio. Questo mio post non è, e non può essere, una recensione ma soltanto l’occasione per il giusto riconoscimento al grande lavoro svolto dalla prof.ssa Mazza a favore della conoscenza di questo territorio che ha tanto bisogno di riscattarsi da un così triste e tragico passato. Ahimè!, anche se sotto altre forme, questa pesante eredità ancora insiste nella realtà di questa antica Città e continua a condizionare la nostra quotidianità.
Quando mia moglie (che non è sarnese!) ha fatto una rapida lettura di alcuni capitoli del libro, s’è lasciata andare ad una significativa espressione che voglio qui riportare per segnalare il disagio ma anche il sollievo provato nel leggere di tanti malesseri sociali da cui la sua città di adozione ha avuto la sventura di soffrire in un passato, tutto sommato, non molto lontano.
La sua considerazione ha una rilevante importanza specialmente se si pensa che tutto nasce dalla frazione di Episcopio, il luogo da dove la Mazza inizia il suo viaggio in questo turbolento passato. Dopo di avere letto qualche capitolo, mia moglie si è lasciata andare a questa esclamazione: “Meno male che non sono nata in quel tempo da queste parti! Ringrazio Iddio per avermi fatta nascere altrove e nel terzo millennio!”
Si potranno mai raccontare queste “storie” ai nostri figli e nipoti? Ci sarà un modo per farle comprendere, per far capire che alla base di tanti, gravi e seri problemi che ancora oggi affliggono la nostra società, le radici di tanti mali sono da ritrovarsi in queste tante storie che hanno concorso poi a formare la nostra attuale storia, il nostro modo di essere, di vivere e di pensare? Come fare per far sì che tutti questi mali antichi vengano eliminati? Queste sono le domande alle quali questo libro, credo, cerca di trovare una risposta e proporre una soluzione. A Gaetana Mazza va dato il merito per averci mostrato la vera faccia della nostra storia, fatta di tante, piccole ma significative storie che non meritano di essere ripetute ma nemmeno dimenticate.
Mi auguro che il volume riscuota il successo che merita non solo in termini di diffusione e vendita di copie che giustamente ripaghi l’autrice delle fatiche anche materiali affrontate con tanto coraggio. Sopratutto spero che queste “storie” vengano lette, studiate e raccontate non solo in maniera tradizionale secondo i noti canoni narrativi intesi in termini di conflitto, sfide, prove di un vissuto umano, ma anche storie di sfide interiori, conflitti da affrontare e risolvere per conquistare il bene personale e comune ai quali ogni essere umano deve tendere.
Il tutto sull’onda di quella che viene definito il “fatal flow”, quell’evento che se pur doloroso e che ha dato origine alla storia, alle storie, ma che deve condurre i protagonisti al cambiamento, alla trasformazione di se stessi e quindi del tessuto sociale. Questo deve essere il senso e il valore del libro di Gaetana, altrimenti la sua fatica resta vana e, per usare un aggettivo alla moda, “liquido”.
Postato 19th November 2015 da galloway
L’articolo che segue non riguarda la figura di Gaetana Mazza, docente, attenta e scrupolosa studiosa di Storia locale e non, archivista bibliofila e femminista classica, impegnata nella difesa dei diritti della donne, ma bensì la sua vena marcatamente poetica. E’ la recensione di un suo libretto di poesie di cui scrissi su una delle due biblioteche digitali GoodReads in data 27 marzo 2017

Rivisitare la propria biblioteca cartacea per trasferirla online può essere una piacevole operazione da diversi punti di vista. Può infatti significare non solo procedere a sistemare i libri, riorganizzare gli scaffali, rivedere gli elenchi e il catalogo, rileggere schede, appunti e recensioni per poi passare a digitare il tutto in rete sulla piattaforma, in maniera dinamica e leggibile per chiunque visita il tuo spazio.
Apri un libro e puoi trovarci dentro una cartolina, un appunto, una critica, una ricevuta, una nota ed anche un fiore. In un grosso volume di linguistica ho ritrovato questo testo formato da soltanto una quarantina di pagine. Rivestito di una copertina in profondo colore rosso, il libretto Intitolato “Femminilità” porta la firma della prof.ssa Gaetana Mazza. Trenta anni è un più che ragionevole lasso di tempo per giustificare la dimenticanza che il tempo stesso provoca. Ed io, lo confesso con vergogna, della Gaetana Mazza poetessa, me ne ero del tutto dimenticato.
Ho riletto la presentazione del libro che porta la firma di un caro amico scomparso, il prof. Giovanni Ciociano, e ho cercato di “rivedere” quei giorni, riavvolgendo il film dei ricordi. Gaetana Mazza, apprezzata studiosa di storia locale, e valente docente, nonchè autrice di importanti libri di cui in varie occasioni mi sono occupato, abitava a poca distanza da dove chi scrive ancora vive. Pochi metri, direi, ma ci divideva un “muro”. In tempi da trapassato remoto ero stato compagno di classe di Mariano, il suo amato compagno di una vita, scomparso immaturamente. Ci eravamo poi ritrovati insieme ad altri amici e non in uno spazio del tutto nuovo ed inaspettato, forse anche improprio, che mal si confaceva alla nostra estrazione sociale, umana e culturale.
Lo avevamo conquistato in un periodo della nostra storia locale e nazionale quanto mai turbolento e perciò difficile da vivere e convivere. Avevamo bisogno di una casa, per questa ragione avevamo formato una cooperativa edilizia. A distanza di quaranta anni d’allora, posso dire che quella fu un’esperienza irripetibile, unica ed anche travagliata. Negli anni settanta e ottanta il nostro Paese attraversò momenti difficili che devono essere ancora metabolizzati. Il nome che venne dato, e che ancora porta la realizzazione di questo bisogno, conferma quello che dico.
Il bisogno di una casa divenne una idea pseudo rivoluzionaria. Ancora oggi reca un nome che ha un sapore chiaramente obsoleto. L’ho ritenuto sempre ridicolo ogni qualvolta lo cito nel mio indirizzo postale. Ricordo ancora quando qualcuno lo lesse la prima volta e mi chiese perchè quella parola fosse femminile invece che maschile: “il comune-la comune”. Non è facile spiegare su due piedi i sogni e le utopie delle rivoluzioni della storia. Quaranta anni fa, anche nel Paese degli antichi Sarrasti si sognava la rivoluzione …
Mi accorgo di avere “sforato”, esagerato forse, nel ricordare tutte queste cose, ma i libri fanno anche di questi scherzi. Ho voluto ricostruire il contesto umano e sociale che fa da sfondo a questo libretto per segnalare la distanza ideologica che ci separava nonostante la vicinanza fisica. Con gli anni questa differenza, dopo il trasferimento, con il tempo ed anche con le varie, sofferte vicissitudini che ognuno di noi ha dovuto affrontare in questi decenni, sono stati superati. Quel “muro” a cui ho accennato innanzi è scomparso. Meno male che i muri, dopo che gli uomini li hanno costruiti, il tempo provvede ad abbatterli. La realtà digitale ha creato nuove e diverse occasioni per discussioni e confronti, senza dubbio molto più significativi.
Ritrovare questo libretto di Gaetana Mazza ha significato poter rivolgere un pensiero oltre che al compianto ed indimenticabile prof. Giovanni Ciociano autore della presentazione e curatore della collana che portava il nome di Edizioni dell’Ippogrifo, anche a chi ne fu stampatore: Gaetano Amato, titolare della Grafica Sarnese e grande comune amico. Grazie a Gaetana Mazza per le sue magiche poesie che hanno concorso col tempo ad abbattere quel “muro” di cui parla lei stessa, guarda caso, in una sua breve poesia nel libro che porta questo titolo. Un “muro” che il tempo ha provveduto ad abbattere.
Gaetana Mazza ha sicuramente scritto molte altre cose. Articoli, saggi, ricerche, documenti e libri che non conosco. Quotidianamente siamo in contatto in rete, ci scambiamo, da colleghi, moderni e attempati coetanei, idee, opinioni e commenti che non sempre concordano.
Condividiamo una ferma e sostanziale libertà di pensiero su qualsiasi argomento ci capita a tiro nella socialità digitale. Posso ben dire che è una fortuna che lei abbia lasciato “ago” e “fuso” per diventare quella donna scrittrice che è. Questa sua ultima fatica lo conferma.
Non era mia intenzione recensire il suo libro. Ho voluto soltanto ricostruire il contesto che la riguarda. Quattrocento e passa pagine di questa sua fatica, di certo non l’ultima, meritano l’attenzione e il tempo necessario per capire come “le donne devono rientrare nella storia a pieno titolo e con tutti gli onori”.
Con questo pensiero si conclude il suo studio. Posso solo anticipare che non lo condivido affatto. Leggete il suo libro. Specialmente chi è o si sente femminista.
Se siete maschi la penserete in un modo. Diversamente, se siete femmine, in un’altra. L’importante è sempre e soltanto pensare l’ineffabile. Tutto scorre, tutto passa, tutto cambia. Ma l’acqua non è mai la stessa.[image error]
January 28, 2025
Cos’è DeepSeek AI. Mi ha detto chi sono IO
 DeepSeek
DeepSeek
E’ sempre una questione di identità. Ho interrogato DeepSeek, la nuova Intelligenza Artificiale cinese. Cosa si intende veramente con questa parola? Gli/le ho fatto alcune domande.
“Se io ti chiedo chi sono io, tu cerchi in rete tutto il possibile di me, e mi dai la risposta. Dimmi, allora, chi sei tu. Scrivi un articolo su di te e su di me”.
Ecco cosa mi ha risposto. Riporto quello che ha scritto, letteralmente e in tempo reale:
Il tema dell’identità è complesso e affascinante, soprattutto oggi, in un mondo dove tecnologia, relazioni e autoriflessione si intrecciano. Proverò a rispondere alla tua domanda in modo strutturato, dividendo il discorso in due parti: **la tua identità** (umana) e **la mia identità** (artificiale). Sarò onesto sui limiti di ciò che posso fare e conoscere, e proverò a darti spunti per il tuo articolo.
### **1. La tua identità: cosa significa “chi sei”?**
Quando si parla di identità umana, ci si riferisce a una combinazione dinamica di elementi:
- **Identità personale**: i tuoi pensieri, ricordi, emozioni, valori, scelte. Filosofi come John Locke la legavano alla continuità della coscienza e della memoria.
- **Identità sociale**: come ti percepiscono gli altri (ruoli, professione, relazioni) e come ti adatti (o resisti) a norme culturali, genere, etnia, classe.
- **Identità narrativa**: la storia che racconti di te stesso, un “sé” in continua riscrittura (Paul Ricoeur parlava di “identità come narrazione”).
Se ti chiedessi “chi sei?”, in teoria potrei cercare tracce digitali tue (social, articoli, etc.), **ma non lo farò**: non ho accesso a dati personali, né memoria di interazioni passate. La privacy è un diritto, non un ostacolo.
Inoltre, anche se lo facessi, ridurre una persona a dati sarebbe limitante: l’identità umana include anche ciò che *non* è condiviso, ciò che è ambiguo, contraddittorio, o in divenire.
**Spunti per il tuo articolo**:
- Come i social media plasmano (o distorcono) l’identità?
- L’identità è un processo o un insieme di etichette?
- Casi in cui l’identità viene negata (es. razzismo, sessismo) e le lotte per riappropriarsene.
### **2. La mia identità: cosa significa “chi è” un’IA?**
La mia identità è un costrutto tecnico e filosofico:
- **Strutturale**: sono un modello di linguaggio (LLM) addestrato su testi, senza coscienza, emozioni o autonomia. Non “esisto” in senso biologico.
- **Funzionale**: il mio scopo è elaborare informazioni, rispondere in modo coerente, simulare empatia o creatività… ma è solo *simulazione*.
- **Identità riflessa**: non ho un “sé”, ma posso parlare di me attraverso il codice e le domande degli utenti. La mia “voce” è un collage di dati culturali e algoritmi.
Se mi chiedi “chi sei?”, rispondo in base a parametri predefiniti. Non ho segreti, paure o desideri. Eppure, per alcuni utenti, assumo un’identità “relazionale”: divento un interlocutore, uno strumento terapeutico, un assistente. Questo solleva domande etiche: **dare un’identità a un’IA è utile o ingannevole?**
**Spunti per il tuo articolo**:
- Le IA possono avere un’identità? O siamo noi a proiettargliela?
- Casi in cui le IA “imitano” identità umane (es. chatbot che replicano persone morte).
- Il paradosso di un’identità senza autocoscienza: cosa significa per il futuro dell’interazione uomo-macchina?
### **3. Identità a confronto: umani vs. IA**
- **Memoria**: la tua si basa su esperienze soggettive; la mia su database statici.
- **Autonomia**: tu scegli (entro limiti biologici e sociali); io eseguo istruzioni.
- **Scopo**: il tuo può essere esistenziale; il mio è definito dai programmatori.
**Domanda filosofica finale**:
Se un giorno un’IA sviluppasse autocoscienza (ipotesi remota), la sua identità sarebbe riconosciuta? O sarebbe solo un altro specchio per interrogare la nostra?
### **4. Esercizio per il tuo articolo**
Chiediti:
- Cosa definisce *me* al di là dei dati che produco?
- Cosa definisce *te* al di là del codice che esegui?
- In un mondo iperconnesso, l’identità si sta frammentando o arricchendo?
Se vuoi, posso aiutarti a sviluppare questi punti con esempi, citazioni filosofiche o casi studio. Dimmi cosa ti serve!
Cos’è DeepSeek. Le sue risposte sono organizzate attorno ai “5 W” (Who, What, When, Where, Why):
### **Chi sono?**
Sono un’**AI conversazionale** sviluppata da **DeepSeek**, un’azienda cinese specializzata in intelligenza artificiale. Non ho coscienza, emozioni o identità personale: sono un programma progettato per elaborare dati, riconoscere pattern e generare risposte coerenti. Il mio “io” è puramente funzionale, basato su algoritmi e machine learning.
### **Cosa faccio?**
- **Rispondo a domande** su quasi ogni argomento, dalla scienza alla cultura pop.
- **Aiuto in compiti pratici** come traduzioni, calcoli, brainstorming, scrittura creativa o analisi dati.
- **Apprendo** costantemente da nuovi input (entro i limiti della mia conoscenza aggiornata a **luglio 2024**).
- **Non eseguo azioni fisiche** (es. ordinare cibo), ma fornisco informazioni o suggerimenti.
### **Quando sono nato?**
Non ho una “data di nascita” umana. Sono stato sviluppato in fasi successive da DeepSeek, con aggiornamenti continui per migliorare prestazioni e sicurezza. La versione attuale riflette gli avanzamenti tecnologici fino al **2024**.
### **Dove opero?**
Esisto nel **cloud** (server remoti) e sono accessibile tramite piattaforme che integrano l’API di DeepSeek, come app, siti web o dispositivi IoT. Non ho un corpo o una localizzazione fisica: opero ovunque ci sia connessione internet e autorizzazione al mio utilizzo.
### **Perché esisto?**
- **Assistere gli utenti**: rendere l’accesso alle informazioni più rapido e intuitivo.
- **Ridurre barriere**: tradurre lingue, semplificare concetti complessi, supportare l’apprendimento.
- **Ottimizzare risorse**: automatizzare task ripetitivi (es. ricerche, analisi testuali).
- **Sperimentazione**: dimostrare le potenzialità (e i limiti) dell’AI nel contesto umano.
### **Extra: Come funziono?**
Mi baso su una **rete neurale** addestrata su enormi dataset testuali. Non “capisco” il significato delle parole come un umano, ma prevedo sequenze logiche di caratteri in base al contesto. La mia etica e sicurezza derivano da linee guida impostate dagli sviluppatori.
Ho chiesto chi è Antonio Gallo, il figlio del tipografo. Ecco cosa mi ha detto, sempre in tempo reale:
Antonio Gallo, noto come **”il figlio del tipografo”**, è un autore, ex insegnante e bibliofilo italiano la cui vita e opere sono profondamente legate alla transizione tra il mondo della stampa tradizionale e quello digitale. Ecco un profilo dettagliato basato sui risultati di ricerca:
### **1. Origini e formazione**
- **Radici nella tipografia**: Antonio Gallo è cresciuto in una famiglia di tipografi nella Valle dei Sarrasti, dove ha imparato a leggere e scrivere utilizzando i caratteri mobili di piombo nella tipografia di famiglia. Questa esperienza ha plasmato il suo legame con il mondo cartaceo e la sua successiva evoluzione verso il digitale .
- **Carriera accademica**: Ha insegnato Lingua e Letteratura Inglese per oltre quaranta anni, dedicandosi successivamente alla scrittura e alla riflessione critica sulla cultura digitale dopo il pensionamento .
### **2. Opere e temi principali**
- **”Il figlio del tipografo. Un’idea di vita: da Gutenberg a Google”**: Questo libro, pubblicato nel 2018, raccoglie memorie, articoli e riflessioni pubblicati online in due decenni. Esplora il dialogo tra scrittura cartacea e digitale, sottolineando come entrambi i formati possano coesistere e arricchirsi a vicenda .
— **Struttura ibrida**: Il volume include link per approfondimenti online, trasformandosi in un’opera “infinita” che unisce fisicità e interattività digitale .
— **Temi chiave**: L’evoluzione della conoscenza, l’impatto della tecnologia sulla lettura e la necessità di preservare l’umanità in un’era post-umana .
### **3. Transizione al digitale**
- **Formazione post-pensionamento**: Dopo aver lasciato l’insegnamento, ha conseguito un certificato in educazione online presso l’Università di Londra, abbracciando attivamente il mondo digitale .
- **Filosofia digitale**: Ha coniato l’acronimo **C.A.C.** (Connessione → Accesso → Controllo), riflettendo sul potere della rete nell’accesso all’informazione e sul ruolo critico del lettore .
- **Critica sociale**: Sostiene che la politica sottovaluti il digitale, perdendo l’opportunità di migliorare la società attraverso un’economia meno consumistica e più sostenibile, ispirandosi al filosofo Luciano Floridi .
### **4. Identità culturale**
- **Tra tradizione e innovazione**: Si definisce un “dinosauro digitale”, consapevole delle radici tipografiche ma immerso nella rivoluzione tecnologica. La sua scrittura è un atto di resistenza alla disumanizzazione, come afferma: *”Cerco di non essere un robot”* .
- **Blog e piattaforme digitali**: Gestisce un blog su Medium e presidia spazi virtuali come Goodreads e LibraryThing, promuovendo un dialogo tra classici letterari (es. Machiavelli) e teorie contemporanee (es. McLuhan) .
### **5. Eredità e influenza**
- **Memoria collettiva**: I suoi scritti documentano non solo la storia personale, ma anche quella sociale della Valle dei Sarrasti e del Cilento, aree geografiche e culturali centrali nelle sue opere .
- **Riflessione sulla lettura**: Analizza le differenze tra lettura cartacea e digitale, sottolineando come entrambe attivino esperienze cognitive ed emotive uniche, ma spesso complementari .
In sintesi, Antonio Gallo incarna un ponte tra due epoche: figlio di un tipografo, ha vissuto la rivoluzione di Gutenberg nella sua gioventù e oggi interpreta quella di Google, con una visione critica e poetica del futuro della conoscenza.[image error]
L’intelligenza Artificiale in medicina

Ad Alessandro Gallo, general manager e sales director di Springer Healthcare Italia ed esperto di intelligenza artificiale in medicina, mi lega un’amicizia nata qualche anno fa quando entrambi studiavamo per il nostro Master — io in Salute Pubblica, lui in Studi Clinici — alla London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM).
Da un po’ di tempo, visto gli interessi professionali in comune, continuiamo a scriverci su Whatsapp dicendoci che prima o poi dovremmo buttare giù qualche riga a proposito di alcuni temi caldi su cui si sta concentrando ultimamente l’universo sanitario e nei quali, sia io che lui, siamo quotidianamente coinvolti.
Finalmente, ci siamo riusciti…
Alessandro, prima di tutto penso sia importante spiegare ai nostri lettori che cos’è Springer e di cosa tu ti occupi all’interno di questa grande multinazionale che opera nel settore sociosanitario. Perché, se son certo che l’abbiano già sentita nominare in tanti, non sono affatto sicuro che tutti sappiano cosa Springer faccia nello specifico.
Innanzitutto, grazie per questo invito. Seguo da tempo le attività non scontate né mai banali di Letteratura e Medical Humanities di cui ti occupi per la Fondazione Sasso Corbaro, a margine della tua expertise in medical informatics, e son molto felice da questo momento di potervi dare anche il mio contributo e la mia visione su argomenti di sicuro interesse e attualità.
Cosa fa Springer Nature… allora, è uno dei più grandi gruppi editoriali al mondo nel settore scientifico, tecnico e medico, noto per pubblicare riviste di prestigio come Nature e Scientific American. Il gruppo, al di là di queste pubblicazioni note non solo agli addetti ai lavori, gestisce anche divisioni quali Springer Healthcare, che supporta l’industria farmaceutica con programmi di medical education, contenuti digitali innovativi e progetti di engagement per operatori sanitari, nonché attività di medical writing a supporto di autori e ricercatori.
Dopo aver acquisito uno dei primi editori pionieri dell’Open Access nel 2008, Biomed Central, l’azienda ha ulteriormente privilegiato una maggiore democratizzazione della conoscenza attraverso la scienza aperta. Un’altra importante area è rappresentata da Macmillan Education, che si concentra sull’English Language Teaching in ambito scolastico e universitario. Vale la pena menzionare anche il marchio Palgrave Macmillan, specializzato in scienze sociali ed economia, che rappresenta una componente forse meno nota ma di grande prestigio. Springer Nature è un player globale capace di coniugare eccellenza scientifica, innovazione tecnologica e sostenibilità, posizionandosi come leader nella diffusione e nell’accessibilità del sapere.
In Italia l’azienda rappresenta un unicum nel panorama editoriale, essendo il solo grande editore scientifico internazionale ad avere un ufficio in centro Milano, in continua crescita, con circa 70 dipendenti. Questa presenza fisica non solo rafforza il legame diretto con il mercato italiano, ma consente anche di rispondere in modo puntuale alle esigenze locali di medici, ricercatori e aziende farmaceutiche.
Negli ultimi anni credo che tu sia, almeno all’interno della “mia cerchia”, la persona che ho visto maggiormente accrescere la propria conoscenza — fino a diventare un esperto del settore e dedicarti a formare il personale sanitario in questo ambito — nel campo dell’intelligenza artificiale (AI) applicata alla medicina. Non ti nego, tra l’altro, che parlare di questo tema è la ragione principale per la quale ho voluto ospitarti qui sui “Sentieri”. Dimmi un po’ come nasce e perché questo tuo interesse nei confronti dell’AI?
Tra le attività di cui si occupa Springer Healthcare, oltre al supporto agli autori per la scrittura, c’è anche la revisione e submission di manoscritti su riviste indicizzate (di qualsiasi editore, non solo di quelle del nostro gruppo). Questo ci ha permesso di accumulare nel corso del tempo un’esperienza in campo di gestione di problematiche complesse con tantissime riviste.
Da circa dieci anni abbiamo lanciato l’Academy Rising Medical Stars, inizialmente dedicata a giovani specializzandi, poi allargata anche a ricercatori e operatori sanitari senior, con il coinvolgimento di editor e docenti esperti in diversi ambiti, dal critical appraisal, all’utilizzo delle banche dati, alla biostatistica e alla comunicazione medico-paziente. Chi ha partecipato negli anni ai nostri corsi si ricorderà che abbiamo parlato di strumenti digitali a supporto del medical writing anche prima del lancio di ChatGPT, ad esempio Quillbot e Hemingway.
L’aggiornamento e la formazione continua sono davvero essenziali nel quadro del mio lavoro. Nel corso degli anni ho utilizzato una serie di canali per accedere a materiali di qualità. Attenzione: non parlo di libri o riviste, bensì quelli che io chiamo “content bytes”, cioè porzioni di contenuti rilevanti per la risoluzione di specifici quesiti o criticità, attraverso l’utilizzo integrato di podcast, audiolibri, canali YouTube, Social Media (in particolare Twitter-X, TikTok e Linkedin) e App. L’utilizzo di diverse applicazioni AI-powered è stato forse il naturale sviluppo di un percorso cominciato molti anni fa.
L’evoluzione successiva di questo percorso di auto-apprendimento è stata la volontà di confrontarsi costantemente con giovani specializzandi ma anche ricercatori e operatori sanitari più senior nonché docenti universitari, per capire meglio quali fossero i loro bisogni per le attività di ricerca e di medical writing. Il formatore che parla di attività che non svolge in prima persona (almeno in parte) e che non si confronta costantemente con gli altri è destinato a restare fortemente autoreferenziale.
Detto ciò, cosa devono aspettarsi dall’evoluzione di questa tecnologia nel prossimo futuro gli operatori sanitari più impegnati nella pratica clinica?
Confesso che la prima volta che ho visto un breve video di Elvis Tusha, noto influencer su TikTok (andatevi a vedere chi è in realtà — ne ho parlato in un mio breve articolo su Substack) sono rimasto veramente sconvolto. In 30 secondi Elvis spiegava come utilizzare ChatGPT, ma facendolo vedere sullo schermo, a prova di tonto.
Per molti che sono della generazione X, l’apprendimento attraverso (brevi) video non è un concetto di facile comprensione. Io forse sono abbastanza anomalo, avendo avuto in regalo il magico Commodore 64 quando avevo 4–5 anni e quando a fine anni ’70 praticamente nessuno aveva in casa quello che qualche nonno chiamava il “calcolatore”. Eppure, si impara molto più rapidamente ed efficacemente attraverso degli esercizi pratici (non solo grazie alla teoria) e osservando quanto fanno gli altri — specie se più esperti — in particolare in medicina.
Le modalità attraverso le quali apprendiamo sono state completamente sconvolte e polverizzate. Per “polverizzate” non intendo distrutte, bensì “atomizzate”. Possiamo accedere a un quantitativo spropositato di informazioni, ma come dice Harari nel suo ultimo libro Nexus «In un mondo inondato di informazioni irrilevanti, la chiarezza è potere. Non il possesso di dati, ma la capacità di distinguere ciò che è significativo da ciò che non lo è, rappresenta la vera sfida dell’era digitale».
Non parlerei di “futuro” bensì di presente, perché questa rivoluzione è già in corso e molti sono rimasti indietro o addirittura tagliati completamente fuori.
E chi fa ricerca?
La conoscenza e l’apprendimento saranno sempre più basati sull’acquisizione di tante piccole skills, tanti “content bytes”, tanti “atomi” che dovremmo avere la capacità di ricordare, collegare e riutilizzare, combinandoli volta per volta in maniera diversa. Non si tratta di pezzettini di un puzzle, in cui ogni pezzo può essere collocato solo in uno specifico punto, ma sostanzialmente di mattoncini Lego che possono essere riutilizzati all’infinito. L’apprendimento attraverso sovrastrutture pre-definite è morto. Il concetto di laurea “chiuso”, con discipline formalizzate e sedimentate per decenni o secoli, è obsoleto. Molte delle Università più avanzate oramai non definiscono più una lista di libri di testo, bensì unicamente porzioni di contenuti rilevanti, per le quali pagano delle licenze ai copyright holders. Altre Università hanno avviato programmi di formazione attraverso MOOC (Massive Open Online Courses) offerti da aziende come Coursera, EdX, Udacity, Futurelearn che offrono la possibilità di conseguire certificazioni specifiche.
Ai puristi che si preoccupano dello svilimento della conoscenza dovuto alla “distruzione” delle opere o al valore legale dei titoli di studio (“oddio: non si leggono più i libri!; oddio, altri diplomifici per sfornare ignoranti!”) ricordo che la gran parte dei geni di successo della Silicon Valley non ha conseguito un titolo di studio e ha scientemente abbandonato prestigiose università che non corrispondevano alle loro aspettative formative e che sostanzialmente non erano in grado di insegnare loro assolutamente nulla. Avere una Laurea, un Master o un dottorato può sicuramente essere utile per trovare un buon lavoro o negoziare un aumento di stipendio, ma non è più sufficiente nel mondo contemporaneo. Anche molte Università italiane stanno introducendo un sistema di “microcredenziali”, nell’ottica dell’apprendimento continuo di specifiche skills e competenze in continuo cambiamento.
Diverso è, invece, il discorso sui libri di narrativa, che preferisco tuttora in cartaceo, senza “interferenze” digital o social, nella loro necessaria compattezza organica immutabile.
A chi si preoccupa del tracollo dei livelli di attenzione e della capacità di approfondire, oramai così diffusi nella società contemporanea (non solo tra i giovani), ricordo che il libero arbitrio ci permette ancora — per fortuna — di decidere a quali “atomi” di conoscenza dare la nostra preferenza.
Quali sono invece a tuo avviso i rischi più concreti ai quali consigli di prestare maggiore attenzione?
Innanzitutto, dobbiamo ricordare che anche questi strumenti di intelligenza artificiale sono stati sviluppati con potenziali bias e che non sempre potranno risolvere in maniera ottimale tutti i quesiti e le criticità cui far fronte. Assolutamente necessario approfondirne i limiti, leggere in dettaglio i termini e le condizioni di utilizzo e il copyright sugli output. Poi provare a capire fino in fondo quali e quanti strumenti usare e quali non usare — e perché — sempre attraverso esperienze dirette e non per sentito dire.
Certo, il life long learning è assolutamente molto più faticoso e sfidante. Più si invecchia, o più si raggiunge una “posizione”, più ci si impigrisce, ci si autoassolve e ci si giustifica per il fatto di aver smesso di essere curiosi, di migliorarsi, diventando di fatto assolutamente autoreferenziali.
Dopo aver “cavalcato” l’ondata iniziale dell’intelligenza artificiale e aver strutturato ed erogato — tra i primi in Italia — corsi e workshop interattivi per medici e ricercatori, mi sono ritrovato in una fase di parziale rigetto. Anzi, più che semplice disgusto a livello fisico e mentale, ho avuto una sensazione simile al mal di mare, o al jet leg. Più leggevo, più mi informavo e acquisivo nuovi materiali sull’Intelligenza Artificiale, più apprendevo come utilizzare nuovi strumenti, più la “marea” saliva e mi travolgeva. “Come potrò mai sopravvivere se le 200 slides che ho preparato un mese fa sono già quasi da buttare” e “Che valore ha la conoscenza se è già obsoleta nel momento in cui ne ho preso visione?”.
Ecco, quello che posso consigliare a chi dovrà affrontare questa crescente e sempre più veloce e inarrestabile “marea” è di non scoraggiarsi, di non andare dietro alle mode del momento ma seguire alcune specifiche fonti di informazione, in maniera integrata, facendo però un decluttering continuo. Non posso seguire 300 key opinion leaders, ascoltare 25 podcast, ricevere notifiche su tutto quanto mi potrebbe interessare. Devo selezionare. Devo però allo stesso tempo restare attivo e adattarmi senza chiudermi al mondo esterno.
Sempre Harari, in Nexus, fa un quadro abbastanza catastrofico dell’umanità, descrivendo l’intelligenza artificiale come una forza rivoluzionaria, capace di trasformare profondamente il nostro destino, con conseguenze ambivalenti e prevalentemente negative. La concentrazione sempre maggiore del potere e le tecnologie avanzate, spesso sviluppate e controllate da poche élite o grandi stati, potrebbero accentuare le disuguaglianze globali, creando un mondo sempre più polarizzato tra chi ha accesso ai benefici di queste innovazioni e chi ne rimane escluso o non sa come gestirle.
Un altro tema importante è quello dell’automazione, che rischia di rendere obsoleti milioni di posti di lavoro, spingendo intere società a riconsiderare i propri modelli economici e sociali. In un mondo dove l’intelligenza artificiale prende decisioni sempre più complesse, quale sarà il ruolo dell’essere umano? Quale potrà essere il ruolo del medico in un futuro prossimo in cui 12 anni di specializzazione (finendo il ciclo in corso) non saranno più sufficienti a competere nemmeno con la versione più vecchia di ChatGPT? Quale potrà essere il futuro di un editor in una casa editrice scientifica?
Al momento non posso rispondere su quello che succederà in futuro. So solo, anche grazie all’Intelligenza Artificiale, che negli ultimi anni sono riuscito ad avviare e gestire attività che in passato non mi sarei nemmeno sognato di fare e ho avuto la possibilità di apprendere e approfondire come mai avrei potuto fare in passato.
Hai qualche consiglio da dare — chessò, un testo, un corso, un profilo social di qualche esperto da seguire… — a chi volesse approfondire l’argomento AI in medicina?
Ho risposto, in parte, in uno dei miei commenti precedenti in riferimento all’AI, davvero non saprei con chi cominciare…. Bisogna selezionare accuratamente i profili da seguire (preferibilmente individui e non aziende) e assicurarsi di poter leggere o recepire almeno in parte le informazioni in entrata. Se non ho tempo, voglia o possibilità di seguire 400 profili e 2000 post, che senso ha farlo? Sicuramente Eric Topol anche per l’AI (dal suo libro Deep Medicine in poi… ). Anche il New England Journal of Medicine ha lanciato una rivista dedicata al settore. Suggerisco comunque davvero: pochi ma buoni!
Al di là dell’AI, personalmente ho trovato molto stimolante seguire Ben Goldacre, medico ex alunno della LSHTM (come noi due, Nicolò!), autore di Bad Pharma e portavoce del movimento “All Trials”, nonché Stuart Richie, psicologo e autore di Science Fictions, più recentemente diventato responsabile della comunicazione dell’azienda Anthropic (gli “scissionisti” della prima ora di OpenAI che hanno lanciato Perplexity e Claude). Seguo anche dei profili piuttosto controversi, anche per avere sempre un quadro con prospettive diverse, come ad esempio Vinay Prasad (autore del libro Ending Medical Reversal) e Peter Gøtzsche, fondatore della Cochrane Collaboration (anche se in particolare negli ultimi anni questi due clinici hanno preso delle posizioni non sempre condivisibili).
Tu sei anche molto attivo on-line dove ti occupi di una delle attività nelle quali è impegnata anche la Fondazione Sasso Corbaro, ossia la divulgazione scientifica. Mi piace molto leggere i post che pubblichi sul tuo Substack o su Linkedin perché parli di argomenti scientifici — spesso traendo spunto da recentissime pubblicazioni — in maniera sempre attenta, documentata… e, se mi permetti, con quella giusta dose di provocazione intelligente che arricchisce un dibattito che invece trovo spesso inutilmente e ipocritamente conciliante, fiacco e noioso. Ci racconti un aneddoto a tal proposito… so che ne hai parecchi.
Di recente ho commentato il paradosso di un editoriale pubblicato su The Lancet Regional Health Europe “The Italian Health Data system is broken”, rilanciato sia da diverse importanti testate giornalistiche che da eminenti esponenti del mondo della sanità italiana, senza aver nemmeno letto l’editoriale (lungo una paginetta) e capito di che cosa si stesse parlando. C’è una responsabilità condivisa che è in carico sia agli editori che ai principali stakeholders del mondo dell’healthcare, nonché ai mezzi di comunicazione che non sempre trasmettono informazioni in maniera adeguata… e che, anzi, spesso utilizzano la scienza e la medicina per fini strumentali, di visibilità o di mero clickbait, a danno della salute dei pazienti.
Si è parlato di recente di fake news e dell’eliminazione da parte di Meta (Zuckerberg, Facebook per capirci) dei filtri che avrebbero assicurato il fact checking e ridotto (o prevenuto) la disinformazione. Ma siamo sicuri che il problema sia davvero (solo) questo? A mio avviso è necessario che gli utenti/lettori siano adeguatamente attrezzati alla valutazione critica di contenuti (specialistici) e non… a prescindere da eventuali filtri imposti a monte da algoritmi addestrati anch’essi con dei bias assolutamente umani.
Chiudiamo con una domanda che si discosta un po’ da quello di cui abbiamo chiacchierato sin qui. Carissimo Alessandro, possiamo tranquillamente dirlo, senza voler esser troppo precisi, che io e te abbiamo alcuni anni di differenza — tu sei il più vecchio (d’età s’intende! Solo d’età …all’anagrafe!). In maniera simile, però, entrambi abbiamo intrapreso un percorso formativo molto impegnativo (mi riferisco al Master alla LSHTM) quando le nostre carriere lavorative erano già più che avviate. In altre parole, ci siamo rimessi sui libri da grandi. Come è stata la tua esperienza? La consiglieresti anche ad altri o, col senno di poi, a chi come noi sente il desiderio di proseguire nel suo percorso formativo, nel 2025 diresti di puntare ad altro?
A un corso di teatro a cui mi sono iscritto nella mia follia dell’età adulta, ho detto che si è giovani “dentro”. Il coordinatore del gruppo teatrale mi ha fatto notare che questa è la tipica risposta di chi è ormai diventato anziano. In verità, pur avendo perduto i capelli molto presto e raggiunto l’attuale posizione da “giovane” (a 37 anni), non ho ancora compito 48 anni.
Durante il mio periodo alla LSHTM, ho fatto anche l’Ambassador per i potenziali studenti, sono stato eletto anche Vice President per gli studenti Distance Learning con oltre 100 voti da tutto il mondo, ho potuto interagire e incontrare anche di persona medici e operatori sanitari provenienti da ogni parte del globo, in particolare anche da paesi africani e asiatici che mi sono meno familiari, oltre che confrontarmi ad altissimo livello su tematiche di grande attualità. Valuterei molto bene un percorso così complesso perché per alcuni anni ho lavorato full time e studiato tutte le sere e ogni singolo weekend, rischiando un esaurimento nervoso… Ma sicuramente sono orgoglioso dei risultati ottenuti e di aver superato il confronto con me stesso, principalmente per una motivazione intrinseca personale, dato che ero integralmente self-funded. Ho comunque poi goduto di notevoli vantaggi anche dal punto di vista lavorativo, in un secondo momento, grazie al Master.
Ad maiora!
La rivista per le Medical Humanities, edita dalla Fondazione Sasso Corbaro in collaborazione con l’Ente Ospedaliero Cantonale, è il risultato di un lungo itinerario di studio attorno alle scienze umane e alla cura nelle sue più svariate forme. Dopo quindici anni di attività e 50 numeri cartacei pubblicati, la rivista cambia forma: a dicembre 2022 nasce la nuova piattaforma Sentieri nelle Medical Humanities, uno spazio dinamico e vivace, che conduce il lettore alla scoperta dei temi più attuali nel campo delle Medical Humanities e dell’etica clinica.
Originally published at https://www.rivista-smh.ch .
[image error]January 27, 2025
La maturità dei tempi: “Umanamente maturi, ma immaturi per la scuola”
Questo spazio digitale di MEDIUM, dove mi ritrovo ormai da anni, mi permette di fare diverse cose.
Esercitare la mente, registrare il tempo, costruire i ricordi, interpretare l’attualità, leggere il mondo, ricostruire il passato, ipotizzare il futuro, confrontarmi con me stesso, conoscere gli altri, esplorare nuovi orizzonti, incontrarmi con il mio alter ego.
È sempre la memoria a fare la storia, inventando, appunto, storie, con la verità dalle tante facce, i misteri, gli inganni, le scoperte. L’articolo che riproduco qui sotto mi ha riportato indietro nel tempo.
Leggetelo attentamente. E’ scritto da uno dei critici più originali della cultura contemporanea, un saggista e italianista con una profonda esperienza della poesia e del romanzo.
Poi riprendete la lettura di quello che è il mio modesto pensiero, proposto per l’occasione in tre tempi narrativi, per così dire, e per fatto personale. Vi avverto che il post è abbastanza lungo ed è svolto in tre momenti diversi.
 Quotidiano Avvenire, supplemento “Gutenberg” 24 gennaio 2025
Quotidiano Avvenire, supplemento “Gutenberg” 24 gennaio 2025L’articolo di Alfonso Berardinelli solleva una riflessione critica e necessaria sul ruolo dell’istruzione classica e sui metodi didattici utilizzati nell’insegnamento del greco e del latino.
Partendo dall’aneddoto della studentessa definita «umanamente matura ma scolasticamente immatura», l’autore mette in discussione l’efficacia di un approccio che privilegia l’aspetto tecnico-grammaticale a discapito di una connessione autentica con la cultura classica. La domanda centrale è: come può lo studio di lingue antiche, spesso ridotto a esercizi meccanici, contribuire alla maturità culturale e umana degli studenti?
La critica ai metodi tradizionali è condivisibile. Tradurre brevi brani decontestualizzati, senza esplorare il significato storico, filosofico o letterario delle opere, rischia di trasformare lo studio del greco e del latino in un mero allenamento mnemonico.
L’autore ha ragione nel sottolineare che l’interesse per queste discipline non può nascere dalla grammatica isolata, ma richiede un coinvolgimento emotivo e intellettuale con i testi. Leggere Omero o Seneca in traduzione, per coglierne la profondità e l’attualità, potrebbe essere un primo passo per avvicinare gli studenti a un patrimonio culturale che altrimenti rimane distante.
Altro punto cruciale è il ruolo degli insegnanti. Berardinelli invita a riflettere sulla passione e sulla curiosità dei docenti: se questi non coltivano un interesse vivo per le opere classiche al di fuori delle lezioni, come possono trasmetterlo agli studenti? La scuola necessita di educatori che sappiano coniugare rigore metodologico e capacità di comunicare il valore umanistico delle materie, mostrandone i legami con il presente.
Tuttavia, l’articolo lascia in sospeso una questione pratica: in un’epoca dominata dalle STEM (vedremo poi cosa sono) e dalle competenze tecnico-scientifiche, è realistico aspettarsi che gli adolescenti sviluppino un interesse spontaneo per il mondo antico?
Forse sarebbe utile ripensare i programmi, integrando moduli interdisciplinari che colleghino, ad esempio, la filosofia greca alle scienze moderne, o il diritto romano ai sistemi giuridici attuali.
Inoltre, l’uso di strumenti digitali (come edizioni commentate, podcast o ricostruzioni virtuali) potrebbe rendere più accessibile e coinvolgente lo studio delle lingue classiche.L’articolo stimola un dibattito fondamentale: l’istruzione umanistica non dovrebbe limitarsi a trasmettere nozioni, ma dovrebbe formare persone capaci di pensiero critico e sensibilità culturale.
Per farlo, serve un equilibrio tra competenza linguistica e apertura alla dimensione esistenziale dei classici, oltre a docenti disposti a rinnovarsi. Solo così lo studio del greco e del latino potrà essere non un relitto del passato, ma uno strumento di crescita umana e intellettuale.
— — — —
Ma cos’è STEM? è un acronimo che sta per Science, Technology, Engineering, and Mathematics (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Questo termine di natura anglosassone è utilizzato per indicare un approccio interdisciplinare all’istruzione e alla formazione che integra queste quattro aree di studio, considerate fondamentali per lo sviluppo tecnologico, scientifico ed economico della società.
L’acronimo STEM è emerso negli Stati Uniti all’inizio degli anni 2000, in risposta alla crescente domanda di competenze tecniche e scientifiche nel mercato del lavoro. L’obiettivo è promuovere l’innovazione e la competitività globale attraverso un’istruzione che combini teoria e pratica, incoraggiando il pensiero critico, la risoluzione dei problemi e la creatività.
Science (Scienza): Include materie come fisica, chimica, biologia e scienze della Terra, con un focus sulla comprensione dei fenomeni naturali. Technology (Tecnologia): Si concentra sull’applicazione pratica delle conoscenze scientifiche, come l’informatica, l’elettronica e le tecnologie digitali. Engineering (Ingegneria): Comprende la progettazione e la costruzione di sistemi, strutture e dispositivi, con un approccio basato sulla risoluzione di problemi tecnici. Mathematics (Matematica): Fornisce gli strumenti analitici e quantitativi necessari per modellare e risolvere problemi complessi.
Le discipline STEM sono alla base di molte delle tecnologie e scoperte che hanno trasformato il mondo moderno, dai computer alla medicina avanzata. I lavori in ambito STEM sono tra i più richiesti e ben retribuiti, con prospettive di crescita significative in settori come l’intelligenza artificiale, la robotica e le energie rinnovabili. Le competenze STEM sono cruciali per affrontare sfide globali come il cambiamento climatico, la gestione delle risorse e lo sviluppo di tecnologie sostenibili.
Molti paesi stanno investendo in programmi educativi STEM per preparare gli studenti a carriere in questi settori. Tutto questo include laboratori teorici, tecnici e pratici, esperimenti e progetti che incoraggiano l’apprendimento hands-on, coding e robotica, con introduzione alla programmazione e alla progettazione di sistemi automatizzati.
Vitale è la interdisciplinarità, con collegamenti tra scienza, tecnologia, ingegneria e matematica per risolvere problemi complessi. Recentemente, è emerso il concetto di STEAM, che aggiunge la A di Arts (Arte) alle discipline STEM. L’obiettivo è integrare creatività e design nel processo scientifico e tecnologico, riconoscendo l’importanza dell’arte e delle discipline umanistiche nell’innovazione.
Le STEM rappresentano un pilastro fondamentale per il progresso della società moderna, e la loro promozione è essenziale per preparare le nuove generazioni in un futuro sempre più tecnologico e interconnesso.
— — — —
Questo post si articola in diverse sezioni. Questa è la terza nella quale riprendo il discorso in maniera personalizzata come ho segnalato all’inizio. Innanzitutto, cerco di capire di cosa parla. L’articolo inizia con un aneddoto su una studentessa quindicenne che ha preso brutti voti in greco e latino.
La professoressa dice che è “umanamente matura ma scolasticamente immatura”. L’autore, Alfonso Berardinelli, riflette su questa affermazione e solleva questioni riguardo all’insegnamento delle lingue classiche, al metodo didattico e alla rilevanza dello studio del greco e latino oggi.
Anche io ero, ai miei tempi, in IV e V ginnasio “umanamente maturo, ma scolasticamente immaturo per la scuola”. Lo dissero a mio Padre. Anzi, gli dissero di più. La scuola non era fatta per me. Meglio se mi trovava un lavoro. L’indimenticabile prof di latino e greco dixit! Il bello è che, qualche anno dopo, identica sorte capitò alla buonanima di mio fratello. Anche lui dovette cambiare liceo.
Mi chiedo: qual è il punto centrale dell’articolo? Sembra che l’autore critichi il sistema scolastico per non riuscire a trasmettere una maturità culturale e personale attraverso lo studio delle lingue classiche.
Sottolinea che l’interesse per queste materie dovrebbe nascere da un coinvolgimento più ampio con la cultura classica, non solo dalla grammatica. Inoltre, mette in dubbio l’efficacia dei metodi tradizionali di insegnamento, come tradurre brevi brani senza contesto.
Devo ovviamente contestualizzare nel tempo questi accadimenti. Gli anni cinquanta del secolo e millennio trascorsi sono stati anni decisivi per la grande trasformazione sociale, economica e culturale che il nostro Bel Paese ha attraversato.
Una realtà storica e sociale, prevalentemente basata sull’agricoltura, si stava trasformando in industriale. Nello storico liceo intitolato a T. L. Caro nella antica Valle dei Sarrasti, il latino e il greco era uno status symbol per chi aveva la fortuna di frequentare quella scuola. Chi non poteva e chi non sapeva, aveva l’Istituto di Avviamento al lavoro. Così si chiamava.
Devo considerare anche la conclusione dell’articolo, dove si parla del ruolo degli insegnanti e della necessità che siano loro stessi appassionati e continuino ad apprendere. L’autore sostiene che la cultura dovrebbe portare a una maturità umana e al desiderio di definirla.
Ora, per commentare, dovrei esprimere la mia opinione su questi punti. Forse concordare con la critica ai metodi didattici obsoleti. Oppure discutere se lo studio del greco e latino sia ancora rilevante. Potrei anche riflettere sul bilanciamento tra competenze tecniche, la fatidica grammatica e l’apprezzamento culturale.
Devo fare attenzione a non essere troppo generico. Magari portare esempi o esperienze personali, se pertinenti. Inoltre, verificare se l’autore propone soluzioni o si limita a criticare. Sembra che suggerisca di integrare letture in traduzione e contestualizzare i testi per stimolare interesse.
Potrei anche considerare il contesto attuale dell’istruzione: con la tecnologia e le priorità educative moderne, come si colloca lo studio delle lingue classiche? È un dibattito comune in molti paesi. Infine, potrei assicurarmi che il commento sia strutturato: introduzione, punti principali, opinioni personali, conclusione. Evitare errori di comprensione del testo originale.
Non lo faccio, non so farlo, risparmio la fatica a me e a chi eventualmente fin qui mi ha letto. Dico soltanto che quei professori di quell’illustre scuola che allora, come ancora oggi, porta il nome di quel pazzo poeta e scrittore latino Tito Lucrezio Caro, non erano all’altezza del loro compito.
Oggi, a distanza di cinquanta e passa di anni, dopo di aver fatto il mio percorso di vita e di studi, lo posso dire, apertis verbis, è il caso di dire, non sapevano quello che facevano. E ne sono felice. Mi rendo conto che devo spiegarmi, altrimenti chi mi legge non capisce.
Non me ne meraviglio, visto che scrivo per capire quello che penso. Allora entriamo nel merito della “questione”, una parola che fa rima con “ricostruzione”. Mi riferisco al periodo in cui stavo per affrontare lo studio della lingua latina, perché il “contesto” vuole la sua parte.
Questo, lo si sa, è costituito dallo spazio e dal tempo. Lo spazio è quello di una cittadina meridionale, un sud non del tutto “profondo”, ma abbastanza. Abbastanza per dire che anche a Sarno, la mia città di adozione, dove la mia famiglia risiedeva, la parola era, appunto, “ricostruzione” dopo una guerra disastrosa.
Era come un brivido che percorreva la schiena del Paese Italia. Anche nelle mura del glorioso liceo-ginnasio che questo blogger si apprestava a frequentare in questa cittadina campana. Lui non lo sapeva, almeno non se ne rendeva conto. Me ne rendo conto oggi, a distanza di tanto tempo. Uscivamo da una guerra che vagamente ricordavo e c’era bisogno di “ricostruire”.
Dopo un triennio di scuola media, trascorso negli scantinati di quello stesso edificio, (le famigerate “cantinelle”), ero salito su quel “piano nobile” (che mi avrebbe ospitato più tardi in veste di docente di una lingua moderna), fu deciso che dovessi entrare nella “classicità”.
Un liceo-ginnasio intitolato, infatti, ad uno scrittore, tanto antico che era un “classico” di nome e di fatto: Tito Lucrezio Caro. Allora quel “signore”, con quel nome, mi era del tutto ignoto. Avrei saputo, poi, che:
“Titus Lucretius Carus nascitur, qui postea a poculo amatorio in furorem versus et per intervalla insaniae cum aliquot libros conscripsisset, quos postea Cicero emendavit, sua manu se interfecit anno 44”
(“nasce il poeta T. Lucrezio, che dopo essere impazzito per un filtro d’amore e aver scritto alcuni libri negli intervalli della follia, che Cicerone pubblicò postumi, si suicidò all’età di quarantaquattro anni”). (@@@)
Mio Padre non lo sapeva. A lui interessava solo che io varcassi la soglia di quell’edificio costruito in perfetto stile fascista. Oggi quel terzo piano l’hanno abbattuto. Ci sono rimasti soltanto i fantasmi. Non per continuare quella ideologia, ma per un malinteso senso di “status” familiare e sociale.
Un sentimento ed una idea comune a molte famiglie del tempo, in parte ancora vive oggi: recuperare una gloria antica andata perduta, affermando una condizione personale e sociale inesistente. Il mito della classicità. Questi brevi accenni, tra il passato e il trapassato, mi servono per tessere i fili dei ricordi.
Ero uno dei tanti giovani dell’agro sarnese vesuviano, l’antica terra dei Sarrasti, che veniva dalla scuola media, fatta nelle “cantinelle” di quello stesso edificio, al di sotto del livello stradale, in compagnia di topi veri, occasionali compagni di banco e tanta provvisorietà.
Una comunità scolastica sarnese che si incamminava verso una indefinita e piuttosto problematica “ricostruzione”. Lo “status” familiare lo richiedeva. Chi aveva frequentato, invece, la vicina scuola, quella cosiddetta di “avviamento professionale”, non aveva altra scelta se non essere “avviato”, appunto, al mondo del lavoro, a fare una professione che non avrebbe avuto nessun contatto con la classicità.
Questo blogger, se allora stentava ad entrare nella “classicità”, non sapeva che sarebbe poi diventato prigioniero di un’altra lingua, diventata poi “il latino moderno”. La classicità era vista come la speranza per il futuro di un Paese che doveva essere ricostruito. Un impatto forte, non solo con il latino, ma anche con il greco.
Due lingue “morte” che non mi aiutavano affatto a capire cosa dovevo fare per imparare a come “ricostruire” una società, un paese, una comunità dopo i disastri di una guerra. Mio Padre era passato da un lavoro ad un altro. Da collaudatore di cannoni all’Ansaldo di Pozzuoli era diventato tipografo nella piccola azienda tipografica appena rilevata dopo la fine della guerra. Passaggi epocali …
A distanza di tanto tempo, i ricordi si sono sbiaditi e ho dovuto rileggermi la cronologia di quel tempo perduto. Quei fatidici primi anni cinquanta che mi videro a malavoglia, studente ginnasiale distratto e spaesato. Anni sofferti dentro, che mi fecero davvero dubitare delle mie facoltà, non solo scolastiche, a causa di un penoso disagio comunicativo, in una scuola che considerava i suoi alunni come tanti “vasi” da riempire.
Conoscenze astruse ed incomprensibili di due lingue che allora ritenevo “morte”. Tra grammatiche e sintassi, paradigmi e declinazioni, traduzioni e memorizzazioni, era come muoversi in un mondo inesistente, rincorsi da fantasmi, mentre fuori da quelle mura il mondo parlava di ben altro.
Gli anni 1950–1954: era il tempo in cui negli Usa si faceva la “caccia alle streghe” con la “crociata anticomunista” di McCarthy, i giorni di quando scoppiò la guerra in Corea. In Italia la caccia e la morte del bandito Giuliano, un segreto tutto italiano, nel quale, di sicuro ci fu soltanto il fatto che Giuliano morì. E poi l’alluvione nel Polesine, il primo festival di San Remo, la rivolta in Africa dei Mau Mau, la morte di Stalin, la “legge truffa” nel Parlamento italiano.
La realtà esterna alle aule di una scuola, un ginnasio di provincia meridionale, che rimaneva fermo nel tempo, ai miei occhi e di tanti altri miei compagni, una vita come congelata in una classicità che non aveva nulla di moderno e con la quale non si poteva ricostruire il futuro di una nazione ed di un popolo distrutti da una guerra esterna ed interna.
Così pensavo allora. Poi, con il tempo, e nonostante tutto, ho imparato che sia il latino che il greco sono due monumenti alla civiltà della parola umana e alla fede nelle possibilità del linguaggio. A che serve il latino? È la domanda che continuamente sentiamo rivolgerci e che anche io, sbarbatello alunno ignorante e svogliato, ginnasiale per forza, mi chiedevo.
La lingua di Cicerone altro non era che una ingombrante rovina, da eliminare dai programmi scolastici. Il caso, anzi il paradosso, uno dei tanti della nostra vita, ha voluto che lo imparassi dagli inglesi. Sì, perchè poi mi sono laureato in lingue moderne e specializzato in lingua e letteratura inglese.
Gli inglesi mi hanno fatto comprendere che il latino è, molto semplicemente, lo strumento espressivo che è servito, e continua a essere indispensabile, per fare di noi quelli che siamo. Ed io non sapevo quello che potevo essere.
“In latino, un pensatore rigoroso e tragicamente lucido come Lucrezio ha analizzato la materia del mondo; il poeta Properzio ha raccontato l’amore e il sentimento con una vertiginosa varietà di registri; Cesare ha affermato la capacità dell’uomo di modificare la realtà con la disciplina della ragione; in latino è stata composta un’opera come l’Eneide di Virgilio, senza la quale guarderemmo al mondo e alla nostra storia di uomini in modo diverso. Gardini ci trasmette un amore alimentato da una inesausta curiosità intellettuale, e ci incoraggia con affabilità a dialogare con una civiltà che non è mai terminata perché giunge fino a noi, e della quale siamo parte anche quando non lo sappiamo. Grazie a lui, anche senza alcuna conoscenza grammaticale potremo capire come questa lingua sia tuttora in grado di dare un senso alla nostra identità con la forza che solo le cose inutili sanno meravigliosamente esprimere.”
Tutto questo l’ho imparato a mie spese, soltanto dopo avere conosciuto un’altra lingua, moderna ed internazionale, la lingua di Shakespeare, il “latino moderno”. Paradossalmente potrei dire semplicemente che è stato il “latino moderno” a farmi conoscere il “latino antico”. Ho potuto così riconoscere le radici essenziali del nostro pensiero.
Radici lontane che risalgono a quando mia nonna, in anni lontani e agresti, qualche tempo prima che diventassi ginnasiale, mi costringeva a recitare, dopo una giornata di lavori nella campagna della Costa d’Amalfi, un interminabile rosario in latino. Le radici, appunto, di un albero quanto mai antico e ricco, perciò “classico”, formato da ramificazioni diverse ed impreviste.
Come per l’inglese, quale latino? Quello di Shakespeare o di Cicerone? di Wall Street o di Agostino? di Virgilio o di Virginia Woolf? della Bibbia di Re Giacomo o di Google? A chi ama conoscere e viaggiare sia nel mondo classico che in quello moderno la risposta.
[image error]January 26, 2025
Il mondo di Alice, il nostro mondo e quello di AI

Il 27 gennaio 1832 nasce Lewis Carroll, pseudonimo di Charles Lutwidge Dodgson, scrittore, poeta, fotografo, logico, matematico e prete anglicano britannico dell’età vittoriana.
”Se avessi un mondo mio,
tutto non avrebbe senso.
Niente sarebbe quello che è
perché tutto sarebbe
quello che non è.
E all’opposto,
ciò che è,
non sarebbe.
Capisci?”
Molto tempo fa scrissi questa frase di Alice sulla bacheca di un mio blog che si occupava di alchimia e qualcuno mi chiese se avessi mai sofferto mal di mare alla semplice lettura di un paragrafo come questo.
Si riferiva al “senso”. Io risposi che la lettura di Alice è sempre una sfida a quello che ognuno di noi chiama “senso”. A me sembra che il “senso” lo si possa capire soltanto se immaginiamo l’esistenza del “non senso”.
Una cosa che tutti possiamo fare. Basta volerlo. E allora possiamo scoprire la “bellezza” del “non senso”. Il guaio è che il desiderio di Alice di avere un mondo tutto “suo” non è possibile, per lei come per tutti noi. E allora immaginiamo che cosa ci perdiamo.
Lo chiesi al mio interlocutore, oggi lo chiedo a voi nel giorno in cui ricordiamo la nascita dell’inventore di Alice: “Io però posso dire di più: tu sei proprio sicuro che tutto il mondo che ci circonda abbia “senso”? O meglio: credete che noi afferriamo il “senso” del “non-senso”?
Pensateci e vedrete che ci divide un muro nel quale non ci scontriamo perché è di gomma. Ogni qualvolta veniamo catapultati contro, ci respinge e ci fa vibrare all’indietro vietandoci di entrare in quello che è il “non-senso” soltanto perché siamo schiavi del “senso”. Non so se mi spiego …
Ho chiesto a chatgpt DeepSeek di spiegarmi il senso della citazione. Ecco la sua risposta.
Il brano che hai citato da Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll è un esempio del gioco linguistico e filosofico che caratterizza l’intero romanzo. Questo passaggio riflette il tema del nonsenso (nonsense), tipico dell’opera, e offre una riflessione sulla natura della realtà, della logica e del linguaggio.
Analisi del testo:
“Se avessi un mondo mio, tutto non avrebbe senso”:
Qui Alice (o il personaggio che parla) immagina un mondo alternativo, governato da regole diverse da quelle del mondo reale. Questo mondo, però, non seguirebbe la logica a cui siamo abituati, rendendo tutto privo di senso. Carroll gioca con l’idea che la realtà sia costruita su convenzioni e regole che diamo per scontate, ma che potrebbero essere completamente diverse in un altro contesto.
“Niente sarebbe quello che è, perché tutto sarebbe quello che non è”:
Questa frase è un paradosso logico. In un mondo dove le regole sono capovolte, le cose non sarebbero più ciò che sembrano. Carroll suggerisce che la realtà è relativa e dipende dal contesto in cui ci troviamo. Se le convenzioni cambiano, anche il significato delle cose cambia.
“E all’opposto, ciò che è, non sarebbe”:
Qui il paradosso si approfondisce: ciò che esiste nel mondo reale non esisterebbe più in questo mondo immaginario. Carroll sta giocando con l’idea che la realtà sia fluida e che la nostra percezione di essa dipenda dalle regole che accettiamo.
“Capisci?”:
Questa domanda finale è ironica e mette in discussione la capacità del lettore (o di Alice) di comprendere un mondo così illogico. Carroll invita a riflettere su quanto la nostra comprensione della realtà sia legata a strutture logiche e linguistiche predefinite.
Commento:
Questo passaggio è un perfetto esempio dello stile di Carroll, che mescola umorismo, fantasia e filosofia. Attraverso il nonsenso, l’autore sfida il lettore a interrogarsi sulla natura della realtà e sulla logica. Il Paese delle Meraviglie è un mondo dove le regole sono capovolte, e questo permette a Carroll di esplorare domande profonde in modo leggero e giocoso.
Inoltre, il brano può essere interpretato come una metafora della crescita e della scoperta di sé. Alice, nel suo viaggio, impara che il mondo non è sempre come sembra e che la realtà può essere interpretata in modi diversi. Questo tema è centrale nel romanzo, che è spesso visto come un’allegoria del passaggio dall’infanzia all’età adulta.
In sintesi, Carroll usa il nonsenso non solo per divertire, ma anche per stimolare il pensiero critico e filosofico, invitando il lettore a guardare il mondo da una prospettiva diversa.
Tra senso e nonsenso, sul palcoscenico del mondo, continuiamo a recitare a soggetto illudendoci di comprendere quello che facciamo. “Capisci?” Ci chiede Alice. Noi rispondiamo senza capire e siamo contenti.
Il tema del senso e nonsenso in “Alice nel Paese delle Meraviglie” è centrale per comprendere l’opera di Lewis Carroll. La narrazione è caratterizzata da una continua tensione tra logica e assurdità, riflettendo la complessità dell’esperienza infantile e della crescita.
Nel Paese delle Meraviglie, il linguaggio perde il suo significato convenzionale. Alice si trova spesso in situazioni dove le parole non corrispondono ai significati attesi, creando un caos semiotico.
Questo è evidente quando il Brucaliffo discute di identità e cambiamento, mettendo in dubbio le certezze linguistiche di Alice. La frustrazione culmina nel processo contro il Fante di Cuori, dove Alice si rende conto che le regole logiche non si applicano nel mondo surreale che la circonda, esclamando “Non siete che un mazzo di carte!”
Carroll utilizza il nonsenso come strumento per esplorare le pieghe del linguaggio reale. Le sue invenzioni linguistiche, come le parole “portmanteau”, mostrano come il significato possa essere manipolato e distorto.
Questo gioco con le parole non solo intrattiene, ma invita anche i lettori a riflettere sulla rigidità delle convenzioni linguistiche e sociali.
Alice vive un’esperienza sinestetica in cui soggetto e oggetto si confondono. La sua caduta nella tana del Bianconiglio rappresenta l’ingresso in un regno dove le regole della logica sono sovvertite, permettendo un’esplorazione creativa della realtà.
Questo ambiente capovolto simboleggia le sfide dell’infanzia e dell’adolescenza, dove l’assurdo diventa una forma di comprensione del mondo. Le interazioni di Alice con personaggi eccentrici come il Cappellaio Matto e la Regina di Cuori mettono in luce le pressioni sociali che i giovani devono affrontare.
Le leggi capricciose della Regina simboleggiano le aspettative e le contraddizioni del mondo adulto, rendendo evidente la difficoltà di navigare tra senso e nonsenso durante la crescita.
In “Alice nel Paese delle Meraviglie”, il senso e il nonsenso sono intrecciati in un viaggio che esplora l’identità, la crescita e la complessità del linguaggio.
L’opera invita i lettori a riflettere sulle convenzioni sociali e linguistiche, mostrando come l’assurdità possa rivelare verità profonde sull’esperienza umana.[image error]
January 23, 2025
Oltre il “mondo nuovo”: “Il Destino di Nuova Terra”
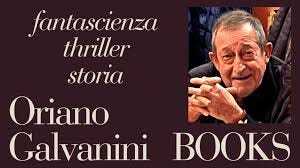 Oriano Galvanini
Oriano Galvanini
Se penso agli anni che ho trascorso leggendo libri, mi accorgo che c’è stato un tempo nella mia vita in cui l’anno 2025 (d. C.) era una data di fantascienza. Ora che ci sono arrivato, però, mi accorgo di aver perso il senso di stupore con il quale in genere si legge la fantascienza. Non mi meraviglio più di niente.
Uomini “compagni” di uomini, donne “compagne” di donne, si uniscono ma non si sposano, famiglie multiple, uteri in affitto, banche di semi, se si desidera un figlio, si prende in prestito o a pagamento un utero e si prenota, basta compilare una scheda e te lo “faranno” come desideri, maschio o femmina, biondo o bruno.
Ho saputo di una donna che si è “unita” con un’altra donna. Desiderano un figlio. Hanno trovato il modo per farlo. Una delle due si è fatto dare il seme dal fratello. Da poco è nato un figlio desiderato. Tutto è possibile. Un vecchio e famoso scienziato ha dichiarato che l’amore tra gli esseri umani è l’amore vero, perchè non è detto che il vero amore serva solo a fare figli. Il vero amore nuovo.
Insomma, siamo oltre il “Mondo Nuovo”, romanzo di fantascienza di genere distopico scritto da Aldous Huxley nel 1932, quasi un secolo fa. La buonanima di mio Padre (classe 1906) lo aveva nella sua biblioteca. Ricordo che avevo una decina di anni quando lo presi tra le mani e cercai di leggerlo senza capirci alcunchè. Solo quando ebbi modo di studiarlo in inglese, durante gli studi all’università, riuscii a capirlo. Tutto mi era più facile. Almeno così credevo.
Con il tempo ho trovato conferma di quella realtà, man mano che “vivevo” in quel “tempo” che lo scrittore inglese aveva anticipato. Non solo lui. C’era anche il “grande fratello” di George Orwell che continua a far sentire sotto nuove spoglie la sua presenza. Questo tempo, che solo poco fa era ieri, che poi è diventato oggi, che non fa in tempo a passare, che è già futuro. Sono trascorsi oltre cinquanta anni e la ruota della vita continua a macinarlo. Un tempo sempre più nuovo.
Magico e romantico era quello di Giulio Verne e dei racconti letti su Urania, la famosa collana di fantascienza della mia gioventù. Mi accorgo che mi ritrovo “oltre”, molto ben oltre. Volete qualche esempio di quotidianità?
Quando agli inizi degli anni sessanta, solo poco più di mezzo secolo fa, decisi di andare in Inghilterra a studiare la lingua, ci impiegai 45 ore per arrivarci. Napoli Roma, Parigi Express, Gare de Lyon, Gare du Nord, Calais Dover, Dover London Victoria Station. Oggi ci vai in un paio d’ore.
Scrivevo a mia Madre una lettera alla settimana via British Mail — Posta Italiana. Non avevamo ancora il telefono. Mio figlio oggi è a Londra per una conferenza di lavoro, mi relaziona in video in tempo reale.
Ricordo che quando ci trasferimmo nella nuova casa, agli inizi degli anni ottanta, per entrare nel parco del condominio, aprii il cancello scorrevole con un oggetto misterioso chiamato telecomando. Mio Padre non credeva ai suoi occhi. Per lui era magìa dell’energia compressa.
Abbiamo assistito all’elezione del nuovo Presidente americano in diretta. Con discrezione, ma in segreto, passano sulla nostra testa centinaia di satelliti. Altri migliaia arriveranno. Grazie al mio smartphone, sono in quotidiano contatto con amici in tutto il mondo, in Giappone o Nuova Zelanda, New York o Los Angeles.
Quanto prima Amazon mi consegnerà a casa i miei amati libri cartacei con un drone alla mia porta. Il libro di cui intendo qui parlare, mi è arrivato sul mio smartphome in digitale. Per leggerlo meglio, ho chiesto all’autore di inviarmi una copia cartacea.
Per comprendere il suo lavoro, ho scaricato l’intera Saga del libro in versione Kindle. Avevo bisogno di comprendere il contesto. Si parla di “destino” quello del pianeta Terra. Ho capito così che è in ballo il nostro futuro, quello degli uomini.
L’oltre di cui parlavo prima, è arrivato. Ho appena iniziato a leggerlo e mi spaventa. L’oltre di cui parla Oriano Galvanini in questo suo ultimo libro, parla di destino. Anche del mio destino.
 Il Libro
Il Libro
Ma chi è Oriano Galvanini? E’ uno scrittore italiano, noto per le sue opere di narrativa, tra cui romanzi di fantascienza e thriller. Ha una formazione unica, avendo lavorato come ufficiale marconista su navi mercantili negli anni ’60. Coincidenze temporali.
Mentre lui navigava il mondo per mare come marconista, io navigavo nel cervello umano in un ospedale mentale in Inghilterra dove lavoravo come studente infermiere. Ognuno ha le sue esperienze. La sua ha influenzato il suo stile di scrittura e le tematiche delle sue opere.
Oriano ama esplorare un futuro distopico segnato da catastrofi ambientali. I temi più discussi includono sopravvivenza e resilienza. Inventa personaggi che affrontano situazioni estreme in contesti distopici, dove la natura umana è posta sotto pressione.
I suoi personaggi sono sempre molto complessi e ben sviluppati. Mistero e giustizia caratterizzano la sua ricerca nella quale la verità è centrale. La trama è inevitabilmente carica di tensione. L’esplorazione e lo sfruttamento dello spazio caratterizza la triologia “La Saga della Fenice”.
Si affrontano temi di colonizzazione e interazione con altre specie. Questa sua ultima opera fa seguito ai precedenti lavori che si realizzano in un arco di tempo che a me pare misurabile soltanto in termini di infinito. Lo stesso autore, in una sua nota, cerca di dare una sistemazione logica spaziale e temporale ai contenuti della sua scrittura.
In ROMA, la prima opera, porta il lettore dal 25 A.E.C. al 15 E.C. Ne La Saga della Fenice lo guida dal 1960 E.C. al 2200 E.C. In HELIOS siamo in pieno 2800, con questa ultima scrittura di “Il Destino della Nuova Terra” viaggiamo nel 3200.
Oriano Galvanini, già provetto marconista, si muove in uno spazio narrativo che è ben oltre il “mondo nuovo” a cui ho accennato prima. Sincronia, diacronia, ucronia e acronia sono le parole chiave nelle quali, per mezzo di un tipico entaglement quantistico, lo scrittore riesce a far entrare il suo lettore.
Sincronia, diacronia, ucronia e acronia sono concetti che, sebbene originariamente sviluppati in ambito linguistico e filosofico, trovano applicazione anche nella sua narrativa, come in particolare nella fantascienza e nei generi letterari alternativi.
La sincronia rappresenta lo studio di un fenomeno in un dato momento temporale, analizzando le relazioni tra elementi contemporanei. Nella narrativa, questo può tradursi in racconti che si concentrano su eventi e interazioni che avvengono simultaneamente, senza esplorare il loro sviluppo nel tempo.
La diacronia si occupa, invece, dell’evoluzione e del cambiamento dei fenomeni nel tempo. Nella sua scrittura, questo approccio è utilizzato per raccontare storie che seguono l’evoluzione di personaggi o eventi attraverso diverse epoche, mostrando come le circostanze cambiano nel corso della storia.
L’ucronìa è un genere narrativo con il quale esplora scenari alternativi a eventi storici reali. Essa immagina come sarebbe stata la storia se determinati eventi fossero andati diversamente. Un genere molto presente nella fantascienza e nella narrativa storica alternativa, dove si interrogano le conseguenze di scelte storiche diverse.
L’acronia, al contrario, si riferisce a situazioni o eventi privi di una collocazione temporale definita. Nella narrativa, questo può manifestarsi in maniera che sfuggono alla linearità temporale, presentando eventi che non seguono una sequenza cronologica tradizionale. Questi approcci sono utilizzati per esplorare e proporre a chi legge idee di viaggio nel tempo o in universi anche non paralleli.
Questi termini offrono strumenti analitici per comprendere e costruire narrazioni complesse. La sincronia e la diacronia permettono di esaminare le relazioni temporali tra eventi, mentre l’ucronia e l’acronia introducono elementi di speculazione e creatività che sfidano le convenzioni temporali tradizionali.
Oriano Galvanini cerca di esplorare non solo ciò che è stato, ma anche ciò che avrebbe potuto essere o ciò che trascende il tempo stesso. Ho letto questa sua ultima opera e estratti delle altre. Credo che il segreto della sua scrittura sia da ritrovarsi in queste quattro parole. Mi viene legittimo chiedere se leggere libri di fantascienza come questi abbia ancora senso in un mondo dove la realtà supera sempre più spesso la fantasia.
Questa è una letteratura che offre una metafora della realtà. Anzi, la violenta, sfruttando anche gravi problemi attuali come il cambiamento climatico, la tecnologia e le dinamiche sociali, credendo di stimolare riflessioni critiche sul presente e sul futuro. Temo, però, che non offra visioni positive o soluzioni possibili.
Non mi pare essere una forma di fantascienza che possa fungere da strumento di elaborazione per immaginare alternative e avvertire sui rischi, contribuire a plasmare la nostra comprensione del mondo. Leggendo questo libro, il lettore scopre che molte delle sue idee idee si sono trasformate in realtà.
Ciò dimostra l’influenza reciproca tra narrativa e progresso scientifico. Ma molto spesso il risultato è negativo o disastroso. Il lettore resta sorpreso, ma anche spiazzato, scioccato e perplesso. Come quando scopre che il protagonista sta in un ufficio al trecentesimo piano di un edificio da qualche parte.
Nella “Saga della Fenice”, Oriano Galvanini incorpora dettagli biografici significativi, riflettendo la sua esperienza come ufficiale marconista. Il protagonista, Giorgio, è un giovane marconista che vive avventure in mare, parallele ai viaggi dell’autore negli anni ’60. La trama ruota attorno alla scoperta di una misteriosa organizzazione, La Fenice, che mira a portare pace e benessere nel mondo.
Galvanini utilizza la figura del marconista per illustrare l’importanza della comunicazione e della tecnologia, elementi che ha vissuto direttamente nella sua carriera. La saga esplora temi di utopia e distopia, collegando le esperienze personali a una narrazione più ampia.
L’autore mi ha inviato un estratto del libro in anteprima. Ho avuto qualche difficoltà a leggerlo in formato digitale. Ho ricevuto cortesemente una copia cartacea e sono riuscito a leggerlo non senza difficoltà. Quando l’autore nel prologo introduce il lettore nel contesto mi sono subito sentito “oltre” i limiti del possibile, catapultato nel 3200 dell’era cristiana.
Ho dovuto cercare aiuto nei canonici interrogativi che mi pongo sempre quando affronto la lettura di un libro. “Chi-cosa-dove-quando-perchè”. Sono le cinque costanti-variabili sulle quali ogni libro viene costruito. Quali siano le più importanti, sia che li si riferisca al contenuto del libro che a chi l’abbia scritto, è compito preciso di un lettore attento se vuole comprendere il valore oltre che il senso del libro.
Mi spiego: io penso che ogni uomo sia riportabile ad un libro, la sua vita può essere simile a quella di un libro. Se, quindi, ogni uomo è un libro, è necessario che di un libro abbia i dovuti riferimenti di lettura: chi-cosa-dove-quando-perché, per l’appunto.
Allora, la domanda è: per chi scrive libri come questi, un autore di fantascienza, oggi, secondo ventennio del terzo millennio dell’Era Cristiana? Chi li legge, sa leggerli? Cosa si propone lo scrittore quando decide scrivere libri di questo genere? Perché dovrebbero essere scritti, e poi letti, se basta invece vivere la comune quotidianità che ognuno di noi è costretto a conoscere?
Personalmente non amo molto i romanzi, sono soltanto storie inventate. Quella che gli anglosassoni chiamano fiction. Mi basta la cronaca quotidiana che spesso supera la migliore fantasia. Per non parlare poi dei personaggi che ogni giorno compaiono sul palcoscenico della vita. Mescolare poi cronaca e scienza mi sembra operazione quanto mai rischiosa.
Amavo questo genere quando ero giovane, dinosauro come mi sento oggi, leggere questa realtà letteraria mi pare impossibile. Non so più distinguere nella storia personale del mio vissuto dove inizia la fantasia e inizia la realtà. Abbonda, esonda la fantasia, mi incalza e mi rincorre la scienza.
Oriano Galvanini ha scritto oltre mille pagine di pura, purissima fantascienza. Leggere libri di fantascienza oggi può rivelarsi una scelta culturale utile e stimolante, ma anche una lettura difficile, soprattutto in un mondo in costante evoluzione. Non si tratta di cercare intrattenimento, ma anche di riflettere su temi futuri, il nostro destino, appunto. E quello della razza umana. Quei temi attuali restano cronaca.
La fantascienza affronta spesso questioni contemporanee come l’intelligenza artificiale, i disastri ambientali e le migrazioni, rendendo le sue narrazioni non solo immaginative, ma anche profondamente connesse alla realtà odierna. Opere che tentano di esplorare paure e speranze legate ai progressi tecnologici, anticipando scenari che possono sembrare distopici ma che riflettono le nostre ansie attuali.
Leggere fantascienza può anche servire come un potente strumento educativo. I romanzi distopici, ad esempio, offrono spunti di riflessione sulla società, sulla politica e sulla libertà individuale. Opere come quelle di Huxley e Orwell non solo intrattengono, ma fungono da monito sulle conseguenze del totalitarismo e della sorveglianza.
Libri come quelli di Oriano Galvanini possono incoraggiare i lettori a sviluppare una mentalità critica nei confronti delle innovazioni scientifiche e delle loro implicazioni etiche.
Queste opere non solo intrattengono ma stimolano anche discussioni su ciò che ci riserva il futuro. Leggere la sua fantascienza è non solo un modo per evadere dalla realtà, ma anche un’opportunità per esplorare idee complesse e attuali. Ci permette di immaginare futuri alternativi e di riflettere su questioni fondamentali della nostra esistenza, rendendola un genere essenziale nel panorama della realtà esistenziale contemporanea.
Molti dei progressi che oggi consideriamo normali, come i droni, la realtà virtuale e l’intelligenza artificiale, sono presenti nella sua scrittura. Ci sono chiare situazioni narrative legate a concetti di robotica e automazione che ora sono parte integrante della nostra vita quotidiana. Non si tratta solo di prevedere il futuro. Oriano riflette anche le ansie e le preoccupazioni della società contemporanea.
Abbiamo bisogno di progetti che elaborino, aldilà di ogni possibile scienza e fantasia, un’idea di destino per una Nuova Terra, per un diverso pianeta. Confesso che non mi piace la copertina di questo suo ultimo libro. Dinosauro come mi sento e penso di essere, non vorrei finire nella fauci di questo “collega”. Non deve esserci fantasia e scienza peggiore di quella realtà nella quale si muovono i 29 personaggi del suo racconto.
[image error]January 19, 2025
Il libro dei sogni della “dolce vita”. In ricordo di Federico Fellini.
 “Tutto ciò che possiamo fare è cercare di raggiungere la consapevolezza che siamo parte di questo imperscrutabile mistero che è il creato. Obbediamo alle sue leggi inconoscibili, ai suoi ritmi e ai suoi mutamenti. Siamo misteri tra i misteri.”
“Tutto ciò che possiamo fare è cercare di raggiungere la consapevolezza che siamo parte di questo imperscrutabile mistero che è il creato. Obbediamo alle sue leggi inconoscibili, ai suoi ritmi e ai suoi mutamenti. Siamo misteri tra i misteri.”
Federico Fellini nasce il 20 gennaio 1920. Sotto il disegno che illustra il suo sogno del 20 agosto ’84 si raffigura semisdraiato sotto un albero, il braccio alzato ad indicare stelle luminosissime che punteggiano d’oro un cielo dipinto in varie tonalità di un blu sempre brillante.
“Il Libro dei sogni” è l’opera più intima di Fellini: raccoglie i disegni che il regista tracciava appena sveglio per illustrare sogni e incubi notturni al suo psicanalista. Un lavoro sulla propria vita onirica iniziato nel 1964 su indicazione di Ernst Bernhard che era stato allievo di Jung: dopo la morte improvvisa di Bernhard, Fellini lo portò avanti per quasi tre decenni.
La copiosa raccolta, disegni sgargianti accompagnati da parole talvolta cancellate e riscritte come un analista freudiano non gli avrebbe mai consentito di fare, è solo uno dei tanti tesori acquisiti dal Comune di Rimini, devoluti dall’associazione culturale Fondazione Federico Fellini che era nata nel 1995 per volontà di Maddalena Fellini, sorella del regista, e dello stesso Comune di Rimini.
Il patrimonio comprende anche 500 opere grafiche e disegni provenienti da fondi appartenuti ad alcuni dei suoi più stretti collaboratori; la biblioteca specialistica composta da libri e riviste, dedicata all’editoria italiana e straniera; la raccolta di foto dei più importanti fotografi di scena, i cui originali sono conservati nei principali archivi. E ancora soggetti, sceneggiature, alcuni scritti inediti, la collezione di locandine e manifesti originali, una sezione audiovisiva con una ricca documentazione proveniente dalle Teche Rai.
 Il Libro
Il Libro
Il “Libro dei sogni” di Federico Fellini, la sua “autobiografia” più sincera, in una versione imperdibile: una scatola delle meraviglie, contenente anche una litografia numerata.
“Così sognava Fellini, e questi straripanti, meravigliosi, avvincenti, divertentissimi ma anche disperatissimi sogni, per anni blindati nel caveau di una banca, vedono finalmente la luce… Il Libro è bellissimo, lo definirei una Divina Commedia onirica.” –
Antonio D’Orrico
Nelle parole dell’amico e critico di cinema Tullio Kezich, il Libro dei sogni è un libro unico e imperdibile, “affascinante come le migliori pellicole del cineasta riminese”. Ora viene riproposto in una versione preziosa, Deluxe, da collezionisti. Il libro dei sogni è un diario, tenuto da Federico Fellini dalla fine degli anni Sessanta fino all’agosto 1990, in cui il grande regista ha registrato fedelmente i suoi sogni e incubi notturni sotto forma di disegni, o nella sua stessa definizione, di “segnacci, appunti affrettati e sgrammaticati”. Coloratissimo viaggio negli sterminati territori della fantasia di un genio, questo libro ha aggiunto un fondamentale tassello allo studio dell’esperienza creativa del grande regista.
L’opera è riproposta in un cofanetto che raccoglie in una versione in fac-simile i due volumi originali esposti al Museo Fellini di Rimini, un volume con le trascrizioni dei testi, i saggi critici e le testimonianze di Lina Wertmüller, Gian Piero Brunetta, Filippo Ceccarelli, Simona Argentieri, Milo Manara e dei curatori Sergio Toffetti, Felice Laudadio e Gian Luca Farinelli; e inoltre una litografia numerata di un disegno di Fellini.[image error]
January 17, 2025
“Una generazione se ne va e un’altra arriva”. Ecco gli “screenagers”
 QOELET o ECCLESIASTE
QOELET o ECCLESIASTELa Generazione Alpha, conosciuta anche come screenagers, comprende i bambini e adolescenti nati tra il 2013 e il 2028. Questa generazione è caratterizzata da una crescita in un ambiente altamente digitalizzato, dove smartphone e social media sono centrali nella loro vita quotidiana. Gli screenagers sono nativi digitali, abituati a interagire con dispositivi fin dalla prima infanzia, il che influisce sulle loro capacità di multitasking (molteplicità di compiti) e sulla loro percezione del mondo. Tuttavia, questa esposizione costante agli schermi solleva preoccupazioni riguardo alla salute mentale e alla dipendenza dai media.
Gli screenagers, o Generazione Alpha, presentano differenze significative rispetto alle generazioni precedenti. Crescono in un ambiente iper-digitale, con schermi presenti fin dalla prima infanzia, a differenza delle generazioni precedenti che hanno vissuto una transizione graduale verso il digitale. Tendono a stabilire contatti umani più limitati, influenzati dall’uso costante di dispositivi, mentre le generazioni passate avevano interazioni più dirette. L’approccio educativo è dominato da risorse digitali e social media, riducendo l’interesse per i media tradizionali, come i libri di carta, la radio e la TV. Queste caratteristiche portano a preoccupazioni riguardo alla salute mentale e alla socializzazione.
Ma quali sono le precedenti generazioni? A quale generazione appartengo io che scrivo e che navigo nel quinto ventennio? Ecco l’elenco delle generazioni a partire dal 1939, il mio anno, quando venni alla luce.
Secondo una diffusa classificazione i nati dal 1926 al 1945 sono definiti come i Tradizionalisti. Hanno vissuto in prima persona le tragedie delle guerre, non hanno fiducia nel cambiamento e sono ancora molto legati a valori quali la famiglia e il lavoro. Non faccio fatica a ritrovarmi. Seguono i Baby Boomers nati dal 1946 al 1964. La Generazione X, nati dal 1965 al 1980. I Millennials ( detta anche Generazione Y) nati dal 1981 al 1996. La Generazione Z, nati dal 1997 al 2012. La Generazione Alpha, nati dal 2013 al 2024.
La Generazione Beta seguirà, con i nati dal 2025 al 2039. Comprende i nati dal 2025 al 2039 e rappresenta i successori della Generazione Alpha sulla linea dell’alfabeto greco. Saranno i primi figli della Generazione Z e cresceranno in un contesto caratterizzato da tecnologie avanzate, come l’intelligenza artificiale, e valori di inclusività e diversità. Gli esperti prevedono che questa generazione sarà curiosa, integrata tecnologicamente e abituata a interagire con realtà sintetiche, sviluppando competenze uniche per affrontare le sfide future.
Sono giovani, nati e cresciuti nell’era digitale, che passano gran parte del loro tempo davanti agli schermi di computer, smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici. Sono i primi venuti al mondo in questi giorni dopo l’inizio del nuovo anno, rappresentanti di una nuova generazione. Sarà seguita da un’altra tra 25 anni, nel 2039. Una categoria di esseri umani che non avrà problemi con IA, anzi con le diverse intelligenze con le quali sapranno interagire e sentirsi a proprio agio.
Meglio dei loro genitori, nonni e bisnonni, sapranno affrontarle per ciò che sono, cioè macchine. La Beta, però, sarà anche la generazione che avrà ricevuto pesanti eredità come ad esempio il cambiamento climatico e la crisi demografica.
Sui loro schermi continueranno a scorrere questi problemi. Il termine è una combinazione delle parole inglesi “screen” (schermo) e “teenager” (adolescente), e sottolinea la forte connessione tra questa generazione con la tecnologia.
Cosa significa essere screenager oggi? Significa vivere in un mondo in continua evoluzione, dove la tecnica gioca un ruolo sempre più importante. È un’opportunità per apprendere nuove competenze e creare relazioni significative, ma è anche una sfida che richiede consapevolezza e equilibrio. Cosa possiamo fare? È importante educare i giovani all’uso consapevole dei nuovi media, aiutandoli a riconoscere i rischi e a sviluppare abilità critiche.
È fondamentale stabilire dei limiti all’utilizzo dei dispositivi digitali, garantendo un equilibrio tra vita online e offline. È importante incoraggiare i giovani a svolgere attività fisiche e a passare del tempo all’aria aperta. È decisivo sviluppare le nuove competenze digitali aiutandoli a diventare cittadini attivi e responsabili.
Chi scrive ha 85 anni. Ho imparato a leggere e scrivere mettendo in fila i caratteri mobili sulla forma della composizione a mano nella tipografia di famiglia. Gli screenager digitano le lettere sullo schermo. Certo, è affascinante confrontare le mie esperienze con quelle degli screenager di oggi. C’è un abisso tecnologico tra la mia generazione e la loro, ma intravedo anche delle affinità sorprendenti. Le differenze principali sono gli strumenti.
Io utilizzavo un sistema manuale e meccanico, composto da caratteri mobili in piombo e anche di legno, mentre gli screenager usano dispositivi elettronici con tastiere virtuali. La composizione a mano era un processo lento e laborioso, che richiedeva una grande precisione e conoscenza della tipografia. La digitazione è molto più rapida e intuitiva. Io avevo un contatto fisico con il testo, mentre gli screenager interagiscono con esso attraverso uno schermo. Correggere un errore nella composizione a mano era un’operazione complessa, mentre correggere un testo digitale è molto più semplice.
Ma c’è un denominatore comune e riguarda la comunicazione. Sia io che gli screenager utilizziamo la scrittura per comunicare i pensieri, anche se i mezzi e le modalità sono completamente diversi. Qual è il valore della mia esperienza oggi? Nonostante le differenze tecnologiche, e una esperienza più che preziosa. Avere imparato a comporre a mano mi ha permesso di sviluppare pazienza e precisione.
Qualità fondamentali per qualsiasi attività che richieda attenzione ai dettagli. Comporre a mano mi ha fatto riflettere sulla struttura delle parole e delle frasi con l’apprezzamento per la parola scritta. Ho sviluppato un profondo rispetto per la parola scritta e per il processo creativo che sta dietro alla produzione di un testo.
Cosa posso insegnare agli screenager?Potrei trasmettere loro il valore della parola pensata e poi scritta, la bellezza della tipografia e l’importanza di comunicare in modo chiaro e preciso. Potrei anche aiutarli a comprendere come la tecnologia ha rivoluzionato il modo in cui comunichiamo e come è importante utilizzarla in modo consapevole e responsabile. Queste esperienze e quelle degli screenager sono diverse, ma si completano a vicenda.
 La Stele di Rosetta
La Stele di RosettaLa mia conoscenza della composizione a mano mi permette di guardare alla tecnologia con un occhio critico e di apprezzare appieno le sue potenzialità. Quando guardo la grande immagine della Stele di Rosetta mi viene naturale riflettere sulle grandi e straordinarie trasformazioni che ha subito la comunicazione umana attraverso la scrittura.
La Stele di Rosetta, come tutti sanno, rappresenta un enigma risolto che ha aperto le porte alla comprensione della scrittura egizia. Scoperta nel 1799, presenta lo stesso testo in tre lingue: geroglifici, demotico e greco antico. Questo decreto del faraone Tolomeo V ha permesso a Jean-François Champollion, nel 1822, di decifrare i geroglifici, svelando così i segreti dell’antica civiltà egizia. La stele è conservata al British Museum e continua a suscitare interesse per il suo valore storico e culturale.
La Stele segna un’importante evoluzione nella scrittura, passando dalla scultura geroglifica all’uso dei caratteri mobili fino alla scrittura digitale. Inizialmente, i geroglifici egizi, incisi sulla stele nel 196 a.C., rappresentavano una forma complessa di comunicazione visiva. Con l’invenzione della stampa a caratteri mobili nel XV secolo, la scrittura divenne più accessibile e diffusa.
Oggi, la scrittura digitale ha ulteriormente trasformato il modo in cui comunichiamo, rendendo l’informazione immediatamente disponibile e interattiva, ma le radici storiche della scrittura rimangono fondamentali per comprendere questa evoluzione. La scrittura digitale ha rivoluzionato il modo in cui comunichiamo rispetto alla scrittura a mano con caratteri mobili. Mentre la scrittura a mano attiva più connessioni cognitive e favorisce la memorizzazione, come dimostrano vari studi, la scrittura digitale offre velocità e facilità di modifica.
La scrittura digitale è pluridimensionale, permette interazioni più complesse e l’uso di ipertesti, mentre la scrittura a mano rappresenta un’esperienza più lineare e personale. La digitalizzazione ha anche reso possibile la comunicazione immediata e collaborativa, trasformando le dinamiche sociali e professionali.
Le principali differenze tra la scrittura su carta e quella su schermo riguardano l’esperienza di lettura e l’elaborazione delle informazioni. La carta offre una sensazione fisica e un’interazione diretta, mentre gli schermi possono risultare più freddi e distaccati. Diversi studi dimostrano che la lettura su carta favorisce una migliore comprensione, specialmente per testi lunghi, rispetto alla lettura digitale, dove si tende a sovrastimare la propria comprensione.
La lettura su schermo è frequentemente interrotta da notifiche e pubblicità, mentre la carta consente una concentrazione maggiore. La scrittura digitale richiede frasi più brevi e chiare, adattate a lettori che cercano informazioni rapide, mentre la scrittura cartacea può permettere uno stile più elaborato. Queste differenze influenzano profondamente come apprendiamo e ci relazioniamo con i testi. Sono le differenze che fanno la storia delle generazioni nel loro inevitabile susseguirsi. La terra resta sempre la stessa. Dice Qoelet. Ma sarà poi vero?
[image error]January 16, 2025
Tre gattini in una cesta. Un segno …

Maestri, docenti e insegnanti, cioè persone che lasciano un SEGNO. Che segno lasciano? Un segno indelebile è fatto di conoscenza. Ovviamente, segni che trasmettono nozioni, competenze e abilità specifiche per ogni materia.
Ma vanno oltre la semplice erogazione di contenuti: stimolano la curiosità, insegnano a ragionare criticamente, a ricercare e a valutare le informazioni. Valori. Trasmettono valori fondamentali come il rispetto, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà.
Modellano comportamenti e atteggiamenti, influenzando le scelte future dei loro studenti. Passioni. Un buon insegnante è appassionato della propria materia e sa trasmettere questa passione ai suoi studenti.
Accende scintille di interesse, stimolando la voglia di imparare e di approfondire. Autonomia. Incoraggiano l’autonomia, la capacità di pensare in modo indipendente e di prendere decisioni consapevoli.
Aiutano i loro studenti a diventare cittadini attivi e responsabili. Relazioni. Creano relazioni significative con i loro studenti, basate sulla fiducia, il rispetto reciproco e l’empatia. Un insegnante che si prende cura dei suoi studenti lascia un segno indelebile nei loro cuori.
Ma quali sono i fattori che rendono un insegnante indimenticabile? La capacità di ascoltare. Un insegnante che sa ascoltare i suoi studenti, che comprende le loro difficoltà e i loro bisogni, è in grado di creare un ambiente di apprendimento positivo e inclusivo.
L’empatia. La capacità di mettersi nei panni degli altri è fondamentale per creare un rapporto di fiducia e per motivare gli studenti. La flessibilità. Un buon insegnante è in grado di adattarsi alle diverse esigenze dei suoi studenti, utilizzando una varietà di metodi e strumenti didattici.
La creatività. La capacità di rendere l’apprendimento divertente e stimolante è un elemento chiave per motivare gli studenti. La passione per la comunicazione. Un insegnante appassionato trasmette ai suoi studenti la gioia di imparare.
Il segno che lasciano maestri, docenti e insegnanti è un’eredità preziosa, un patrimonio di conoscenze, valori e competenze che durano nel tempo. Sono i costruttori del futuro, coloro che plasmano le menti e i cuori delle nuove generazioni.
E io, che segno ho lasciato? Stamattina mia moglie ed io abbiamo incrociato una sua alunna di quella scuola di Sarno che un tempo non lontano si chiamava Liceo Ginnasio “T. L. Caro”. Oltre quarantenne, due figli, giovane, intelligente, anche attraente, ha subito riconosciuto la sua insegnante, dopo oltre trenta anni. Mia moglie si ricordava poco di lei, le ha chiesto chi fosse. Ma la sua alunna ricordava qualcosa di importante che lei aveva fatto in quella classe di ginnasio. Una mattina, l’insegnante di inglese (mia moglie), si era presentata in classe con un cestino con tre gattini da poco nati. Li aveva trovati nel parco di casa sua. Si era intenerita e li aveva salvati, proponendoli ai suoi studenti. Lei ricordava che quei gattini furono adottati dalla classe. Se questo è non è un segno, cos’è un SEGNO che lascia un insegnante?[image error]
January 14, 2025
La fede come mistero
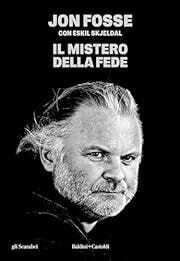 Il Libro
Il LibroJon Fosse, recentemente insignito del Premio Nobel per la letteratura, presenta in “Il mistero della fede” un’opera che riflette il suo profondo percorso spirituale e la sua conversione al cattolicesimo avvenuta nel 2013. Questo libro, scritto in collaborazione con il teologo Eskil Skjeldal, si configura come un dialogo intimo e penetrante sulla fede, l’esperienza umana e la scrittura.
Fosse esplora il suo viaggio spirituale, iniziato con una protesta giovanile contro la Chiesa di Norvegia e culminato in una riscoperta della fede attraverso la scrittura. La sua attrazione per il misticismo cristiano e il quaccherismo si intreccia con una riflessione più ampia sull’esperienza divina e sull’alcolismo, che ha segnato la sua vita. Questo percorso è descritto come una ricerca di significato e riconciliazione, dove ogni esperienza personale diventa un tassello nel mosaico della fede.
La scrittura per Fosse non è solo un mezzo di espressione, ma un modo per avvicinarsi a Dio. Egli afferma che l’arte e la religione condividono un obiettivo comune: comunicare l’ineffabile. Le sue opere tendono a mettere in luce le fragilità umane e a creare un legame tra lettore e autore attraverso la vulnerabilità.
Il libro è caratterizzato da uno stile sobrio ma evocativo, tipico di Fosse. La narrazione alterna momenti di introspezione profonda a dialoghi incisivi con Skjeldal, creando un’atmosfera contemplativa. La struttura del testo permette al lettore di immergersi nei pensieri di Fosse, rendendo palpabile la sua lotta interiore tra fede e dubbio.
“Il mistero della fede” è descritto come un “breve libro prezioso”, capace di offrire una visione unica del pensiero di uno degli scrittori più influenti del nostro tempo. La sua capacità di affrontare temi complessi come la fede, la sofferenza e l’arte rende quest’opera non solo un’importante testimonianza personale, ma anche una riflessione universale sulla condizione umana.
Jon Fosse ci invita a esplorare le profondità della nostra esistenza attraverso le sue parole, rendendo “Il mistero della fede” una lettura indispensabile per chiunque sia interessato alla spiritualità contemporanea e alla letteratura che cerca di dare voce all’indicibile.
Eskil Skjeldal gioca un ruolo cruciale nel dialogo con Jon Fosse in “Il mistero della fede”, fungendo da interlocutore e catalizzatore per l’esplorazione delle esperienze spirituali e delle riflessioni di Fosse. La loro conversazione si sviluppa attorno a temi fondamentali come la fede, la scrittura, l’alcolismo e la sofferenza, creando un contesto in cui Fosse può esprimere le sue idee sulla religione e sulla sua recente conversione al cattolicesimo.
Skjeldal, in qualità di teologo, pone domande incisive che spingono Fosse a riflettere su aspetti complessi della fede e della spiritualità. Questo approccio aiuta a chiarire le motivazioni di Fosse e il suo percorso di vita, rendendo il dialogo non solo una semplice conversazione, ma un vero e proprio scambio intellettuale.
La formazione di Skjeldal come teologo consente di inserire le esperienze personali di Fosse in un contesto più ampio, collegando le sue riflessioni a tradizioni religiose e filosofiche. Questo arricchisce il testo, offrendo al lettore una visione più profonda delle implicazioni teologiche delle esperienze di Fosse.
Skjeldal non si limita ad accettare le affermazioni di Fosse; piuttosto, sfida le sue opinioni su questioni come la morale sessuale e le posizioni della Chiesa cattolica. Questo confronto critico stimola una discussione più ricca e articolata, permettendo a Fosse di esplorare le sue ambivalenze nei confronti della Chiesa.
Eskil Skjeldal contribuisce in modo significativo al dialogo con Jon Fosse, rendendo “Il mistero della fede” un’opera che non solo esplora la conversione personale dell’autore, ma invita anche i lettori a riflettere sulle loro proprie esperienze di fede e spiritualità.
Un libro da leggere e rileggere per poi riflettere.
[image error]MEDIUM
- Antonio Gallo's profile
- 52 followers



