Antonio Gallo's Blog: MEDIUM, page 122
February 14, 2018
Il "folle" Nolano: Giordano Bruno
 Il 17 febbraio di ogni anno, se vi trovate a Roma, non mancate di fare un salto a Campo dei Fiori. Vi troverete circondati da strani ed originali gruppi di persone non facilmente identificabili: atei, anarchici, panteisti, massoni, mistici, cristiani riformatori, liberi pensatori ed anche membri della giunta comunale. Non so se ci saranno anche quelli dei centri sociali. Siamo in periodo pre-elettorale quest'anno. Questi signori fanno sempre comodo.
Il 17 febbraio di ogni anno, se vi trovate a Roma, non mancate di fare un salto a Campo dei Fiori. Vi troverete circondati da strani ed originali gruppi di persone non facilmente identificabili: atei, anarchici, panteisti, massoni, mistici, cristiani riformatori, liberi pensatori ed anche membri della giunta comunale. Non so se ci saranno anche quelli dei centri sociali. Siamo in periodo pre-elettorale quest'anno. Questi signori fanno sempre comodo.
Uno straordinario anniversario che si rinnova da oltre quattro secoli ormai. Si troveranno raccolti ai piedi di una statua eretta nell'altro secolo in ricordo di un frate che venne arso vivo proprio in quel posto. Venne condannato al rogo dalla Inquisizione Romana per l'eresia espressa nelle sue opere e nei suoi comportamenti.
Giordano Bruno nacque a poca distanza da Sarno, nella Valle dei Sarrasti, nel 1548, figlio di un soldato, diventò monaco domenicano a San Domenico Maggiore a Napoli a soli 17 anni. Aveva una intelligenza precoce, eccelleva in filosofia e teologia. Per questa ragione, sin da giovane, fu in continuo conflitto con il pensiero dei suoi superiori. Nel 1576 scappò dal convento per non essere interrogato dall'inquisitore che l'aveva sorpreso a leggere un libro di Erasmo da Rotterdam, una scrittura proibita. Da qui ebbe inizio una vita di peregrinazioni, fughe e nascondimenti per tutta l'Europa. Fu scomunicato "in absentia", ma venne anche nominato docente universitario, istruttore privato di Re Enrico III di Francia, conobbe Elisabetta I a Londra.
Seppe frequentare circoli e ambienti irraggiungibili con la sua innata audacia e anche carisma, per la sua straordinaria memoria ed acuto intelletto. Una vita assolutamente precaria. Tanti amici, quanti nemici. Venne sbattuto varie volte in prigione per il suo pensiero ed i suoi scritti. In pieno Cinquecento viaggiò da Parigi a Londra, Praga a Zurigo, Venezia e Padova. Se avesse potuto avrebbe attraversato anche l'Atlantico, conoscendo ambasciatori, arciduchi, re, imperatori e regine, sempre in cerca di protettori che potessero non solo proteggerlo ma anche comprendere quello che diceva, pensava e scriveva.
A Venezia fu tradito. Qualcuno fece la spia, venne arrestato e processato davanti alla Inquisizione e condannato al rogo il 17 febbraio del 1600. Bruciò mentre fissava il crocifisso che gli veniva offerto. Gaspar Schioppe, un tedesco convertito al cattolicesimo che fu testimone del rogo, scrisse che Bruno, dopo la pronunzia della condanna, disse a chi la leggeva: "Voi avete più paura a leggere questa condanna di me che la devo subire e che accetto".
Per la lunghezza e la spietatezza del processo sarebbe facile dire, oggi, che Bruno fu un martire, perchè credeva non tanto nella verità, ma in quello che lui pensava, allora, fosse non solo la sua verità, ma quella del mondo. La teoria Copernicana, la forza dell'immaginazione, l'idea di Infinito nell'universo, la molteplicità dei mondi e di quelli abitabili. Idee queste che, in quel tempo, non potevano nemmeno essere pronunziate, argomentate. Non si può dire con certezza su quali basi poggiò la sua esecuzione col fuoco del rogo, anche se la sentenza si basò su otto diverse accuse tutte legate al concetto di eresia.
I documenti del processo e quello della dichiarazione respinta di abiura andarono distrutti durante l'invasione napoleonica. Resta indiscutibile il suo contributo tanto al progresso scientifico, quanto alla sua libertà di pensiero ed intelligenza. Le sue intuizioni non avevano nè una base scientifica nè matematica. Alla luce della cognizioni moderne, rimane il fatto che è difficile accertare quello in cui Bruno realmente credeva e sosteneva.
Scrittore quanto mai prolifico e difficile, dalla visione cosmica e super umana. Possiamo dire, comunque, che credeva nella forza della magia nella filosofia. Sosteneva che l'universo era composto da particelle chiamate "atomi". Credeva che una forza divina benigna desse vita all'universo e fosse presente in ogni singola parte di esso. Una sorta di panteismo moderno: "Il Principio dell'Esistenza, Sorgente di ogni Specie, Mente, Dio, Essere, Uno, Verità, Destino, Ragione".
Certamente il suo pensiero e le sue opere non hanno una coerenza logica, ma molti studiosi hanno sostenuto che il suo pensiero contiene il seme di molte idee che fioriranno nel pensiero di molti scrittori e scienziati successivi. Il Nolano era troppo in anticipo sui suoi tempi, e come al solito, non poteva non essere considerato che un "folle". Folle specialmente nella sua visione universale che considerava l'unità di Dio e dell'Universo, bypassando la divisione tra cattolicesimo e protestantesimo. Va detto che nessuno dei tanti patroni che lo conobbero e con i quali lui entrò in contatto, il Re di Francia Enrico III, la regina Elisabetta I, l'Imperatore del Sacro Romano Impero Rodolfo II, durarono nell'appoggio alle sue idee.
Quando Bruno ritornò a Venezia nel 1591, contro i consigli dei suoi amici, stava preparando un libro che voleva presentare a Papa Clemente VIII per invitarlo ad una revisione della teologia canonica. Forse fu questo a farlo ritenere definitivamente un "folle", tanto folle da credere in idee che da tanti potenti venivano ritenute solamente arroganti e presuntuose, maniacali. La studiosa Frances Yates ha scritto in un suo studio che "persone come Giordano Bruno sono tanto incapaci da comprendere il senso di pericolo nella missione in cui si sono lanciate, da sfiorare la megalomania, una condizione mentale che sconfina dalla salute mentale". Un giudizio forse troppo forte e distaccato da quella che fu ed era la realtà del tempo.
Rimane il fatto che il nostro "folle" Nolano è un personaggio che continua ad affascinare non tanto e non solo per i suoi scritti, ancora molto difficili da comprendere, quanto anche per la sua vita misteriosa. Non è un caso se scrittori come James Joyce, Oscar Wilde, Bertold Brecht e tanti altri ne abbiano scritto nei loro libri. Victor Hugo si fece promotore di una raccolta di fondi in Francia per la erezione del monumento a Piazza dei Fiori. Quello che attira particolarmente di Giordano Bruno è la sua figura complessa di uomo e di frate, due condizioni a volte conflittuali, altre volte convergenti. Due identità che hanno dato vita a scritture ancora oggi oggetto di studi e discussioni.
Il suo continuo conflitto con l'autorità nasceva da un problematico rapporto interno alle sue distinte identità di uomo e di frate. Lui sembra, comunque, rimanere un estraneo sia a se stesso che alla sua comunità, un conflitto continuo tra umano e divino, terreno e trascendenza, passato, presente e futuro. Il suo successore, Galileo, diversamente da lui, ebbe modo di ritrattare le sue idee e fu ufficialmente perdonato per le sue idee rivoluzionarie. Bruno, invece, si era spinto troppo in avanti, deviando dalla dottrina cristiana e per questa ragione continua ad essere fuori da quelli che sono gli schemi tradizionali ai quali ogni filosofia basata su una fede deve fare riferimento. Inevitabile lo scontro ed il conflitto con chi fa dell'intelletto il suo strumento di conoscenza, contro ogni limite ed inquisizione.
-----
N.B. Per la stesura di questo post mi sono servito del saggio della scrittrice Stephanie Merritt apparso sulla rivista elettronica qui al link AEON

Published on February 14, 2018 12:06
February 13, 2018
Libri che aiutano a vivere
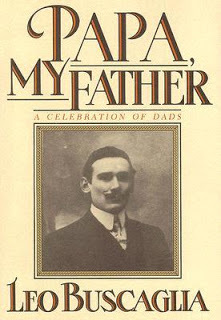 Che i libri aiutino a vivere è una affermazione che credo nessuno possa negare. Cosa sarebbe il mondo senza i libri, senza le biblioteche, senza le librerie e, (lo possiamo dire?), anche senza Internet? Oggi, tutti i libri che si stampano su questa terra sono presenti, non solo in formato cartaceo, ma anche in digitale, sul palcoscenico del mondo. Se ogni uomo è un libro, e ogni libro è un uomo, senza libri la biblioteca dell'umanità sarebbe senza uomini.
Che i libri aiutino a vivere è una affermazione che credo nessuno possa negare. Cosa sarebbe il mondo senza i libri, senza le biblioteche, senza le librerie e, (lo possiamo dire?), anche senza Internet? Oggi, tutti i libri che si stampano su questa terra sono presenti, non solo in formato cartaceo, ma anche in digitale, sul palcoscenico del mondo. Se ogni uomo è un libro, e ogni libro è un uomo, senza libri la biblioteca dell'umanità sarebbe senza uomini. Di tutti i generi, quelli che ho sempre privilegiato sono quei libri che aiutano a vivere. In italiano li chiamano "libri di autoaiuto", dall'inglese "self-help books". Ce ne sono molti nella mia biblioteca, da sempre li compro, li uso e li consulto. Volere è potere, dice un antico detto. La volontà di migliorarsi è il primo passo verso il cambiamento. Prima di rivoluzionare la propria vita, però, bisogna capire in cosa si sta sbagliando per poter correggere il tiro. Se vuoi dare una svolta alla tua vita, ma non sai come fare, prendi spunto da chi ha qualche consiglio da dare.
Ma che cosa è un libro scritto con l'intenzione di aiutare? Come si differenzia dagli altri tipi di libri, sia per genere che argomento? Un genere che non è affatto moderno, bensì antico, risalente, niente di meno che agli antichi "codici" egizi, ben più antichi dei testi che concorrono a formare quella biblioteca di vita che, tutto sommato è la Bibbia, specialmente quella del Vecchio Testamento.
Ma è bene non andare troppo lontano nel tempo. Mi basta ricordare il fiorentino Monsignor Giovanni della Casa con il suo famoso libro, il manuale di belle maniere "Galateo overo de' costumi", scritto probabilmente dopo il 1551 a Calvisano, ma pubblicato postumo nel 1558, che fin dalla pubblicazione godette di grande successo. Non si faceva altro che continuare una tradizione molto in voga nel Medio Evo quando erano in uso libri manuali su come amare, fino a risalire a Cicerone con i suoi tre libri "De Officiis", ed all' "Arte di Amare" di Ovidio.
Da Gutenberg in avanti, con l'avvento della stampa a caratteri mobili e a diffusione popolare, il libro è diventato il compagno fisso di ogni uomo, senza differenze di colore, identità e lingua. Mi è capitato tra le mani un libro di Leo Buscaglia uno noto scrittore statunitense, nonché docente, scomparso qualche tempo fa. Il suo vero nome era Felice Leonardo Buscaglia.
Nacque a Los Angeles, in California, il 31 marzo 1924. I suoi genitori erano italiani, originari di Aosta. Celebre la sua frase rivolta ai suoi studenti in un libro di successo: "La vostra responsabilità più grande è diventare tutto ciò che siete, non soltanto per il vostro beneficio, ma anche per il mio." ("Vivere, amare, capirsi"). In un altro libro, scritto con l'intenzione di onorare i padri, in particolare il suo che si chiamava Rocco, Buscaglia si lascia andare al ricordo di lui quando arrivò in America con una valigia di cartone dall'Italia e gli dimostrò che la vita è una magnifica avventura, oltre che una sfida a cercare e prendere tutto quanto essa possa offrirci.
Gli insegnò ad imparare ad assumersi la responsabiloità di lasciare il mondo in condizioni migliori di come l'aveva trovato. Durante il suo insegnamento universitario divenne famoso con il nome di "Dr. Love". Un tragico evento sconvolse la sua vita di docente quando un suo studente si suicidò. Ebbe modo, così, di approfondire il suo senso della vita, pur tra diffidenze e contrasti nell'ambiente in cui svolgeva il suo lavoro. Molto popolare ed amato dagli studenti, scrisse decine di libri tra i quali questo, su suo padre Rocco, che volle ricordare con alcune frasi chiave a sintetizzare il suo ricordo e il messaggio che gli aveva lasciato:
"Impara a ballare, cantare e sorridere. Ogni cosa è collegata ad un'altra. Non perdere tempo a discutere del dolore, della sofferenza e della morte. Trova un posto tranquillo dove puoi ritrovare te stesso. Non ingannare mai te stesso. La nascita e la morte sono parte di di un ciclo. Nè l'uno, nè l'altro hanno inizio e fine con te. Stai vicino al tuo Dio. E' essenziale amare. L'idealismo è una forza, non una debolezza. La gente è buona se le si offre l'ooportunità di esserlo. La discriminazione, per qualsiasi ragione, è sbagliata. L'autorispetto è essenziale per la vita. Non siamo creati tutti eguali, come davanti a Dio. Siamo responsabili per quelli che non ce la fanno da soli. La crudeltà è un segno di debolezza. Alla base dell'amore c'è impegno ed attenzione. L'amore è indistruttibile, la forza umana più potente. Il cambiamento è inevitabile. Chi crede di sapere tutto è pericoloso."

Published on February 13, 2018 05:30
February 12, 2018
Il tempo per star fermi ed osservare ...

Sette distici a rima baciata di "Leisure" del poeta gallese William Henry Davies (1861-1940), trasposti e amplificati in altrettanti quartetti di endecasillabi ora a rima ripetuta, ora alterna, ora chiusa. Inutile dire che io preferisco la versione in lingua originale. Vale sempre l'espressione "traduttore, traditore". Ma come si fa a tradurre la parola che dà il titolo a questa poesia? "Leisure" in italiano significa "tempo libero", una traduzione senza dubbio riduttiva. La poesia riguarda il tempo della vita, quello che scorre e passa, senza che non ce ne accorgiamo e non facciamo nulla per fermarlo. Ci limitiamo a lamentarci quando è passato, rimpiangiamo per averlo fatto scorrere, senza fermarlo, senza nemmeno rifletterci su.
Ma cos’è dunque questa vita nostra,che di affanni sempre colma si mostra,e il tempo per star fermi ed osservarespesso del tutto ci viene a mancare?
Perché tempo a star fermi non abbiamosotto quieti rami di verdi alpeggi?Perché fissare a lungo non sappiamocome di pecore e mucche le greggi?
Perché tempo per veder non abbiamoquando folti boschetti attraversiamo,dove tonde noci scoiattolininascondono fra l’erba e lor semini?
Perché tempo per veder non abbiamo,in pieno dì, rivi colmi di stellerilucenti e assai vaghe damigelle,come nei cieli notturni un ricamo?
Perché tempo per volgere attenzionialla vera Bellezza non abbiamo,e osservare i suoi piedi non vogliamocome possan danzare e dar spintoni?
Perché tempo ad aspettar non abbiamoche la bocca sua dolce arricchir possaquel grato sorriso che ognora amiamo,e che dai vivi occhi suoi ha preso mossa?
Assai misera è questa vita nostra,se di affanni sempre colma si mostra,e il tempo per star fermi ed osservarespesso del tutto ci viene a mancare.
-----
What is this life if, full of careWe have no time to stand and stare.
No time to stand beneath the boughsAnd stare as long as sheep or cows.
No time to see, when woods we pass,Where squirrels hide their nuts in grass.
No time to see, in broad daylight,Streams full of stars, like skies at night.
No time to turn at Beauty’s glance,And watch her feet, how they can dance.
No time to wait till her mouth canEnrich that smile her eyes began.
A poor life this if, full of care,We have no time to stand and stare.
"Leisure" by William Henry Davies.

Published on February 12, 2018 09:11
February 11, 2018
Review: Le rivoluzioni dell'universo
 Le rivoluzioni dell'universo by Giovanni F. Bignami
Le rivoluzioni dell'universo by Giovanni F. BignamiMy rating: 4 of 5 stars
"Quando ancora a scuola c’erano solo i libri (di carta) e si dovevano
studiare cose barbosissime come le guerre puniche o quelle
di Indipendenza, la Divina Commedia o I promessi sposi, si poteva
contare sull’aiuto di comodi libretti universali, che contenevano
riassunti semplificati, ragionati e molto ben fatti. Erano prodotti
in formato tascabile (quindi facilmente occultabili), dalla benemerita
casa editrice del prof. Ernesto Bignami (nessuna parentela) e
perciò venivano chiamati i «bignamini» o semplicemente i «bignami».
Per quei «carogna» dei prof, prepararsi sul bignami era indice
di pigrizia o superficialità, ma, ripensandoci senza sensi di colpa,
erano meglio di niente…"
-----
"Introduzione
Il bello dell’Universo, e della sua evoluzione passata e futura,
compresa quella dell’uomo, è che è facile da raccontare. Basterebbe
anche un tweet.
Gran botto, nasce materia, poi stelle, molecole, pianeti, Darwin e
noi, tredici miliardi di anni dopo. E domani? Più difficile, ma proviamo.
(140 caratteri, spazi inclusi)
Intorno a questo «tweet universale» si costruiscono, e poi si espandono
a piacere, il racconto dell’Universo – dalla sua nascita alla sua
evoluzione, fino a quando compare homo sapiens – e la descrizione
del suo contenuto, come pure delle ipotesi sul futuro di tutti e di tutto.
Ecco un primo esempio di espansione, riguardante il passato
dell’Universo; si tratta della sigla della popolare trasmissione televisiva
americana (ora anche in Italia, naturalmente), la Big Bang
Theory, solo di poco più lunga del «tweet universale»:
Tutto l’Universo era in uno stato denso e caldo
Poi quasi 14 miliardi di anni fa cominciò l’espansione
Aspetta…
La Terra cominciò a raffreddarsi
Gli autotrofi cominciarono a sbavare
I Neanderthal svilupparono attrezzi
Facemmo un muro (costruimmo le piramidi),
Matematica, scienza, storia, svelare i misteri
Tutto questo cominciò con il big bang!
Siamo già a 294 caratteri, più del doppio del «tweet universale».
È una sintesi poetica non male per una trasmissione di modesta
levatura culturale (vedere per credere): forse è opera di uno dei
protagonisti, quello che vanta un quoziente d’intelligenza 187 (!)
e, almeno lui, qualche volta lo usa.
Che il titolo e la sigla (indovinata) di uno show televisivo di grande
successo mondiale siano dedicati all’Universo non sorprende.
In centinaia di incontri e conferenze, con il pubblico più vario, ho
sempre sentito scoccare una scintilla quando parlavo dell’Universo,
della sua nascita e, soprattutto, della sua morte. Ne ho avuto
conferma anche in TV, lavorando con quell’ineguagliabile maestro
della comunicazione che è Piero Angela.
È chiaro però che in un libro (anche in un bignami…) ci vogliano
un po’ più di caratteri per descrivere, in maniera comprensibile,
l’Universo, la rivoluzione che stiamo vivendo nello studiare la sua
nascita e la sua evoluzione fino a oggi e nell’ipotizzare quanto avverrà
da qui alla sua morte, sempre con noi dentro. Ma, alla fine, il
lettore potrà controllare che questo bignami non conterrà tanti più
caratteri di quelli della serie TV della Big Bang Theory, al massimo
moltiplicati per sole dieci volte…
Parleremo di quattro rivoluzioni nella storia dei metodi di osservazione
dell’Universo. Le prime tre sono successe negli ultimi
15-20 anni, la quarta è prossima ventura, ma, come vedremo, imminente;
eccole in dettaglio:
• rivoluzione cosmologica;
• rivoluzione planetologica, composta da due rivoluzioni distinte,
pur se entrambe centrate su pianeti;
• rivoluzione astrobiologica, che ci prepara all’avvento di AVE
(Astronomia della Vita Extraterrestre).
Per capire le prime tre, ma probabilmente anche quella prossima
ventura, abbiamo utilizzato e utilizzeremo un’altra rivoluzione,
questa volta trasversale: è quella osservativa, sui metodi di studio
dell’Universo intorno a noi. Per fortuna l’Universo si lascia graziosamente
vedere e studiare attraverso cinque diversi messaggeri, di
cui parleremo e che, da poco, siamo diventati capaci di ascoltare,
espandendo enormemente i nostri sensi, poco adatti da soli a percepire
la fenomenologia universale.
In attesa di scoprire, in futuro, chissà quali altri messaggeri celesti,
per il cortile di casa nostra useremo l’astronomia attiva o «di
contatto», che consiste nel «toccare» o visitare da vicino, per ora,
gli oggetti del sistema solare: una conquista dei nostri tempi, che è
stata per millenni il sogno impossibile di astronomi e poeti.
Il racconto dello sviluppo della capacità umana di capire i messaggeri
dell’Universo e di trarne conclusioni sorprendenti, è qui
spesso intervallato da storie di vita vissuta – per esempio, ai telescopi
e con i satelliti di tutto il mondo – o da aneddoti comunque
connessi (talvolta anche in modo incoerente) al racconto. Questo
un po’ perché la tecnologia e la teoria per leggere il cielo sono migliorate
più nel corso della mia carriera (40 anni abbondanti), che
nei 400 anni trascorsi dai tempi di Galileo, e ancora molto di più
che nei 4000 anni da quando homo sapiens ha avuto il tempo e la
voglia di osservare il cielo. Un po’ per vivacizzare una lettura che
potrebbe alla fine risultare piuttosto barbosa.
Parleremo anche del futuro dell’Universo, con noi dentro, e delle
rivoluzioni che devono ancora avvenire, in cielo ma anche sulla
Terra. Naturalmente, senza pretendere di sapere come andrà a finire,
soprattutto per noi, che spariremo molto prima dell’Universo.
L’astronomia è una scienza che, pur studiando il passato del
cielo, permette di prevedere con sorprendente precisione il futuro,
riguardo non solo alla posizione di un pianeta, al ritorno di una
cometa o alla luminosità di una stella periodica, ma anche a fenomeni
che avvengono su scale di tempo molto più lunghe, anche di
miliardi di anni. Certezze a lungo termine, per esempio, le abbiamo
a proposito dell’evoluzione e della fine del Sole (e quindi della
Terra) ossia della parte dell’Universo che a noi, antropocentristi
accaniti, interessa di più…
Diciamocelo: magari viviamo nell’Universo sbagliato. Questa è
l’insana conclusione alla quale sono arrivati alcuni miei sciagurati
protolettori. Altri invece ne hanno tratto la convinzione di esistere
nell’unico Universo per noi possibile. È certo vero che se le costanti
maggiori della fisica (come il valore numerico della carica elettrica
di protone o elettrone, o la costante della legge di gravitazione
universale) cambiassero i loro valori numerici anche di pochissimo,
la vita forse non sarebbe mai decollata. Se, per esempio, il Sole
esistesse solo da 5 milioni di anni, anziché da cinque miliardi, non
ci saremmo noi a guardarlo. Altri invocano il principio antropico,
secondo una versione del quale la finalità dell’Universo sarebbe solo
quella di ospitarci. Ce n’è per tutti i gusti: fanno subito capolino
filosofia, religioni, pregiudizi… come sempre, quando andiamo a
cercare l’origine delle cose.
Sono dubbi che possiamo permetterci il lusso di avere da quando
abbiamo cominciato a capire, una ventina di anni fa, che di Universi,
dentro il nostro, ce ne sono più di uno. E forse anche tantissimi
altri che, per ora, restano inaccessibili alle nostre osservazioni (ma
ci stiamo lavorando).
L’idea di Universo, infatti, è cambiata radicalmente, non solo per
astronomi, cosmologi e scienziati vari, ma anche per tutti noi, da
quando abbiamo scoperto che ci sono due Universi in più, quello
della materia oscura e quello dell’energia oscura, due entità delle
quali non sappiamo niente. Per la natura della materia oscura azzarderemo
una primizia, anzi, una previsione un po’ folle: qualcosa
nato nel Big Bang e che da allora gioca a nascondino con i fotoni
più energetici dell’Universo.
L’ultima vera rivoluzione in cosmologia è recentissima, e viene,
in parte, da Kip Thorne, un grande scienziato, bravissimo a fare
divulgazione e scienza attraverso i film. È lui che ha scoperto, insieme
ad altri, le onde gravitazionali, aprendo una nuova finestra
sull’Universo. La rivoluzione gravitazionale è nata insieme a quella
astronomico-planetologica generata dalla scoperta di nuovi pianeti
intorno alle stelle della nostra galassia, anche a quelle molto vicine
a noi. Molti di questi pianeti sembrano simili alla Terra, quindi perfettamente
«abitabili», adatti a ospitare la vita come la conosciamo.
Se Giordano Bruno aveva ragione – come l’aveva, e l’ha poi pagata
cara –, stiamo per scoprire una pluralità di mondi e di vite
intorno a noi. Mica male, come rivoluzione, questa scoperta prossima
ventura: forse la più grande della storia dell’umanità. O meglio,
sarà il più grande regalo che la scienza potrà fare al resto del
mondo. Speriamo che lo capisca, impegnato com’è a guardare la
Big Bang Theory. Per adesso, sappiamo che l’unica cosa che ci impedisce
di trovare un altro Universo là fuori, è la limitatezza della
nostra capacità di osservazione. Sarà un Universo diverso da tutti
gli altri, e sarà quello che più ci attrae e terrorizza insieme: l’Universo
della vita aliena.
Per precauzione, comunque, ricordiamo che la lettura dell’ultimo
capitolo, che racconta come si concluderà l’avventura di homo
sapiens e come finirà l’Universo, è esplicitamente sconsigliata al
lettore impressionabile, come l’ottovolante al luna-park è sconsigliato
ai deboli di cuore. Chi la vorrà affrontare lo farà a suo rischio
e pericolo. Ma niente panico: una lieve postilla fornisce, alla fine,
formule taumaturgiche per esorcircizzare eventuali eccessi di angosce
cosmiche."
View all my reviews

Published on February 11, 2018 14:11
Review: Viaggio nel tempo. La storia del mondo attraverso le mappe antiche
 Viaggio nel tempo. La storia del mondo attraverso le mappe antiche by Kevin J. Brown
Viaggio nel tempo. La storia del mondo attraverso le mappe antiche by Kevin J. BrownMy rating: 5 of 5 stars
Piano dell’opera: 2 mappe allegate a ciascun volume
1. L’alba della cartografia da Peutinger a Keplero
2. Il secolo d’oro olandese e la nascita delle mappe moderne
3. I francesi e l’immaginario cartografico positivista
4. La prospettiva dell’estremo Oriente
5. La cartografia scientifica
6. Cartografia fantasiosa e di propaganda
7. Gentiluomini viaggiatori ed esploratori in poltrona nel XIX secolo
8. La fantasia e i mondi che non esistono
Un viaggio quanto mai affascinante nel tempo, su come gli uomini hanno immaginato e visto la Terra, il nostro miserioso pianeta. Quello era il loro "mondo". Oggi questa parola sappiamo essere quanto mai impropria. Il mondo che conosciamo oggi è ben altra cosa da quello che questi artisti, cartografi, studiosi, mercanti e viaggiatori hanno disegnato in tutte le immaginazioni possibili, con i mezzi che avevano a loro disposizione. Artisti, pittori, disegnatori si mescolano con avventurieri, politici, scienziati e studiosi nel tentativo di conoscere quello che in quel tempo era il "mondo", ma che oggi sappiamo essere soltanto uno dei tanti pianeti, galassie ed universi che questi cartografi non avrebbero mai potuto immaginare ...
"Nel 1554 in occasione della fiera del libro che già all'epoca, dopo l'invenzione della stampa a caratteri mobili di Gutenberg, si teneva con grande successo a Francorforte, un celebre professore, poco più che quarantenne, Gerardus Mercator, incontrò un giovane di Anversa, Abrahamus Ortelius. I due erano molto diversi e non solo per via dell'età o dell'aspetto fisico. Mercator, matematico e astronomo oltre che geografo, corrispondeva all'idea del «dotto» rinascimentale. Univa cultura umanistica e ricerca scientifica e non disdegnava la sperimentazione tecnologica. Era nato da una famiglia tedesca trasferitasi nelle Fiandre e aveva imparato a lavorare materiali metallici nonché, in particolare, a incidere su ottone e rame. Aveva realizzato due splendidi globi complementari, l'uno terrestre e l'altro celeste, che ancora oggi suscitano l'ammirazione di chi li osserva nel Palazzo Ducale di Urbania. Ortelius, invece, che apparteneva a un'altra generazione (aveva 16 anni meno di Mercator) proveniva anch'egli dagli studi umanistici e scientifici, nutriva una enorme passione per la geografia, ma, grande viaggiatore, aveva avviato una sua fortunata attività di librario.
Quell'incontro fu importante, anzi fondamentale, per la storia della cartografia. Mercator convinse il giovane Ortelius, ambizioso, intellettualmente vivace, a occuparsi di geografia e di cartografia in maniera scientifica. Non si era ancora nel pieno di quello che gli storici avrebbero chiamato il «secolo d'oro» della civiltà olandese ma se ne assaporavano le premesse. Dall'incontro fra Mercator e Ortelius nacquero gli atlanti e i portolani che si sarebbero rivelati essenziali per il futuro delle esplorazioni, dello studio della geografia e, anche, della storia. Mercator, che aveva inventato un nuovo sistema di proiezione rimasto legato al suo nome, negli ultimi anni della sua vita pubblicò un Atlas che recava nel frontespizio l'immagine del mitologico Atlante e che conteneva mappe relative ai Paesi Bassi, alla Francia, alla Germania, all'Italia, alla Grecia. Dal canto suo, l'amico-rivale Ortelius riuscì ad ottenere il monopolio della pubblicazione degli atlanti. Le sue mappe, divenute ben presto famose, le redigeva raccogliendo informazioni attraverso una fittissima rete di corrispondenti amici sparsi per l'Europa, una rete che comprendeva persone di ogni genere, matematici e cartografi, navigatori e finanche corsari e occultisti: da Francis Drake a John Dee.
La storia della cartografia è, naturalmente, molto più antica degli atlanti di Mercator e di Ortelius come dimostrano i volumi curati da un noto collezionista di mappe e autorevole studioso della materia, Kevin J. Brown, e proposti in una bella edizione speciale da Il Giornale. È una storia che comincia con i primi documenti cartografici provenienti dall'antichità classica. Uno di questi che apre il primo dei volumi di Brown e che mi ha particolarmente colpito è la cosiddetta Tabula peutingeriana che offre una prima rappresentazione del mondo romano antico in età imperiale e che mette in risalto strade e vie di comunicazione. Si tratta di una rappresentazione che, letta in controluce, offre una spiegazione, da un punto di vista storico, delle vicende che resero grande Roma e ne favorirono l'ascesa e l'espansione e cioè la combinazione fra vocazione mercantilistica e capacità militare: una combinazione resa possibile dalla costruzione di strade e ponti. Di quella mappa il cartografo fu un personaggio eccezionale: Marco Vipsanio Agrippa, amico e fidato collaboratore di Ottaviano Augusto.
Più in generale, la storia delle mappe, delle carte geografiche, dei portolani, degli atlanti, dei mappamondi consente di cogliere il succedersi delle epoche storiche. Qualche esempio. All'età d'oro della cartografia fiamminga, quella di Mercator e di Ortelius per intenderci, funzionale alla grande espansione commerciale dell'Olanda, succedette, con la nascita dello Stato assoluto propiziata da Richelieu e Luigi XIII e con il consolidarsi dello stesso ad opera di Luigi XIV, una nuova fase che vide lo spostamento a Parigi dei centri di produzione dell'attività cartografica e vide persino la creazione della carica di «primo geografo del Re» ricoperta da Guillaume Delisle. Questi fece scomparire dalle rappresentazioni cartografiche quelle terre immaginarie di cui si favoleggiava molto nella letteratura filosofica, utopistica e fantastica. Eppure, a ben vedere, anche le mappe che riproducevano territori inesistenti popolati da esseri semiselvaggi e strani animali ovvero da comunità ideali e felici, avevano una loro consistenza «storica» perché riflettevano aspetti della speculazione filosofica del tempo e talune mode intellettuali, come l'esotismo e l'orientalismo che affascinarono l'Europa. E che dire, poi, del nuovo trasferimento del centro di produzione e di irradiamento della cartografia da Parigi a Londra nel XIX secolo se non che esso fu effetto di un evento epocale come la Rivoluzione francese?
Sul rapporto fra storia e geografia c'è una battuta, celebre e calzante, di un geografo francese dell'Ottocento, noto per le sue idee anarchiche, Elisée Reclus: «la geografia non è altro che la storia nello spazio come la storia è la geografia nel tempo». Mappe e carte geografiche costituiscono un tramite concreto e percepibile fra le due discipline. E hanno, comunque, un grande fascino: quel fascino visionario del quale furono preda tanti intellettuali come Italo Calvino e Jorge Louis Borges. Il quale ultimo legò il proprio nome a un delizioso frammento che, citando una cronaca apocrifa del XVII secolo da lui inventata di sana pianta, raccontava di un'epoca e di un impero nei quali l'arte della cartografia aveva raggiunto una perfezione tale che i cartografi avevano voluto creare «una Mappa dell'Impero, che uguagliava in grandezza l'Impero e coincideva puntualmente con esso»: una mappa che le generazioni successive, non senza empietà, avrebbero abbandonato alle «inclemenze del sole e dell'inverno»."
Francesco Perfetti - IL GIORNALE 06/10/2017
View all my reviews

Published on February 11, 2018 14:08
Review: Cervello. Manuale dell'utente. Guida semplificata alla macchina più complessa del mondo
 Cervello. Manuale dell'utente. Guida semplificata alla macchina più complessa del mondo by Marco Magrini
Cervello. Manuale dell'utente. Guida semplificata alla macchina più complessa del mondo by Marco MagriniMy rating: 4 of 5 stars
"Il cervello offre un servizio straordinario e irreplicabile. La contemporanea disponibilità di un sistema sensoriale per la percezione dell’ambiente, di un sistema nervoso per il controllo dell’apparato motorio, nonché di una coscienza integrata per discernere e decidere, le regalerà anni di continua esistenza. Come diceva il celebre inventore Thomas Alva Edison, «il corpo serve a portare in giro il cervello». Un modo bizzarro per dire che noi siamo il nostro cervello.
Il mondo è popolato da milioni di manuali. Sul sito www.manualsonline.com ce ne sono oltre 700mila, uno per qualsiasi macchina si possa avere: dalla friggitrice al tosaerba, dallo spazzolino elettrico alla porta del garage.Eppure, in questo microcosmo di informazioni spicciole, non si fa cenno alla macchina più importante che ognuno ha in dotazione. Il cervello è una macchina. Quantomeno nel senso che compie una complessa serie di calcoli in parallelo per decodificare in tempo reale le informazioni che gli arrivano dalle numerose “periferiche” sensoriali collegate, la più complessa delle quali è la vista. La risposta del cervello può essere paragonata a un algoritmo, come se la mente fosse il software che “gira” sull’hardware dell’encefalo ...
Ma il cervello non è una macchina in senso letterale. Non è né hardware né software. Wetware, lo chiama qualcuno. Dove quel “wet”, bagnato, sottolinea la natura biologica della macchina cerebrale. È il frutto più meraviglioso – e misterioso – dell’Evoluzione. È meraviglioso perché non c’è nulla, nell’intero universo, che possa eguagliarlo per complessità. Eppure è fatto degli stessi atomi della Tavola periodica che compongono le stelle, pazientemente arrangiati in modo da produrre il pensiero, la parola e l’azione. E quindi un sacco di altre cose: dalla storia alla filosofia, dalla musica alla scienza.
È misterioso perché proprio la scienza – una creazione del cervello stesso – sa di non saperne ancora abbastanza. Cioè quasi nulla. Non solo non si sa bene come funzioni il cervello, ma non c’è neppure un consenso su cosa sia veramente. Figurarsi se c’è un’intesa su cosa sia la coscienza, la sua caratteristica più strabiliante, la proprietà cerebrale che ha acceso secoli di incomprensioni e di dibattiti furibondi, e non solo fra teologi e filosofi. A titolo d’esempio, non c’è un’intesa unanime neppure su quella frequente perdita di coscienza chiamata sonno: si contano più di venti teorie alternative sul perché l’encefalo abbia bisogno di addormentarsi (mentre intanto continua a lavorare).
Se è per questo, non c’è consenso nemmeno sulla natura dei disturbi del sonno e su alcune sgradite conseguenze, come la depressione. E ovviamente, indovini un po’, non esiste un approccio o un’idea comune sulla depressione. E si potrebbe andare avanti così, all’infinito. Eppure, sappiamo un sacco di cose. I primi filosofi si chiedevano se la mente risiedesse nel cervello o nel cuore, con esponenti autorevoli come Aristotele che propendevano per il secondo. Oggi sappiamo che il cervello è il centro di controllo del sistema nervoso di tutti i vertebrati e di buona parte degli invertebrati. Sappiamo attraverso quali stadi si è evoluto. Sappiamo di cosa è composto. Sappiamo che conserva il codice genetico in ogni cellula, e sappiamo leggerlo.
Abbiamo nuove tecnologie come la fMRI (risonanza magnetica funzionale) o la MEG (magnetoencefalografia) che ci permettono di osservare le attività cognitive mentre avvengono. Stiamo avanzando a rotta di collo nella comprensione retrospettiva dell’intero sistema ...."
View all my reviews

Published on February 11, 2018 14:04
Review: Il secondo cervello
 Il secondo cervello by Michael D. Gershon
Il secondo cervello by Michael D. GershonMy rating: 3 of 5 stars
Secondo cervello, una nuova concezione dell'uomo. Il Prof. Gershon ci presenta una rivoluzione copernicana nella concezione dell'organismo umano: la visione del corpo dominato dalla mente lascia il posto a una visione integrata, dove l'intestino è un secondo cervello. La caduta dell'impero retto dal cervello unico sovrano apre la via a un sistema pluricentrico. La storia di questa scoperta è anche la conferma di alcune conoscenze tradizionali: l'affermazione neurobiologica della stretta connessione tra mente e corpo, in particolare tra cervello e intestino.
Nella storia della medicina moderna, l'intestino per molto tempo è stato considerato una struttura periferica dell'organismo, deputata a svolgere funzioni se non marginali, sicuramente secondarie rispetto a più nobili attività svolte da altri organi quali il cervello e il cuore.
La radice di questo pregiudizio è rintracciabile nell'antica idea platonica del corpo visto come composto dal soma — il corpo inerte del morto — vivificato dalla psiche — l' anima — che conferisce vita e intelligenza al tutto. Più tardi Cartesio si sentirà in obbligo di sottolineare la predominanza di una res cogitans deputata a controllare e dirigere la passiva res extensa, inerte.
Nel corso della storia della medicina, in questa visione che assegna al corpo il ruolo di passivo esecutore di ordini impartiti dall'alto, nel ruolo di imperatore si alterneranno differenti organi. I principali coordinatori dell'organismo saranno essenzialmente due: cuore e cervello. L'intestino non sarà mai coinvolto in queste guerre di palazzo e nei secoli resterà relegato nell'oscuro ruolo di cloaca dei palazzi imperiali.
Solo la medicina cinese azzarderà una sua promozione a Ministro delle Dismissioni, ma ciò non lo avvicinerà di un passo a quella stanza dei bottoni da cui gli organi imperatori coordinano le attività funzionali dell'intero organismo. È pur vero che in questo lungo periodo le menti più eccelse avevano dovuto constatare come le più nobili passioni o le idee più audaci potessero essere ridotte al nulla da banali mal di pancia. Come afferma Gershon, «Nessuno riesce a pensare seriamente se la sua mente è concentrata sulla toilette». Tuttavia queste insurrezioni coliche non avevano mai dato origine a riflessioni serie sui rapporti intercorrenti tra cuore, mente, cervello e intestino.
La scoperta dell'intestino «sede indipendente di integrazione ed elaborazione neurale» costituisce, quindi, un'importante innovazione, che ha rilevanti implicazioni a livello della valutazione delle relazioni organismo/intestino, ma anche, e soprattutto, a livello di un mutamento di concezione della struttura dell'uomo, di cui probabilmente siamo solo agli albori. Ma non basta.
Le importanti scoperte di Gershon portano a intravedere nell'intestino non un regno oscuro e caotico, contrapposto all'impero chiaro e ordinato del cervello, bensì un altro ordine, un altro tipo di strutturazione, non per questo barbara. Fornisce gli elementi di base per capire come l'attività dell'imperatore, cuore o cervello che sia, venga condizionata dagli influssi di questo regno periferico, non meno di quanto essa condizioni la vita e il funzionamento dell'intestino stesso.
In questo senso, uno dei meriti principali dell'autore è proprio la sua capacità di far emergere con chiarezza come l'uomo non possa essere paragonato a una macchina o a un robot perché, in realtà, è una struttura complessa, ove tutte le parti, in costante contatto tra loro, contribuiscono in maniera paritetica allo sviluppo e al mantenimento dell'unità dell'essere, nella salute come nella malattia.
View all my reviews

Published on February 11, 2018 13:56
Bergogliate linguistiche: "zitellanza"
 "Zitellanza" (Ogni riferimento è puramente casuale)
"Zitellanza" (Ogni riferimento è puramente casuale)Papa Francesco ha una sua personale linguistica: inventa parole-etichette, le cosidette "bergogliate". L'ultima, dopo "misericordiando", "spuzzare", "mafiarsi", "nostalgiare", è questa: "zitellanza", ovvero l'arte usata da molti preti che si perdono in pettegolezzi alla maniera di tante cosidette "zitelle".
Chiamiamole pure "begogliate", per non dire poi di qualche altra parola che sarebbe poco ortodossa, ed anche offensiva, ma questo modo di comunicare quanto mai moderno di Papa Francesco, attira l'attenzione anche di chi non si intende non solo di linguistica ma anche di religione. Eufemismi, gergo, perifrasi, dal gr. eyphēmismós, der. di eyphēmízō "dire parole di buon augurio", comp. di eu- "bene¹" e phēmí "dire".
Una figura retorica che consiste nel sostituire l'espressione propria con un'altra di significato attenuato, per comunicare al meglio qualcosa che già si sa, ma che si fa fatica ad accettare. E lui sembra che faccia di tutto per dare ad ogni parola il significato augurale, un modo nuovo di leggere la realtà e consigliare adeguati comportamenti.
Lo si potrebbe interpretare anche come "humour", ma questa parola di origine anglosassone ci porterebbe lontano in questo discorso. Meglio, perciò, parlare di "messaggio neologista" nato tra i "bits & bytes" dei nuovi media e del modo nuovo di leggere ed interpretare la realtà.
Saranno anche novità linguistiche, resta il fatto che hanno un obiettivo preciso: farsi comprendere da tutti, arrivare là dove non è sempre possibile far pervenire un messaggio che racchiude, nasconde, o porta dentro qualcosa che deve essere accettato, se non come un dogma, almeno come un vecchio comandamento.
Prendiamo ad esempio la parola "misericordiando". Deriva chiaramente da "misericordia", vista nella sua dimensione di spazio e tempo. Quel gerundio sta, infatti, ad indicare "qualcosa" vista nel suo divenire, messa in azione da qualcuno, da qualche parte, per una qualche specifica ragione. E cos'è questo "qualcosa"? La misericordia.
Facile a dirsi, difficile a spiegare cosa sia questo sentimento: amore, compassione, pietà, perdono, virtù. La parola dal latino ‘misericors’, composto dal tema di ‘miserere’ = aver pietà e ‘cor’ = cuore. Con il termine si intende quindi un sentimento di pietà e compassione per l’infelicità altrui, che spinge ad agire per alleviarla, soccorrendo, perdonando o desistendo da una punizione.
Sarebbe di conseguenza errato considerare la misericordia un puro sentimento, poiché essa non può concretizzarsi se non nell’atto di soccorrere e offrire un aiuto concreto. Ecco perchè ho detto prima che è una parola che si realizza nel tempo e nello spazio. Come fa, allora, un rappresentante di Cristo, e della sua azione su questa terra, ad insegnare a chi lo segue, come si realizza questo sentimento, farlo diventare virtù, trasformandolo in azione?
Che dire poi della parola "spuzzare" riferita alla corruzione? il termine “spuzza” potrebbe essere corretto, non nuovo alla cultura di chi l'ha ripescata. La sua origine risalirebbe all’inizio del secolo passato. Tra la fine dell’800 e l’inizio del '900. Infatti, Piemontesi, Liguri e soprattutto Veneti, abbandonarono i loro paesi per andare a cercare fortuna in Argentina. Proprio nella capitale Buenos Aires – città natale di Papa Francesco – nacque il dialetto “Lunfardo”, parlato dagli italiani emigrati in terra sudamericana, che in associazione al dialetto veneto avrebbe dato vita a questo vocabolo.
"Se la società costringe poveri a 'mafiarsi' va in miseria". Non credo ci sia bisogno di dire molto su una frase di questo tipo. La parola chiave ha una risonanza linguistica mondiale. "Quando una società ignora i poveri, li perseguita, li criminalizza, li costringe a 'mafiarsi', quella società si impoverisce fino alla miseria, perde la libertà e preferisce l'aglio e le cipolle della schiavitù". L'immagine, anzi lo scenario che uno si fa nella mente, a leggere una frase del genere, è talmente efficace che quasi sembra di avere in bocca il sapore acre, forte e penetrante sia dell'aglio che della cipolla.
La rivista "Limes" ha scritto che "il Papa ha saputo togliere il dialetto da una periferia geografica e farlo simbolo di una periferia esistenziale". Non saprei dire se questi "bergoglismi" sono il frutto casuale di un parlare estemporaneo, oppure sono più meditati, scelti, voluti e, in quanto tali, rimangono nella versione ufficiale e definitiva dei discorsi papali seguendo i consigli di chi cura e coordina la sua comunicazione mediatica.
Francesco forgia parole nuove, per vincere l’usura e la scontatezza dei termini comuni, che irrimediabilmente corrodono l’esperienza. Una rivoluzione che passa anche attraverso le parole, esemplificando ed abbattendo un patrimonio linguistico e comunicativo, quello papale, che in passato aveva bel altri registri linguistici.
Dietro una voluta semplificazione del messaggio può nascondersi anche il rischio della banalizzazione. Se "mortificare" è uno dei tanti sinonimi di questa parola di origine francese, allora gli eufemismi bergogliani possono pure significare negare, abbattere, rinunciare alla tradizione, al passato ed alla sua identità.

Published on February 11, 2018 08:09
February 4, 2018
Review: Breve storia di chiunque sia mai vissuto: Il racconto dei nostri geni
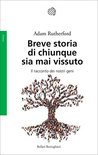 Breve storia di chiunque sia mai vissuto: Il racconto dei nostri geni by Adam Rutherford
Breve storia di chiunque sia mai vissuto: Il racconto dei nostri geni by Adam RutherfordMy rating: 4 of 5 stars
La vita di un libro non finisce con l'ultima pagina. Questa frase l'ho letta alla fine di questo libro che ho letto in versione Kindle. Desidero chiarire questo perché quando leggo in versione digitale non è come leggere sulle pagine di carta. Non è il caso che io qui dica ancora una volta quale sia la differenza tra questi due tipi di letture. Mi basta ricordare a me stesso che leggere sulle pagine di un libro cartaceo significa confrontarsi con la "solidità" di ciò che l'autore del libro intende comunicare a chi legge, mentre la lettura digitale rimane quanto mai liquida, volatile ed evanescente.
Il contenuto di questo libro non ha nessuna di queste tre ultime qualità citate. Tutta scienza, dati, fatti i quali hanno una loro "solidità", che solo la pagina di un libro stampato può contenere. Da questa solidità il lettore, poi, può e deve procedere per i necessari approfondimenti. Che ci sia bisogno di saperne di più e meglio, me ne sono reso conto, ignorante come sono, anzi ero, di tutto quello l'autore di questo libro mi ha saputo trasmettere.
Il lessico finale, che lui ha voluto astutamente aggiungere per chiarire in breve sintesi alcune parole chiave, mi ha fatto comprendere quanto io abbia bisogno di approfondire questi importanti contenuti. Ma una conclusione, se non un giudizio, almeno la posso fare. La grande scienza, la grande conoscenza, il grande, vero sapere "pesa", e ha bisogno per questo di cautela, coraggio, volontà per cercare di varcare quel muro di mistero nel quale siamo avvolti.
I geni, il DNA, il genoma, con tutto il resto, e vi assicuro che il resto non è poco. La parola che sintetizza ogni cosa resta sempre la stessa, nonostante la "grande" scienza: nebbia. Una parola che, guarda caso ben si accoppia con un'altra: religione. La scienza, senza la religione, non potrà mai spiegare il mistero del nostro essere e non essere. Entrambe dovranno scrivere l'ultima pagina ...
View all my reviews

Published on February 04, 2018 23:37
January 31, 2018
Review: A Short History of Truth: Consolations for a Post-Truth World
 A Short History of Truth: Consolations for a Post-Truth World by Julian Baggini
A Short History of Truth: Consolations for a Post-Truth World by Julian BagginiMy rating: 3 of 5 stars
Elogio delle verità. Avete letto bene: non esiste la verità, esistono tante verità, l'autore ne identifica dieci, inquadrandole in altrettante aree che possono avere risonanze diverse. A queste verità succede quella che comunemente al giorno d'oggi viene chiamata "post-verità". Che significa questo? Mi pare di poter dire, allora, che la lista si allunga. Alla domanda "quid est veritas?" nemmeno il Cristo diede una risposta. Non perché non sapesse darne una, Lui non era uno stupido. Lo fu, invece, chi gliela pose quella domanda. Non si rendeva conto, infatti, che la Verità' ce l'aveva davanti. Il Cristo lo era, ma nessuno osò pensarlo e dirlo. Venne riconosciuto soltanto "dopo", quando si "compì" la storia. Posso dire, allora che nemmeno l'autore di questo ennesimo libro sulla verità riesce a spiegarci cosa esattamente essa sia. Tre stelle sono anche troppe, forse.
View all my reviews

Published on January 31, 2018 13:01
MEDIUM
Nessuno è stato mai me. Può darsi che io sia il primo. Nobody has been me before. Maybe I’m the first one.
- Antonio Gallo's profile
- 52 followers



