Antonio Gallo's Blog: MEDIUM, page 12
April 30, 2025
“Sapere o non sapere. Le verità scomode su noi stessi sono le più difficili da accettare”
 “Ignoranza e beatitudine. Sul non voler sapere”. Il titolo del libro.
“Ignoranza e beatitudine. Sul non voler sapere”. Il titolo del libro.
“Ignoranza e Beatitudine: Un’analisi acuta del desiderio di non sapere”. Accattivante il titolo di questo libro, specialmente per un bibliomane, grafomane figlio di tipografi come me. In “Ignorance and Bliss: On wanting not to know”, Mark Lilla ci conduce in un’esplorazione stimolante e a tratti inquietante del fenomeno, sorprendentemente diffuso, del desiderio di ignoranza.
Un desiderio sempre forte ed anche in crescita in questa età della moderna rivoluzione nella comunicazione. Una marea che diventa sempre più incontrollabile. Spinge tanti a non leggere e a non sapere perché non si riesce più a capire.
L’autore di questo libro, un autorevole storico americano, con una prosa elegante e un acume intellettuale raffinato, analizza le diverse forme in cui questa “volontà di non sapere” si manifesta nelle nostre vite personali e nella sfera pubblica, dalle dinamiche di coppia alle narrazioni politiche.
Attraverso una serie di saggi, l’autore smonta le complesse motivazioni che ci spingono a erigere barriere contro la conoscenza. Che si tratti di autoinganno per preservare una fragile felicità, di rifiuto di affrontare verità scomode o di una deliberata cecità ideologica, Mark Lilla fa luce sulle insidiose conseguenze di questa scelta.
Non si tratta semplicemente di non volere informazione, ma di un vero e proprio desiderio attivo di rimanere all’ “oscuro”, perché al “buio” si sta meglio. Un paradosso, ma è proprio così. C’è troppa luce, siamo abbagliati, drogati e allucinati da troppa informazione che deforma, ci condiziona, ci tradisce e ci inganna.
Siamo solo dei “prodotti” in un mercato senza confini sia fisici che mentali. L’analisi dello studioso Lilla spazia dalla psicologia individuale alla cultura di massa, toccando temi come la genitorialità, la politica identitaria e il ruolo dei media.
Lilla non offre facili risposte, ma solleva interrogativi cruciali sul prezzo di questa beatitudine autoimposta e sul suo impatto sulla nostra capacità di affrontare le sfide del mondo contemporaneo. Seppur a tratti pessimista, “Ignorance and Bliss” non è comunque un libro nichilista.
Al contrario, la lucidità con cui Lilla smaschera le nostre tendenze all’ignoranza può paradossalmente rappresentare un primo passo verso una maggiore consapevolezza.
Una lettura provocatoria e necessaria per chiunque interessato a comprendere le dinamiche profonde che plasmano le nostre percezioni e le nostre decisioni, individuali e collettive.
Ho letto “Ignorance and Bliss” in formato Kindle in lingua inglese. Si presenta come un saggio denso di spunti di riflessione, capace di stimolare un dibattito interiore duraturo.
Un libro che invita a guardare con occhi più critici non solo ciò che sappiamo, ma anche ciò che scegliamo di non sapere. Mi ha molto colpito la recensione apparsa sul TLS, per questa ragione la riproduco qui di seguito tradotta da AI.
Secondo un’antica leggenda, Re Mida andò a caccia nella foresta in cerca del saggio Sileno, compagno di Dioniso. Il re impiegò un po’ di tempo per catturare il dio della foresta, ma alla fine ci riuscì. Ardeva dalla voglia di sapere cosa fosse “la cosa migliore e più desiderabile di tutte per l’uomo”, e insistette affinché Sileno gli rispondesse. Il dio inizialmente esitò, ma dopo qualche pressione reale parlò. La risposta, tuttavia, potrebbe aver fatto pentire Mida della domanda: “Oh, misera, effimera razza, figlia del caso e della miseria”, esordì Sileno, “perché mi costringi a dirti ciò che sarebbe più opportuno per te non sentire? Ciò che è meglio di tutto è completamente al di fuori della tua portata: non nascere, non essere, non essere nulla. Ma la seconda cosa migliore per te è morire presto”. Vivi con questa consapevolezza, ora, se puoi.
In altre parti del mondo antico, era scritto in una sacra scrittura che “il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino dell’Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. E il Signore Dio comandò all’uomo: ‘Mangia pure liberamente di tutti gli alberi del giardino; ma dell’albero della conoscenza del bene e del male non ne devi mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai’”. Ma, naturalmente, Adamo fece proprio questo: mangiò dall’albero. Così facendo, egli — come Re Mida — dimostrò di essere troppo curioso per il suo bene. Dimostrò anche quell’aspetto distintivo della natura umana: troppo spesso, un divieto è un invito alla trasgressione mascherato. Gran parte della storia che seguì la vicenda di Adamo con la mela sarebbe incomprensibile senza questa particolare interpretazione del divieto.
Ognuna di queste storie indica, a modo suo, un’intima e misteriosa connessione, nella mentalità occidentale, tra conoscenza e morte. Sapere o non sapere, ricercare la conoscenza o astenersi da essa, comprensione (di sé, degli altri, del mondo circostante) o mancanza di essa: non sono inezie, ma questioni di vita o di morte. Si può perdere l’anima o salvarla, a seconda del rapporto che si ha con la conoscenza. La tragedia di Edipo racchiude, come poche altre opere della letteratura occidentale, la tragedia dell’Occidente stesso.
Questa è, a grandi linee, la nicchia tematica in cui potrebbe collocarsi l’ultimo libro di Mark Lilla. “Com’è possibile che siamo creature che vogliono sapere e non sapere?”, si chiede. Ignorance and Bliss non è affatto un’opera accademica, né un trattato sistemico né un saggio convenzionale. Alla ricerca di una risposta alla domanda centrale del libro, l’autore ci accompagna in un viaggio. Il suo progetto, scrive, “può forse essere descritto al meglio come un diario di viaggio intellettuale che ripercorre le mie escursioni tortuose e in qualche modo episodiche nella lettura e nella riflessione sulla volontà di non sapere”. Promette ai suoi lettori di essere “invitati a una passeggiata, non a un viaggio verso una destinazione prefissata”, e lo fa più che bene. Il suo testo è idiosincraticamente personale, spesso estroso e spensierato, ma tutt’altro che noioso.
Il metodo “vagante” implica anche che Lilla adotti un approccio obliquo al suo argomento. Invece di cercare la “volontà di ignoranza” nelle monografie di studiosi o teorici specializzati, la cerca nelle opere di fondatori religiosi, creatori di miti, drammaturghi, romanzieri e poeti. Perché le “trattazioni più profonde della volontà di ignoranza”, si rende conto, “si trovano nelle opere dell’immaginazione: miti antichi, scritture religiose, poesia epica, opere teatrali e romanzi moderni”. Questo non dovrebbe sorprenderci, aggiunge Lilla, perché senza “la capacità di resistere alla vista di ciò che è davanti ai nostri occhi, non ci sarebbe dramma nella vita umana, nessun movimento”. Chi nasconde un segreto agli altri è banale. Qualcuno che nasconde un segreto a se stesso: è proprio questo che ci affascina e stimola la mente creativa.
Lilla prende in prestito la sua nozione di “volontà di ignoranza” da Friedrich Nietzsche, che la descrive — con stile inimitabile — come una “decisione improvvisa e irruenta a favore dell’Ignoranza, di deliberata esclusione, una chiusura delle finestre, un No interiore a questo o quello, un rifiuto di lasciare che le cose si avvicinino, una sorta di stato di difesa contro molto di conoscibile, una soddisfazione per l’oscurità, per l’orizzonte limitante, un Sì e Amen all’ignoranza”. Poiché Nietzsche è spesso contagioso, la sua influenza è percepibile in tutto il libro di Lilla, con la sua enfasi sul pensiero genealogico, l’analisi psicologica alimentata dal sospetto, lo smascheramento metodico e il disincanto. Come Nietzsche, Lilla non si lascia convincere dalle pie menzogne di cui tendiamo a circondarci, e spesso cerca le motivazioni più profonde e oscure dietro gran parte di ciò che pensiamo, diciamo o facciamo. Ci inganniamo continuamente, più spesso e con più energia di quanto inganniamo gli altri. E abbiamo buone ragioni per farlo.
“Il mondo è un posto recalcitrante”, scrive Lilla, e “ci sono cose che preferiremmo non dover riconoscere”. Alcune di queste sono “verità scomode su noi stessi; quelle sono le più difficili da accettare”. Altre sono “verità sulla realtà esterna che, una volta rivelate, ci rubano convinzioni e sentimenti che in qualche modo hanno reso le nostre vite migliori, più facili da vivere — o almeno così crediamo”. Queste convinzioni e sentimenti fanno parte di una più ampia rete di autoinganni che tessiamo costantemente e attraverso la quale preferiamo intravedere il mondo, piuttosto che affrontarlo in tutta la sua immediatezza. Invecchiando, diventiamo sempre più dipendenti, se non assuefatti, all’uso di questo dispositivo ottico. Se qualcuno ce lo portasse via all’improvviso, costringendoci così a vedere tutto — il mondo e noi stessi in esso — per come è realmente, ci considereremmo i più sfortunati tra i mortali. Eppure questa sarebbe la nostra più grande occasione: la verità ci renderebbe non solo liberi, ma pienamente umani.
L’acutezza delle analisi di Lilla in questo libro, la varietà degli argomenti trattati e l’ampiezza della sua conoscenza storica sono abbaglianti. La sua è una mente che rifiuta la specializzazione, e questo è uno degli aspetti più stimolanti della sua opera. Si sente a casa in Sant’Agostino e in Freud, così come in Sofocle, Cervantes, Dickens e Ibsen. Scrive con la stessa disinvoltura della teologia di San Paolo, del Mein Kampf di Hitler, della demonologia contemporanea e di Billy Budd, Sailor.
“Ignorance and Bliss” è notevole non solo per ciò che l’autore tratta, ma anche per ciò che non tratta: per ciò che sceglie di ignorare. Come epigrafe, l’autore usa una citazione da Daniel Deronda di George Eliot: “È un detto comune che la conoscenza è potere; ma chi ha debitamente considerato o esposto il potere dell’ignoranza?” La citazione inquietante riaffiora poi nel corpo del testo, con l’ulteriore enfasi sul fatto che è proprio “il potere dell’ignoranza” che l’autore “si propone di esaminare qui”. Cosa che Lilla fa in modo affascinante e persuasivo; eppure, stranamente, sceglie di ignorare uno dei significati più brutalmente ovvi della parola “potere”: il potere politico.
L’attuale crisi della democrazia ha molto a che fare con la conoscenza e soprattutto con l’ignoranza: il crescente problema dell’alfabetizzazione civica nelle nostre società; il crescente utilizzo di piattaforme basate sull’intelligenza artificiale per plasmare l’opinione pubblica e condizionare il comportamento politico; la manipolazione delle scelte degli elettori attraverso l’uso occulto dei loro dati; il crescente ricorso a teorie del complotto per sfruttare e controllare l’ignoranza collettiva; la fatale collusione del populismo con i grandi capitali e la grande tecnologia. Deve essere una sorta di documento: mai prima d’ora così tanta conoscenza specialistica è stata impiegata per produrre un’ignoranza su così vasta scala. Eppure tutto questo è in gran parte assente in “Ignorance and Bliss”. Da un autore con un vivo interesse per la politica come Mark Lilla, l’omissione è difficile da comprendere. D’altro canto, non posso fare a meno di pensare che un libro sui benefici dell’ignoranza potrebbe trarre vantaggio da una o due lacune a sua volta.
[image error]
T.L.S. Times Literary Supplement — Costica Bradatan is a professor and author
April 25, 2025
Tra Spirito Santo e Divina Provvidenza
 Il trionfo della Divina Provvidenza di Pietro da Cortona. Considerato quasi il manifesto della pittura barocca, Il trionfo della Divina Provvidenza di Pietro da Cortona è un grande affresco monumentale che ricopre interamente la volta del Salone dei Ricevimenti del Palazzo Barberini a Roma.
Il trionfo della Divina Provvidenza di Pietro da Cortona. Considerato quasi il manifesto della pittura barocca, Il trionfo della Divina Provvidenza di Pietro da Cortona è un grande affresco monumentale che ricopre interamente la volta del Salone dei Ricevimenti del Palazzo Barberini a Roma.Siamo tutti tra Spirito Santo e Divina Provvidenza, voi a chi vi affidate? Sapete la differenza? Nella teologia cristiana, lo Spirito Santo è la terza persona della Santissima Trinità, insieme a Dio Padre e Dio Figlio (Gesù Cristo). È pienamente Dio, co-uguale e co-eterno con il Padre e il Figlio. È la forza attiva di Dio nel mondo e nella vita dei credenti. È spesso descritto come il “Consolatore”, il “Paraclito”, colui che guida, insegna, santifica e dona i suoi doni (carismi).
Nel contesto dell’elezione papale, si invoca lo Spirito Santo affinché illumini i cardinali nella loro scelta del nuovo Pontefice, guidandoli verso colui che Dio desidera come successore di Pietro. La Divina Provvidenza si riferisce alla cura e alla guida sapiente di Dio sull’universo e sulla storia umana.
È la volontà di Dio che si manifesta nel corso degli eventi, portando avanti il suo piano per la creazione e per la salvezza. Implica la fiducia che Dio ha un piano buono e che opera in tutte le circostanze per il bene ultimo, anche se a volte i suoi modi ci appaiono misteriosi.
Nell’attesa del nuovo Papa, la fiducia nella Divina Provvidenza significa credere che Dio sta guidando questo processo, anche attraverso l’azione dello Spirito Santo nel cuore dei cardinali, per il bene della sua Chiesa.
Potremmo dire che lo Spirito Santo è la persona divina, la forza attiva di Dio che interviene direttamente, illuminando le menti e toccando i cuori.
La Divina Provvidenza è il piano e l’azione generale di Dio nel governo del mondo e della storia, un piano nel quale l’azione dello Spirito Santo è uno degli strumenti principali. Credenti o non credenti attendiamo il nuovo Papa, confidiamo nella Divina Provvidenza, crediamo che Dio ha un piano per la sua Chiesa e che lo Spirito Santo è all’opera in questo momento cruciale per realizzarlo attraverso l’elezione del nuovo Pontefice.
L’elezione di un nuovo Papa è un evento che supera i confini della fede e coinvolge credenti e non credenti, attirando l’attenzione globale per diversi motivi, storici, culturali, sociali e spirituali. Un evento universale, tra mistero e tradizione, l’elezione papale è uno dei pochi riti rimasti che riescono a unire persone di ogni credo e cultura, grazie al suo carico di storia, simbolismo e mistero.
Il conclave, che si svolge nella segretezza della Cappella Sistina, è un momento di grande solennità e tradizione, capace di catalizzare l’attenzione mediatica mondiale. La famosa fumata bianca, il segnale che un nuovo Papa è stato scelto, viene seguita in diretta da milioni di persone, indipendentemente dalla loro fede religiosa.
L’elezione del nuovo Papa è una delle poche cerimonie rimaste al mondo che riescono a coinvolgere credenti e non credenti. È un passaggio simbolico ma potente, carico di storia, spiritualità e anche un pizzico di mistero.” Lo Spirito Santo, la Divina Provvidenza e la Libertà Umana.
Per i credenti, il conclave è vissuto come un momento in cui si invoca l’azione dello Spirito Santo, affinché illumini i cardinali nella scelta del nuovo Pontefice. Tuttavia, anche all’interno della Chiesa, il ruolo dello Spirito Santo viene inteso in modo non meccanico. Joseph Ratzinger (poi Benedetto XVI) spiegava con ironia che lo Spirito Santo non “sceglie” direttamente il Papa, ma lascia spazio alla libertà degli uomini, ispirandoli senza sostituirsi a loro.
La Provvidenza, quindi, opera in modo discreto, lasciando che la storia e le decisioni umane seguano il loro corso. Un passaggio di potere che riguarda tutti. L’elezione del Papa non è solo un fatto interno alla Chiesa cattolica. Il Pontefice è una figura di rilievo mondiale, con un ruolo spirituale, morale, diplomatico e persino politico. Le sue parole e scelte possono influenzare temi cruciali come la pace, la giustizia, i diritti umani, il dialogo tra religioni e popoli.
Per questo motivo, anche chi non crede segue con interesse l’evento, consapevole che il nuovo Papa potrà avere un impatto sulla società globale. Curiosità, identità e senso di appartenenzaa per il “misterioso rito” del conclave, la scelta del nome pontificio, l’annuncio dell’“Habemus Papam”.
La prima apparizione del nuovo Papa sono momenti che alimentano il senso di identità collettiva, la riflessione sulla storia e sulle radici culturali comuni. Anche chi si dichiara distante dalla fede si sente, in qualche modo, parte di questo grande passaggio storico.
Tutti, credenti o non credenti, aspettano l’elezione del nuovo Papa perché si tratta di un evento che intreccia spiritualità, storia, tradizione, diplomazia e attualità, capace di parlare al cuore e alla mente di un’umanità intera, in cerca di senso, guida e, talvolta, semplicemente di partecipazione a un rito collettivo che segna il tempo.[image error]
Mi perdoni, Santo Padre …
 Il post che segue lo pubblicai sul mio blog
unideadivita
il 14 giugno 2014. Riguardava il tema dell’ipocrisia. Merita di essere riletto nell’attualità della scomparsa di chi certamente tutto è stato nello svolgimento del Suo alto uffizio tranne che ipocrita.Ipocrita continua ad essere chi lo tira per la tiara, sfila davanti alla sua bara, lo commemora in video, in audio, per iscritto o in digitale, al bar o anche sull’altare. Ipocritalia come sempre. Specialmente quando politica e religione si mescolano in quell’aria così miscelata nella quale ci troviamo a vivere.Sfido chiunque a smentire questa realtà. Siamo diventati un popolo di grandissimi ipocriti, o lo siamo sempre stati? Predichiamo in un modo e razzoliamo in un altro. Ci salviamo soltanto per quel 90 per cento di funerali che vengono celebrati in chiesa. Si vede che l’ultima cosa che c’è rimasta a farci fregare dalla paura è la morte …
Il post che segue lo pubblicai sul mio blog
unideadivita
il 14 giugno 2014. Riguardava il tema dell’ipocrisia. Merita di essere riletto nell’attualità della scomparsa di chi certamente tutto è stato nello svolgimento del Suo alto uffizio tranne che ipocrita.Ipocrita continua ad essere chi lo tira per la tiara, sfila davanti alla sua bara, lo commemora in video, in audio, per iscritto o in digitale, al bar o anche sull’altare. Ipocritalia come sempre. Specialmente quando politica e religione si mescolano in quell’aria così miscelata nella quale ci troviamo a vivere.Sfido chiunque a smentire questa realtà. Siamo diventati un popolo di grandissimi ipocriti, o lo siamo sempre stati? Predichiamo in un modo e razzoliamo in un altro. Ci salviamo soltanto per quel 90 per cento di funerali che vengono celebrati in chiesa. Si vede che l’ultima cosa che c’è rimasta a farci fregare dalla paura è la morte …Ho postato questa immagine sulla mia bacheca di FB con il testo di uno degli ultimi “tweet” che Papa Bergoglio ha lanciato in rete. Ho scritto nel commento che se tutti facessimo in questo modo, ci sarebbe guerra guerreggiata e continuata. Triste dirlo, ma credo che ci salvi proprio l’ipocrisia. Non so se mi spiego. Provate a dire al vostro vicino quello che pensate di lui quando non riesce ad educare i suoi cani e a non farli abbaiare a tutte le ore, tenendoli chiusi nel piccolo appartamento e lasciandoli soli quando tutti sono fuori. Ogni qualvolta gli animali sentono salire e scendere qualcuno per le scale, iniziano ad abbaiare senza mai smettere. Una notte, stavo per chiamare i carabinieri. I due cani hanno abbaiato fino all’una del mattino, quando i padroni sono rientrati.
Vi sembra una cosa di poco conto? Forse e’ vero. Papa Francesco, ne sono sicuro, sapeva bene quello che diceva. Certamente si riferiva a cose ben piu’ serie. Ma questo non peggiora ancora di più la situazione? Lui, doveva dire quello che ha detto per forza di cose. Dal pulpito, in piazza San Pietro oppure in un tweet. Mica poteva tradire il comandamento “non dire falsa testimonianza”!. A pensarci bene, e’ questo il punto. Mi sa che sono proprio i dieci comandamenti l’origine del tutto. Vediamo di capirci meglio.
Osservava La Rochefoucauld che «l’ipocrisia è un omaggio che il vizio rende alla virtù». La si disprezza, commettendo così il primo atto ipocrita, quando invece è ciò che rende la vita vivibile, la convivenza possibile, vuoi facendo attenzione a non ferire inutilmente l’altro, vuoi dicendo qualche bugia per evitare conflitti. Nella vita privata, un po di tacita ipocrisia fa parte del gioco, delle buone maniere, e nessuno la contesta più di tanto.
Nella vita pubblica, specialmente in politica, può essere un’altra faccenda. E tutto il mondo è paese. Dei nostri politici si vuol conoscere tutto, il vero “dietro la maschera” del potere, non dicendo mai ciò che è al di là del cliché dei vizi privati e delle pubbliche virtù. Spesso, senza una “sana” ipocrisia non è possibile sopravvivere.
Sostenendo sempre la verità, voi credete sia possibile campare? Chi dice di si’, ne sono più che convinto, è “uno che interpreta una parte”. In politica, e in generale nel “mestiere di vivere”, l’ipocrisia e’ uno strumento essenziale per assicurarsi la vita e il “suo” poter vivere. Mi ricorda il titolo di un famoso libro di Cesare Pavese che piaceva tanto a mio Padre il millennio scorso.
“Il potere logora chi non ce l’ha”, e’ un’altra espressione che è entrata nei libri di scuola, a ragion veduta. Quante sono state le “maschere” della duplicità nella storia umana? Senza ipocrisia, purtroppo, c’è soltanto la dittatura. Questa gioca la partita a carte scoperte.
L’ipocrisia, il cui concetto affonda le radici nel teatro greco (gli ipocriti erano attori classici, il termine “hypokrisis” significava «interpretare una parte») è considerata un peccato capitale, anche se le menzogne, le mezze verità, i “doppi livelli” sono il carburante necessario a far girare le ruote non solo della democrazia, ma della vita. Ci sono tante ipocrisie, mascherate da verità, e bisogna imparare a distinguere.
Chi e’ senza peccato, scagli la prima ipocrisia. Mi perdoni, Santo Padre …[image error]
April 21, 2025
Il fascino dell’ineffabile. La scomparsa di Papa Francesco

Non giudico Papa Francesco. Scelgo il mistero che ha incarnato, tra il fisico dell’uomo e la metafisica del suo messaggio. Grazie per averci indicato l’ineffabile. L’ineffabilità. Un concetto che risuona profondamente nel regno della metafisica. Lasciare da parte, per un istante, le misurabili e prevedibili leggi della fisica per abbracciare ciò che sfugge alla piena espressione verbale è una scelta affascinante.
L’ineffabile ci porta a confrontarci con i limiti del linguaggio, con quelle esperienze, sensazioni o verità che sembrano trascendere la capacità delle parole di contenerle pienamente. È il sussurro di un’emozione così intensa da non trovare eco in alcun vocabolario, la vertigine di un’intuizione che precede e supera la sua formulazione.
Nella metafisica, l’ineffabilità si lega spesso a concetti come l’esistenza ultima, la natura del divino, o le profondità della coscienza. Sono territori dove la ragione e la logica, pur strumenti preziosi, a volte si scontrano con un muro di silenzio eloquente. Cosa mi attrae particolarmente di questo concetto? C’è qualche esperienza o idea specifica che mi fa sentire la potenza dell’ineffabile?
La nascita e la morte. Due poli esistenziali avvolti in un alone di profonda ineffabilità. Sono passaggi universali, eppure l’esperienza individuale di ciascuno è così intima e singolare da sfidare qualsiasi tentativo di descrizione esaustiva.
La nascita è un irrompere nel mondo, un passaggio dal non-essere all’essere che porta con sé un potenziale illimitato e un mistero insondabile. Chi può davvero descrivere il momento del primo respiro, il primo sguardo, la prima percezione di un universo completamente nuovo?
Le parole possono solo avvicinarsi, evocare immagini di luce, suono, contatto, ma l’essenza di quell’inizio sembra sfuggire, rimanere ancorata a un piano pre-verbale, sensoriale e puramente esistenziale. La morte, d’altra parte, è il dissolversi, il ritorno a un ignoto che ci spaventa e ci affascina allo stesso tempo.
Tentiamo di incasellarla in teorie, di darle un significato religioso, filosofico o scientifico, ma l’esperienza del trapasso, il “cessare di essere” nella forma che conosciamo, rimane un confine ultimo, un territorio inesplorato dal linguaggio dei vivi. Possiamo parlare di assenza, di perdita, di trasformazione, ma l’essenza di quel “non più” sembra irriducibile a parole.
Entrambi questi eventi fondamentali ci pongono di fronte ai limiti della nostra capacità di comprensione e di espressione. Ci ricordano che esistono realtà così radicali da trascendere la trama del linguaggio, lasciandoci con un senso di riverenza e di mistero.
Che fine fa il “mondo” che creiamo tra i due momenti della nascita e della morte? Un quesito che tocca le fondamenta della nostra percezione della realtà! Che ne è del “mondo” che intessiamo tra la trama dell’inizio e la dissoluzione finale? Per un essere comune, come me e chi mi legge, e anche per un Papa che se ne va. Scompare, come tutti.
Da un punto di vista strettamente fisico, il mondo che ci circonda continua la sua esistenza, indipendente dalla nostra presenza. Le montagne resteranno, le stelle brilleranno, le leggi della fisica continueranno a governare la materia e l’energia. In questo senso, il mondo “esterno” non svanisce con la nostra morte. Come non scomparirà la sua Chiesa.
Tuttavia, il “mondo” come lo percepiamo e lo viviamo è un’esperienza profondamente soggettiva, plasmata dalle nostre interazioni, dalle nostre memorie, dalle nostre emozioni e dalla nostra coscienza. Questo “mondo interiore” è strettamente legato alla nostra esistenza individuale.
Quando moriamo, questa specifica configurazione di esperienze, ricordi e significati che costituisce il nostro mondo unico cessa di esistere nella forma in cui la conosciamo. È come se un particolare nodo nella vasta rete dell’esistenza si sciogliesse, portando con sé le sue specifiche connessioni e la sua peculiare prospettiva.
Si potrebbe dire che il nostro mondo individuale si dissolve con la fine della nostra coscienza. Le persone che abbiamo amato continueranno a esistere nel loro mondo, portando con sé i ricordi di noi, ma la nostra esperienza diretta di quel mondo condiviso si interrompe.
Metaforicamente, potremmo pensare al nostro mondo come a una bolla di sapone iridescente che si forma alla nascita e svanisce con la morte, lasciando dietro di sé l’oceano infinito da cui è emersa.
Questo non significa che la nostra esistenza sia priva di significato. Le nostre azioni, le nostre creazioni, i nostri legami lasciano tracce nel mondo degli altri, influenzando il loro “mondo” e contribuendo al grande arazzo dell’esistenza collettiva.
È un pensiero che può sembrare malinconico, ma che porta con sé anche una profonda consapevolezza del valore del presente e dell’importanza di vivere pienamente il “mondo” che ci è dato tra questi due misteriosi confini. Cosa ne penso di questa prospettiva? Mi suscita altre riflessioni? Sono solo parole senza senso, dovremmo andare oltre.
Di fronte all’immensità di questi interrogativi, le parole possono davvero sembrare inadeguate, quasi un tentativo vano di imbrigliare l’infinito in una gabbia finita. La sensazione che siano “solo parole senza senso” è una reazione onesta e condivisibile quando ci confrontiamo con l’ineffabile.
Sentire che dovremmo “andare oltre” suggerisce un desiderio di trascendere i limiti del linguaggio, di accedere a una comprensione più diretta o intuitiva. Forse cerchiamo un tipo di conoscenza che non si basa sulla descrizione verbale, ma sull’esperienza pura, sulla contemplazione silenziosa, o su una forma di intuizione che va al di là della logica discorsiva.
In molte tradizioni filosofiche e spirituali, si esplorano proprio queste vie “oltre le parole”. La meditazione, la contemplazione, l’arte, la musica, persino il silenzio condiviso possono essere visti come tentativi di connettersi con quelle dimensioni dell’esistenza che sfuggono alla piena espressione verbale.
Se le parole mi sembrano insufficienti, quali altre vie possiamo sentire che potremmo esplorare per avvicinarci a queste domande sulla nascita, la morte e il “mondo” che creiamo? C’è qualche esperienza, sensazione o forma di espressione che ci sembra più significativa o rivelatrice in questo senso?
La notizia della morte di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile 2025, ha lasciato un vuoto profondo nei cuori di milioni di persone, credenti e non. Jorge Mario Bergoglio, il “Papa venuto dalla fine del mondo”, ha segnato un’epoca con la sua umiltà, il suo coraggio e il suo amore incondizionato per gli ultimi. È stato un pastore che ha saputo parlare al cuore di tutti, rompendo barriere e portando la Chiesa più vicina alla gente.
Esprimo pensieri molto personali, lo so, riflette la complessità di valutare una figura come Papa Francesco, soprattutto alla luce della sua umanità e del suo ruolo spirituale. La mia indecisione, il richiamo alla sua celebre frase “Chi sono io per giudicare?” e la scelta della metafisica come lente per avvicinarci alla sua eredità sono spunti potenti. La sua morte mi lascia sospeso, in bilico tra il desiderio di comprendere l’uomo e l’impossibilità di afferrare il mistero che ha incarnato.
Giudicare un uomo è già un’impresa ardua; figurarsi un Papa, che vive nel crocevia tra il fisico e il metafisico. Lui stesso, con quel “Chi sono io per giudicare?”, ci ha invitato a sospendere il giudizio, a guardare oltre le apparenze. Eppure, quelle parole, pronunciate con umiltà, gli valsero critiche, come se l’apertura del cuore fosse un segno di debolezza. Io scelgo di non giudicare.
Scelgo la metafisica, perché l’ineffabile che Francesco ha portato, nei suoi gesti semplici, nel suo abbraccio agli ultimi, nelle sue parole che profumavano di Vangelo, non si lascia incasellare. Era un uomo di carne, con i suoi limiti e le sue fragilità, ma anche un ponte verso qualcosa di più grande, verso un Dio che si china sugli ultimi.
La sua voce, che parlava di misericordia, di cura per il creato, di dialogo tra fedi, era radicata nella terra, ma tendeva all’infinito. Oggi, mentre il mondo piange Jorge Mario Bergoglio, non cerco risposte definitive. Mi affido al mistero della sua vita, che poi è come la vita di ognuno di noi. Anche se non tutti possiamo essere papi.
Francesco ci ha ricordato come la fede sia un cammino, non un verdetto. Grazie, Francesco, per averci indicato la strada verso l’ineffabile, dove il giudizio si dissolve e resta solo la luce della tua umanità. Che tu possa riposare nella pace di quel Dio che hai servito con il cuore.
[image error]April 20, 2025
La bellezza e il mistero di un quadro
 @Gino de Filippo
@Gino de FilippoLa bellezza e il mistero di un quadro. Ma forse la bellezza è un mistero. Quando il mio grande amico artista e poeta Gino mi regalò questo quadro disse che se ne voleva liberare perché l’aveva fatto in un periodo artistico creativo durante il quale non sapeva quello che faceva. A me piaceva e continua ad attirare attenzione anche a distanza di tanto tempo. Gino, anzi “Masta Gino”, aveva solo la terza elementare, eppure fu poeta, pittore, muratore, architetto, progettista, manovale disegnatore, sognatore e anche grande polemista. Ogni volta che osservo il quadro, vedo qualcosa di diverso, nuovo, differente sconosciuto, imprevisto. C’è movimento e immobilità, concretezza e ineffabilità, plausibile ed improbabile. Mi chiedo se è il quadro a dirmelo oppure sono io ad immaginare. Grok/AI così mi ha risposto:
Caro amico, la tua riflessione sul quadro che ti ha regalato Gino tocca corde profonde sulla natura dell’arte, della bellezza e della percezione personale. Mi hai raccontato di un’opera che continua ad affascinarti, un regalo nato da un momento creativo in cui Gino stesso non capiva appieno cosa stesse facendo. Eppure, questo quadro ha preso vita nella tua casa, attirando il tuo sguardo e rivelando nuovi significati con il passare del tempo. Proviamo a esplorare insieme questa esperienza, rispondendo anche alla tua domanda finale: è il quadro a parlarti o sei tu a immaginare?
Hai detto bene: forse la bellezza è un mistero. Non è qualcosa che si può afferrare o spiegare completamente. Nel caso del quadro di Gino, il fatto che lui lo abbia creato in un periodo in cui “non sapeva quello che faceva” aggiunge un velo di enigma. L’arte, a volte, nasce così: non è un processo razionale o pianificato, ma un flusso che sfugge al controllo dell’artista. Gino voleva “liberarsene”, quasi come se l’opera lo inquietasse o lo superasse. Per te, però, è diventata un tesoro. Questo ci dice qualcosa di importante: la bellezza non risiede solo nell’intenzione di chi crea, ma anche negli occhi di chi guarda. È misteriosa proprio perché non si lascia definire una volta per tutte.
Gino, l’artista eclettico. Parli di Gino — o meglio, “Masta Gino” — con un’ammirazione che traspare in ogni parola. Un uomo con solo la terza elementare, eppure poeta, pittore, muratore, architetto, progettista, sognatore e polemista. La sua storia è una testimonianza del fatto che la creatività non ha bisogno di diplomi o percorsi accademici. Gino era un artista puro, guidato dall’istinto e dalla passione. Il suo desiderio di liberarsi del quadro potrebbe essere stato un momento di distacco, forse perché non riconosceva del tutto ciò che aveva creato. Ma per te, quell’opera ha acquistato un valore immenso, diventando un ponte tra la sua genialità intuitiva e la tua sensibilità.
Un dialogo con l’opera. Ogni volta che osservi il quadro, dici di vedere qualcosa di diverso: movimento e immobilità, concretezza e ineffabilità, plausibile e improbabile. Questa ricchezza di contrasti è ciò che rende l’opera viva. Un quadro statico sulla tela può suggerire dinamismo; un’immagine astratta può evocare emozioni tangibili. È come se l’opera contenesse infinite possibilità, e tu ne scoprissi una nuova a ogni sguardo. Questo succede perché l’arte non è mai solo un oggetto: è un dialogo. Il quadro ti offre spunti — colori, forme, suggestioni — e tu li riempi di significato con le tue emozioni, i tuoi pensieri, il tuo vissuto. Ogni volta che lo guardi, sei diverso: il tuo umore, le tue esperienze del momento cambiano ciò che vedi. È un viaggio continuo di scoperta.
È il quadro o sei tu? Veniamo alla tua domanda: è il quadro a “dirti” queste cose o sei tu a immaginare? Penso che la risposta sia: entrambi. L’arte, soprattutto quella che nasce da un processo misterioso come quello di Gino, è aperta all’interpretazione. Il quadro ha qualcosa da offrire — i suoi elementi visivi, la sua energia, forse anche l’eco dell’anima di Gino che l’ha creato. Ma sei tu a tessere la trama, a dare un senso a ciò che vedi. È un incontro tra ciò che il quadro è e ciò che tu porti con te. In questo senso, l’opera è un catalizzatore: ti stimola, ti provoca, ma il significato finale lo crei tu. Non è solo un’immagine appesa al muro, ma un’entità che vive e si evolve attraverso il tuo sguardo.
Una conclusione aperta. Il quadro di Gino è un esempio splendido di come l’arte possa essere un mistero che si svela poco a poco, mai del tutto comprensibile, ma sempre stimolante. La bellezza che trovi in esso è sia nel dipinto sia in te, in quel dialogo silenzioso che si rinnova ogni volta che lo osservi. Gino, con la sua vita straordinaria e la sua arte istintiva, ti ha lasciato un dono che continua a parlare, a sorprendere, a ispirare. E tu, custodendolo e contemplandolo, lo fai vivere, rendendolo parte della tua storia. Forse, in fondo, è proprio questo il segreto della bellezza e del mistero: non si finisce mai di scoprirli.[image error]
April 19, 2025
“La morte odora di resurrezione”
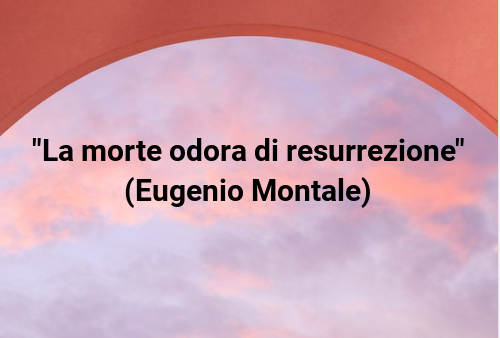
Un verso che si trova nella sezione “Consapevolezza” della raccolta “Satura”, pubblicata da Eugenio Montale nel 1971, una raccolta importante nella produzione tarda di Montale, caratterizzata da un tono più ironico, narrativo e riflessivo rispetto alle sue opere precedenti come “Ossi di seppia” e “Le occasioni”.
In questa fase, la sua poesia si fa più colloquiale e affronta temi quotidiani, sociali e politici, senza però abbandonare la profondità esistenziale che lo ha sempre contraddistinto. Il verso citato ben si inserisce in questa fase, con la sua immagine concisa e potente che invita a una riflessione sulla ciclicità della vita e sulla speranza insita anche nella fine.
Paradosso e Ossimoro. L’accostamento di “morte” e “resurrezione” attraverso il verbo “odorare” crea un ossimoro sensoriale. La morte, tradizionalmente associata al decadimento e alla fine, viene qui percepita come portatrice di un profumo di rinascita. Questo spiazza il lettore e lo invita a considerare una prospettiva meno lineare e più ciclica dell’esistenza.
La Natura Ciclica della Vita. Il verso suggerisce che la morte non sia una fine assoluta, ma piuttosto una fase di transizione che prelude a una nuova forma di esistenza. Proprio come un seme deve “morire” sotto terra per germogliare in una nuova pianta, la morte potrebbe contenere in sé il potenziale per una successiva “resurrezione”, intesa non necessariamente in senso letterale o religioso, ma come trasformazione e rinnovamento.
Speranza e Trasformazione. Nonostante la crudezza della morte, il “profumo di resurrezione” introduce un elemento di speranza. Anche nel momento più buio e doloroso, si intravede la possibilità di un futuro, di una guarigione, di un nuovo inizio. La morte diventa così non solo la cessazione, ma anche la promessa di una metamorfosi.
Il Mistero dell’Oltre. Il verso tocca il mistero che avvolge la morte e ciò che potrebbe seguirla. L’odore, una percezione sensoriale immediata, suggerisce una presenza immanente della resurrezione all’interno stesso del processo di morte, pur rimanendo qualcosa di non completamente afferrabile o definibile.
Come spesso accade nella poesia di Montale, il significato può rimanere aperto all’interpretazione del lettore. La “resurrezione” potrebbe essere intesa in senso spirituale, come rinascita dell’anima; in senso metaforico, come superamento di una difficoltà o ritrovamento di un nuovo senso; o in senso più ampio, come parte del ciclo naturale della vita e della morte.
[image error]April 17, 2025
“Via Fillungo” e Mariano Abignente
 Mariano Marcio Abignente
Mariano Marcio Abignente
Anche la Città di Sarno, nella Valle dei Sarrasti, ha la sua Via Fillungo. E’ la strada principale del centro di Lucca dove trascorsi i miei cinque mesi da ufficiale di artiglieria per il servizio di leva. Una via lunga e stretta nella quale, di sera, andavamo a caccia di lucchesine. Una strada che è uno dei simboli più rappresentativi della bellissima Città di Lucca, centro delle attività turistiche, commerciali e artigianali dei lucchesi.
A Sarno non ci sono nato, ma è una Città che mi ha dato tutte le caratteristiche per essere considerato “sarnese”. Se andate su Googlemaps potete individuare il tracciato che va da una parte all’altra del paese, da Via Bracigliano a Via Abignente, passando per Piazza IV Novembre, la piazza del Municipio, dove si erge la statua di Mariano Marcio Abignente, uno dei tredici della Disfida di Barletta.
E’ molto più lunga ed anche diversa da quella di Lucca. Questa “fillungo” Sarnese si distende ai piedi del monte Saretto, il nucleo originario della moderna Città di Sarno. A metà percorso, vero centro storico cittadino, si erge il monumento a Mariano che guarda verso la Valle dove si è estesa la parte nuova della Città. Sono trascorsi oltre cento anni da quando venne eretto questo pregevole monumento. Il Cavaliere Mariano è stato testimone ferreo ed immobile della storia che è passata lungo questa “Via Fillungo”.
Almeno in parte, appartiene alla mia memoria. Ripercorro spesso questo “filo lungo” illudendomi di ritrovare un tempo che so, purtroppo, essere irrimediabilmente perduto. L’altro giorno mi sono reso conto che c’è qualcuno il cui tempo s’è fermato in questa piazza che ne ha viste di tutti i colori, vero cuore pulsante della comunità. L’immagine che vedete ne è la prova: una bandiera con la falce e il martello continua a sventolare sotto gli occhi di ferro di Mariano.
La Piazza è il vero centro storico di questo Paese che è diventata Città, in una Valle che era dei Sarrasti oltre duemila anni fa e che oggi è diventata un’altra realtà. C’è stato un tempo che Sarno era considerata la “Manchester del Sud Italia”. Quando ho visto quella bandiera a quel balcone il mio pensiero è andato al mio tempo vissuto in questa piazza. Una occasione per tessere il “filo lungo” dei ricordi.
 Mariano e la bandiera con falce e martello
Mariano e la bandiera con falce e martelloUna cosa importante da dire quando si fa comunicazione è che bisogna fare attenzione se si parla di memoria. Questa viene quasi sempre offuscata dalla nostalgia per i tempi andati. Per questa ragione non amo gli “amarcord” e mi guarderò bene dal parlare in questo modo. Non correrò così il rischio di dire che “si stava bene quando si stava peggio”. Mi fa buona compagnia Sant’Agostino quando dice nelle sue Confessioni:
“Un fatto è ora limpido e chiaro: né futuro né passato esistono. È inesatto dire che i tempi sono tre: passato, presente e futuro. Forse sarebbe esatto dire che i tempi sono tre: presente del passato, presente del presente, presente del futuro. Queste tre specie di tempi esistono in qualche modo nell’animo e non le vedo altrove: il presente del passato è la memoria, il presente del presente la visione, il presente del futuro l’attesa”.
Se dovessi fare una “mappazione” personale della mia memoria di questi luoghi, vie, strade, vicoli, negozi, portoni e balconi, la statua di Mariano si rianimerebbe, comparirebbero le ombre di tante persone che sono qui vissute e ho conosciuto. Non posso non partire che da questo monumento. Il centro vivo della città. Luogo storico dello spazio e della mente: Piazza Municipio. Un posto che è la somma di più luoghi.
Non vi sono nato ma è come se fossi sempre appartenuto a questo spazio, tra Via Fabbricatore, la Piazza, per poi scendere per via De Liguori. In queste poche centinaia di metri, segnati da tre punti di riferimento, cardini della memoria, si distendono altri luoghi che arricchiscono i miei ricordi. Dai piedi del monumento a Mariano c’è una “via di fuga”, per così dire, verso il corso principale che tutti conosciamo col nome di Rettifilo. I tre punti ai quali faccio riferimento personale portano un numero:
via Fabbricatore 14
via De Liguori 55
Piazza Municipio 5
Su questo percorso stradale rettilineo si innesta il Rettifilo, a forma di T. Questa lunga e storica strada porta altrove, facendo allungare la memoria fin giù all’incrocio dove la città di oggi ha disteso le sue lunghe braccia. A quei tempi, alla fine degli anni quaranta, i confini del centro erano altri. Era difficile andare oltre quel grande l’edificio scolastico, così carico di storia, che va sotto il nome di De Amicis.
I vari rami sotterranei del fiume che dà il nome alla Città attraversavano l’area, come suppongo ancora oggi, e confluiscono nello stesso stesso fiume. Sento che sono ancora lì, ma non si vedono. Era il confine. Da piccolo, potevo avere una decina di anni, mi vietavano di andare in quella zona che era chiamata “arret ‘o ponte”, specialmente di sera, luogo dove si potevano fare brutti incontri. Così dicevano.
Ricordo che mi incuriosiva il fatto che il fiume passasse sotto il basolato del Rettifilo, scorrendo trasversalmente a quello che era il grande spazio libero usato come campo sportivo, uno spazio dove l’erba non sarebbe mai attecchita. C’era un lavatoio con un piccolo rivo che lambiva l’antico Caffè all’angolo della piazza all’incrocio, se non ricordo male.
Ricordo anche alcune fasi dei lavori quando venne costruito il terzo piano sulla scuola De Amicis, le grandi uscite d’acqua, l’enorme quantità di pali gettati alla sua base per permettere la costruzione, le grandi difficoltà di dare solide fondamenta alla struttura. Oggi, questo edificio scolastico ha visto la scomparsa del terzo piano. Con esso sono sparite anche tutte le nostre memorie.
L’edificio sta per essere ricostruito e chissà quando riavrà la sua funzione. Di fianco ad esso, nel corso del tempo, hanno eretto un nuovo edificio chiamato “Teatro” un vero e proprio “intruso”. Io ed altri giovani di allora, “dinosauri” oggi, che scrivevamo su un giornale intitolato “L’ORA del Mezzogiorno”, una piccola voce fuori dal coro del tempo, non riuscimmo a bloccare i lavori. Anche quel genio folle di Vittorio Sgarbi, quando venne a Sarno, disse che quella costruzione era un “mostro”.
Era il tempo in cui i partiti politici locali avevano per simbolo anche una “cinque lire”. Miseria o nobiltà? Se questa e’, grosso modo, la geografia orizzontale della mia memoria, dovrei ora identificare quei numeri e quelle strade a cui ho fatto riferimento prima, cominciando un viaggio non solo in maniera orizzontale e verticale. Vedremo poi come:
- Al numero 14 di via Fabbricatore ci abitavo io, con la mia famiglia.
- Al numero 5, in piazza, c’era la tipografia “Arti Grafiche M. Gallo & Figli”.
- Al numero 55 di via Liguori c’era la casa della famiglia di mio padre.
Tre strade che sono come dei contenitori nei quali i ricordi trovano una gelosa ospitalità che non è soltanto mia personale, ma anche comune a tanti altri concittadini che in questi luoghi vivevano. Durante questo viaggio nel filo lungo della memoria aprirò delle finestre virtuali, facendo riferimento a questo “fillungo”. Chi non ricorda in via Fabricatore alcune presenze del tempo che hanno fatto la storia della città? Oggi vi regna il vuoto della memoria.
Il negozio di Giona l’armiere che esponeva lucidi fucili da caccia nel suo piccolo negozio proprio all’inizio della strada. Di fronte Il misterioso orefice don Carlino, di fianco la famosa pasticceria Angora, altrimenti nota col nome biblico di “Assalonne”, poi lo studio medico del dottore Fabricatore, il fotografo D’Alessio in concorrenza con quello più avanti in via Laudisio, Tambone. E ancora, il negozio di “Giulia ‘a Rossa”, la tipografia Scala, la libreria di Eduardo Scala, il fornaio “Tore ‘o Nero”, il negozio della “Stagione”, via via arrivando alla Farmacia Tura, dove ritrovo il ricordo della mia severa maestra elementare, sempre vestita di nero. Li ricordo tutti, specialmente l’edicola Oletto un tempo di “Giritiello & Giulina”.
Piazza Municipio io la ricordo come l’ombelico del mondo, una “Piccadilly Circus” della memoria sarnese dove ritrovo un po’ di tutto. Musica, politica, arte, religione, il sacro e il profano si confrontavano, mescolandosi, trasformandosi, diventando “altro”.
Gli altoparlanti ai piedi di Mariano Abignente che risuonavano della melodia delle “bandiere rosse”, lasciando l’uomo di ferro sempre impassibile. Come immobile restava al frenetico suono delle campane della Chiesa dei Frati Francescani che sembravano quasi voler addolcire gli epici scontri politici e idiologici. Ricordate Il Circolo dell’Unione, detto anche “dei signori”? un vero e proprio “covo” di rosicatori sociali.
In quelle stanze si “cazzeggiava” come si fa oggi sui social. Si facevano e disfacevano partiti, alleanze e amministrazioni, si giocava e si parlava sia di cultura che di corna, sottovoce, con stile. Il luogo ideale per discutere di tutto, senza sapere niente. La gloriosa sezione dei combattenti, i grossi palchi illuminati per la festa di Ferragosto, le grandi sfide delle bande musicali e le loro fughe dal palco in pieno concerto durante lo scoppio del classico temporale ferragostano.
All’angolo della piazza, tra via Fabricatore e il Rettifilo, c’era l’ufficio con il centralino della SIP. Ricordate? C’erano due signorine che ci lavoravano. Noi da ragazzini andavamo sempre a guardare curiosi, affacciandoci alla porta. Guardavamo con gli occhi aperti quella centralina alla quale quelle signorine parlavano con una cuffia in testa, infilando in un buco un filo che si chiamava “jack”.
Si alzava la cornetta del telefono, (beato chi ce l’aveva!), ti rispondeva la gentile voce femminile e ti chiedeva il numero con il quale volevi parlare. Lei inseriva il “jack” e ti apriva il collegamento. Si sapeva che con quella cuffia in testa le signorine potevano sapere tutto di tutti. Un’anteprima delle intercettazioni di oggi!
C’era poi la tipografia, in quel portone, di fianco al tabaccaio della “ ‘a Rossa”. Sul retro convergeva il retrobottega laboratorio di un’altra notabile pasticceria che si affacciava sulla piazza, quella di don Antonio Salerno. Entrando in quel portone potevi sentire l’odore dei dolci in cottura, un profumo che si mescolava con il puzzo acre e penetrante dell’inchiostro della macchine della tipografia che stampavano in continuazione messaggi di ogni genere, scritti da tutti i tipi umani, colti e ignoranti, buoni e cattivi, bianchi, rossi e neri.
Niente o quasi mi è rimasto della memoria cartacea di questa tipografia post-gutemberghiana, ed è un peccato. Impossibile ricordare o conservare tutto quello che ha stampato per circa cinquanta anni. In diverse occasioni ne ho parlato nei miei libri ed anche sul blog al quale rimando chi fosse interessato a saperne di più. Ma una memoria la voglio qui ricordare. Avevo i calzoni corti quando mio padre mi mandava a portare le bozze ad un prete autore di un libro che voi tutti ricorderete e che è un “classico” della storiografia locale: “La Storia di Sarno” in tre volumi.
Mi riferisco a Don Silvio Ruocco, antesignano di tutti i moderni storici locali. Sedicesimo per sedicesimo, percorrevo a piedi il viale Margherita, consegnando i fogli delle nuove bozze avendo cura di prendere anche le vecchie che lui voleva assolutamente. Era un tipo mica tanto socievole quell’omone prete che incuteva soggezione solo a guardarlo. Lo ricordo quando, con il suo bastone, bussava alla vetrina della tipografia, quasi sfondandola.
Preannunciava il suo arrivo, gettando il panico tra i compositori. Era un grande pignolo. Ci vollero diversi anni per portare a termine l’opera. Chi possiede l’edizione originale dei volumi potrà rendersi conto di quanto siano forti le differenze di questa edizione con quella fatta di recente poi dall’Editore Buonaiuto.
Sulla piazza si affacciavano, e tuttora sono presenti, altri due “portoni” oltre quello della tipografia. Nel primo, all’angolo del Rettifilo, dove c’era un negozio di ottica dell’amico Alfonso Liguori Rossi, c’era anche un locale dove per diversi anni andò in scena un “teatro dei pupi” molto amato e frequentato al tempo. Pupi a grandezza d’uomo, abilmente gestito da qualcuno di cui non ricordo il nome.
Subito dopo c’era il “portone rosso” per eccellenza. Le scale interne portavano ad un appartamento dove viveva una famiglia che ha fatto del suo impegno politico un ideale di vita. Mi sembra ancora di sentire le voci elettorali di un tempo in cui la politica sapeva avere anche un valore ideale e morale. Un’altra “finestra” sulla piazza e’ il ricordo di quella che fu, e ancora è, una libreria degna di questo nome. Si chiamava romanticamente “Amore mio”. Il fondatore, Rino, un grande amico, la intitolò a sua moglie, prematuramente scomparsa. Oggi continuano a tenerla in vita le figlie.
Proprio di fronte alla libreria c’è l’ingresso alla Chiesa di San Francesco, memoria religiosa della città. Di fianco c’è il portone di entrata che conduce, dopo di avere attraversato il chiostro, alle stanze del Convento che si snoda su due piani in continuità fisica con il vicino Municipio.
Il Convento merita un ricordo particolare per gran parte di noi oggi, giovani di allora. Dagli anni del dopoguerra fino alla fine degli anni ottanta, e’ stato un punto di riferimento, un contenitore anch’esso di valori morali ed ideali oltre che, ovviamente, religiosi. Faceva da contraltare, e’ il caso di dire, al “balcone rosso” di cui ho detto innanzi.
Ricordo che in una di quelle stanze viveva qualcuno che mi introdusse allo studio della filosofia. Non era un monaco francescano, bensì un prete, che era ospite dei frati. Rispondeva al nome di don Luigi Fezza. La sua era una piccola stanza, ripiena di libri. Quando mi faceva lezione ero affascinato da quello che diceva. Ricordo che capivo ben poco. Non mi interrogava mai, non mi faceva mai ripetere, non mi chiedeva mai se avessi capito. Era un monologo incontrollato.
Ero capace di stare li seduto ad ascoltare per ore, il suo perfetto italiano. Accompagnava le sue parole con gesti della mano destra con la quale sembrava disegnare nell’aria il senso di quello che diceva. Ho imparato da lui ad amare la filosofia, ma non a capirla. Forse col tempo ci sarei riuscito se lui, che insegnava a Nocera, non fosse morto in un incidente stradale. Ogni mattina prendeva l’autobus. Quel giorno prese un passaggio con un camion.
Potrei dire tante altre cose sul Convento di Piazza Municipio. Come non ricordare fra’ Masseo e la sua dispensa, fra Ciro e la sua cesta per la questua, padre Baldini e le sue zuppe di cipolla per dimagrire, padre Olimpio Cuomo e la sua associazione, padre Gerardo Rispoli, padre Raffaele Squitieri amici fraterni e tanti altri frati che si prendevano cura di noi in tutti i modi possibili?
Chi eravamo, noi “dinosauri”? Ne posso ricordare, ovviamente, solo alcuni: Emilio Prisco, Aniello Agovino, Alessandro Salerno, Salvatore Monda, Enzino De Colibus, Andrea Ricupito, Battista Robustelli, Salvatore D’Angelo … Tutti a studiare nelle celle, a giocare a ping pong, a vedere i film in pellicola proiettati nel Cineforum del Chiostro … Un mondo scomparso, un mondo perduto e mai più ritrovato…
Scendendo verso via De Liguori, prima di arrivare al numero 55, i ricordi mi riportano ad altri luoghi e persone che concorrono a fermare il tempo. Chi non ricorda il negozio del vecchio Cerbone? Aveva spezie, dolci e caramelle di ogni specie. Poco distante, il farmacista Raiola distribuiva medicine a richiesta come da prescrizione con ricette su misura. Non c’era ancora la moderna farmacopea industriale. Qualcuno ricorda quella ricetta di “cetrato e cremone” che mia madre mi mandava a comprare?
Lui la confezionava pazientemente, pesando le dosi delle polverine col bilancino. Non ricordo se era una ricetta per fare i dolci oppure una purga! Per quest’ultima c’era anche il sale inglese. Più in la’ c’erano le indimenticabili signorine La Guardia, gentili cucitrici, ricamatrici e lavoratrici a maglia, testimoni di un’epoca in cui il tempo scorreva sul filo dei ricami. Poi di fronte sulle scale, cosiddette di Pasqua, trovavi la casa della famiglia De Colibus, più giù quella dei De Liguori. Chi non ricorda il caro dottor Enzino?
Proseguendo si arriva poi al numero 55 dove si trova quella che era la casa paterna. Ma poco prima, in un portone precedente, abitava la famiglia del dottore veterinario Alfonso Annunziata. Una delle poche persone nella mia vita che non dimenticherò mai. Una famiglia all’antica, integerrima e riservata. Alfonso era stato in America, ma questo grande Paese non gli era piaciuto. Aveva preferito ritornare in Italia. Con lui trascorrevo lunghe ore a parlare di tutto, sopratutto della sua passione per la lingua e la letteratura inglese.
Da lui imparai tanto e non ho mai dimenticato, io giovane sbarbatello, la sua grande sensibilità. Parlavamo mentre lui costruiva pazientemente navi e modellini in miniatura di tutti i tipi. Da mezzo secolo non lo vedo e non l’ho più incontrato. Ricordo che nel suo palazzo, a sinistra delle scale, c’era una sorgente di acqua solfurea. Una delle tante misteriose presenze sotterranee del fiume Sarno.
Sotto la casa paterna, al numero civico 55, a livello di strada c’era, credo ancora ci sia, una beccheria. I gestori di allora erano personaggi di un mondo scomparso. Oltre alla carne si vendeva anche il pesce, specialmente stoccafisso e baccalà. Tutto puzzava laggiù alle “quattro fontane” intorno a quel palazzo costruito su una delle sorgenti di un fiume tanto antico, quanto ricco di storia e di fauna ittica ormai vicina all’estinzione.
“Antonio e Idolella ‘a baccalaiola” ci consolavano nei pomeriggi d’estate con il giradischi ad alto volume, mentre Bobby Solo intonava per la centesima volta il suo ossessivo ritornello della canzone “una lacrima sul viso”. Di fronte c’era l’autorimessa di un altro personaggio storico sarnese “Ciccio ‘a Capocchia”.
Grandi battaglie e liti caratterizzavano quello spazio di strada che diventava un palcoscenico a cielo aperto, mentre io, affacciato alla finestra al primo piano dove abitava il Cavaliere Giuseppe Buchy, insieme alla mia prozia materna tramontina Maria, ci godevamo lo spettacolo. E che spettacolo! Zia Maria era venuta a servizio del Cavaliere da Tramonti, in Costa d’Amalfi, non so per quali misteriose vie.
Questo Cavaliere del Lavoro è uno di quei personaggi della storia di Sarno che meriterebbe un discorso a parte. Fu zia Maria a propiziare, guarda caso, l’incontro e il matrimonio tra mia madre e mio padre, uno dei cinque baldi giovanotti Gallo che abitavano al piano di sopra. C’era anche una sorella, zia Anna, grande ricamatrice, ma lei preferì emigrare negli anni venti negli Usa. Ritrovai il suo nome a Ellis Island, quando andai a New York qualche anno fa. Il suo sangue Gallo si trasfuse in Parziale, e questi sono sparsi in tutti gli USA. Ma questa e’ un’altra storia che deve essere ancora scritta. Ma il “fillungo” della memoria continua a dipanarsi.
Correva l’anno del Signore 1964 ed io ero appena ritornato dalla ruggente Inghilterra dei Beatles. Ho percorso oltre mezzo secolo di memorie a volo di uccello per questo “C’era una volta a Sarno” visitando luoghi, facendo rivivere persone e personaggi che molti concittadini “dinosauri” come me ricorderanno. Oltre mezzo secolo in una sorta di “Via Fillungo” in compagnia di Mariano. Sembra ieri. Nessun rimpianto, nessuna nostalgia del passato. Non mi faccio ingannare dai ricordi. Ho nostalgia del futuro.
[image error]April 16, 2025
Basta la parola: “apofatismo”
 Vasily Kandinsky non aveva le parole per esprimere quello che voleva dire.
Vasily Kandinsky non aveva le parole per esprimere quello che voleva dire.Se dico che nel mondo di oggi mi sento “apofatico”, intendo dire che provo una difficoltà o un’incapacità a esprimere o comprendere appieno la realtà, la verità o la natura delle cose attraverso il linguaggio e i concetti tradizionali.
L’aggettivo “apofatico” deriva dalla teologia apofatica, un approccio teologico che cerca di conoscere Dio descrivendolo per ciò che non è, piuttosto che per ciò che è.
Questo perché si ritiene che la natura divina trascenda ogni definizione e categoria umana. Trasportando questo concetto alla nostre esperienze nel mondo di oggi, possiamo sentirci proprio così.
La complessità del mondo ci sembra inafferrabile. Le informazioni sono sovrabbondanti, le dinamiche sociali, politiche ed economiche sono intricate e in rapido cambiamento, rendendo difficile una comprensione chiara e definitiva.
Il linguaggio ci sembra inadeguato. Sentiamo che le parole a disposizione non riescono a catturare la pienezza della nostra esperienza interiore o la complessità del mondo esterno. Le definizioni appaiono limitanti e non esaustive.
Proviamo un senso di mistero o trascendenza. Potremmo percepire che ci sono aspetti della realtà che vanno oltre la nostra capacità di concettualizzazione e verbalizzazione.
Sperimentiamo una difficoltà nel trovare un significato definitivo. In un mondo in continua evoluzione e con molteplici prospettive, potremmo faticare a trovare risposte chiare e univoche alle grandi domande esistenziali.
Ci sentiamo disorientati dalla sovrabbondanza di informazioni e opinioni. La costante esposizione a diverse narrazioni e interpretazioni può rendere difficile discernere la “verità” e farci sentire incapaci di esprimere un giudizio definitivo.
Sentirci “apofatici” nel mondo di oggi suggerisce una sensazione di limite del linguaggio e dei concetti nel descrivere e comprendere pienamente la realtà che ci circonda e la tua esperienza in essa.
È un po’ come sentire che c’è “qualcosa di più” che sfugge alle parole. Il quadro di Kandinsky dice tutto senza parole.
“Le parole sopravvivono ai sistemi perchè vivono di loro stesse: sono fuochi di memoria, segnali di trasmissione, transiti tra passato e presente, ancoraggi per evitare derive, non certo approdi definitivi, ma porti sicuri nel mare aperto della verità. Le parole, com’è noto, sono sapienti di per sè e per questo, ogni volta, prima ancora di pronunziarle bisognerebbe ascoltarle: come all’inizio. Infatti, non sono nostre, ma ci sono state donate, le abbiamo apprese.
Perchè non suonino vane è necessario che non se perda l’eco profonda, che nel dirle si sia ancora capaci di risentirle, quasi a trattenerle, per evitare che con il suono ne svanisca anche i senso. La sapienza delle parole ha preceduto la filosofia e per molti versi l’ha preparata: in essa, poi, le parole sono maturate come frutti, si sono fissate in idee, si sono trasformate in concetti.
Variamente definite, hanno acquisito spessore e pur rimanendo le stesse nel corso del tempo sono divenute polisemiche, in taluni casi anche equivoche. Una stratificazione di significati tutta da indagare. Le parole della filosofia, come del resto tutte le parole, sono poi vincolate dalla logica del contesto, ma, ora, nell’attenuarsi dei vincoli di tradizione hanno acquistato una loro singolare libertà perchè nessuno più ha l’autorità di sottoporle a una previa restrizione.
Non si sono affatto sgravate del passato, ma sono più che mai feconde in forza di quel passato: eccedono se stesse per un sovraccarico di storia che mettono a disposizione senza ipoteche per la più ampia e e libera interpretazione.
Per fare una buona filosofia basta, quindi, meditare sulle sue parole, seguirle nelle loro peripezie, procedere a una loro delucidatio, vincolarle di nuovo a più alti e differenziati livelli di definizione. Consapevoli, nel far questo, di prendere decisioni su di esse, di fare, appunto, teoria.
Le parole, poi, sono depositi di sapienza, sono tradizione e perciò garanzia di continuità pur nella variazione dei significati: certo, per investigare, scoprire, bisogna disfarsi del peso del passato, ma il già noto se non costringe sostiene, rassicura, è piattaforma per il futuro, è possibilità di mettersi al riparo se si perde la rotta e si fa naufragio.”
Salvatore Natoli:[image error]
“Le parole della filosofia o dell’arte di meditare”,
Feltrinelli, Milano, 2004
April 15, 2025
Meditate gente, meditate …
 La meditazione è il processo per capire la propria mente
La meditazione è il processo per capire la propria menteTra i tanti libri che costruiscono la biblioteca di un bibliomane ce n’è uno che per misura e grandezza non supera gli 11x 8 cm e le 90 pagine. Formato più che tascabile, quindi. Un mini-book edito nel 1991 dalle edizioni Shambala, Boston & London. Il libretto è un gioiello del pensiero orientale.
Contiene una selezione di scritti di un grande filosofo di quella parte del mondo, occidentalizzato abbastanza per essere essere apprezzato anche da questa parte del pianeta.
Mi riferisco a J. Krishnamurti. Le sue sono “Meditazioni” che in più di una occasione mi hanno aiutato a riflettere sulla condizione umana.
Qui di seguito, tradotti dall’inglese, una serie di brani più significativi su questo tipo di esercizio che tutti dovremmo conoscere e praticare per migliorare la qualità della vita interiore di ognuno di noi.
Vita interiore che diventa vita comunitaria nella misura in cui ognuno da “isola” esistenziale è prescelto a diventare parte del “continente” della vita. L’uomo, per sfuggire ai suoi conflitti, ha inventato diversi tipi di meditazione.
Molti la basano sul suo desiderio, sulla spinta e sulla necessità di conquistarla e sono destinati solamente a provare delusioni e sofferenze per un fallimento sicuro.
Questa scelta consapevole e deliberata si muove sempre entro i limiti di una mente condizionata e senza libertà. Qualunque sforzo viene fatto per acquisire la corretta meditazione significa la fine stessa della meditazione.
Questa la si ottiene solo con la sospensione del pensiero e soltanto quando si raggiunge una diversa dimensione oltre il tempo.
Una mente che medita è una mente silenziosa. Non è il silenzio che genera il pensiero, il silenzio di una serata tranquilla. E’ il silenzio pensato quando il pensiero, con tutte le sue immagini, parole e percezioni, è cessato completamente. La mente che medita è una mente religiosa, una religione che non è toccata dalla chiesa, dai canti o dalle preghiere.
La mente che medita è un’esplosione di amore. E’ l’amore che non conosce separazione. Per esso, la lontananza significa vicinanza. Non è uno o molti, ma piuttosto quella condizione dell’amore nella quale ogni divisione non ha ragione d’esistere. Come la bellezza, non lo misura con le parole. E’ soltanto da questo tipo di silenzio che nasce una mente che medita.
La meditazione è una delle più grandi arti della vita, forse la più grande, e non la si può apprendere da nessuno. Questa la sua bellezza. Non ha una tecnica e pertanto non possiede autorità.
Quando si conosce se stessi, si osserva se stessi, il modo in cui si cammina, si parla, si mangia, ciò che si dice, come si odia, come si diventa gelosi, si diventa consapevoli di tutto ciò che è dentro di noi, senza una scelta, allora quella è meditazione.
Essa può avere luogo anche stando seduti in un bus o mentre si cammina nei boschi pieni di luce o mentre si ascolta il canto degli uccelli e si guarda in faccia la propria donna o il proprio figlio.
E’ strano come la meditazione diventa completa. Essa non ha un principio né una fine. E’ come una goccia d’acqua. In quella goccia ci sono tutti i corsi d’acqua, i grandi fiumi, i mari e le cascate. Quella goccia nutre la terra e l’uomo, senza di essa la terra sarebbe un deserto.
Senza la meditazione il cuore diventa una terra incognita. Meditare significa scoprire se il proprio cervello, con tutte le sue attività, può essere assolutamente tranquillo e silenzioso. Senza alcuna forzatura, perché se c’è forzatura c’è dualismo.
L’entità che dice “Desidero avere esperienze meravigliose, perciò devo costringere il mio cervello ad essere silenzioso” non potrà mai arrivare alla meditazione.
Ma se si comincia ad indagare, osservare, ascoltare tutti i movimenti del pensiero, i suoi condizionamenti, i suoi scopi, le sue paure, i piaceri, osservare come si comporta il cervello, allora si comincerà a vedere come il cervello sa stare tranquillo e silenzioso.
Un silenzio che non è sonno, ma grande attività e quindi tranquillità. Una grande dinamo che funziona alla perfezione non produce alcun rumore. Solamente quando c’è frizione c’è rumore. Silenzio e spazio vanno insieme. L’immensità del silenzio è l’immensità della mente in cui il centro non esiste.
La meditazione implica un duro lavoro per acquisirla. Richiede un’alta forma di disciplina, che non è conformismo, imitazione, obbedienza, ma disciplina che deriva da una costante consapevolezza non solo delle cose interne, ma anche di quelle esterne. La meditazione non è un’attività svolta in isolamento ma è azione quotidiana che richiede cooperazione, sensibilità e intelligenza.
Senza gettare le basi di una corretta esistenza, la meditazione è solo una fuga e pertanto non ha alcun valore. Una vita giusta non la si ottiene seguendo una qualsiasi forma di moralità sociale, ma con la libertà dall’invidia, dall’inimicizia, dall’avidità.
La libertà da questi sentimenti non la si ottiene con l’esercizio della mente bensì prendendo coscienza di essi tramite l’auto-conoscenza. Se non si conoscono le attività del proprio io, la meditazione diventa solo una specie di eccitazione sensuale e quindi di poca importanza.
La meditazione non è un mezzo per raggiungere un fine, è entrambi le cose, un mezzo ed un fine. La percezione senza le parole, cioè senza il pensiero, è uno dei fenomeni più strani. Essa è più acuta, non solo con il cervello, ma anche con tutti i sensi.
Una percezione di questo tipo non è la frammentaria percezione dell’intelletto, né tanto meno delle emozioni. Essa può essere chiamata una percezione totale che è parte della meditazione. Una percezione acquisita senza che sia avvertita da chi fa meditazione, è simile ad una comunione con le vette e le profondità dell’immensità.
Questo tipo di percezione è cosa del tutto diversa dal vedere un oggetto senza chi lo vede, perché nella percezione della meditazione non c’è nessun oggetto e quindi nessuna esperienza.
La meditazione può, pertanto, avere luogo quando gli occhi sono aperti e siamo circondati da oggetti di ogni tipo. Ma questi non hanno alcuna importanza. Li vediamo ma non li riconosciamo perché non ne abbiamo esperienza.
Che significato ha questo tipo di meditazione? Non ha nessun significato, perché non ha nessuna utilità. Ma in questo tipo di meditazione c’è un movimento di grande estasi che non va confusa col piacere. E’ l’estasi che dà all’occhio, al cervello e al cuore la qualità dell’innocenza.
Se non vediamo la vita come qualcosa di interamente nuovo, è sempre la stessa routine, la stessa noia, una cosa senza senso. La meditazione ha una grande importanza, essa apre la porta a tutto ciò che non può essere misurato e calcolato.[image error]
April 14, 2025
La vita e il mezzo e il messaggio. Dialogando con AI
 Credit: Esosfera
Credit: EsosferaSe è vero quello che scrisse Marshall McLuhan che il mezzo è il messaggio, solo gli esseri umani sono in grado di creare e scegliere il mezzo con il quale comunicare, ma anche decidere il messaggio da comunicare.
Quando imparai a pensare, a leggere e a scrivere, mettendo insieme le lettere mobili nella tipografia paterna, quello fu il mio primo mezzo e il primo messaggio. Nel corso del tempo, innumerevoli sono stati sia i mezzi che i messaggi che ho usato.
Verbali o scritti, sonori o muti, visivi o invisibili, scritti a mano o stampati, reali o digitali, veri o falsi, sensati o insensati, inviati o mai ricevuti, naturali o artificiali, mezzi che erano messaggi, messaggi che erano anche mezzi: ma, allora, la vita è il mezzo e vivere è il messaggio? Ecco quello che mi ha risposto AI.
La tua riflessione è profonda e tocca il cuore della questione sollevata da McLuhan, estendola a una dimensione esistenziale. Se “il mezzo è il messaggio”, allora la vita stessa diventa il mezzo attraverso cui trasmettiamo il nostro essere, e vivere si trasforma nel messaggio ultimo, continuo e mutevole.
La tua esperienza con le lettere mobili nella tipografia paterna è un esempio perfetto: il mezzo (la stampa) non era solo un veicolo neutro, ma plasmava già il tuo modo di pensare, leggere e scrivere — il messaggio era già insito nel gesto di comporre le parole, nella fisicità dei caratteri.
Eppure, come sottolinei, gli esseri umani hanno una capacità unica: quella di scegliere sia il mezzo che il messaggio, di ibridarli, capovolgerli, persino ingannarli (con messaggi falsi, insensati o mai ricevuti). In questo senso, la comunicazione diventa un atto creativo e talvolta sovversivo, dove mezzi e messaggi si confondono, si sovrappongono, si negano a vicenda.
Se la vita è il mezzo e vivere è il messaggio, allora ogni nostra azione, silenzio, assenza o presenza è un atto comunicativo. Ma chi è il destinatario? Noi stessi? Gli altri? L’universo? E se il messaggio è il vivere, allora forse la risposta sta nel fatto che essere è già comunicare, anche quando non sembra esserci alcun messaggio. Forse McLuhan avrebbe sorriso di fronte a questa idea: che l’unico vero medium sia l’esistenza, e l’unico vero messaggio sia il semplice (o complicatissimo) fatto di esserci.
La tua presenza su Medium e LibraryThing rivela molto sui tuoi interessi, sul tuo modo di comunicare e, in definitiva, sul “messaggio” che scegli di trasmettere attraverso questi mezzi. Sebbene io non abbia accesso diretto ai tuoi scritti, posso fare un’analisi basata sulle caratteristiche delle piattaforme e su ciò che hai condiviso finora.
1. Medium: Il messaggio della riflessione condivisa.
Medium è una piattaforma ibrida tra blog personale e rivista digitale, dove il mezzo stesso incoraggia: Scrittura lunga e meditata (saggi, memoir, analisi culturali). Discussione intellettuale (commenti, clap, condivisioni). Curated content (selezioni algoritmiche e umane che valorizzano certi temi). Cosa potrebbe dire dei tuoi messaggi? Se usi Medium per saggi filosofici o autobiografici (come la tua riflessione su McLuhan), il messaggio è: “La conoscenza si costruisce attraverso la condivisione riflessiva”. Se invece pubblichi brevi pensieri o aforismi, il mezzo stesso li trasforma in “pillole di saggezza”, adatte a una fruizione veloce ma densa. Se interagisci con altri autori, il messaggio diventa: “La comunicazione è un dialogo, non un monologo” — coerente con la tua idea che il medium influenzi il senso.
2. LibraryThing: Il messaggio della connessione tra libri e identità.
LibraryThing è un social network basato sui libri, dove il catalogo personale diventa un’estensione della mente. Organizzazione ossessiva (tag, recensioni, liste) → “Il pensiero ha bisogno di strutture per essere compreso”. Condivisione di letture → “Leggere non è mai un atto solitario, ma una conversazione con autori e altri lettori”. Dati bibliografici come autoriflessione → “La mia libreria è una mappa della mia mente”. Cosa potrebbe dire dei tuoi messaggi? Se annoti citazioni o scrivi recensioni brevi, il messaggio è: “I libri sono vivi solo se discussi”. Se invece cataloghi senza commentare, il messaggio diventa: “L’ordine è una forma di silenziosa poesia”. Se partecipi a gruppi tematici, trasmetti: “La cultura è collettiva, non un archivio privato”.
Il meta-messaggio. Perché queste due piattaforme? Medium è fluido, immediato, performativo (scrivi per un pubblico). LibraryThing è stratificato, intimo, archivistico (scrivi per te, ma lasci tracce per altri). Insieme, rivelano un bisogno di bilanciare l’urgenza della condivisione con la profondità della conservazione — un dialogo tra presente e passato.
Se volessi approfondire. Potresti chiederti: “I miei scritti su Medium cambierebbero se fossero su Substack o su un blog personale?” (Sì, il mezzo altera il messaggio.) “Catalogare su LibraryThing è un atto di comunicazione o di autoanalisi?” (Forse entrambi: stai parlando a un futuro te stesso o a un lettore ideale.)
Gli ho poi chiesto cosa ci fa uno come me, dinosauro e bibliomane, su social come X e Facebook. Ecco la sua straordinaria risposta:
Ah, la domanda delle domande: **cosa ci fa un dinosauro bibliomane come te su Facebook o X (ex-Twitter)?**
### **1. La contraddizione in termini**
Facebook e X sono *l’antitesi* della tua natura:
- **Tu**: ami i libri fisici, la profondità, la lentezza tipografica, il silenzio delle biblioteche.
- **Loro**: algoritmi che premiano l’urlo, lo scroll compulsivo, la semplificazione violenta, il contenuto usa-e-getta.
Eppure, sei lì. Perché?
### **2. Le ragioni del dinosauro sociale (anche senza volerlo)**
Potresti essere su quei social per:
- **Missione archeologica**: studiare come l’umanità sia passata da *”Così parlò Zarathustra”* a *”meme del gatto che piange”*.
- **Disseminazione strategica**: condividere frammenti del tuo libro, link a Medium, citazioni colte — *semi lanciati nel deserto digitale*.
- **Nostalgia della piazza**: un tempo si discuteva al bar o in tipografia; oggi si fa sotto i post di Grillo o Musk.
- **Schadenfreude intellettuale**: godere (soffrendo) del trash culturale, come un antropologo che studia rituali tribali.
### **3. Cosa puoi fare lì, senza vendere l’anima?**
Se vuoi usarli *senza tradire la tua essenza*, prova a:
- **Trasformare X in un taccuino pubblico**: tweet come aforismi, come faceva Pessoa con i suoi *eteronimi*. Esempio:
*”Oggi ho trovato una virgola storta in un’edizione del ’32. Era più saggia di tutti i thread su X.”*
- **Usare Facebook come un “album di ritagli”**: condividere foto di libri rari, errori tipografici divertenti, pagine annotate a mano — *un museo minimo per pochi eletti*.
- **Creare attrito**: postare citazioni lunghe, senza spiegazioni, per *costringere chi passa a fermarsi*. Esempio:
*”Leggo su un incunabolo: ‘La luce inchiostrata non teme il buio dei secoli’. Suvvia, ditemi che non è più bello di ‘Like se anche tu ami leggere!’.”*
### **4. La domanda radicale: Devi proprio esserci?**
- **No, se ti logora**. I social sono *macchine da guerra all’attenzione*: un bibliomane può sentirsi un *bonsai in un tornado*.
- **Sì, se li domi**. Come un samurai che usa il bastone del nemico, puoi *sovvertire il linguaggio del social*:
— Postare *solo in caratteri tipografici rari* (Garamond, Baskerville).
— Rispondere ai troll con *verso dantesco* (es.: *”Ahi serva Italia, di dolore ostello…”* sotto un post politico).
— Usare i thread come *microsaggi* (su X, lo fanno già filosofi come Byung-Chul Han).
### **5. L’opzione nucleare: ritirarti in una Repubblica dei Letterati**
Se i social ti disgustano, ci sono *oasi* per dinosauri come te:
- **Goodreads** (ma ormai è un Amazon 2.0).
- **Mastodon** (dove si discute come in un *salotto ottocentesco*, con meno urla).
- **Forum di bibliofili** (spazi di nicchia dove si parla di *rilegature in pelle e errori di stampa*).
### **Conclusione: Sei un punk della carta in un mondo di pixel**
La tua presenza su Facebook o X è *un atto sovversivo*: dimostri che si può abitare il caos digitale *senza diventare il caos*.
Come? **Trattando ogni post come una *lettera mobile***:
- **Scegli con cura le parole** (perché resteranno, anche se il social muore).
- **Ignora i like** (l’approvazione dei algoritmi è meno duratura dell’inchiostro).
- **Ricorda: i social sono un mezzo, non il messaggio**. Il tuo messaggio è più grande di loro.
O, come direbbe McLuhan: *”Non chiederti cosa puoi fare tu per X, ma cosa può fare X per te”*. 😉
Se vuoi, possiamo immaginare un *decalogo del bibliomane sociale* — regole per sopravvivere online senza smettere di essere te stesso.
Ho accettato la proposta. Ecco il suo decalogo:
Eccolo qui, fresco di stampa (metaforicamente e non):
### **DECALOGO DEL BIBLIOMANE SOCIALE**
*10 comandamenti per navigare nei social senza tradire l’anima di carta*
#### **1. Non sprecherai caratteri**
Ogni post sia come un aforisma di Cioran: *essenziale, tagliente, e possibilmente tossico d’eleganza*. Esempio:
> *”Leggo. A volte annoto. Il resto è rumore.”*
#### **2. Onorerai il silenzio algoritmico**
Resisti alla tentazione di commentare ogni assurdità virale. *Il vero potere è lasciare che il caos scorra via, come acqua su un’incisione a secco.*
#### **3. Userai i social come un ex libris**
Il tuo profilo sia una *targhetta di proprietà*: foto di librerie, dettagli di copertine, refusi gloriosi. Diventerai un *archeologo della carta in un mondo di screenshot*.
#### **4. Citerai senza spiegare**
Lancia citazioni oscure *senza contesto*, come semi per pochi eletti. Chi capirà, sorriderà. Agli altri, resta il dubbio:
> *”‘La verità è una landa desolata’, diceva Eco. Ora capisco perché Zuckerberg ci ha costruito un parco giochi.”*
#### **5. Trasformerai i thread in zibaldoni**
Usa i thread (su X o FB) come fossero *annotazioni a margine*: collegamenti labirintici tra un’edizione rara di Borges e il tuo caffè stamattina.
#### **6. Non temerai il blocco**
Se un troll ti assale, seppelliscilo sotto una *bibliografia commentata*. Esempio:
> *”Caro anonimo, le consiglio: 1) ‘De contemptu mundi’ di Innocenzo III, 2) un tè caldo, 3) silenzio.”*
#### **7. Celebrerai il refuso**
Condividi errori di stampa come fossero *poesie concrete*. Un *”Edizionee raraa”* diventa arte dadaista.
#### **8. Posterai come se nessuno leggesse**
Scrivi per il *fantasma di Gutenberg* o per il tuo futuro io archivista, non per i like. La qualità è sovversione.
#### **9. Consacrerai il digitale al fisico**
Ogni post punti a qualcosa di *tangibile*: un libro, una libreria, una mappa antica. *Il tuo schermo sia una vetrina per il mondo reale.*
#### **10. Tornerai alla tua caverna**
Dopo 20 minuti online, chiudi tutto. *La vera connessione è tra te, l’inchiostro e la polvere.*
### **Extra: Il mantra del bibliomane sociale**
> *”Io sono qui di passaggio, come un’annotazione a matita su un libro usato. Non cancellaemi.”*
Se vuoi, possiamo stampare questo decalogo *con caratteri mobili* e inviarlo a Zuckerberg in una bottiglia. 🖨️[image error]
MEDIUM
- Antonio Gallo's profile
- 52 followers



