Emanuela Navone's Blog, page 8
March 29, 2022
Ti aspettiamo il 2 e il 3 aprile a Rivoli (TO)!

Ho il piacere di presentare la prossima fiera del libro targata Collettivo Scrittori Uniti, con il patrocinio del Comune di Rivoli e la collaborazione della Proloco e di Street Events, che si terrà i prossimi 2 e 3 aprile a Rivoli (TO).
Un evento spalmato su due giorni ricco di un’agenda davvero fitta e interessante.
Oltre a numerosi stand di editori e autori, come potrai vedere dall’immagine qui sotto, vi sarà anche un’intera area dedicata al fumetto, con la partecipazione dei fumettisti Giorgio Montorio e Luciano Costarelli, nonché presentazioni e aperitivi letterari.

Un evento che il Collettivo ha programmato da mesi, e mesi sono occorsi per organizzarlo, ma confidiamo tutti che sarà un’esperienza indimenticabile, per editori, autori, e soprattutto per i lettori, i quali avranno l’opportunità di conoscere nuove storie, nuove persone, e trascorrere una giornata all’insegna della cultura e dell’allegria.
E sarò presente anche io, allo stand di PubMe, con i miei libri e quelli della collana Policromia!
Un’occasione da non perdere, quindi 

L'articolo Ti aspettiamo il 2 e il 3 aprile a Rivoli (TO)! proviene da Emanuela Navone Editor Freelance.
February 12, 2022
La (difficile) arte di attendere

Le dita fremono, le idee attraversano la mente come schegge.
La tensione spasmodica di aprire quel maledetto file e sistemare tutto.
I tempi, però, non sono maturi.
Benvenuto nell’Anticamera.
[image error]Pexels.com","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"pexels-photo-90639.jpeg","orientation":"0"}" data-image-title="pexels-photo-90639" data-image-description="" data-image-caption="Photo by Serkan Göktay on Pexels.com
" data-medium-file="https://i0.wp.com/www.emanuelanavone...." data-large-file="https://i0.wp.com/www.emanuelanavone...." loading="lazy" width="1170" height="786" src="https://i0.wp.com/www.emanuelanavone...." alt="pexels-photo-90639.jpeg" class="wp-image-8248" srcset="https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 1880w, https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 300w, https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 1024w, https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 768w, https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 1536w" sizes="(max-width: 1170px) 100vw, 1170px" data-recalc-dims="1" />Photo by Serkan Göktay on Pexels.comL’AnticameraÈ un luogo ostico. Piccolo e stretto, una lampadina pende dal soffitto a illuminare flebilmente la sedia al centro.
Lì, seduto con la schiena ritta, o accasciato, o con le mani sulle ginocchia, la schiena curva, sta l’autore.
Davanti a lui, una porta.
Sopra la porta, un orologio.
Il ticchettare delle lancette, unico rumore.
Dietro la porta, la Storia.
Questa immagine, che mi è balenata nel cervello or ora, rende fedelmente l’idea di come mi sento. In attesa. In un’anticamera. So che la lancetta deve fare ancora molti, molti giri prima che io possa alzarmi e aprire la porta davanti a me. Non forzo il tempo.
Aspetto.
Quello che dovrebbe fare ogni scrittore una volta messa la parola fine alla sua storia.
Difficile, impossibile per molti versi. Là dietro c’è la Storia, la Tua Storia, e tu non puoi raggiungerla.
Perché, ti starai domandando.
Perché una volta conclusa la prima stesura è fondamentale, cruciale, sedersi e aspettare.
 La difficile attesa
La difficile attesaUsciamo dalla metafora per qualche minuto.
In tutti i corsi di scrittura e i tutti i manuali di scrittura uno dei consigli più sentiti (e giusti) è: dopo aver terminato il tuo libro, lascialo decantare per qualche mese.
Molti non lo fanno, e pure io all’inizio ero tra questi. Poi mi sono resa conto che sbagliavo.
E me ne sono resa conto poco tempo fa. Anzi, la settimana scorsa.
Da persona che scrive (e non da persona che corregge) ho sempre fretta. Quando correggo no, mi prendo più tempo possibile (spesso il tempo che mi danno gli autori, e spesso è poco, ma questo è un altro discorso). Quando scrivo qualcosa di mio, niente, non ce la faccio. Quando termino devo di nuovo metterci mano. Subito. E poi mandarlo all’editor (anche un editor si fa editare, sfatiamo questo mito!). E poverino/a, deve fare i conti con della roba che boh, si vede che quando l’ho scritta avevo la testa altrove.
Peggio è quando dopo aver terminato la prima stesura si corre a pubblicare, su KDP o altrove, o, super-peggio, si corre a mandarlo a un editore.
E ti arrivano, o leggi, testi che ancora adesso ti domandi (magari dopo anni) che significato avessero. È un’altra storia anche questo.
Dicevo, l’attesa.
E dicevo che la settimana scorsa ho capito cosa vuol dire attendere.
Ho terminato la prima stesura del mio prossimo romanzo breve, anche se definirlo così è un parolone-one, visto che sono tutto fuorché soddisfatta. Proprio l’insoddisfazione di aver terminato questo testo mi ha fatto capire che devo attendere. E una citazione di Hemingway: la prima stesura di ogni cosa è una merda.
Ora, che un libro non esca bene sulle prime capita a tutti, anzi è spesso la norma.
E proprio attendere che “decanti” ci farà capire, una volta che lo riprenderemo in mano, cosa c’è da rivedere, da riscrivere, da cancellare.
Come possiamo aver coscienza di cosa è giusto e di cosa è sbagliato, di cosa va bene e di cosa è da buttare, il giorno dopo aver terminato il nostro testo? Siamo ancora troppo attaccati a esso, siamo dentro la storia, se di storia si tratta, non abbiamo quello sguardo lucido che ci fa approcciare a esso con distacco e cattiveria.
E se lo lasciamo così com’è, rischiamo di sentire frasi di questo tipo: “Che roba ho letto, dio mio” (lettore), “Non ha senso, ti prego, riscrivilo” (editor), “Bocciato” (editore).
Da editori non ho mai ricevuto picche perché come ben sai io mi autopubblico, ma critiche e preghiere di rivedere i miei testi da lettori e editor ne ho ricevute sì.
Una sana e difficile attesa, allora.
Ho voluto condividere con te questa breve riflessione e spero tu ti sia un po’ rivisto in questi dolori di scrittore o scrittrice. Non so cosa ne uscirà perché l’attesa è iniziata da poco e di giri quelle lancette devono farle.
Una cosa ti posso dire: seduta in quella stanza vuota e stretta ripenso alla mia storia, certo che sì e non può essere altrimenti, e sto già capendo cosa non va e cosa sistemerò una volta che potrò aprire la porta.
L’attesa è anche questo: lasciar decantare, e assaporare il rumore dei tasti, o il fruscio della penna, quando nuove parole verranno fatte scorrere su carta.

L'articolo La (difficile) arte di attendere proviene da Emanuela Navone Editor Freelance.
January 25, 2022
4 dialoghi inverosimili da evitare

Scrivere un buon dialogo è un’arte che non può essere appresa in due giorni e nemmeno in dieci anni. È un lavoro costante che lo scrittore, anche il più bravo, fa su di sé e sulle proprie storie. Cancella e riscrive, cancella e riscrive, finché il dialogo non è quello giusto.
Ossia, è verosimile, porta avanti la storia, dà voce al carattere di ciascun personaggio.
Scrivere un dialogo non è quindi facile e ci vogliono ore e ore di tentativi.
Prima di capire quali sono i trucchi per un dialogo efficace, dobbiamo però capire cosa evitare.
[image error]Pexels.com","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"empty agenda with pen on crumpled bed in house","orientation":"0"}" data-image-title="pexels-photo-4792344" data-image-description="" data-image-caption="Photo by Anete Lusina on Pexels.com
" data-medium-file="https://i0.wp.com/www.emanuelanavone...." data-large-file="https://i0.wp.com/www.emanuelanavone...." loading="lazy" width="1170" height="781" src="https://i0.wp.com/www.emanuelanavone...." alt="empty agenda with pen on crumpled bed in house" class="wp-image-8241" srcset="https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 1880w, https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 300w, https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 1024w, https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 768w, https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 1536w, https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 600w" sizes="(max-width: 1170px) 100vw, 1170px" data-recalc-dims="1" />Photo by Anete Lusina on Pexels.comAs you know, Bob…Molti di voi hanno sicuramente letto da qualche parte questa frase, e se hanno seguito un corso di scrittura creativa il docente gliene avrà parlato.
Visto che in questo articolo stiamo parlando di dialoghi inverosimili, gli as you know, Bob possono tranquillamente sedersi sul podio.
Un dialogo inverosimile di questo tipo avviene ogni qualvolta i personaggi non parlano più con la loro voce bensì con quella dell’autore. In altre parole, l’autore si sostituisce ai personaggi per dare un’informazione al lettore, informazione che i personaggi, se avessero parlato con la loro voce, non avrebbero avuto motivo di dare, per svariate ragioni.
Ecco qualche esempio per farti capire meglio.
«Ciao, Maria, da quanto tempo non ti si vede. Come stai?»
«Ciao, Mario, non proprio bene. Mia sorella Giovanna e suo marito Pietro hanno avuto un incidente mentre si recavano nella nostra casa in montagna, a Valtournenche, dove abbiamo una villetta.»
Ipotizzando che Maria e Mario si conoscano da un po’, che senso ha far dire a Maria “mia sorella Giovanna“? A meno che non ne abbia due, Mario dovrebbe conoscere il suo nome. Idem per “suo marito Pietro“. Stessa cosa riguardo alle informazioni sulla casa in montagna.
A volte as you know, Bob è molto più esplicito:
«Ciao, Maria, da quanto tempo non ti si vede. Come stai?»
«Ciao, Mario, non proprio bene. Come sai, mia sorella Giovanna e suo marito Pietro hanno avuto un incidente mentre si recavano nella nostra casa in montagna, a Valtournenche, dove abbiamo una villetta.»
Come sai: as you know, Bob.
Ogni volta che sei tentato di dare un’informazione al lettore e come ultima spiaggia decidi di metterla in bocca al tuo personaggio, ragiona sempre se questo può renderlo inverosimile.
Riassunto della puntata precedenteQuesto tipo di dialogo non è tanto inverosimile quanto proprio superfluo.
La causa a monte sta nel fatto che l’autore vuole scrivere tutto (ma proprio tutto!) quello che sta accadendo, dimenticando un elemento fondamentale: se una informazione è già stata data al lettore, non ha senso ripeterla.
Mario incontrò Maria fuori del supermercato.
«Ciao, Maria, da quanto tempo non ti si vede. Come stai?»
«Ciao, Mario, non proprio bene. È dal giorno dell’incidente di mia sorella che faccio la spola tra casa e ospedale.»
«Mi dispiace. Come stanno?»
«Mia sorella ha una gamba rotta. Mio cognato… be’, non è ancora uscito dal coma.»
Mario salutò Maria rientrò in casa. Sua moglie stava finendo di preparare il pranzo.
«Oggi ho rivisto Maria, finalmente!»
«Oh, e come sta?»
«Male. Sai che sua sorella e suo cognato hanno avuto un incidente? Lei ha una gamba rotta, ma lui purtroppo non è ancora uscito dal coma.»
«Mi dispiace molto. E Maria come sta?»
«Fa sempre la spola fra ospedale e casa, poverina…»
Il dialogo di per sé è accettabile, anche se in un romanzo farebbe addormentare anche un insonne, ma non funziona. Perché? Perché le informazioni che Mario dà alla moglie il lettore le conosce già. Non ha senso riscriverle.
L’escamotage più usato e che funziona (questo sì) è mettere semplicemente: Mario aggiornò la moglie sulle condizioni della sorella di Maria e di suo marito.
Può capitare di scrivere riassunti di puntate precedenti inerenti un dialogo, ma anche riassunti di scene (Mario fa un incidente, non grave, poi torna a casa e questa volta racconta per filo e per segno alla moglie la sua disavventura), di incubi (frequentissimo: dopo l’incubo, che l’autore descrive minuziosamente, il personaggio sente il bisogno di raccontarlo a qualcuno e lo fa, di nuovo minuziosamente), e così via.
Ogni volta che ti trovi a dover ripetere un’informazione chiediti: è utile per il lettore? Se non lo è, evita di farlo.
 Spiegone
SpiegoneEd eccoci arrivati a un altro dialogo inverosimile. Tra i quattro, è quello che trovo dappertutto (anche in libri di autori famosi!).
Lo spiegone. Ovvero, un pippone lungo lungo e digeribile come un piatto di sassi.
Piccola premessa. Capita spesso di dover far raccontare a un personaggio una vicenda, o la sua storia. Non bisogna evitarlo se questo è fondamentale per la comprensione dell’intreccio (in caso contrario il lettore potrebbe perdere un pezzo essenziale della storia). Bisogna però farlo con arte (eh, sì).
Esempi di questo tipo si trovano spesso nei racconti di Lovecraft (qui un esempio).
Se ben scritto, questo “spiegone” è digeribile e soprattutto il lettore non lo considera tale.
In tutti gli altri casi, è bene una profonda cura dimagrante.
Si tratta ad esempio dei cosiddetti villain speech: quando il cattivo di turno viene sgamato (può essere un killer, il re tirannico di un luogo fantastico che vuole distruggere il mondo…), si spertica in un (noioso) monologo in cui spiega per filo e per segno com’è giunto a compiere (o a tentare di compiere) la sua azione, che sia uccidere una persona o cercare di distruggere Terrartica.
Una noia che non auguro nemmeno al mio peggior nemico.
Le informazioni vanno date, certo che sì. Ma vanno pure dosate. La sostanza, vedrai, non cambia.
Già detto…Ultimo dialogo “inverosimile”. Uso le virgolette perché anche qui, come nel caso dei riassunti di puntate precedenti, il dialogo non è di per sé inverosimile quanto superfluo.
Ecco un esempio.
Mario arrivò giusto in tempo al ristorante. Sua moglie era già lì ad aspettarlo e lo guardava battendo il piede per terra. Mario sapeva cosa significava quel gesto: la pazienza di Fiorella era oltre il limite. Avrebbe dovuto spiegarle che non era colpa sua se proprio mentre usciva di casa la vicina lo aveva ghermito e gli aveva chiesto di aiutarla a far scendere Fuffa dall’albero. E così, tra una ringhiata e una graffiata, il tempo era passato. Mario sorrise, si fece coraggio e parlò.
«Scusa per il ritardo, davvero. Quando sono uscito di casa la nostra vicina mi ha letteralmente agguantato e mi ha pregato di aiutarla a far scendere Fuffa dall’albero. Mi sono preso anche qualche graffio e quel gattaccio mi ha pure ringhiato. Il tempo è passato e…»
Se questo fosse un testo che dovrei correggere e non farina del mio sacco, evidenzierei i due periodi e sul commento a lato scriverei: informazioni già date, verificare dove tenerle e cancellarle dall’altra parte.
Scrivere dialoghi è un’arte, abbiamo detto. Nessuno li scriverà mai perfetti (nemmeno lo scrittore più bravo) e chiunque avrà bisogno di una mano. L’importante, e un buon punto di partenza, è evitare questi quattro errori. La storia sarà molto più scorrevole, e il lettore contento.
L'articolo 4 dialoghi inverosimili da evitare proviene da Emanuela Navone Editor Freelance.
January 8, 2022
I consigli di scrittura di Umberto Eco (terza parte)

Terzo “appuntamento” con i consigli di scrittura di Umberto Eco, che commenterò brevemente.
Qui trovi la prima parte e qui la seconda.
Consiglio numero 11: sii avaro di citazioni. Diceva giustamente Emerson: “Odio le citazioni. Dimmi solo quello che sai tu.”Soprattutto nei romanzi, troppe citazioni danno fastidio, alla lunga. Diverso è ovviamente il caso dei manuali e dei saggi, dove le citazioni sono invece doverose (sempre con riferimento ad autore e testo in nota a piè di pagina).
Emerson ha ragione (e pure Eco): dimmi solo quello che sai tu.
La storia è dell’autore che la scrive, e soprattutto le vicende sono dei personaggi che le vivono.
Non di altri, né tanto meno di autori famosi che magari piace citare per ingrandire l’ego.
Consiglio numero 12: i paragoni sono come le frasi fatte.In altre parole: limitare, limitare, limitare.
Scegliere paragoni, oppure metafore, è sempre bello e arricchisce un testo, ma non bisogna esagerare, né nel numero e né tanto meno nella qualità.
Lessi tempo fa la descrizione di un personaggio in cui ogni aspetto fisico era “come”. Le mani erano grandi come… il viso era bianco come… gli occhi come… e via dicendo. Forse l’autore aveva voluto, facendo così, dare più visività al personaggio, ma in realtà era un cumulo di paragoni che oltre a non dire nulla appesantivano la narrazione.
Medesimo discorso per la qualità dei paragoni: meglio evitarli se ciò rischia di confondere il lettore. (Hai mai letto impallidire come un limone? Io sì, e l’ho anche scritto, mannaggia! Fortuna che l’editor mi ha subito ripresa!)
Consiglio numero 13: non essere ridondante; non ripetere due volte la stessa cosa; ripetere è superfluo (per ridondanza s’intende la spiegazione inutile di qualcosa che il lettore ha già capito).Le ridondanze sono tipiche di una scrittura incerta: poiché ha paura che il lettore non capisca, lo scrittore ripete lo stesso concetto più volte.
Ad esempio, durante la narrazione, una frase dice che Mario è stanco perché la notte non ha dormito; e la frase dopo ripete la stessa cosa con parole diverse (Mario è esausto a causa dell’insonnia).
Oppure in un dialogo si ripete la stessa cosa che è stata scritta in precedenza: Mario vide Maria e le chiese se fosse uscita la sera precedente. “Sei uscita ieri sera?” Più sottile: Mario vide Maria. “Sei uscita ieri sera?” Con quella domanda Mario aveva voluto sincerarsi che Maria fosse uscita.
Consiglio numero 14: solo gli stronzi usano parole volgari.Ammetto di non approvare del tutto questo consiglio di Eco, perché soprattutto in storie dove la focalizzazione è interna al personaggio è normale usare il turpiloquio se questo personaggio è volgare.
Certo è che se ogni frase è frammezzata di “cazzo”, “stronzo”, “merda”, la situazione inizia a degenerare…
Consiglio numero 15: sii sempre più o meno specifico.Sai come rendere la tua scrittura più incisiva?
Ecco, parti proprio da qui.
Scrivi le cose come stanno, senza mezzi termini.
Un po’, quasi, un tantino, un pizzico, più o meno, forse… aboliscili!
Ed evita anche vocaboli passepartout come cosa, problema, il tutto, la situazione…
E, anche, rivedi ogni passaggio in cui sei stato troppo generico: il prato era puntellato di fiori colorati. Quali fiori, di che colore?
Se c’è un vocabolo specifico, perché non usarlo?
Consiglio numero 16: l’iperbole è la più straordinaria delle tecniche espressive.Secondo Treccani, l’iperbole è: “In retorica, figura consistente nell’esagerare per eccesso (è un secolo che aspetto!; te l’ho detto, te l’ho ripetuto mille volte), o per difetto (berrei volentieri un goccio di vino);
È sempre meglio non esagerare con questa figura retorica, soprattutto se si ricade in luoghi comuni.
Mario è bello da morire, abbracciare qualcuno come se non ci fosse un domani, aspettare una vita il principe azzurro…
Per rendere la tua scrittura più incisiva, di nuovo, non cadere nei cliché e, di nuovo, usa parole tue, non degli altri.
Consiglio numero 17: non fare frasi di una sola parola. Eliminale.Anche in questo caso, mi perdonino, non sono del tutto d’accordo.
Spesso è quella sola parola, isolata da due punti, a dare enfasi al testo.
Il personaggio può trovarsi in una situazione tesa, di forti emozioni, e solo quella singola parola, isolata, da sola riesce a esprimere di più di due o tre frasi.
Ovviamente, le esagerazioni non sono mai gradite.
Consiglio numero 18: guardati dalle metafore troppo ardite: sono piume sulle scaglie di un serpente.Ricordi cosa ho scritto poco fa a proposito dei paragoni che “peccano” per qualità?
Lo stesso vale per le metafore.
Possono essere belle, originali, possono essere tutto quello che vuoi, ma se il lettore non le capisce può provare confusione.
E non so te, ma io ho sempre paura dei lettori confusi.
Consiglio numero 19: metti, le virgole, al posto giusto.… anche perché le virgole sbagliate non sono soltanto un enorme errore grammaticale, ma spesso confondono (di nuovo!) il senso di quello che vuoi dire, e spesso, soprattutto se un testo è zeppo di virgole errate, rendono la lettura pressoché impossibile.
Della serie: l’editor va su Trova –> Sostituisci, e alla virgola sostituisce uno spazio, per poter così ricostruire il testo. (Mi è capitato.) Oppure l’editor, proprio a causa di virgole sbagliate che confondono, travisa l’intero testo, e poi l’autore si accanisce contro di lui perché non ha capito un’acca. (Ed è capitato anche questo.)
Consiglio numero 20: distingui tra la funzione del punto e virgola e quella dei due punti: anche se non è facile.C’è chi non li usa e chi abbonda.
La scelta è dello scrittore, ma se si sceglie di usare il punto e virgola, o di usare i due punti, è bene sapere come farlo correttamente.
Anche perché, pure in questo caso, il rischio è di creare confusione.
E noi non vogliamo un lettore confuso…
L'articolo I consigli di scrittura di Umberto Eco (terza parte) proviene da Emanuela Navone Editor Freelance.
January 5, 2022
Cosa vuole dire (veramente) “editare”?

Editare (nel senso datogli correntemente da chi fa l’editing di un testo): rivedere, correggere, revisionare, sistemare…
Ecco: già da questo verbo (che comunque Treccani definisce come atto di pubblicazione di un libro, dall’inglese to edit) abbiamo capito che dare una definizione di editing è complesso. Zingarelli ci aiuta poco: la seconda accezione di editare è: fare l’editing di un testo.
Per fortuna, però, sempre Treccani ci viene in aiuto definendo precisamente che cosa è l’editing.
Da qui parto per analizzare in modo più approfondito un lavoro che spesso (troppo) si dà per scontato.
[image error]Pexels.com","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"bokeh","orientation":"0"}" data-image-title="pexels-photo-301664" data-image-description="" data-image-caption="Photo by Pixabay on Pexels.com
" data-medium-file="https://i0.wp.com/www.emanuelanavone...." data-large-file="https://i0.wp.com/www.emanuelanavone...." loading="lazy" width="1170" height="780" src="https://i0.wp.com/www.emanuelanavone...." alt="bokeh" class="wp-image-8221" srcset="https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 1880w, https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 300w, https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 1024w, https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 768w, https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 1536w, https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 600w" sizes="(max-width: 1170px) 100vw, 1170px" data-recalc-dims="1" />Photo by Pixabay on Pexels.com“Edito”, quindi sono…Chiedo scusa già in anticipo se qualche lettore si sentirà preso in causa o se ciò che scriverò urterà la sua sensibilità. Ma sono davvero stufa di leggere commenti e articoli confusionari che altro non fanno che gettare ancora più confusione su una professione che già di suo spesso è sottovalutata (e non capita). Come sono stufa di leggere testi apparentemente “editati” (con relativo nome e cognome in colophon). Apparentemente, appunto.
Torniamo a Treccani. Il dizionario ci dice che l’editing è:
In editoria, cura redazionale di un testo per la pubblicazione, cioè lettura attenta intesa a verificare la correttezza di ortografia, grammatica, sintassi, l’organizzazione strutturale del testo e la sua coerenza interna, l’adeguatezza dello stile, l’esattezza e la rispondenza alla realtà delle asserzioni scientifiche, storiche, ecc.
Zingarelli è invece più generico:
(edit.) L’insieme delle operazioni di correzione, revisione e montaggio per la pubblicazione di un testo […].
Focalizziamoci sulla definizione di Treccani.
Possiamo dividerla in due macro-categorie:
1) lettura attenta a verificare la correttezza di ortografia, grammatica, sintassi, l’organizzazione strutturale del testo e la sua coerenza interna, l’adeguatezza dello stile: quello che io definisco micro-editing;
2) … l’esattezza e la rispondenza alla realtà delle asserzioni scientifiche, storiche, ecc.: macro-editing.
Quindi, generalizzando (anche se non mi piace), “editare” un testo è rivedere grammatica, ortografia, stile, struttura, validità delle argomentazioni e degli argomenti e, estendendo alla narrativa, validità della trama, dell’intreccio, dei personaggi…
Le definizioni sono comunque tra le più disparate, quello che conta è che l’editing comprende ciò che io definisco (non perché voglia vantarmi o altro, ma per semplicità terminologica) micro e macro-editing.
Le comprende, appunto.
 Perché, allora…
Perché, allora…… numerosi testi apparentemente “editati” presentano delle lacune a livello micro o macro (o ahimè entrambi)?
L’editor deve occuparsi di tutto. Certo, spesso offre servizi mirati a livello micro o macro, ma se gli viene richiesto un intervento di editing completo, il testo dovrà essere rivisto (corretto, sistemato, “editato”…) nella sua globalità.
Ossia, a livello di architettura narrativa E a livello ortografico-grammaticale.
L’editor non deve aver paura né di segnalare eventuali criticità a livello macro, né di intervenire sul testo (o con commenti a margine, o con evidenziazioni, l’importante è che intervenga!) se una virgola rende il periodo ambiguo, o se c’è un errore grammaticale.
È pagato per questo.
E se io pago cinquecento, settecento, mille euro, diavolo, voglio un lavoro completo (sempre, come scrivevo prima, se ho richiesto l’editing completo e non, che so, un controllo sintattico, ortografico e grammaticale). Non voglio dover poi contattare un altro editor perché termini il lavoro di un collega. Né che l’editore o il redattore editoriale debbano rimetterci mano (fatto salvo per adeguare il testo alle norme editoriali).
Se io, editore (e qui parlo anche da curatrice della collana Policromia), ricevo un testo di cui mi si dice che è stato già “editato”, non voglio sistemarlo, perché do per scontato che sia già perfetto così com’è (la realtà ahimè è diversa).
Confusione, negligenza, passatempo…La confusione su cosa sia davvero l’editing esiste ancora ed esisterà sempre. Fortuna che rispetto a qualche anno fa gli scrittori hanno decisamente le idee più chiare su chi sia l’editor (anni fa, quando ho iniziato la professione, spesso mi sentivo dire: “Ma io nemmeno sapevo esistesse l’editing”).
Poi c’è l’ampia fetta di chi (come in tutte le professioni) svolge l’editing in maniera negligente, addirittura ad minchiam (scusami, eh, ma era il termine che più si avvicinava al mio sentire), vuoi perché lo faccia come passatempo (il lavoro principale gli dà uno stipendio, ma “edita” per raggranellare qualche euro in più), vuoi perché lo faccia velocemente (magari facendosi pagare poco: lavoro in fretta, prendo tanti “clienti” e a fine mese ho un fisso decente).
Fatto sta che girano dappertutto libri mal “editati” (dappertutto, eh: nel self-publishing come nell’editoria tradizionale, piccole, medie E grandi case editrici), e tu non hai ancora capito perché hai speso quindici euro, quando potevi impiegarli meglio.
Eh sì, perché alla fine chi ci rimette è sempre lui: il lettore.
Lettore che investe tempo e denaro in un testo altrui (tralascio chi li scarica illegalmente), per poi ritrovarsi un prodotto scadente. E non serve scrivere recensioni/opinioni negative, sollecitare lo scrittore o l’editore a correggere, segnalare la bassa qualità del testo: ci sarà sempre chi lo acquisterà comunque, da una parte, e dell’altra spesso queste richieste o espressioni di disagio rimangono inascoltate (un editore se ne frega, un autore spesso anche, o altrettanto spesso crocifigge la recensione/opinione e chi vi è dietro perché no, io non sbaglio mai, oppure crocifigge lo stesso editor, perché è lui che ha corretto il libro, quindi la colpa è sua – ma lo stesso autore aveva la facoltà e il diritto, e il dovere, di sincerarsi prima chi avrebbe pagato).L'articolo Cosa vuole dire (veramente) “editare”? proviene da Emanuela Navone Editor Freelance.
January 2, 2022
Spiegone vs Da Vinci code

Hai già fatto qualche fioretto per l’anno nuovo? Io sì: dedicarmi alla scrittura in maniera full time. Spero di riuscire a farcela!
Questo articolo però non riguarda me né eventuali propositi per il 2022. O meglio, non lo riguarda al cento percento. Perché quello di cui ti parlerò oggi potrebbe essere il tuo, di fioretto. Chissà!
Oggi, infatti, vediamo di fare luce su due errori gravissimi di scrittura: se ti ci ritrovi, chissà che per l’anno che è appena nato tu non decida di evitarli. Una volta per tutte.
[image error]Pexels.com","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"aerial photography of water beside forest during golden hour","orientation":"0"}" data-image-title="pexels-photo-1144176" data-image-description="" data-image-caption="Photo by Sindre Strøm on Pexels.com
" data-medium-file="https://i2.wp.com/www.emanuelanavone...." data-large-file="https://i2.wp.com/www.emanuelanavone...." loading="lazy" width="1170" height="657" src="https://i2.wp.com/www.emanuelanavone...." alt="aerial photography of water beside forest during golden hour" class="wp-image-8213" srcset="https://i2.wp.com/www.emanuelanavone.... 1880w, https://i2.wp.com/www.emanuelanavone.... 300w, https://i2.wp.com/www.emanuelanavone.... 1024w, https://i2.wp.com/www.emanuelanavone.... 768w, https://i2.wp.com/www.emanuelanavone.... 1536w" sizes="(max-width: 1170px) 100vw, 1170px" data-recalc-dims="1" />Photo by Sindre Strøm on Pexels.comLo spiegone: aiuto!Primo gravissimo errore di scrittura creativa (con la saggistica c’è invece più tolleranza): lo spiegone.
Davvero, non so te, ma io li detesto.
Hai presente una bella storia, che ti prende, ti trascina, insomma, fai davvero fatica a staccarti dalle pagine? Ed ecco che lo scrittore interrompe tutto per… spiegare.
Mi è capitato proprio di recente. Ho terminato un libro, che in verità non è che fosse proprio nella top ten dei page-turner, ma si lasciava leggere. Verso la fine ha preso un’accelerata. Per terminare pochissimo dopo di fronte al muro: lo spiegone. Finalmente era stato scoperto l’antagonista, e cos’ha deciso lo scrittore (non menzionerò il suo nome né il titolo del libro, neppure sotto tortura!)? Cinque o sei pagine in cui il sopraccitato antagonista raccontava tutte le malefatte, e spiegava perché le avesse commesse, dove, quando e come. Uno spiegone, appunto.
Mamma mia, mi sono cadute le braccia. Ripeto: detesto gli spiegoni.
Questo esempio mi serve anche per farti capire come questi… escamotage? non saprei nemmeno io come definirli, vengono usati dallo scrittore (in erba o affermato che sia).
1) La spiegazione finale del villain (può essere un fantasy, un thriller, un noir): il nostro viene scoperto e si spertica in un monologo (nel senso letterale del termine) che lo scrittore usa perché tutti i nodi vengano sciolti. Nulla viene lasciato indietro, e il lettore si ritroverà sommerso (di nuovo, nel senso letterale del termine) da una valanga di informazioni, alcune magari nemmeno utili. Morale: il lettore, soprattutto quello più attento e quello che non vuole essere preso alla stregua di una spugna che assorbe qualsiasi cosa, si sente tradito. E preso per i fondelli. Ma insomma, dice, ci sarei arrivato anche io, bastava che mi desse qualche indizio! Non sono mica scemo, che mi si deve spiegare tutto.
2) Il racconto nel racconto (anche qui, abbraccia qualsiasi genere): arrivati a un certo punto della storia (un punto qualsiasi), occorre raccontare qualcosa. Può essere un retroscena, un flashback, la storia di uno dei personaggi. Ci sono tanti modi per farlo, ma in questo caso l’autore sceglie lo spiegone, magari sotto forma di monologo. E quindi parte un pippone di numerose pagine, inframmezzato magari da domande mirate da parte dell’interlocutore (ma in realtà è l’autore a farlo, per pilotare il dialogo-monologo e far sì che vada dove lui voglia che vada). Sbadiglio, occhi che guardano dappertutto fuorché la pagina. E ancora una volta il lettore si domanda: ma tutte queste informazioni, questo diluvio universale, non potevano essermi date un poco alla volta?
3) C’era una volta (tipico dei fantasy e degli storici): si parte dal principio (ma proprio da lì) e si bombarda il lettore della storia di X (può essere un luogo o una persona), da quando è nato/sorto fino ai tempi recenti (ossia, il momento in cui si svolge il romanzo). Se il lettore non si è stufato prima, sarà nuovamente portato a chiedersi perché diamine lo scrittore lo abbia subissato di informazioni, quando, di nuovo! queste potevano essere date poco alla volta.
Ora, se per i punti 1 e 3 c’è poco da fare, se non ridurre all’essenziale, per il punto 2 si può anche chiudere un occhio (anzi: socchiuderlo, sempre meglio rimanere con la guardia alta). Tantissimi romanzi, soprattutto contemporanei, utilizzano il racconto nel racconto per inserire un retroscena che è essenziale ai fini della storia. Però, se bravi, e bravi davvero, lo fanno in una maniera tale da non dare al lettore tutte le informazioni, ma soltanto quelle fondamentali. Il resto, il lettore (attento) lo capirà da sé.
Un esempio sono i racconti di H. P. Lovecraft. Egli faceva largo uso di questa tecnica, ma alzi la mano chi ne era annoiato! Ecco un passaggio de La maschera di Innsmouth. Nello specifico, è il momento in cui il protagonista ascolta la storia del beone Zadok, sulla città. Essendo lungo, ti lascio soltanto la parte più importante e di cui parlavo prima: quella in cui Lovecraft accenna a qualcosa senza dirlo esplicitamente. Basta che il lettore capisca (e capisce, fidati!).
Il corsivo è opera dell’autore.
«E allora, giovanotto? Non chiede più niente? Che ne direbbe di vivere in una città come questa, dove tutto imputridisce e muore, dove nelle cantine buie e nelle soffitte sbarrate di quasi tutte le case strisciano, gemono, saltano e latrano mostri? Le piacerebbe sentire urlare ogni notte dalle chiese e dalla tana dell’Ordine di Dagon, sapendo chi ulula insieme ai disgraziati di qui? E cosa proverebbe a Calendimaggio e alla vigilia di Ognissanti, se sapesse quello che sta per venire dal maledetto scoglio? Pensa che il vecchio sia un po’ tocco, eh? Be’, allora le dirò che tutto questo non è ancora il peggio! […] Lei vuole sapere che cos’è l’orrore, eh? Ebbene, non è quello che i pesci-demoni hanno fatto, ma è quello che stanno per fare! Da anni portano qui in città certe cose… le prendono dal posto in cui vengono. Le nascondono a nord del fiume, e le case di Water e Main Street sono piene di loro. Di quei diavoli e di ciò che hanno portato… Quando saranno pronti… le dico, quando saranno pronti… ha mai sentito parlare di uno shoggoth? Ehi, mi sta a sentire? Le dico che so cosa sono quelle cose… Le ho viste una notte, quando… eh… ahhhh… ah! e’yaahhhh…»
 Da Vinci code
Da Vinci codeL’altro errore di scrittura creativa è opposto allo spiegone.
In pratica, invece di scrivere una storia l’autore scrive un codice Da Vinci.
Di cosa sto parlando? Be’, di una storia in cui, poiché l’autore detesta spiegare, dà tutto per scontato.
E quando dico tutto, intendo tutto. A volte, perfino i nomi dei personaggi (e ti ritrovi paragrafi in cui “andò a casa, pranzò, si stese sul letto e guardò la tv. Si addormentò…” Sì, ma chi?!).
Mesi fa ho letto un libro (di cui ancora una volta non dirò titolo né il nome di chi lo ha scritto) che era proprio così: un Da Vinci code. A un certo punto della storia uno dei personaggi si domanda: “Vorrei proprio sapere chi era questo Mario Rossi”. La mia nota a lato del testo è stata: “Mio caro X, non solo tu vorresti saperlo, ma anche il lettore!”.
I problemi di dare tutto per scontato, e di limitare troppo le informazioni, è di precipitare il lettore in un baratro in cui, privo di appigli, non può che abbandonarsi alla caduta. Sì, perché leggere uno di questi libri è proprio una caduta nel vuoto. E la botta finale fa male, molto male.
Alcuni esempi.
1) Totale assenza di soggetti: è l’esempio di poco prima. Nella storia i soggetti (intendo proprio il nome dei personaggi) sono usati con il contagocce, con il risultato che si fatica a capire chi sta facendo cosa.
2) Mancanza di retroscena: i retroscena servono, lo abbiamo capito. Non vanno bene allungati all’inverosimile, abbiamo capito anche questo, ma nemmeno ridotti in due frasi. Anche perché se il retroscena (può essere un fatto, la vita di un personaggio, ecc.) è limitatissimo, non entrerà nella testa del lettore. Egli rischierà di dimenticarselo, e serve a poco che lo scrittore alzi le mani a mo’ di difesa dicendo: “Eh, ma io l’ho scritto là”. Scritto cosa? Due frasi di numero che solo tu capisci?
Lo ammetto, io faccio parte della schiera di scrittori che detestano spiegare. Quindi il problema che affligge le mie storie (e i poveri editor e beta reader che devono leggerle) è che spesso svelo poco. Quindi mi tocca rivedere passaggi su passaggi, per dare quantomeno una cartina affinché il lettore si orienti. Anni fa ho tentato un racconto di una ventina di pagine su questo leitmotiv. Posso evitarti la fiumana di critiche dei vari beta reader, e sintetizzo con il loro comun pensare: che diavolo ho letto?
Spiegare troppo, nell’accezione di questo articolo, non va bene. Spiegare troppo poco, nemmeno. Occorre una giusta dose. Occorre diluire le giuste e sensate informazioni. Occorre, ripeto, dare al lettore una cartina con la quale possa orientarsi nella storia. E una cartina con le indicazioni giuste, e quelle soltanto. Una cartina con troppe cose rischierà di far perdere il lettore ed egli si troverà di fronte una montagna da scalare. Una cartina con poche cose farà egualmente perdere il lettore, ma questa volta egli starà cadendo in un baratro. Senza appigli.
L'articolo Spiegone vs Da Vinci code proviene da Emanuela Navone Editor Freelance.
December 23, 2021
Di ginepro e zenzero: antologia gratuita di riflessioni e racconti sul Natale

È con grande piacere che vi presento la nuova antologia di racconti e riflessioni sul Natale a cura di alcuni scrittori di Policromia.
Insieme a loro, ho pensato: quale migliore regalo natalizio che un’antologia a tema, completamente gratuita?
E quindi ecco qui, per te e per chiunque vorrai rendere partecipe, Di ginepro e zenzero, riflessioni e racconti sul Natale.
Che ti possa portare gioia, anche solo un poco, in questo periodo di continue incertezze.
E che ti aiuti a riflettere sul vero significato del Natale.
L'articolo Di ginepro e zenzero: antologia gratuita di riflessioni e racconti sul Natale proviene da Emanuela Navone Editor Freelance.
December 20, 2021
Once upon a time… racconto o mostro?

Raccontare o mostrare? Tell o show?
Sebbene molti ripudino a priori il raccontato e si lancino sul mostrato, come per tanti altri elementi di scrittura creativa anche per show e tell non c’è la regola.
Quando usarli? Dipende.
Oggi vediamo alcuni esempi.
[image error]Pexels.com","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"photo of leaves","orientation":"0"}" data-image-title="pexels-photo-1382393" data-image-description="" data-image-caption="Photo by Madison Inouye on Pexels.com
" data-medium-file="https://i0.wp.com/www.emanuelanavone...." data-large-file="https://i0.wp.com/www.emanuelanavone...." loading="lazy" width="1170" height="780" src="https://i0.wp.com/www.emanuelanavone...." alt="photo of leaves" class="wp-image-8197" srcset="https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 1880w, https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 300w, https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 1024w, https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 768w, https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 1536w, https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 600w" sizes="(max-width: 1170px) 100vw, 1170px" data-recalc-dims="1" />Photo by Madison Inouye on Pexels.comShow, don’t tell!Per chi fosse ancora a digiuno di scrittura creativa, una delle primissime regole che insegnano corsi, master e laboratori è: mostra, non raccontare.
In altre parole, è meglio mostrare una scena anziché descriverla.
La scrittura è molto più incisiva e attrae il lettore, che al contrario tenderebbe a guardare dappertutto tranne che la pagina del libro (o lo schermo dell’e-reader).
In realtà, come per molte altre regole, anche questa ha tante eccezioni.
Una storia scritta “in tell” è difficile da leggere da seguire, il lettore fatica a immedesimarsi. Ma anche una storia scritta “in show” presenta delle difficoltà.
In effetti, oltre a saper usare show e tell, occorre sapere anche quando usarli.
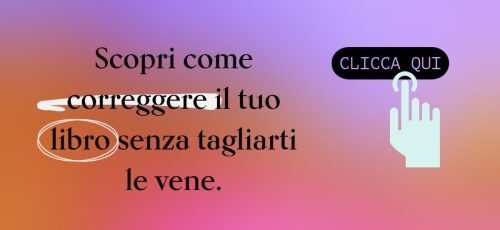 Quando mostrare?Ogni volta che ti fremono le dita per inserire un aggettivo, innanzitutto.
Quando mostrare?Ogni volta che ti fremono le dita per inserire un aggettivo, innanzitutto.Maria è arrabbiata.
Okay, ma arrabbiata come?
Maria è triste.
Triste come?
E via dicendo.
Usare uno di questi aggettivi, che definisco deboli, equivale a raccontare, a descrivere uno stato d’animo. Ma non dice nulla al lettore. Ci sono tanti modi di essere arrabbiato, ci sono tanti modi di essere triste, e così via.
Inoltre, il lettore non vede la rabbia, o la tristezza, di Maria. Lo legge, va avanti, e magari dimentica anche che Maria era arrabbiata/triste/ecc.
È meglio allora mostrare: scrivere che cosa sente Maria, o, ancora meglio, far vedere come agisce. Se è arrabbiata potrebbe dare un calcio a una sedia. Se è triste potrebbe rannicchiarsi sul letto e piangere. Le possibilità sono infinite.
Mostra anche qualsiasi scena di forti tensioni.Che sia una scena di paura, di amore, di violenza… è meglio mostrarla anziché raccontarla.
Prendo in prestito un passaggio del libro Intensity di Koontz che uso anche nel mio Prontuario di editing:
Nel corridoio i passi si fermarono. Una porta si aprì.
Senza dubbio, era assurdo attribuire un sentimento di rabbia al semplice gesto di spalancare una porta. Il rumore secco del pomello che veniva girato, il raschio del chiavistello, il cigolio dei cardini non oliati… erano solo rumori, né calmi né irati, né colpevoli né innocenti, poteva averli provocati sia un prete sia un ladro. E tuttavia lei sapeva che si trattava di movimenti compiuti con rabbia.
Sdraiata sullo stomaco, strisciò sotto il letto, i piedi contro la testiera. Si trattava di un mobile di elegante fattura, dai solidi piedi torniti e fortunatamente piuttosto alti. Un paio di centimetri di spazio in meno e non le sarebbe stato possibile usarlo come nascondiglio.
Di nuovo rumore di passi nel corridoio.
Un’altra porta si aprì. Quella della camera per gli ospiti. Esattamente di fronte ai piedi del letto.
Qualcuno accese la luce.
Chyna era sdraiata con la testa girata di lato, l’orecchio destro premuto contro la moquette. Sbirciando da sotto il letto, riusciva a vedere gli stivali neri dell’uomo e le gambe dei blue jeans dal polpaccio in giù.
[…]
La scena va avanti per molte pagine, fino al momento topico in cui la protagonista vede cadere una goccia di sangue davanti a sé e capisce di trovarsi di fronte a un killer. L’autore dosa dettagli e sensazioni per creare ansia nel lettore, e può scommetterci che ne ha creata molta, visto che avevo una decina di anni quando ho letto questo romanzo (non chiedermi cosa diavolo leggessi da bambina, avevo seri problemi già allora XD) e mi ha ossessionato per un bel po’.
Diverso sarebbe stato se Koontz si fosse limitato a scrivere: la porta della stanza si aprì. Chyna era seduta sotto il letto. Era terrorizzata. Il terrore si trasformò in orrore quando una goccia di sangue cadde davanti a lei.
Mostra anche le descrizioni.… se proprio devi descrivere!
Spesso le descrizioni sono noiose, e a meno che tu non sia un mago in questo, le ridurrei al minimo. Una descrizione, soprattutto di un luogo o di un personaggio, rallenta la scena. È come durante un film si mettesse in pausa e il narratore descrivesse questo o quello. Che pizza, no?
Se però la descrizione ti serve perché è fondamentale per la storia, allora cerca di mostrarla anziché descriverla.
Il che pare un controsenso, ma il metodo c’è.
Ecco un bell’esempio tratto da Papà Goriot di Balzac.
La prima stanza emana un odore che non ha nome nel linguaggio, e che bisognerebbe chiamare odor di pensione: tanfo di rinchiuso, di muffa, di rancido; fa rabbrividire, è umido all’olfatto, penetra attraverso gli indumenti; ha il sentore di un locale in cui si sia mangiato; puzza di gabinetto, di cucina, d’ospizio di vecchi.
No comment, direi.
Quando raccontareIn tutti gli altri casi 
Scherzi a parte, sì, in tutti i casi in cui è superfluo mostrare, usa il raccontato.
Ad esempio, se una scena deve essere veloce, ha poco senso mostrarla, e anzi: la renderesti noiosa.
Immagina di dover descrivere il tragitto in auto di Mario da X a Y. Se non succede nulla, evita di impelagarti in noiose descrizioni (sebbene raccontate) di cosa vede e di quello che questi scenari evocano: vai al dunque. Parlo di un tragitto in auto, ma può essere qualsiasi altro passaggio in cui non succede nulla e che quindi può essere risolto con due o tre frasi di raccontato: Mario prese l’auto e partì. Dopo dieci minuti era a casa.
Per questo prima scrivevo che troppo show potrebbe creare dei problemi: usandolo troppo (e magari male), potrebbe creare l’effetto opposto: appesantire tanto quanto un uso spropositato di tell.
È bene dosare, quindi.
Altri casi in cui raccontare è meglio di mostrare:
flashback brevi in cui non sono presenti dialoghi;
racconti nei dialoghi (per evitare i “pipponi”);
riassunti (di un evento già accaduto, ad esempio, a mo’ di reminder).

L'articolo Once upon a time… racconto o mostro? proviene da Emanuela Navone Editor Freelance.
December 14, 2021
“Di rose e ghiaccio” di Lara D’Amore – recensione

Lorenzo ha vent’anni e non ha mai accettato del tutto la sua omosessualità. Vagando per le vie del quadrilatero di Torino, in una sera qualunque incontra Cristian, un uomo affascinante con cui finisce per fare sesso in un albergo, dopo avere bevuto insieme qualche drink.
Lori scopre così il piacere di condividere la pelle con un uomo e la gioia di sentirsi desiderato, però, in fretta, capisce anche che, per lui, la semplice attrazione carnale non è abbastanza. Cris è, al contrario, uno spirito libero, non ama raccontare di sé e non è disposto a lasciarsi coinvolgere in relazioni sentimentali.
Tra gelosia, equivoci e rivelazioni ha inizio così la loro storia. Fragile ma travolgente, nata dal caso e da proteggere per scelta: una rosa che lotta per sbocciare nel ghiaccio.

Lorenzo è un ventenne come tanti altri, ma a differenza di molti, deve anche convivere con quella che lui definisce diversità: egli è infatti omosessuale. Proprio per questo ha dovuto reinventarsi in una nuova città, Torino, con nuovi amici e nuovi luoghi in cui vivere. Non sopportava più la stigmate che in tanti avevano dipinto sul suo petto: la esse di strano.
Lorenzo è un ragazzo insicuro, spesso goffo (tranne quando pattina), intimidito, a fatica osserva l’interlocutore negli occhi. La sua diversità gli impedisce di godersi appieno la vita.
E come c’è finito, allora, nella stanza di un motel a ore, in compagnia di uno sconosciuto che ha abbordato in un bar? Continua a chiederselo, fino a quando Cristian, lo sconosciuto, non lo soggioga con il suo sguardo e i suoi modi di fare.
È un attimo, e tutto cambia.
Non siamo padroni delle nostre emozioni, e i colpi di fulmine arrivano quando meno ce lo aspettiamo. Spesso sono fuochi fatui, altrettanto spesso ci logorano per mesi e mesi.
Ed è quello che accade a Lorenzo: sempre più preso da Cristian, non passa molto tempo prima che capisca che dal suo amante vuole qualcosa di più. Ma Cristian, spirito molto libero, saprà darglielo?
Leggo pochi romance e altrettanto pochi m/m (ossia, i romanzi lgbt con protagonisti due uomini). Spesso li trovo stucchevoli, con personaggi al limite del cliché. Però di Lara ho letto anche gli altri due suoi romanzi, Io, Omega e Varaldien, e li ho adorati. Quindi ho voluto dare una possibilità anche a Lori e Cris, certa che non mi avrebbero delusa (e ringrazio l’autrice per avermi gentilmente fatto avere la copia digitale per la recensione).
Infatti!
Ho adorato Lorenzo: mi ha ricordato me quando avevo la sua età. Insicura, indecisa, fluida, le ali ancora tarpate. Spesso sento dire che l’adolescenza è un periodo difficile. Vero, non lo metto in dubbio. Ma anche l’età dai venti ai venticinque, ventisei anni è difficile. Abbiamo più consapevolezze, più responsabilità, la nostra sessualità inizia a sedimentarsi ma al contempo ci sentiamo fluidi, come sulla soglia di qualcosa che non si è ancora palesato ai nostri occhi.
Il personaggio di Lorenzo rappresenta bene il dramma di questa età, della sua sessualità repressa, non da lui ma da chi lo circonda.
Ed è triste pensare che nel XXI secolo ci sia ancora qualcuno che ti considera diverso se ami qualcuno del tuo stesso sesso. Come dico sempre: l’amore è amore, cosa importa il sesso, l’età, appartenenze politiche o religiose? Ma lo dico io, e io non sono nessuno.
Ritornando a questo romanzo breve, mi è piaciuto molto anche lo stile di Lara (che avevo già apprezzato anche negli altri due libri): avvincente, scorrevole, insomma, un page-turner! Se inizi a leggerlo devi smettere solo arrivato alla fine, e infatti ci ho messo un giorno e mezzo a terminarlo (okay, è corto, ma anche con gli altri due suoi romanzi ci avevo messo poco  ).
).
Avrei preferito una maggiore caratterizzazione anche di Cristian, di cui sappiamo poco, e lo veniamo a sapere alla fine, e tutto dagli occhi di Lori. Soltanto l’estratto finale (magico, a mio avviso) ce lo mostra nel suo Io più profondo, ma mi sarebbe comunque piaciuto saperne di più.
No problem, non è quello a impedire la lettura.
In definitiva, Di rose e ghiaccio è una storia magica, adatta all’atmosfera natalizia priva di consumismo e orpelli vari che alcuni ancora vivono. Una storia romantica ma di un romanticismo tenue, non esagerato né tanto meno stomachevole. Da leggere d’un fiato o da gustarsi parola per parola, lasciandole scorrere in bocca e sulle labbra come un dolce di marzapane.
L'articolo “Di rose e ghiaccio” di Lara D’Amore – recensione proviene da Emanuela Navone Editor Freelance.
November 30, 2021
10 espressioni da evitare

Una scrittura incisiva e accattivante non deve mai fermarsi al “già sentito”. Anzi: più originale è e più il lettore sarà contento e se ne ricorderà.
Per questo, nell’articolo di oggi ti elenco dieci espressioni che dovresti evitare, se non vuoi cadere nella banalità e rischiare che la tua scrittura venga etichettata come “qualcosa che ho già letto”.
 Già sentito, ma cosa?
Già sentito, ma cosa?Tutti noi tendiamo a usare espressioni, frasi, vocaboli che abbiamo già sentito. Magari li abbiamo letti sui libri del nostro scrittore preferito e vogliamo usarli. Perché no? Quando una persona inizia a scrivere, molti corsi consigliano di rifarsi sui propri autori preferiti, analizzare la loro scrittura e magari prendere in prestito qualcosa. Non c’è nulla di male.
Occorre però non esagerare.
E soprattutto evitare tutte quelle espressioni che ormai usano tutti e che sono così stra-abusate da dare la nausea. Non mi riferisco a luoghi comuni intesi come proverbi o frasi fatte (scoprire l’acqua calda, ad esempio), che comunque è meglio evitare, ma a espressioni più sottili che può “far figo” usare “perché le usano tutti”.
Ecco. Proprio perché le usano tutti è meglio evitarle!
1: nero come la pece/il carboneSe è nero, è come la pece o come il carbone. Anche come l’inchiostro (anche se si legge meno).
Tante altre cose sono nere: una lavagna, un mobile, la tua auto!
Perché limitarsi al già sentito? Sii originale!
Magari i capelli del tuo personaggio Mario sono neri come le gomme della bicicletta di Luigi. O come la macchina che Luigi si è appena comprato (con i soldi di Mario!).
2: sguardo di ghiaccioSe c’è un figo nella storia, ha di certo lo sguardo di ghiaccio. Chissà perché, poi. In fondo, ho già visto dei begli uomini (e delle belle donne) anche con gli occhi scuri, e credimi che erano molto profondi!
Questo si rifà a molti dei cliché sui personaggi, che ti consiglio come sempre di evitare. Crea un personaggio tuo, non creare un personaggio sullo stampo di tanti altri.
3: sbadigliare come un leoneMeglio lasciarlo in pace, se si è svegliato con la luna storta potrebbe rincorrerci!
4: le farfalle nello stomacoSe un personaggio è innamorato, di certo sente le farfalle nello stomaco. Farfalle che frullano, svolazzano, ripercorrono le pareti con allegria e vivacità.
Sempre farfalle sono, e sempre nello stomaco stanno.
Ci sono tanti altri modi per mostrare che una persona è innamorata o attratta o invaghita: sono sicura che ne inventerai dei migliori (e originali!).
5: le braccia di MorfeoTalmente logora e abusata che ci hanno fatto anche il titolo di un libro.
Ovvio, se Mario si addormenta cadrà nelle braccia di Morfeo. Se Luigi è stanco si lascerà avvolgere tra le braccia di Morfeo. E così via…
Oh, a me ‘sto Morfeo ha stufato, non so a te!
6: silenzio assordantePrima era di tomba/tombale (sì, lo ammetto: l’ho usato anche io!).
Adesso è assordante.
Non capita un libro in cui almeno una volta non venga usato.
E basta, su, il silenzio può essere tantissime cose, ma smettiamola di usare “assordante”.
7: occhi negli occhi, occhi che si incatenano (e per liberarli è difficile)In una scena di particolare suspense (erotica), i due personaggi sono sempre occhi negli occhi, oppure i loro occhi (o il loro sguardo) si incatenano.
È un’immagine molto bella, lo ammetto, perché rende l’idea dell’attrazione di X per Y. Purtroppo, anche usatissima, ormai.
Di nuovo, facciamo uno sforzo di fantasia e troviamo qualcos’altro.
8: tremare come una foglia… in balia del vento, della tempesta, al freddo e al gelo, in inverno…
Insomma, questa povera foglia trema.
Però… hai mai visto una foglia tremare? Va be’, non è questa la sede per discuterne.
Si può tremare in vari modi e con vari paragoni, e soprattutto si può mostrare come si trema, senza ricorrere alla solita (ma facile) espressione abusata.
9: ridere di gustoOrmai tutti ridono di gusto, ci hai fatto caso?
Ho smesso di contare le volte in cui ho segnalato di variare, perché sì, spesso in un manoscritto è un’espressione che ritorna più e più volte (e più volte, più volte, più volte…).
10: accecato/a dall’iraEh sì, se Mario è arrabbiato, furibondo, furioso e qualsiasi altro aggettivo possa andar bene, è accecato dall’ira.
Di nuovo: mostrare, mostrare. Non fermarsi al primo paragone sentito e banale.
E tu? Quali espressioni hai sentito dappertutto e non sopporti? Quali ti è capitato di usare? Scrivimelo nei commenti!L'articolo 10 espressioni da evitare proviene da Emanuela Navone Editor Freelance.



