Emanuela Navone's Blog, page 5
February 7, 2023
Come rendere la tua scrittura più incisiva? (parte terza)

Uno dei difetti di numerosi testi è una scrittura poco incisiva che rallenta la lettura. Talvolta, la impedisce anche.
Vediamo oggi alcuni giri di frase o di parole da evitare, per uno stile più efficace.
Qui trovi la prima parte di questa guida sulla scrittura incisiva.
E qui la seconda.
[image error]Polar Mesospheric Clouds at Orbital Sunrise (NASA, International Space Station Science, 06\/16\/10) by NASA's Marshall Space Flight Center is licensed under CC-BY-NC 2.0","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"Polar Mesospheric Clouds at Orbital Sunrise (NASA, International Space Station Science, 06\/16\/10)","orientation":"0"}" data-image-title="4743045711_17519728d5_b" data-image-description="" data-image-caption="Polar Mesospheric Clouds at Orbital Sunrise (NASA, International Space Station Science, 06/16/10) by NASA’s Marshall Space Flight Center is licensed under CC-BY-NC 2.0
" data-medium-file="https://i0.wp.com/www.emanuelanavone...." data-large-file="https://i0.wp.com/www.emanuelanavone...." decoding="async" loading="lazy" width="1023" height="699" src="https://i0.wp.com/www.emanuelanavone...." alt="Polar Mesospheric Clouds at Orbital Sunrise (NASA, International Space Station Science, 06/16/10)" class="wp-image-8464" srcset="https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 1023w, https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 300w, https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 768w" sizes="(max-width: 1023px) 100vw, 1023px" data-recalc-dims="1" />Polar Mesospheric Clouds at Orbital Sunrise (NASA, International Space Station Science, 06/16/10) by NASA’s Marshall Space Flight Center is licensed under CC-BY-NC 2.0Accoppiate di preposizioniTi capita di usare due o più preposizioni? Ecco: questo è il primo campanello d’allarme di una frase poco incisiva e che quindi andrebbe migliorata.
Doveva discutere della nuova apertura del negozio di via Pinco Pallo.
Frase davvero lunga e bruttina, pesante da leggere.
Doveva discutere del nuovo negozio che avrebbe aperto in via Pinco Pallo.
Di uguale lunghezza, ma più scorrevole.
In alcuni casi è possibile risolvere le accoppiate di preposizioni eliminando tutte quelle informazioni che non servono alla storia.
Ero innanzi al dipinto di Mario Rossi della casa colonica di colore giallo oro.
Ero innanzi al dipinto di Mario Rossi.
Che sia nella casa colonica possiamo ad esempio scriverlo prima (dovremo pur dare questa informazione). Che sia giallo oro non serve, a meno che il dettaglio non sia fondamentale per la storia.
Gerundio, di nuovoDel gerundio ne ho parlato in alcuni articoli (qui per un cenno generale sull’uso).
A differenza di altre lingue, l’italiano usa sì il gerundio, ma soprattutto in testi tecnici e burocratici. Se ne sconsiglia l’uso in testi narrativi o manuali per un pubblico non esperto. Se ne sconsiglia soprattutto l’uso accostato ai dialoghi, come in questi esempi.
«Ciao» disse Mario entrando in casa e gettando la borsa sul divano.
«Qualcosa non va?» indagò Luigi guardando Mario e bevendo un sorso di birra.
«Beccati questa!» gridò Fiorella scattando in avanti e menando un fendente.
In casi come questi si può rimuovere il verbo che regge il dialogo e passare all’azione.
«Ciao.» Mario entrò in casa e gettò la borsa sul divano.
«Qualcosa non va?» Luigi guardò Mario e bevve un sorso di birra.
«Beccati questa!» Fiorella scattò in avanti e menò un fendente.
Il gerundio, soprattutto se doppio, appesantiva le frasi – che comunque sono ancora migliorabili.
Fai attenzione, inoltre, a usare il gerundio con lo stesso soggetto della frase principale: in italiano, infatti, non è ammesso il gerundio associato a un soggetto diverso.
La libertà di lavorare da casa mi ha aiutata molto, vivendo adesso con più serenità.
Il soggetto della frase principale è la libertà, ma il gerundio della subordinata fa riferimento a “io”, e non va bene. Occorre legarlo al soggetto della frase principale.
La libertà di lavorare da casa mi ha aiutata molto, permettendomi di vivere adesso con più serenità.
Due verbi sono meglio di tre (e un verbo è meglio di due)Come per il primo punto di questo elenco, se una frase ha due o tre verbi è un campanello d’allarme.
Mario pensò di poter riuscire ad arrivare in tempo.
La subordinata non va bene, troppo lunga. Inoltre, potere e riuscire, qui, si riferiscono alla stessa cosa.
Mario pensò di arrivare in tempo.
Migliorabile, ma già più corta e scorrevole.
Mario decise di accettare l’offerta di lavoro.
Mario accettò l’offerta di lavoro.
Più incisiva, diretta al punto.
Molto? Anche noL’avverbio “molto” è talmente usato in scrittura da essere diventato un fastidiosissimo acaro – uso il superlativo non a caso.
In un testo di cento pagine è capace di comparire cinquanta volte, segno di quanto se ne abusa.
Alcune volte può essere sostituito da un termine più diretto, altre va eliminato in quanto superfluo al cento percento.
Mario si sentiva molto stanco > Mario si sentiva/era esausto
Luigi era molto arrabbiato > Luigi era furioso
Era una giornata molto calda >à Era una giornata torrida
Queste frasi sono già migliori, anche se, come tanti insegnano, è sempre meglio mostrare che raccontare… 
Molto spesso pensava alla sua infanzia.
Molto e spesso non vanno bene insieme: qual è infatti la differenza fra “spesso” e “molto spesso”? Nessuna. Quindi togliamo l’avverbio!
Mia piace davvero molto.
Mamma mia, davvero brutta. O lasciamo uno o lasciamo l’altro. Entrambi gli avverbi appesantiscono.
Mi piace davvero.
Mi piace molto.
L'articolo Come rendere la tua scrittura più incisiva? (parte terza) proviene da Emanuela Navone Editor Freelance.
January 31, 2023
Ottimo stile con tanti errori o cattivo stile con zero errori?

La domanda del secolo, nel convieni?
Personalmente, io taglierei la testa al toro (povero…) con una risposta diversa, ma andiamo per ordine.
[image error]A portion of Green River and its tributary canyons in the state of Utah by NASA Johnson is licensed under CC-BY-NC-ND 2.0","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"A portion of Green River and its tributary canyons in the state of Utah","orientation":"0"}" data-image-title="44709428995_1c770b1e52_b" data-image-description="" data-image-caption="A portion of Green River and its tributary canyons in the state of Utah by NASA Johnson is licensed under CC-BY-NC-ND 2.0
" data-medium-file="https://i0.wp.com/www.emanuelanavone...." data-large-file="https://i0.wp.com/www.emanuelanavone...." decoding="async" loading="lazy" width="1024" height="683" src="https://i0.wp.com/www.emanuelanavone...." alt="A portion of Green River and its tributary canyons in the state of Utah" class="wp-image-8459" srcset="https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 1024w, https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 300w, https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 768w, https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" data-recalc-dims="1" />A portion of Green River and its tributary canyons in the state of Utah by NASA Johnson is licensed under CC-BY-NC-ND 2.0Stile ed errori: perché non vanno d’accordo?Una volta, durante una conversazione, il mio interlocutore disse: “Va bene qualche refuso, non importa; quello che conta è che la storia trascini”.
Ho condiviso solo in parte questa opinione e continuo a condividerla solo in parte, soprattutto quando mi capita di leggere un libro magari anche bello, ma carico, denso, di errori (non solo refusi!). Sarà deformazione professionale, ma non riesco a non storcere il naso davanti a una virgola messa a casaccio, a costruzioni morfosintattiche barcollanti o orrori grammaticali e di stile.
Passi il refuso (testi senza refusi sono rari quanto un quadrifoglio), ma gli errori proprio no. Anche se la trama è super-trascinantissima.
Una “tramona” di orroriCome ho scritto poco sopra, sebbene sia positivo che la trama regga e soprattutto invogli il lettore a proseguire (viste le piattezze che ci sono in giro ultimamente), il fatto che si accompagni a imprecisioni, refusi (tanti), errori e altro è comunque segno di scarsa cura del testo.
Purtroppo, situazioni di questo tipo non sono affatto rare.
Mi è capitato di leggere due libri, in due periodi diversi (e nota come il fenomeno sia allargato nello spazio e nel tempo), con una trama incalzante ma che avevano un grave errore di punteggiatura: la totale assenza delle virgole nei vocativi (e leggevi roba tipo che bello Maria vieni a vedere, o respira Mario respira, che, tra l’altro, scritta così si presta a diverse interpretazioni). Uno strazio.
Per non parlare, poi, di libri quasi illeggibili perché, sebbene (ripeto) la trama incoraggi la lettura, hanno una gestione del punto di vista che oserei definire oscena.
Ma di chi è la colpa?
Be’. Innanzitutto non mi sento di escludere l’autore, che dovrebbe quantomeno avere le basi della grammatica italiana e qualche nozione di scrittura creativa. Se l’autore, poi, pubblica senza passare da un editor o da un’agenzia di servizi editoriali, la colpa è sua al cento percento. Se pubblica dopo che un editor ha corretto il testo, o se viene pubblicato da una casa editrice dopo che un editor ha corretto il testo, allora la situazione cambia.
In questo ultimo caso la responsabilità è dell’editor, che non ha saputo (o voluto) correggere degnamente. E ahimè, in questo periodo dove tutti sono editor, non accade raramente. In un libro, letto di recente, l’autore ringraziava addirittura l’editor per il lavoro svolto: peccato il testo fosse zeppo di errori! Altro che ringraziarlo, era da prendere a pedate!
Ci sarebbe poi una terza opzione, terrificante per l’editor, di cui parlerò altrove ma che voglio anticiparti: lo scrittore che non si fida delle correzioni (giuste) dell’editor e che le rifiuta, e pubblica un libro denso di errori. È difficile capire quando avviene, so che succede perché è capitato a me: un autore mi aveva rimandato il testo corretto per una rilettura e mi sono accorta che tantissime correzioni non erano state accettate. Correzioni base come “sì” al posto del “si”, non minuzie. Gliel’ho fatto presente, ma chissà se poi… si è fidato.
E i pipponi scritti bene ma piattissimi?Ci sono anche quelli, sì. Più rari rispetto ai primi, ma ci sono.
Testi impeccabili dal punto di vista ortografico e grammaticale, ma con uno stile che definirei più che banale. Testi che abbandoni dopo le prime pagine, visto che niente ti trattiene.
Anche in questo caso, la colpa può essere sia di scrittori che di editor, visto che questi ultimi dovrebbero (il condizionale è doveroso) migliorare anche lo stile, laddove è carente. Tanti scrittori però hanno il timore panico degli editori che lavorano sullo stile perché temono che il loro venga stravolto. Peccato che non abbiano uno stile, quindi cosa c’è da stravolgere?
Quindi: tra ottimo stile con tanti errori e cattivo stile con zero errori mi sento di poter dichiarare: scelgo ottimo stile e zero errori.In pratica sono destinata a fallire dal principio.L'articolo Ottimo stile con tanti errori o cattivo stile con zero errori? proviene da Emanuela Navone Editor Freelance.
January 27, 2023
Consi e sconsi di gennaio

Consi e sconsi è la nuova rubrica librosa del 2023 che uscirà ogni fine mese.
In questa rubrica ti presenterò i tre libri che ho letto più belli del mese (o dei precedenti, nel caso di gennaio) e i tre che sconsiglio.
Una rubrica di forme e colori diversi, perché anche dei libri non si butta via niente!
I consi, ovvero libri belli di gennaioNb. 1 Per andare alla pagina di acquisto del libro basta cliccare sulla copertina.
Nb. 2 Purtroppo le copertine sono prese da Amazon, e quindi a bassa risoluzione. Mi dispiace.
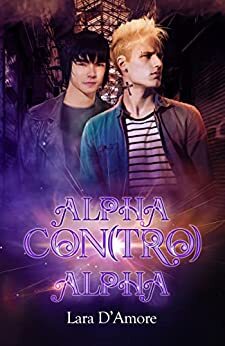
Figlio di una società che discrimina gli uomini e le donne per il loro genere secondario, Roy Baker è un giovane alpha di sedici anni con il cuore già pieno di cicatrici, che ha imparato presto a disprezzare gli omega per la loro fragilità.
È per questa sua avversione che Mark Foreman, anche lui alpha e grande sostenitore dell’uguaglianza dei generi, lo vede come un bullo. I due frequentano la stessa scuola e lo scontro non tarderà ad arrivare. Una questione d’onore per Roy, l’alpha dagli occhi di ghiaccio, tanti piercing e il tatuaggio di una croce celtica sul collo, pronto a fare a botte col mondo intero. Un gioco intrigante per Mark, detto il Corvo, l’alpha difensore degli omega, dagli abiti neri e l’aria scaltra sotto la lunga frangia. Può l’odio a prima vista avere una ragione più profonda?
Sarà il gusto del gelato al pistacchio a segnare il loro inizio, tra paure, incertezze e una buona dose di coraggio nell’andare contro le regole che ci vengono imposte.
Questo romanzo autoconclusivo, della serie Soffio di Speranza, piacerà ai lettori di Io, Omega, che anche la sottoscritta ha letto e apprezzato. Seguiremo le vicende di altri personaggi, questa volta due Alpha, Mark e Roy, soffriremo e gioiremo con loro, e arriveremo alle ultime pagine con il fiato sospeso. Perché la capacità dell’autrice è proprio quella: tenerti incollata al libro fino alla fine. E, dopo, farti pentire di averlo letto così velocemente.
Maria è una ragazza ingenua. Ama la vita, il lavoro, gli amici e ha una profonda fede in Dio. Ma questo è sempre un bene?
Silvano è ossessionato dal suo profondo odio per le donne e vuole vederle tutte morte o sottomesse all’uomo come secoli prima. Due giovani avvocati vivono una vacanza che cambierà le loro vite portandoli a fare un’importante scelta professionale. Una coppia di quarantenni, profondamente unita, sogna un mondo migliore e s’impegna a realizzarlo nella propria quotidianità. Due senzatetto, che vivono chiedendo l’elemosina, scoprono qualcosa di importante, ma rivelarlo potrebbe essere pericoloso. Una giornalista senza paura e sicura di sé si ritrova coinvolta in una vicenda che va oltre ogni sua immaginazione.
Nella bella e caotica città di Milano, che fa da sfondo a questo avvincente e intrigante noir, destini paralleli si incroceranno fino al clamoroso epilogo.
Dopo due romanzi autobiografici, il Bida esce con un noir ambientato a Milano e che tratta di un tema ahimè sempre attuale: la violenza sulle donne. Diverse storie parallele si incroceranno alla fine, lasciandoti basito, ma non per questo meno contento di aver letto il libro. Eltjon dà così prova di saper spaziare in più generi, e chissà cosa ci regalerà in futuro!
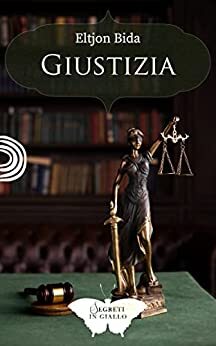
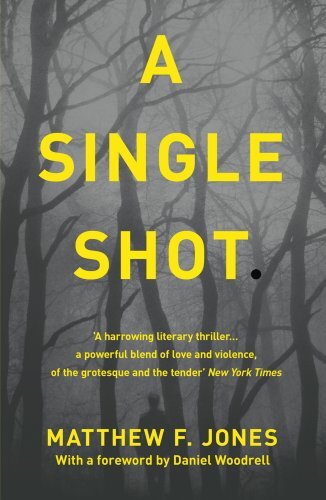
Anyone’s life can change in an instant. In Matthew F. Jones’s acclaimed novel, one man’s world is overturned with a single shot. Trespassing on what was once his family’s land, John Moon hears a rustle in the brush and fires. But instead of the deer he was expecting, he finds the body of a young woman, killed by his stray bullet. A terrible dilemma is made worse when he stumbles upon her campground – and the piles of drugs and money concealed there. Moon makes his choice: he hides the corpse, and takes the cash. His decision will have consequences he can neither predict or control.
Un thriller adrenalinico che afferra dalle prime pagine, con un finale forse intuibile, ma bello comunque (e comunque per il protagonista non c’erano molte vie di scampo!). Quello che ho apprezzato di più è però la figura di John Moon, il protagonista: un vero anti-eroe dall’inizio alla fine. Questo per dire che non sempre devi essere bello, bravo e buono perché il lettore ti segua.
Gli sconsi, ovvero libri brutti di gennaioNb 1 Libri brutti per me, si intende.
Nb 2 Cliccando sulla copertina vai alla pagina di acquisto. Questo perché i gusti sono gusti. Idem come sopra per la bassa risoluzione.
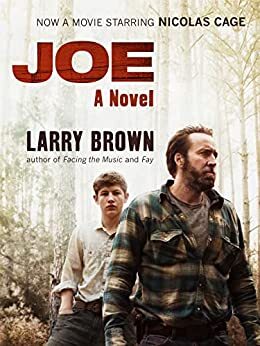
Joe Ransom is a hard-drinking ex-con pushing fifty who just won’t slow down–not in his pickup, not with a gun, and certainly not with women. Gary Jones estimates his own age to be about fifteen. Born luckless, he is the son of a hopeless, homeless wandering family, and he’s desperate for a way out. When their paths cross, Joe offers him a chance just as his own chances have dwindled to almost nothing. Together they follow a twisting map to redemption–or ruin.
Un mattone per lunghezza e contenuto. Per i 2/3 del libro non succede nulla, di Joe, che come recita il titolo dovrebbe essere il protagonista, sappiamo poco e niente, a parte che beve e uccide alberi su commissione. Meglio caratterizzato l’altro protagonista, Gary. Per fortuna. Il restante 3/3 scivola verso la fine, o forse dovrei dire rovina verso la fine, e quando arrivi a terra l’unica cosa che vorresti è alzarti e correre via.
Charlie Reade è un diciassettenne come tanti, discreto a scuola, ottimo nel baseball e nel football. Ma si porta dentro un peso troppo grande per la sua età. Sua madre è morta in un incidente stradale quando lui aveva sette anni e suo padre, per il dolore, ha ceduto all’alcol. Da allora, Charlie ha dovuto imparare a badare a entrambi. Un giorno, si imbatte in un vecchio – Howard Bowditch – che vive recluso con il suo cane Radar in una grande casa in cima a una collina, nota nel vicinato come «la Casa di Psycho». C’è un capanno nel cortile sul retro, sempre chiuso a chiave, da cui provengono strani rumori. Charlie soccorre Howard dopo un infortunio, conquistandosi la sua fiducia, e si prende cura di Radar, che diventa il suo migliore amico. Finché, in punto di morte, il signor Bowditch lascia a Charlie una cassetta dove ha registrato una storia incredibile, un segreto che ha tenuto nascosto tutta la vita: dentro il capanno sul retro si cela la porta d’accesso a un altro mondo. Una realtà parallela dove Bene e Male combattono una battaglia da cui dipendono le sorti del nostro stesso mondo. Una lotta epica che finirà per vedere coinvolti Charlie e Radar, loro malgrado, nel ruolo di eroi.
Leggo King da quando avevo tredici anni e lui scrive dal doppio del tempo. Ci sta che qualche libro esca meno bene e purtroppo negli ultimi anni i suoi libri non mi hanno fatto impazzire. Questo, però, ti fa proprio dire: Ehi, Stephen, non ci provi nemmeno più, vero? Lento l’inizio, ma non spaventa conoscendo lo stile kinghiano. Quando accelera, però, ti fa capire anche come finirà. E finirà proprio così. I rimandi a Lovecraft per le descrizioni, li avrei evitati: King è il Re, e ha la sua testa per descrivere, a che serve attingere ad altri?
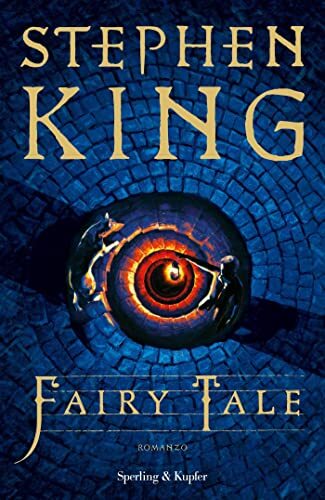
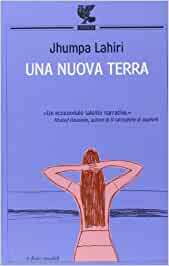
Da Boston a New York, da Londra a Roma, dall’India alla Thailandia: scenari diversi per raccontare storie di esilio e di perdita, di amore, di maternità e di conflitti famigliari. Al centro, le gioie e i drammi quotidiani di giovani immigrati di origine indiana, le loro vite divise tra due paesi e due culture. Vite come quella di Ruma, giovane madre trasferitasi a Seattle con il figlio e subito alle prese con un segreto sconvolgente custodito dal suo stesso padre; o come quelle di Hema e Kaushik, una ragazza e un ragazzo le cui esistenze rincorrendosi tracciano un percorso condiviso che dall’infanzia li porterà fino alla maturità. Otto racconti di malinconica bellezza in cui Jhumpa Lahiri delinea, con profonda sensibilità e maturità stilistica, incontri e scontri di padri e madri, fratelli e sorelle, amici e amanti.
Letto in un gruppo di lettura, a cui di tanto in tanto partecipo per scoprire autori nuovi (alla sottoscritta). Non mi ha lasciato nulla, nonostante sia scritto bene e tratti di un tema, quello dello choc culturale dovuto a sradicamento. Forse perché io ho ben salde le radici al mio territorio. Il fatto, poi, di voler quasi dire: se non emigri non hai vissuto, mi ha un po’ lasciata perplessa. Chi ha vissuto la stessa esperienza forse lo gradirà di più.
L'articolo Consi e sconsi di gennaio proviene da Emanuela Navone Editor Freelance.
January 17, 2023
Tre storie che difficilmente piaceranno (ossia: il già sentito dopo un po’ puzza)

Qualsiasi lettore forte è anche un lettore esigente, soprattutto se legge da anni (e per anni intendo venti, trenta) e soprattutto se ha letto qualsiasi genere.
Oggi, con l’aumento del numero di libri autopubblicati, ossia con l’entrata nel mercato di un numero enorme di scrittori, ma soprattutto di un numero enorme di “finti-scrittori”, si assiste a una piattezza narrativa davvero desolante. E desolante è anche il fatto che, spesso, oltre ai “finti-scrittori” autopubblicati, anche le case editrici si sono adagiate sul piattume.
[image error]Antarctic mountains by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC-BY 2.0","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"Antarctic mountains","orientation":"0"}" data-image-title="8145725224_769279904f_b" data-image-description="" data-image-caption="Antarctic mountains by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC-BY 2.0
" data-medium-file="https://i0.wp.com/www.emanuelanavone...." data-large-file="https://i0.wp.com/www.emanuelanavone...." decoding="async" loading="lazy" width="1024" height="768" src="https://i0.wp.com/www.emanuelanavone...." alt="Antarctic mountains" class="wp-image-8441" srcset="https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 1024w, https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 300w, https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" data-recalc-dims="1" />Antarctic mountains by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC-BY 2.0Che barba che noiaQuante volte ti è capitato di iniziare un libro e poi di interromperlo perché era noioso e soprattutto sapeva di vecchio? A me tante, sia di scrittori autopubblicati sia di scrittori editi da una casa editrice (questo per ripetere che il piattume è un male che si è espanso dappertutto).
Scavando nella memoria, ricordo che, dopo l’uscita de Il codice Da Vinci di Brown, tantissimi libri venivano scritti sullo stesso leitmotiv. Idem dopo Twilight e, poveri noi, dopo Cinquanta sfumature. Sulla scia del successo di questi libri (sono solo tre esempi, ce ne sono anche tanti altri), numerosi autori hanno scritto cose simili, per cavalcare l’onda, diciamo, e prendersi la propria fetta di torta. Se prima però era un fenomeno… passeggero, adesso l’onda viene cavalcata a lungo, e genera una serie di libri tutti uguali – e noiosi.
Questo articolo non esplora il panorama editoriale bensì si sofferma su tre tipologie di storie la cui impalcatura si replica a mo’ di meme e alla lunga diventa pesante. Nel primo caso non riguarda la trama in sé bensì l’ambientazione, il contesto, tuttavia il risultato non cambia: sempre noia è.
Vediamole una per una.
Happy people in happy landQualsiasi scrittore di un certo livello ci insegna che in ogni storia deve esserci conflitto. Anzi: la storia è conflitto (ti consiglio, a questo proposito, il corso di scrittura gratuito di Fabio Bonifacci, dove il conflitto è spiegato magistralmente).
Ci interessa leggere le vicende di Mario o di Maria perché siamo spinti dal conflitto che a sua volta motiva le loro azioni. Un conflitto porta sempre a un evento. Se non c’è conflitto, non c’è evento, e la storia può anche proseguire per cento pagine, ma non decollerà mai.
Ultimamente si leggono tante storie in cui… la gente è felice in un mondo felice: protagonisti circondati da famiglie superfelici, con tantissimi amici e un partner che li adora. Il lavoro è fenomenale e non c’è nulla che vada male.
Se non c’è nulla che va male, che senso ha continuare a leggere la storia di Mario o di Maria? Se sono felici così come sono, che senso ha scrivere di loro?
Non dico che debbano accadere fatti tragici, basta soltanto inserire un conflitto e aizzarlo.
E soprattutto: aizzarlo subito, non dopo cinquanta pagine. Il rischio è che il lettore, attorniato da nuvole di pan di zucchero, non ci arrivi nemmeno, alle cinquanta pagine.
E tira e tira e tira-là!Tipico dei romanzi con l’aspetto amoroso predominante, è il tira e molla: si prendono, si lasciano, si prendono-si lasciano-si prendono si lasciano e via così.
In pratica cento pagine di tira e molla. La trama è il tira e molla, dietro non ruota nulla. Non abbiamo altre informazioni, altre sottotrame, niente: solo il tira e molla dei protagonisti.
Qualcuno storcerà il naso e mi dirà: ma questa è la trama di tutte le storie d’amore, non c’è altro!
Invece c’è altro. Non tutte le commedie (o tragedie) romantiche si fondano sul tira e molla, innanzitutto, e poi, qualora ci fosse, è circondato anche da alcune sottotrame che arricchiscono un andamento principale che, se lasciato solo, non può che annoiare.
Anni fa lessi un romance urban fantasy in cui i 2/3 erano un tira e molla fra lei e lui. Poco importava se tutto sarebbe precipitato a 1/3 dalla fine: i 2/3 restanti bastavano per far chiudere il libro e gettarlo nella spazzatura (o riporlo in un cassetto per chi non ama gettare i libri).
Bello, bravo e buonoQuesto tipo di “storie” riguarda invece il sé del protagonista e di solito fa riferimento alla narrativa autobiografica. Nell’ultimo periodo ho letto numerose autobiografie, soprattutto per la collana che gestisco, e le ho accantonate tutte – tranne una, poi però la situazione si è aggravata, non per colpa dell’editore, e la pubblicazione è stata interrotta, ma di questo parleremo altrove.
Le ho accantonate, dicevo, per un motivo e uno solo: erano “agiografie”. Estremizzando il significato di questo termine, erano volte soltanto a deificare il soggetto dell’autobiografia (l’autore stesso), che si (auto)elevava a “santone” del XXI secolo.
Trattasi di storie caratterizzate dal continuo piacersi (e pascersi) dell’autore lo rendeva alla lunga noioso e antipatico, ma come potrebbe essere altrimenti se a ogni frase leggiamo che Mario è bravo a fare questo, è bravo a fare quello, ha un carattere che non se ne vedono in giro eccetera eccetera. In alcuni casi è presente una trama, in altri no.
Anche perché spesso sono persone come me e te, che non hanno fatto chissà cosa, quindi che scrivere oltre all’ordinario?
Conosci altri leitmotiv pallosi della narrativa odierna? Scrivimeli nei commenti!
L'articolo Tre storie che difficilmente piaceranno (ossia: il già sentito dopo un po’ puzza) proviene da Emanuela Navone Editor Freelance.
January 10, 2023
La mia idea non funziona!

Quante volte ti è capitato di avere un’idea che per te era L’IDEA, la migliore fra tutte, l’idea che avrebbe dato via a una delle storie più belle che tu abbia mai scritto…
… ma poi, parlandone, ti è stato detto che non funzionava?
A me è capitato un po’ di volte, e tutte le volte è stata difficile da mandare giù.
Idee, tante…In altri articoli ho parlato dell’idea alla base di un racconto o di un romanzo. Come ormai saprai, ci sono idee che valgono, idee che magari adesso non funzionano ma possono essere accantonate per poi riprenderle in un secondo momento (le “tazzine” di Stephen King) e idee che, invece, per quanto le giri e le rigiri, non porteranno da nessuna parte.
Purtroppo, in quest’ultimo caso, spesso l’autore difficilmente se ne rende conto. Non so dove l’ho già scritto, ma una storia è come un figlio, quindi sembra sempre la più bella.
A volte non è così.
Di dieci idee che ti vengono in mente, è possibile che solo due o tre riescano effettivamente a condurre a una storia.
E se è proprio l’idea che ti piace di più a essere bocciata?
 … idee che valgono, poche
… idee che valgono, pocheL’anno scorso, durante un corso di scrittura creativa, noi alunni dovevamo produrre almeno due o tre racconti e, a mano a mano che li sviluppavamo, interfacciarci con le docenti. Per quanto riguardava l’ultimo racconto, avevo qualche idea in mente che mi sembrava carina e originale, e l’ho esposta in classe.
Cassate.
O non erano originali, o lo erano ma non formulate bene, oppure l’impalcatura non reggeva… Insomma, ho dovuto pensare ad altro.
Certo, è scoraggiante quando ogni idea di storia viene bocciata. Ti svilisce, alcune persone si abbattono così tanto da smettere di scrivere per un po’. Altre magari proseguono con la loro idea per poi capire che chi l’aveva bocciata era nella ragione. Tempo sprecato, quindi.
Per quanto mi riguarda, le ho accantonate, poi, chissà.
Come comportarsi?Come comportarsi quando ci viene detto che la nostra idea non funziona?
Accantonarla sarebbe la scelta più logica, ma non in tutti i casi.
Innanzitutto, conta sì il parere dell’altro, ma soprattutto conta chi è l’altro. Mi spiego meglio.
Una persona qualunque, che non abbia le giuste competenze, difficilmente darà un parere corretto. È come se io, che non ci capisco nulla di cucina, mi permettessi di criticare uno chef sulle quantità che ha usato per preparare un piatto qualsiasi. Lo stesso vale per chiunque non abbia una conoscenza approfondita della narratologia, della scrittura, e non sia un lettore: quanto può valere il suo parere?
Questo è un problema che si pone soprattutto quando si cercano dei beta reader: come capire se è davvero un lettore e conosce l’argomento? Purtroppo, il problema si pone anche con editor e agenzie di servizi editoriali (che non dovrebbe porsi, visto che, a differenza dei beta reader, queste persone dovrebbero svolgere un lavoro dopo aver acquisito le giuste competenze).
Chiedere un parere sulla propria idea è quindi difficile: bisogna cercare la persona giusta. Soltanto dopo che si ha ottenuto il parere, dalla persona giusta, si deciderà che strada seguire.
Con una postilla: il parere di una persona competente è difficilmente sbagliato.
L'articolo La mia idea non funziona! proviene da Emanuela Navone Editor Freelance.
January 3, 2023
Generalizzare? Grazie, ma anche no!

Tutti gli scrittori (nessuno escluso!) orbitano attorno a due pianeti: il Generale e lo Specifico.
Quando si tratta di scrittura, però (ormai lo sai se segui da un po’i miei articoli), non esiste LA regola che dice “fai questo e fai quello”. Quindi, non esiste lo scrittore di serie B (o A) che generalizza o di serie B (o A) che specifica.
Tuttavia, spesso, nell’economia di una frase, è meglio o generalizzare o specificare, ed è sbagliato generalizzare o specificare.
Oggi vediamo alcuni casi in cui generalizzare funziona poco e soprattutto penalizza.
[image error]Multi-hued clouds by NASA Johnson is licensed under CC-BY-NC 2.0","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"Multi-hued clouds","orientation":"0"}" data-image-title="29518684160_35241c5c78_b" data-image-description="" data-image-caption="Multi-hued clouds by NASA Johnson is licensed under CC-BY-NC 2.0
" data-medium-file="https://i0.wp.com/www.emanuelanavone...." data-large-file="https://i0.wp.com/www.emanuelanavone...." decoding="async" loading="lazy" width="1024" height="682" src="https://i0.wp.com/www.emanuelanavone...." alt="Multi-hued clouds" class="wp-image-8422" srcset="https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 1024w, https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 300w, https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 768w, https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" data-recalc-dims="1" />Multi-hued clouds by NASA Johnson is licensed under CC-BY-NC 2.0Generalizzare?A me piace sempre partire dal significato della parola che uso a mo’ di argomento di un articolo. In questo caso, generalizzare. Secondo Treccani, nell’accezione numero due (quella che serve qui) è: “Parlare in modo generico, senza precisare o scendere in particolari.”
Declinando questa definizione alla scrittura (o meglio, alla scrittura di una storia), si fa riferimento a tutti quei casi in cui descrizioni, scene o personaggi non siano precisi o non si scenda in particolari durante l’atto di scrivere.
Come ho anticipato, non esiste LA regola che dice: qui devi generalizzare e qui devi essere più specifico. In alcuni casi, però, è bene scendere nei dettagli per colorare il testo – leggi arricchirlo –, dare una migliore spiegazione o evitare lacune che possano confondere il lettore.
Quando non generalizzare nelle descrizioniSappiamo bene, e soprattutto lo sentiamo ripetere ovunque, che le descrizioni, se non attinenti alla storia o alla scena, servono a ben poco. Anche perché novantanove su cento il lettore se ne dimentica dopo due pagine. Se proprio vogliamo inserirle, poi, le descrizioni devono essere quantomeno mostrate e non… descritte, perché il lettore possa immedesimarsi. Sennò, leggi sopra: il lettore se ne dimentica dopo due pagine.
Non è questo il momento per stabilire, o suggerire, quando e dove inserire una descrizione. Prendiamo come fatto che la descrizione va bene in quel preciso punto. In questo caso, è sempre meglio mantenere una certa accuratezza. Detto in parole (davvero) povere: già che descrivi, fallo bene!
Un albero svettava accanto alla casa.
Sì, ma quale albero?
Premesso che l’albero abbia importanza nella scena/storia/narrazione (repetitia iuvant!), il lettore sarà aiutato se gli diciamo che albero è. Una quercia? Un pioppo? Un salice piangente? Se è un salice piangente, ad esempio, il lettore potrà immaginare un abitante della casa sedersi sotto le fronde e immergersi in un clima di pace e rilassamento; fatto che non potrebbe accadere qualora l’albero fosse un pioppo, o qualsiasi altro albero i cui rami e la fogliazione “vadano in alto”.
Altro esempio.
Le pareti erano tinte di un tenue colore.
Quale?
Anche in questo caso il tipo di colore fa la differenza. Un rosato, ad esempio, mi fa immaginare una stanza per bambine, magari piena di giocattoli; un grigio chiaro mi fa pensare a una sala. Se la stanza è, diciamo, “intercambiabile” (perché non è tutto bianco e nero), specificare il colore è un segno che aiuta il lettore a comprendere meglio l’ambiente e, in ultimo, i personaggi che lo vivono.
In ultimo, classico esempio:
Un fiore giallo.
Di fiori gialli ce ne sono tante varietà e spiegare qual è, di nuovo, aiuta il lettore a immergersi nell’ambiente. Oltre a far capire, senza doverlo dire, in che periodo siamo: i narcisi sono tipici di inizio primavera, le radichielle e i piè di gallo di fine inverno (dalle mie parti sono i primi a fiorire), i denti di leone di primavera inoltrata e così via…
 Quando non generalizzare nelle scene
Quando non generalizzare nelle sceneAnche certe scene non dovrebbero essere generalizzate.
Ecco un esempio per schiarire le idee.
Dopo che Mario le ebbe parlato, Maria sentì crescere un forte sentimento.
È importante, in questo punto, capire di che sentimento si tratta, perché a seconda del tipo cambia la narrazione. È odio? È amore? È tenerezza? È compatimento?
Oppure:
Tornando dal Kenya, ho preso una malattia africana.
Di malattie africane ne abbiamo tantissime, alcune più gravi e altre meno. Anche in questo caso, specificare la malattia “prepara” il lettore a cosa avverrà. Se è ebola, ci si aspetta esiti ben gravi, ad esempio.
Nell’ospedale vennero impiegate alcune tecniche inconsuete.
Quali? Già il fatto che siano inconsuete dà un’idea di qualcosa che prima non veniva impiegato, ma non basta per far capire al lettore di cosa si sta parlando.
Quando non generalizzare con i personaggiL’ho scritto anche sopra: spesso le descrizioni sono raccontate e il lettore le dimentica subito. Ancor più spesso le descrizioni di un personaggio non servono a niente, a meno che la descrizione non sia parte integrante della storia. Scrivere, ad esempio, che Mario ha gli occhi blu può servire se successivamente il colore degli occhi avrà un ruolo importante. Scrivere che Maria indossa un braccialetto di stoffa serve se questo dettaglio sarà utile in seguito.
In tutti gli altri casi, non è sconsigliato descrivere; semplicemente, si corre il rischio che la descrizione rimanga fine a se stessa. Questo non toglie che alcune descrizioni, sebbene fini a se stesse, sono davvero suggestive e arricchiscono la nostra storia. Quindi, di nuovo: non tutto è bianco o nero.
In alcuni casi, comunque, è fondamentale caratterizzare il personaggio perché in caso contrario si rischierebbe di confondere il lettore – anche, attenzione!, se il personaggio è una semplice comparsa.
La persona a guardia dell’accampamento mi fece cenno di fermarmi.
Il termine “persona”, spesso usato proprio per le comparse, è sconsigliato perché troppo generico. È un uomo? Una donna? Anche se non comparirà più, è comunque meglio specificarne il sesso. Anche perché, nell’esempio qui sopra, la situazione può cambiare (ahimè) se chi intima di fermarsi è uomo o è donna. Un protagonista maschile “macho” e sessista (ce ne sono), infatti, potrebbe reagire diversamente se dinnanzi ha una donna.
VUOI LEGGERE ALTRI ARTICOLI DI SCRITTURA CREATIVA?
Clicca qui
L'articolo Generalizzare? Grazie, ma anche no! proviene da Emanuela Navone Editor Freelance.
October 5, 2022
Autore con editore: un decalogo

Ovvero: come NON interagire con il proprio editore.
Un decalogo di errori che, per il quieto vivere, e per un rapporto editore-autore professionale, consiglio di leggere con attenzione.
Warning: ironia a gogò, quindi se sei suscettibile ti sconsiglio la lettura.
[image error]Pexels.com","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"opened notebook","orientation":"0"}" data-image-title="pexels-photo-574283" data-image-description="" data-image-caption="Photo by Tirachard Kumtanom on Pexels.com
" data-medium-file="https://i0.wp.com/www.emanuelanavone...." data-large-file="https://i0.wp.com/www.emanuelanavone...." loading="lazy" width="1170" height="780" src="https://i0.wp.com/www.emanuelanavone...." alt="opened notebook" class="wp-image-8408" srcset="https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 1880w, https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 300w, https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 1024w, https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 768w, https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 1536w, https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 600w" sizes="(max-width: 1170px) 100vw, 1170px" data-recalc-dims="1" />Photo by Tirachard Kumtanom on Pexels.com1) Tutto ruota intorno a meL’errore principale (ahimè non l’unico) che commettono certi autori è di ritenere che l’editore stia pubblicando soltanto il suo/i suoi libro/i.
A parte che, salvo rarissimi casi, è praticamente impossibile che un editore esista solo per un autore, occorre tenere a mente che ogni casa editrice ha un piano editoriale ben preciso, con uno scadenzario che è fondamentale seguire. Spesso molti editori chiudono le selezioni proprio perché hanno già i piani uscita occupati.
Quindi ogni autore deve attenersi alle comunicazioni del proprio editore, al piano editoriale, e non ritenere che, visto che ha scritto un libro (!) e ha trovato un editore (!!), si debba fare come decide lui.
Spesso autori che si comportano così non hanno minimamente chiaro come funziona una casa editrice e tirano fuori pretese che non stanno né in cielo né in terra. Un esempio su tutti: ti chiedono prove copertina a ripetizione e se non rispetti la (loro) scadenza è finita. Come se i grafici che lavorano in quella casa editrice avessero solo quello da fare.
2) Ti querelo!Il cavallo di battaglia di ogni autore scontento è minacciare l’editore di ricorrere a vie legali se.
Talvolta ne ha ben donde, non lo metto in discussione, altre volte basta un semplice errore (anche un refuso in copertina) che parte la minaccia.
Di solito chi ragiona così ha brutte esperienze editoriali alle spalle e fa di tutta l’erba un fascio: il mio precedente editore è stato disonesto e quindi lo sono tutti.
In realtà, esistono tantissimi editori onesti, e basta uno scambio diplomatico per risolvere questi problemi (perché spesso sono davvero irrisori), senza scomodare avvocati e affini. Vaglielo a spiegare…
3) Nessuno mi vuole bene…L’autore lagnoso e insicuro è un fenomeno che ogni editore conosce.
Ritenendo di star ricevere la più grande ingiustizia del secolo (magari per il refuso in copertina di cui sopra), inizia una sequela di critiche e roba simile, magari nemmeno con l’editore ma sproloquiando sui social o sui blog, o ancora sui forum… gettando in cattiva luce l’editore.
Guai a rispondere in maniera formale, ad esempio, o a rispondere il giorno dopo a un’e-mail: e niente, non vuoi loro bene, sei cattivo, disinteressato e via di seguito!
4) Domani esce!I più simpatici (per modo di dire) sono quegli autori che decidono loro quando dovrà uscire il libro, nel totale spregio del piano editoriale e dello scadenzario di cui parlavo prima. In effetti, questo errore è fratello del “tutto ruota intorno a me”.
Memorabile (di nuovo: per modo di dire) un autore, tempi addietro, in cui sui social pubblicizzava già l’uscita del suo romanzo, una settimana dopo la firma del contratto. Senza aver parlato con l’editore, beninteso. Oppure un altro autore, le cui parole erano velate di un certo sentore di comando: “Sai, mi hanno chiesto quando uscirà il mio libro. Per non dire nulla ho risposto a fine anno, ma senza impegno eh…”. Senza impegno ‘sta cippa.
5) So che sei in ferie, ma…Classico: questi autori magari spariscono per mesi, si disinteressano del loro libro, di come sta andando la pubblicazione-promozione-ecc. (lo vedremo negli ultimi punti del decalogo), e poi un bel giorno saltano fuori con richieste assolutamente prioritarie, e non importa se l’editore è in ferie, malato, addirittura moribondo: bisogna agire, e subito.
Il cavallo di battaglia: so che sei in ferie, ma… c’è questa cosa che… eh, sì, bisogna risolverla con urgenza.
Sempre tempo addietro uno di questi autori, addirittura, arrivò a far squillare con ripetizione il mio cellulare, perché non rispondevo. Oh, magari ero in bagno con un attacco di dissenteria, o ancora a mollo nel mare, o intenta a cambiare un pannolino, ma niente: occorreva assolutamente rispondere.
6) Io, non voi!Questo autore è pienamente consapevole dei propri diritti (bene), un po’ meno dei propri doveri (meno bene); del tutto ignorante, nel senso che ignora (Ajeje cit.), dei diritti dell’editore. Anzi: l’editore non ha diritti, solo doveri.
Anche in questo caso può essere reduce da brutte esperienze editoriali, perciò impone clausole su clausole da aggiungere al contratto, di modo da blindarlo da qualsiasi attacco dell’editore sconsiderato, vietando qualsiasi azione che (a suo modo di pensare) potrebbe risultare lesiva di questi diritti.
L’editore diventa un mero esecutore, non ha più voce in capitolo. L’autore è in pratica editore di se stesso: comanda editing, copertina, pubblicazione, promozione. Ma perché non autopubblicarsi, a questo punto?
 7) Scusa, non è che potresti…?
7) Scusa, non è che potresti…?Un autore velatamente gentile che però, come il punto 6), di fatto impone la sua volontà.
Attenzione, non sto dicendo che l’autore debba essere relegato in un angolo e avere un ruolo passivo, anzi, ma a lungo andare gli “scusa, non è che potresti” diventano “senti, fai…” e “fai, oppure dovrai rendere conto del tuo operato”.
Questo autore/errore è fratello di quello successivo e ne ho già parlato in un altro articolo: si parte da una situazione di finta amicizia, con cui si sonda il terreno, per diventare via via sempre più arroganti e minacciosi.
Aneddoto: tempo fa (eh, sì), un autore minacciò di chiedere conto del mio operato perché a suo parere non eravamo stati chiari su alcune clausole contrattuali. Il medesimo autore doveva però avere la memoria corta, perché carta alla mano queste clausole erano state più che sviscerate insieme. Bastò uno screenshot a zittirlo, ma ahimè spesso non non è sufficiente.
8) Caro amico mioTanti autori vogliono da subito instaurare un rapporto che vada oltre la professionalità e sfoci in un certo tipo di amicizia.
Questo non è sbagliato: anzi, posso dire che i rapporti più belli li ho proprio con autori di questo genere.
È sbagliato quando l’amicizia valica il rispetto, o peggio, lo elimina. Come recita il detto: dai loro una mano e si prendono il braccio.
Puoi considerare l’editore tuo amico, ma fino a un certo punto.
È pur sempre, per prima cosa, l’editore del tuo libro. Occorre quindi evitare quei comportamenti che si possono sì adottare con amici di lunga data, ma che in rapporto in primo luogo professionale sono oltremodo sconvenienti, come chiamare a orari assurdi, inviare sms nelle ore più impensabili o pretendere (hai notato che questo verbo ritorna sempre?) salti mortali e favori “perché siamo amici, no?”.
9) ‘frega nienteUn altro errore, all’esatto opposto di tutti quelli che abbiamo visto in questo articolo, è disinteressarsi totalmente del libro e di quanto è a esso collegato, come pubblicazione, promozione, ecc.
Soprattutto in fase di promozione, alcuni autori non fanno nulla. Sta all’editore avviare la promozione, certamente, ma l’autore, con questo comportamento, dà l’idea di infischiarsene. Non partecipare ai bandi per fiere, saloni, fregarsene degli eventi, della possibilità di ottenere interviste, recensioni, è un comportamento che non giova all’autore, e soprattutto al libro.
L'”evoluzione”, chiamiamola così, è l’autore che, da ceccozaloniana memoria, poi cade dalle nubi.
10) Questo non me lo hai dettoL’autore cade dalle nubi, appunto, ma si trincera dietro il “questo non me lo hai detto”.
Aneddoto (ne ho tanti, lo so, ahimè): autore che per mesi è sparito, disdegnando richieste di partecipazioni a eventi, fiere, salotti letterari, che poi sbuca da sotto il mobile e, incurante che i tempi sono ormai scaduti, chiede di partecipare. Alla risposta che ormai è tardi, la replica: ma non mi è stato detto.
L’editore ha ormai tantissimi canali per tenersi in contatto con i suoi autori, come gruppi social o su WhatsApp o Telegram. Io li uso regolarmente al posto della e-mail, che spesso non viene letta. Peccato che alcuni autori silenzino le notifiche e quindi si perdano eventi e altro. Non possono poi protestare sperando che sia l’editore a cercarli ogni volta. I canali a disposizione per tenersi aggiornati li hanno, sta a loro decidere di seguirli o meno. Se non lo fanno, è una scelta.

L'articolo Autore con editore: un decalogo proviene da Emanuela Navone Editor Freelance.
September 20, 2022
Bellissimo, meraviglioso e altri inganni del “tell”

I puristi dello “show, don’t tell” epurano qualsiasi elemento di “disturbo” dai testi che scrivono (se autori) e che correggono (se editor).
A me una scrittura in “tell” non dispiace, o perlomeno non sempre la vedo con gli occhi di fiamma.
Come sempre, però, a tutto c’è un limite, e nel caso della scrittura in tell c’è un limite che, se varcato, potrebbe annoiare il lettore… o peggio.
[image error]Pexels.com","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"film photography of aman and buildings","orientation":"0"}" data-image-title="pexels-photo-3572686" data-image-description="" data-image-caption="Photo by Александр Македонский on Pexels.com
" data-medium-file="https://i0.wp.com/www.emanuelanavone...." data-large-file="https://i0.wp.com/www.emanuelanavone...." loading="lazy" width="1170" height="784" src="https://i0.wp.com/www.emanuelanavone...." alt="film photography of aman and buildings" class="wp-image-8400" srcset="https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 1880w, https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 300w, https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 1024w, https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 768w, https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 1536w" sizes="(max-width: 1170px) 100vw, 1170px" data-recalc-dims="1" />Photo by Александр Македонский on Pexels.comShow VS TellPer chi non lo sapesse, lo show riguarda un tipo di scrittura “mostrato”, dove emozioni, azioni e quant’altro sono mostrate (appunto) al lettore. Al contrario il tell riguarda un tipo di scrittura “raccontato”, dove si racconta, si descrive.
Va da sé che sarebbe bene usare un mix di show e tell per rendere il proprio stile il più accattivante possibile, e quindi evitare tutte quelle parole (aggettivi e avverbi soprattutto) che io chiamo deboli, perché non apportano nulla al testo e anzi impediscono al lettore di immergersi completamente (enfasi voluta) nella storia.
Appurato che occorre, quindi, un buon mix di show e tell, vediamo quali elementi del “raccontato” non funzionano e come evitarli (o eliminarli).
 Aggettivi deboli
Aggettivi deboliIniziamo con tre esempi, utili a chiarire la differenza fra show e tell.
Un cancello delizioso racchiudeva una graziosa villetta circondata da un giardino bellissimo.
La giovane era alta e bella, con lunghi capelli castani che le incorniciavano morbidi il viso di un ovale perfetto.
«Smettila di prendermi in giro» disse Mario furibondo. Era arrabbiatissimo quel giorno. «So che mi stai tradendo, e so anche con chi» continuò fuori di sé.
Apparentemente… non c’è nulla che non va. Le tre frasi scorrono, non ci sono errori grammaticali, sintattici o altro. Tuttavia se hai un occhio esperto, e se conosci già i fondamenti dello show don’t tell, avrai storto il naso al primo aggettivo: delizioso.
Questi tre esempi portano almeno due constatazioni.
La prima: gli aggettivi utilizzati sono deboli, perché non dicono nulla. Un cancello è delizioso, sì. E allora? La giovane è alta e bella, sì. E quindi? Mario è arrabbiatissimo. Ah, davvero?
Sono tutti aggettivi il cui unico scopo è allungare la frase e appesantirla, perché la mente del lettore non li “vede” bensì li cataloga come semplici parole e prosegue oltre. Dopo una pagina ha già dimenticato il cancello delizioso, la villetta graziosa e il giardino bellissimo. E pure la giovane e pure Mario.
Questi aggettivi non accendono nessuna luce nella testa del lettore. Non “vede”, come dicevo prima.
E poi c’è la seconda costatazione: il cancello è delizioso, la villetta graziosa e il giardino bellissimo… ma per chi? Per il lettore? No, perché il lettore non se ne fa niente di questi aggettivi deboli. Cancello, villetta e giardino sono deliziosi, graziosi e bellissimi per l’autore, che vuole imporre il suo punto di vista. Magari io, lettore, potrei ritenere quel cancello tutto fuorché delizioso, e pure la giovane, alta e bella: magari al lettore sembrerà uno spaventapasseri.
La situazione è peggiore nel terzo esempio. L’autore ci dice che Mario è furibondo, arrabbiatissimo, fuori di sé. Ma cosa vede il lettore? Niente.
Ecco, potrei proseguire per altri tre o quattro paragrafi, ma non servirebbe: il tell, usato in questo modo, è da evitare. Lo scrittore pigro, o lo scrittore che vuole imporre il suo punto di vista, è uno scrittore poco attento al lettore.
Le soluzioni?
Nelle descrizioni è semplice: qualsiasi aggettivo debole va rimosso (e la frase non perderà di significato), e se proprio si vuol far capire al lettore che la villetta è bella, e che la giovane è bella, perché questo serve alla storia, basta mostrarlo.
Come si deve mostrare il fatto che Mario è arrabbiato.
«Smettila di prendermi in giro» gridò Mario. Apriva e chiudeva i pugni, le labbra tese in una linea retta. «So che mi stai tradendo, e so anche con chi.» Diede una manata sul tavolo che fece sobbalzare il piatto e rovesciare il brik del succo di frutta.
Avverbi (enteologia)Tanti scrittori hanno studiato enteologia: ogni due righe usano un avverbio che finisce in -ente.
Ecco, questi, salvo rari casi, sono avverbi deboli e sintomo di scrittura in tell.
Facciamo qualche esempio.
Omaggiare degnamente
Imbattersi casualmente
Peggiorare ulteriormente
In alcuni casi l’avverbio è debole e ridondante. Imbattersi ha già in sé il significato di “incontrare per caso, trovarsi inaspettatamente davanti a qualcuno”, quindi l’avverbio a che serve? Idem con peggiorare ulteriormente. Se qualcosa peggiora, è ovvio che lo fa ulteriormente. Se omaggio qualcuno di qualcosa, è logico che lo faccio in modo adeguato.
Ci sono tantissimi altri esempi di enteologia (non contiamo in praticamente, veramente, completamente…).
Le soluzioni sono due ed entrambe sono drastiche: togliere ogni avverbio (e se lo farai noterai come la scrittura non perda di significato, anzi!), o sostituire l’accoppiata verbo+avverbio con una costruzione più incisiva. Solito esempio: Mario era completamente stanco > Mario era esausto > e per andare nello show > Mario trascinava un piede davanti all’altro e dovette appoggiarsi al muro per riprendere fiato.
In conclusione: non è un errore da penna rossa o penna blu scrivere in tell, e talvolta è necessario farlo, però è sempre meglio mostrare qualcosa, anziché raccontarlo: ne va dell’immersione del lettore. Un lettore che si immerge nella storia potrà essere soddisfatto o scontento, ma prova qualcosa. un lettore indifferente è il peggior nemico di ogni scrittore.
L'articolo Bellissimo, meraviglioso e altri inganni del “tell” proviene da Emanuela Navone Editor Freelance.
September 14, 2022
Editing fatto bene VS editing “a babbo”

Sì, sull’editing è stato scritto tanto e tanto ancora verrà scritto.
E per fortuna, direi, visto che fino a qualche anno fa in Italia erano in molti a non sapere nemmeno che questo lavoro esisteva.
Dall’altra parte, però, la fioritura di numerosi editor che non hanno le giuste competenze sta minando questa professione, e, altro problema grave, sta causando numerose perplessità su cosa sia davvero l’editing.
[image error]Pexels.com","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"close up of hand holding pencil over white background","orientation":"0"}" data-image-title="pexels-photo-316466" data-image-description="" data-image-caption="Photo by Lum3n on Pexels.com
" data-medium-file="https://i0.wp.com/www.emanuelanavone...." data-large-file="https://i0.wp.com/www.emanuelanavone...." loading="lazy" width="1170" height="780" src="https://i0.wp.com/www.emanuelanavone...." alt="close up of hand holding pencil over white background" class="wp-image-8396" srcset="https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 1880w, https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 300w, https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 1024w, https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 768w, https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 1536w, https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 600w" sizes="(max-width: 1170px) 100vw, 1170px" data-recalc-dims="1" />Photo by Lum3n on Pexels.comCome, non cosaSiccome, appunto, di articoli sull’editing ne escono tanti, invece di capire cosa è, cerchiamo di capire come viene fatto. E soprattutto, di distinguere l’editing fatto bene da quello fatto “a babbo”: ossia male, velocemente, con disattenzione (tre parole che un editor dovrebbe epurare dal suo vocabolario).
Un lavoro di editing veloce, infatti, contiene già in sé un paradosso: “editare” un testo spesso richiede tempo, puntigliosità e meticolosità, e mal si accorda con l’aggettivo veloce. Certo, talvolta, soprattutto chi chiede poco va veloce per “fare numero” e a fine mese ha un buon fisso, ma siamo sicuri che lavorando così facciamo il nostro bene (e il bene dell’autore e il bene del libro)?
Direi di no.
Stessa cosa per un lavoro di editing svolto con disattenzione: come la scrittura, l’editing disattento e magari non riletto provoca qualche problema, e ovviamente mina la credibilità del professionista. Se mi ritrovo un testo corretto male, sebbene ad esempio abbia pagato poco, col piffero che il prossimo testo lo faccio correggere a questa persona X. Pago di più e mi cerco un professionista serio (enfasi poiché si dà il caso che un professionista dovrebbe, dovrebbe dico, essere serio).
Ma come distinguere un buon lavoro di editing da uno cattivo, assodato che quest’ultimo è fatto male, veloce e con disattenzione?
 https://www.emanuelanavone.it/iscrizione-newsletterRefusi: sì, ma…
https://www.emanuelanavone.it/iscrizione-newsletterRefusi: sì, ma…Innanzitutto, molti diranno: un lavoro di editing fatto male presenta moltissimi refusi. Sì, ma anche no. Purtroppo, il refuso è quasi sistemico, direi, nel senso che è ormai più frequente trovare un testo (di grandi case editrici, di case editrici medio-piccole, di scrittori self in gamba e di scrittori self casalinghi e caserecci) con tre e più refusi che un testo senza. Anzi: un testo senza refusi è una rarità.
Proprio per questo il refuso difficilmente è un indicatore di cattivo editing, anche se gioca un ruolo ancora importante (se leggo un testo con venti refusi immagino che l’editor e il correttore di bozze siano stati disattenti).
Altri indicatori, magari per alcuni quisquilie, fanno capire se l’editing è stato fatto bene oppure no.
Attenzione: mi riferisco a lavori di editing che comprendono anche grammatica, sintassi ecc., sebbene una scuola di pensiero contesti che l’editing lavori anche su questo.
Stile “moscio”, frasi ridondanti, ripetizioni et similiCapiamo subito se c’è stato “poco” editing dallo stile e dalla scrittura.
Lo stile. Tanti scrittori sono reticenti a contattare un editor proprio perché temono che omogenei il suo stile al mercato (un po’ come la standardizzazione di un certo tipo di prodotti), e spesso è quello che capita con i testi di grandi scrittori, bestseller direi, il cui stile, se ci fai caso, sembra avere lo stampino. Lavorare sullo stile è però importante perché permette una lettura più agevole, più scorrevole.
Quindi occorre lavorare sull’incisività di certe frasi (magari inizi e fine di capitoli, con un dovuto aggancio per far rimanere il lettore “nella storia”), ripulire il testo da ripetizioni, ridondanze, cliché e paragoni già sentiti – e non per uniformare lo stile ma per far emergere la voce dello scrittore.
Non solo. Bisogna anche considerare il lessico, che in molti purtroppo tralasciano, valutare parola per parola se quanto si scrive è adeguato al contesto, al personaggio, all’ambiente (e quindi posso dire cazzo, perdona la volgarità, in un testo del 1200? Apparentemente no, perché il De Mauro attesta la parola al 1310. E nemmeno posso usare gli euro in Italia nel 1999).
Per non parlare di prolissità, arrampicate sugli specchi e affini, che affaticano la lettura.
Un lavoro di editing deve considerare anche questo, e se un testo presenta lacune sotto questo punto di vista, le antenne iniziano a drizzarsi. Piano piano.
Punteggiatura, ahi ahiChecché ne dicano, anche l’editor deve valutare e sistemare la punteggiatura. Soprattutto per se stesso. Anni fa mi capitò un testo abbastanza scorrevole… a patto di togliere ogni virgola e inserirle una per una da zero. Sennò, era illeggibile, anche per me, e non avrei nemmeno potuto cominciare a lavorarci.
Per non parlare della punteggiatura dei dialoghi. Ecco: questo è l’elemento che più di tutti fa capire se l’editor è stato pignolo o se, come si usa, “ci ha dato là”, ossia ci è passato sopra senza farci granché caso.
Io, nella mia piccola esperienza, capisco se il testo è stato editato male anche e soprattutto dalla punteggiatura dei dialoghi. Sarà che su questo aspetto sono fiscalissima (e chi lavora con me lo sa), ma mi accorgo subito se prima la virgola era fuori dalla virgoletta e adesso è dentro. Non voglio vantarmi, ci mancherebbe, ognuno ha le proprie fisime (ci sono ad esempio colleghe che dal primo paragrafo si accorgono se il testo è stato scritto con distrazioni o senza!).
Certo, molti di voi sbufferanno pensando che l’importante è che il testo si legga, queste sono sciocchezze.
No, perché un buon lavoro di editing (unito a un altrettanto buon lavoro di correzione di bozze) è anche e soprattutto (lo sto ripetendo un sacco, perdonami!) questo.
Ma anche…
IncoerenzeIl vero lavoro di un editor, dicono quelli della scuola di cui sopra. Una parte fondamentale, mi accodo io.
Aneddoto. Tempo fa ho letto un libro, pubblicato da una casa editrice (precisazione per chiunque ritenga che i libri scritti male siano solo self), davvero bello e che mi ha presa fino all’ultima pagina. Peccato che proprio all’inizio ci fosse un’incoerenza grande come un grattacielo che, per carità, non inficiava la storia, però mi ha fatto capire che l’editor era stato… disattentino direi: a pagina 20, diciamo (non ricordo di preciso), era morta la sorella del protagonista. Qualche pagina dopo (non cento!) a essere morta era la moglie.
Non penso serva fare altri esempi.
In conclusione, tu, autore, se ricevi un testo che manca di queste “sottigliezze” (neanche tanto), fossi in te mi farei qualche domanda. E pure se leggi un testo con gli stessi problemi pubblicato da un editore a cui volevi mandare il tuo manoscritto. Sicuramente saranno bravi in altre cose, ma con l’editing c’è ancora molto da lavorare.
L'articolo Editing fatto bene VS editing “a babbo” proviene da Emanuela Navone Editor Freelance.
September 6, 2022
Morfosintassi della fantasia

Spesso sento dire che una volta che conosci le regole, disattendile.
Ecco, in scrittura creativa è sempre un piacere farlo (sì!), perché altrimenti dove starebbe la creatività?
In scrittura creativa, appunto, non in scrittura (e basta).
[image error]Pexels.com","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"man sitting under a tree reading a book during night time","orientation":"0"}" data-image-title="pexels-photo-4256852" data-image-description="" data-image-caption="Photo by Josh Hild on Pexels.com
" data-medium-file="https://i0.wp.com/www.emanuelanavone...." data-large-file="https://i0.wp.com/www.emanuelanavone...." loading="lazy" width="1170" height="780" src="https://i0.wp.com/www.emanuelanavone...." alt="man sitting under a tree reading a book during night time" class="wp-image-8386" srcset="https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 1880w, https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 300w, https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 1024w, https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 768w, https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 1536w, https://i0.wp.com/www.emanuelanavone.... 600w" sizes="(max-width: 1170px) 100vw, 1170px" data-recalc-dims="1" />Photo by Josh Hild on Pexels.comLa morfosintassiSecondo Treccani, la morfosintassi è lo “studio sistematico delle regole che presiedono alla formazione di un enunciato linguistico (parole, sintagmi, frasi) mediante la combinazione di morfemi. La m. si occupa dei rapporti reciproci delle parole nella frase, come per es. nella concordanza fra nome e aggettivo (libro rosso, e non rossi o rosse), nome e verbo (il cane gioca e non il cane giocano).”
È chiaro, anche per chi non padroneggia la linguistica o comunque ha difficoltà grammaticali (che è normale e non deve spaventare ammetterlo: siamo umani e abbiamo dei limiti), che la morfosintassi, sebbene con questo nome quasi aulico, pomposo, è alla base della scrittura.
Ognuno di noi padroneggia la morfosintassi da quando ha imparato a scrivere, magari senza sapere che si chiama così.
È la base della base, diciamo.
Errori di morfosintassi possono seriamente compromettere la comprensione, e ancora prima, la lettura di un testo.
 I miei genitori va al mare
I miei genitori va al marePer fortuna i moderni software di scrittura, come Word e compagnia, sanno subito riconoscere molti tra gli errori di morfosintassi, e se allo scrittore o all’editor sfuggono sarà la “penna” blu di Word a ricordarglielo.
Nella frase del titolo, infatti, Word sottolinea in blu “va”.
I miei genitori va al mare è un errore morfosintattico, nello specifico un accordo sbagliato: si ha confuso la terza persona singolare con la terza persona plurale, quella corretta.
Altri esempi riguardano accordi sbagliati di aggettivi o articoli, come l’uomo era vogliosa di vendetta o la case era dipinta di bianco.
Queste frasi sono davvero semplici da correggere e bastano poche dosi di bianchetto, o qualche clic.
Che succede però se l’errore morfosintattico è contenuto in una frase complessa, con coordinate e subordinate? E se si somma ad altri errori grammaticali?
Errori di questo tipo sono spesso frutto di disattenzione, mancanza di rilettura o, peggio, di una conoscenza nulla della lingua italiana.
Non bastano pochi clic e nemmeno una piccola dose di bianchetto. Qui occorre riscrivere. E, nel caso dell’editor, capire qual era il messaggio principale fatto passare dall’autore.
A turbare la serenità di quel pomeriggio e la siesta che si concedeva sempre Mariuccia fu spezzata dallo squillo del telefono.
La frase è di per sé comprensibile (sappiamo cosa succede), ma per nulla leggibile, e grammaticalmente sbagliata. Può essere riscritta in due modi, a seconda di cosa si vuol far emergere.
A turbare la serenità di quel pomeriggio e la siesta che si concedeva sempre Mariuccia fu lo squillo del telefono (accento sul disturbo generato).
Lo squillo del telefono spezzò la serenità di quel pomeriggio e la siesta che si concedeva sempre Mariuccia (accento sul soggetto che disturba).
Per Raffaello ed Ezechiele, e anche per Olivia, Ortensia e gli altri gatti, sui loro visi si leggeva la preoccupazione: chi avrebbe dato loro da mangiare quel giorno?
Altra frase comprensibile ma grammaticalmente sbagliata (e illeggibile).
Anche in questo caso possiamo riscriverla in due modi.
Per Raffaello ed Ezechiele, e anche per Olivia, Ortensia e gli altri gatti, non sapere chi avrebbe dato loro da mangiare era fonte di preoccupazione.
Sui visi di Raffaello ed Ezechiele, e anche su quelli di Olivia, Ortensia e gli altri gatti, si leggeva la preoccupazione: chi avrebbe dato loro da mangiare quel giorno?
Errori di questo tipo, come avrai ben capito, minano una storia (o un saggio, o un manuale) nelle sue fondamenta. Pensa a un testo di duecento, trecento pagine così: illeggibile. Per prima cosa, quindi, occorre un bel (e lungo) lavoro di correzione. Certo, si ha sempre fretta di pubblicare o di inviare il testo all’editor, all’editore o all’agente, ma, come non mi stancherò mai di ripetere, prima bisogna rileggere, rileggere e rileggere.
L'articolo Morfosintassi della fantasia proviene da Emanuela Navone Editor Freelance.



