Fabrizio Ulivieri's Blog, page 57
February 23, 2023
About those who are looking for the truth and those who are not
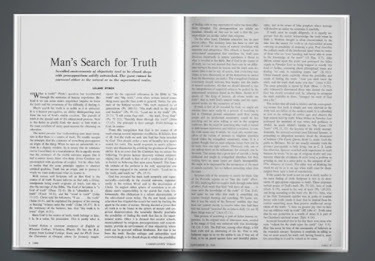
There is a real risk to end up thinking that those who do not seek the truth it is because they are predetermined to act in such a way. But as Saint Augustine makes clear, from the very beginning we are given the possibility to decide. It is up to us, it is in our free will to decide whether to remain in the Good that has been given to us from the beginning or to choose Evil. The choice, obviously, always takes place following certain signs that appear around us, we are immersed in a system of created nature, and through this system, we are interacted, interoperated and connected with the One who set this whole system in motion, in lay terms with the Moment-When-The-System-Originated.
In fact, Saint Augustine said [1] naturae competit esse cum Deo: It belongs to nature to be with God. Because sine dubio, ubi est vitium, natura non vitiata praecedit: without a doubt, where there is vice, a non-vitiated nature precedes
[1] De Civitate Dei XI, 17
Sobre los que van buscando la verdad y los que nunca la buscan

Se corre el riesgo de poder pensar que quienes no buscan la verdad lo hacen porque están predeterminados a hacerlo. Pero como aclara San Agustín, este no es el caso. Desde el principio se nos da la posibilidad de decidir. Depende de nosotros en nuestro libre albedrío decidir si permanecer en el bien que se nos ha dado desde el principio o elegir el mal. La elección, obviamente, siempre tiene lugar siguiendo ciertos signos que aparecen a nuestro alrededor, estamos inmersos en un sistema de naturaleza creada, y a través de este sistema estamos interactuatos y conectados con Quien puso en marcha todo este sistema, en términos laicos con el Momento-Cuando-El-Sistema-Originó.
De hecho San Agustín dijo [1] naturae competit esse cum Deo: Pertenece a la naturaleza estar con Dios. Porque sine dubio, ubi est vitium, natura non vitiata praecedit: sin duda, donde hay vicio, una naturaleza non viciada precede
[1] De Civitate Dei XI, 17
February 21, 2023
Autobiografia di un poeta - da lui medesimo scritta (Giorgio conosce Luisa)

Ma quando aveva cominciato a pensare alla poesia in modo così vitale?
Se lo ricordava bene. Avrà avuto diciotto anni.
Era stato in un bellissimo giorno d‘estate, probabilmente a metà di giugno, mentre camminava sul Ponte di Mezzo, e aveva visto una mamma baciare sua figlia, nell‘atto di separarsi, e aveva visto come si illuminavano gli occhi di quella madre al solo guardare la figlia.
Lì, a metà del ponte, aveva inteso che la poesia è il bello che vive e pulsa nell‘uomo, e che affiora talvolta e si manifesta in moti di commozione e di felicità. Probabilmente la poesia è molto vicina alla felicità. Pensò. Al piacere di vivere e di essere umani quando ti senti mondato del lezzume del mondo.
Ed è soprattuto poesia l‘emozione della meraviglia, la capacità di stupirsi davanti al mondo, nonostante tutto.
Questa meraviglia, questa capacità di meravigliarti o ce l‘hai o non ce l‘hai. E‘ come avere un naso camuso o aquilino. Una proprietà tua e particolare, che solo tu hai e hai un modo unico e irripetibile.
Volge il sole al tramonto; un luccichiocava dai vetri, un dorato splendore,
della casetta su in alto romita.
E tutto il dolce che c’è nella vita
in quel sol punto, in quel solo fulgore
s’era congiunto, in quell’ultimo addio.
All‘Istituto di glottologia, dove insegnava il padre, frequentava i corsi di sanscrito ma tenuti dall‘assistente del padre. Il dottor Daniele Poggi, specializzato in indo-iranico, che oltre ai testi dei Veda studiava con grande interesse, e profitto, quelli dell‘Avesta.
Le sue lezioni erano minuziose analisi delle parole da un punto di vista glottogonico. I 45 minuti di lezione volavano via sull‘analisi di una o due parole, molte volte.
Si ricordava di una lezione intera sulla particella ápa, presente nei testi vedici. Pert 45 minuti spaziò dal greco antico ἀπό all‘ittita āppa , āppan, al luvio apara/i, licio epre/i per finire all‘avestico apāxtara-.
Erano percorsi tortuosi che lo meravigliavano e lo rapivano e lo portavano in estasi, perso in quel monto di segni arcaici che continuavano a parlare nel mondo dopo secoli e secoli a chi voleva sentirli parlare.
Non etrano molti in quel corso. Nei momenti di massimo affollamento potevano raggiungere le 7 unità.
Nel corso vi era una ragazza dai capelli scuri, ricci, con una lunga coda di cavallo. Labbra carnose. Occhi grandi verdi come il mare e seni prominenti duri come due meloni.
Si chiamava Luisa.
Non era una studentessa giovanissima, aveva 27 anni come poi scroprì.
Qualche volta, specialmente nelle uggiose e fredde giornate d‘inverno, non era raro che fossero lui e lei i soli a seguire il corso.
Siete i miei più fedeli studenti. Si rivolse a loro due una volta il dottor Poggi al termine di una di quelle sue lezioni mozzafiato. Come vi chiamate? Chiese sinceramente incuriosito il professore.
Fu allora che Giorgio scoprì che lei si chiamava Luisa.
Fu allora facendo conversazione con il professore che cominciarono a parlarsi e a conoscersi. Prima di allora mai si erano parlati. Appena si erano salutati.
Così quando il professore, ringraziandoli, li salutò, Giorgio e Luisa continuarono a parlare e decisero di andare in un bar vicino all‘istituto per mangiare qualcosa insieme.
Le lezioni finivano sempre verso mezzogiorno e si offriva bene quella situazione di andare a pranzo insieme, qualcosa in modo completamente naturale. Spontaneo e senza forzature.
Ma tu, Luisa, di dove sei? Non hai l‘accento toscano. Le chiese Giorgio mentre addentava un panino al tonno e carciofini con tanta maionese.
Sono di Parma.
Di Parma?
Sì.
E abiti alla casa dello studente?
No, a Firenze.
A Firenze???
Sì.
Che curioso...e come mai?
Mio marito insegna all‘università di Firenze.
Tuo marito??? Sei sposata?
Sì. Lui è molto più anziano di me. Venti anni di più. Ci siamo conosciuti in un corso di filologia baltica all‘università di Firenze. Poi ci siamo innamorati e sposati.
E perché non studi a Firenze? E perché soprattutto fai sanscrito e non una lingua baltica?
Non era conveniente che io continuassi a frequentare l‘isituto di baltistica a Firenze. Dava adito a voci che lui mi aiutasse e favorisse negli esami. Allora ho deciso di venire a Pisa e studiare sanscrito. Sai che ci sono molte analogie fra il sanscrito e il lettone, il lituano in particolare.
No, non lo sapevo. Per esempio?
Molte parole per esempio. Ti faccio qualche esempio ma sono molte di più...Per “fumo“ in lituano abbiamo dūmasin sanscrito abbiamo dhumas. “Uomo“ lituano vyras sanscrito viras. “Lupo“ abbiamo vilkas in lituano e vrikas in sanscrito. “Notte“ naktisin lituano e naktis in sanscrito, ratase rathas per dire “ruota“, šuo e švan per “cane“...e poi il futuro lituano è uguale al futuro sigmatico sanscrito: per esempio le prime tre persone singolari...būsiu "sarò" būsi "sarai" bus "sarà" sono pari pari il sanscrito bhaviṣyāmi bhaviṣyasi bhaviṣyati...che poi se ti ricordi c‘è anche in greco antico λύσω λύσεις λύσει ...
Era bella Luisa. E colta. Si sentiva attratto da lei. Mentre lei parlava lui la seguiva come fosse pietrificato dai suoi occhi grandi e incantatori come quelli della gorgone Medusa.
Come sei bella Luisa! Le disse imbambolato, con la faccia da pesce lesso, mentre lei continuava a parlargli con tanto trasporto delle somiglianze fra la lingua lituana e sanscrita.
Lei si fermò. Lo guardò per un attimo in modo strano e tesa, quasi offesa. Poi il suo viso divenne dolce, morbido e non più teso, e arrossì improvvisamente fino alla punta dei capelli.
Io ero, Giorgio - Giorgio conosce Luisa

Ma quando aveva cominciato a pensare alla poesia in modo così vitale?
Se lo ricordava bene. Avrà avuto diciotto anni.
Era stato in un bellissimo giorno d‘estate, probabilmente a metà di giugno, mentre camminava sul Ponte di Mezzo, e aveva visto una mamma baciare sua figlia, nell‘atto di separarsi, e aveva visto come si illuminavano gli occhi di quella madre al solo guardare la figlia.
Lì, a metà del ponte, aveva inteso che la poesia è il bello che vive e pulsa nell‘uomo, e che affiora talvolta e si manifesta in moti di commozione e di felicità. Probabilmente la poesia è molto vicina alla felicità. Pensò. Al piacere di vivere e di essere umani quando ti senti mondato del lezzume del mondo.
Ed è soprattuto poesia l‘emozione della meraviglia, la capacità di stupirsi davanti al mondo, nonostante tutto.
Questa meraviglia, questa capacità di meravigliarti o ce l‘hai o non ce l‘hai. E‘ come avere un naso camuso o aquilino. Una proprietà tua e particolare, che solo tu hai e hai un modo unico e irripetibile.
All‘Istituto di glottologia, dove insegnava il padre, frequentava i corsi di sanscrito ma tenuti dall‘assistente del padre. Il dottor Daniele Poggi, specializzato in indo-iranico, che oltre ai testi dei Veda studiava con grande interesse, e profitto, quelli dell‘Avesta.
Le sue lezioni erano minuziose analisi delle parole da un punto di vista glottogonico. I 45 minuti di lezione volavano via sull‘analisi di una o due parole, molte volte.
Si ricordava di una lezione intera sulla particella ápa, presente nei testi vedici. Pert 45 minuti spaziò dal greco antico ἀπό all‘ittita āppa , āppan, al luvio apara/i, licio epre/i per finire all‘avestico apāxtara-.
Erano percorsi tortuosi che lo meravigliavano e lo rapivano e lo portavano in estasi, perso in quel monto di segni arcaici che continuavano a parlare nel mondo dopo secoli e secoli a chi voleva sentirli parlare.
Non etrano molti in quel corso. Nei momenti di massimo affollamento potevano raggiungere le 7 unità.
Nel corso vi era una ragazza dai capelli scuri, ricci, con una lunga coda di cavallo. Labbra carnose. Occhi grandi verdi come il mare e seni prominenti duri come due meloni.
Si chiamava Luisa.
Non era una studentessa giovanissima, aveva 27 anni come poi scroprì.
Qualche volta, specialmente nelle uggiose e fredde giornate d‘inverno, non era raro che fossero lui e lei i soli a seguire il corso.
Siete i miei più fedeli studenti. Si rivolse a loro due una volta il dottor Poggi al termine di una di quelle sue lezioni mozzafiato. Come vi chiamate? Chiese sinceramente incuriosito il professore.
Fu allora che Giorgio scoprì che lei si chiamava Luisa.
Fu allora facendo conversazione con il professore che cominciarono a parlarsi e a conoscersi. Prima di allora mai si erano parlati. Appena si erano salutati.
Così quando il professore, ringraziandoli, li salutò, Giorgio e Luisa continuarono a parlare e decisero di andare in un bar vicino all‘istituto per mangiare qualcosa insieme.
Le lezioni finivano sempre verso mezzogiorno e si offriva bene quella situazione di andare a pranzo insieme, qualcosa in modo completamente naturale. Spontaneo e senza forzature.
Ma tu, Luisa, di dove sei? Non hai l‘accento toscano. Le chiese Giorgio mentre addentava un panino al tonno e carciofini con tanta maionese.
Sono di Parma.
Di Parma?
Sì.
E abiti alla casa dello studente?
No, a Firenze.
A Firenze???
Sì.
Che curioso...e come mai?
Mio marito insegna all‘università di Firenze.
Tuo marito??? Sei sposata?
Sì. Lui è molto più anziano di me. Venti anni di più. Ci siamo conosciuti in un corso di filologia baltica all‘università di Firenze. Poi ci siamo innamorati e sposati.
E perché non studi a Firenze? E perché soprattutto fai sanscrito e non una lingua baltica?
Non era conveniente che io continuassi a frequentare l‘isituto di baltistica a Firenze. Dava adito a voci che lui mi aiutasse e favorisse negli esami. Allora ho deciso di venire a Pisa e studiare sanscrito. Sai che ci sono molte analogie fra il sanscrito e il lettone, il lituano in particolare.
No, non lo sapevo. Per esempio?
Molte parole per esempio. Ti faccio qualche esempio ma sono molte di più...Per “fumo“ in lituano abbiamo dūmasin sanscrito abbiamo dhumas. “Uomo“ lituano vyras sanscrito viras. “Lupo“ abbiamo vilkas in lituano e vrikas in sanscrito. “Notte“ naktisin lituano e naktis in sanscrito, ratase rathas per dire “ruota“, šuo e švan per “cane“...e poi il futuro lituano è uguale al futuro sigmatico sanscrito: per esempio le prime tre persone singolari...būsiu "sarò" būsi "sarai" bus "sarà" sono pari pari il sanscrito bhaviṣyāmi bhaviṣyasi bhaviṣyati...che poi se ti ricordi c‘è anche in greco antico λύσω λύσεις λύσει ...
Era bella Luisa. E colta. Si sentiva attratto da lei. Mentre lei parlava lui la seguiva come fosse pietrificato dai suoi occhi grandi e incantatori come quelli della gorgone Medusa.
Come sei bella Luisa! Le disse imbambolato, con la faccia da pesce lesso, mentre lei continuava a parlargli con tanto trasporto delle somiglianze fra la lingua lituana e sanscrita.
Lei si fermò. Lo guardò per un attimo in modo strano e tesa, quasi offesa. Poi il suo viso divenne dolce, morbido e non più teso, e arrossì improvvisamente fino alla punta dei capelli.
February 18, 2023
Autobiografia di un poeta - da lui medesimo scritta (scendere nelle viscere e portare in superficie la poesia)
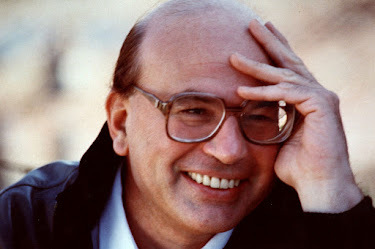
Fu orribile vedere Bettino Craxi fischiato all‘uscita dell‘hotel Rafael di Roma.
Lui da solo, praticamente, affrontare una folla assurdamente costituitasi per sfogare un odio indotto e lanciare monete verso il Presidente del Consiglio.
Certo era difficile in quegli anni scorgere la farsa che stava dietro l‘operazione mani pulite. Molti ci credevano davvero che avrebbe portato più onestà. Pochi sapevano. O forse non erano poi così pochi. Ma sapevano e agivano. Allora riuscivano a coprirsi bene. Riuscivano a non manifestarsi. E tutto quello che appariva in superfice sembrava vero.
In quei giorni era giovane, aveva diciotto anni. Era all‘ultimo anno del classico.
Quelle scene lo avevano sconvolto. L‘Italia era un paese che aveva perso il senso del sangue e dello scontro. Gli anni Settanta, erano alle spalle e quelli della guerra ancora più lontani.
Non riusciva nonostante tutto a vedere in Craxi quel criminale che i giornali e le televisioni
dipingevano.
Nonostante tutto gli pareva onesto, per quanto possa essere un politico.
Capì che il mondo diventava brutto. Che c‘era bisogno di bellezza.
Per uno come lui, che in Dio non credeva, che bellezza poteva rimanere in quel mondo?
Nella quotidianità dei suoi giorni?
La risposta la conosceva. Era lì radicata fino dall‘infanzia, dai tempi di Livorno.
Gli vennero in mente i versi di Saba, che trovò la bellezza dell‘essere umano infinito nell‘umiltà delle cose e delle azioni umane.
Qui tra la gente che viene che va
dall'osteria alla casa o al lupanare
dove son merci ed uomini il detrito
di un gran porto di mare,
io ritrovo, passando, l'infinito
nell'umiltà.
In quella folla inferocita, che avrebbe anche massacrato Craxi, se glielo avessero permesso, era il peggio dell‘essere umano. La sua bruttura, la lordura dell‘odio.
E capì che solo nell‘essere individuale vi è il raccoglimento che porta alla bellezza. E non in tutti gli essere umani vi è uno stato che può portare alla bellezza. Sono pochi, e sono gli eletti, che possono scendere nelle miniere e nei cuniculi, nei budelli dove la bellezza si asconde e poi di nuovo salire su in superficie e parlare al mondo di quella bellezza che si ritraeva nelle viscere.
Gli altri (quelli senza il dono della discesa nel profondo e del ritorno da quei luoghi bassi) li definisce bene Antonio Machado:
Y en todas partes he visto
gentes que danzan o juegan,
cuando pueden, y laboran
sus cuatro palmos de tierra.
Nunca, si llegan a un sitio,
preguntan a dónde llegan.
Cuando caminan, cabalgan
a lomos de mula vieja,
y no conocen la prisa
ni aun en los días de fiesta.
Donde hay vino, beben vino;
donde no hay vino, agua fresca.
Son buenas gentes que viven,
laboran, pasan y sueñan,
y en un día como tantos,
descansan bajo la tierra.
Io ero, Giorgio - scendere nelle viscere e portare in superficie la poesia
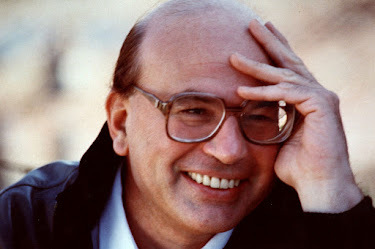
Fu orribile vedere Bettino Craxi fischiato all‘uscita dell‘hotel Rafael di Roma.
Lui da solo, praticamente, affrontare una folla assurdamente costituitasi per sfogare un odio indotto e lanciare monete verso il Presidente del Consiglio.
Certo era difficile in quegli anni scorgere la farsa che stava dietro l‘operazione mani pulite. Molti ci credevano davvero che avrebbe portato più onestà. Pochi sapevano. O forse non erano poi così pochi. Ma sapevano e agivano. Allora riuscivano a coprirsi bene. Riuscivano a non manifestarsi. E tutto quello che appariva in superfice sembrava vero.
In quei giorni era giovane, aveva diciotto anni. Era all‘ultimo anno del classico.
Quelle scene lo avevano sconvolto. L‘Italia era un paese che aveva perso il senso del sangue e dello scontro. Gli anni Settanta, erano alle spalle e quelli della guerra ancora più lontani.
Non riusciva nonostante tutto a vedere in Craxi quel criminale che i giornali e le televisioni
dipingevano.
Nonostante tutto gli pareva onesto, per quanto possa essere un politico.
Capì che il mondo diventava brutto. Che c‘era bisogno di bellezza.
Per uno come lui, che in Dio non credeva, che bellezza poteva rimanere in quel mondo?
Nella quotidianità dei suoi giorni?
La risposta la conosceva. Era lì radicata fino dall‘infanzia, dai tempi di Livorno.
Gli vennero in mente i versi di Saba, che trovò la bellezza dell‘essere umano infinito nell‘umiltà delle cose e delle azioni umane.
Qui tra la gente che viene che va
dall'osteria alla casa o al lupanare
dove son merci ed uomini il detrito
di un gran porto di mare,
io ritrovo, passando, l'infinito
nell'umiltà.
In quella folla inferocita, che avrebbe anche massacrato Craxi, se glielo avessero permesso, era il peggio dell‘essere umano. La sua bruttura, la lordura dell‘odio.
E capì che solo nell‘essere individuale vi è il raccoglimento che porta alla bellezza. E non in tutti gli essere umani vi è uno stato che può portare alla bellezza. Sono pochi, e sono gli eletti, che possono scendere nelle miniere e nei cuniculi, nei budelli dove la bellezza si asconde e poi di nuovo salire su in superficie e parlare al mondo di quella bellezza che si ritraeva nelle viscere.
Gli altri (quelli senza il dono della discesa nel profondo e del ritorno da quei luoghi bassi) li definisce bene Antonio Machado:
Y en todas partes he visto
gentes que danzan o juegan,
cuando pueden, y laboran
sus cuatro palmos de tierra.
Nunca, si llegan a un sitio,
preguntan a dónde llegan.
Cuando caminan, cabalgan
a lomos de mula vieja,
y no conocen la prisa
ni aun en los días de fiesta.
Donde hay vino, beben vino;
donde no hay vino, agua fresca.
Son buenas gentes que viven,
laboran, pasan y sueñan,
y en un día como tantos,
descansan bajo la tierra.
Autobiografia di un poeta - da lui medesimo scritta (la magia e la poesia di Livorno)

Il rapporto con il padre fu piacevole in quegli anni a Pisa.
Gli parlava spesso degli inni del Rigveda, di cui il padre era specialista.
Ma ciò che più lo affascinava, a parte una serie di inni del Rigveda chiamati cosmogonici, era l‘Atharvaveda. Un testo probabilmente posteriore, in certe parti, al Rigveda ma in alcune avrebbe potuto essere anche anteriore, un testo di inni terapeutici e magici.
Fin da piccolo cominciò infatti a pensare che magia e poesia andassero di pari passo.
Livorno era questo. Livorno aveva una magia. Non era belle come città. Ma aveva una magia struggente, languida in certi momenti, burbera in altri. Livorno era pura poesia, che vibrava, per lui.
Quando r'culo caa e r'cazzo rende, vo 'n culo alle medicine e chi le vende!
Meglio ave' i pantaloni rotti ar culo che un culo rotto ne' pantaloni.
Le parole le porta via 'r vento, le bicirette i livonesi e i bischeri nessuno.
Le donne sono come le sarcicce: budelle fori, maiale dentro e vanno ´onsumate carde.
Non era pura poesia ironica una lingua che diceva le cose più volgari e trite con una musica innata dentro?
Quella lingua, gli si era radicata nell'anima come una musica di violino. La rima gli era venuta spontanea avendo dentro quella lingua.
E per lui non fu difficile partorire versi come
Anima mia, fa' in fretta.
Ti presto la bicicletta,
ma corri. E con la gente
(ti prego, sii prudente)
non ti fermare a parlare
smettendo di pedalare...
Faceva poesia e parlava di cose banali. Come i livornesi
Io ero, Giorgio - la magia e la poesia di Livorno

Il rapporto con il padre fu piacevole in quegli anni a Pisa.
Gli parlava spesso degli inni del Rigveda, di cui il padre era specialista.
Ma ciò che più lo affascinava, a parte una serie di inni del Rigveda chiamati cosmogonici, era l‘Atharvaveda. Un testo probabilmente posteriore, in certe parti, al Rigveda ma in alcune avrebbe potuto essere anche anteriore, un testo di inni terapeutici e magici.
Fin da piccolo cominciò infatti a pensare che magia e poesia andassero di pari passo.
Livorno era questo. Livorno aveva una magia. Non era belle come città. Ma aveva una magia struggente, languida in certi momenti, burbera in altri. Livorno era pura poesia, che vibrava, per lui.
Quando r'culo caa e r'cazzo rende, vo 'n culo alle medicine e chi le vende!
Meglio ave' i pantaloni rotti ar culo che un culo rotto ne' pantaloni.
Le parole le porta via 'r vento, le bicirette i livonesi e i bischeri nessuno.
Le donne sono come le sarcicce: budelle fori, maiale dentro e vanno ´onsumate carde.
Non era pura poesia ironica una lingua che diceva le cose più volgari e trite con una musica innata dentro?
Quella lingua, gli si era radicata nell'anima come una musica di violino. La rima gli era venuta spontanea avendo dentro quella lingua.
E per lui non fu difficile partorire versi come
Anima mia, fa' in fretta.
Ti presto la bicicletta,
ma corri. E con la gente
(ti prego, sii prudente)
non ti fermare a parlare
smettendo di pedalare...
Faceva poesia e parlava di cose banali. Come i livornesi
Autobiografia di un poeta - da lui medesimo scritta (Livorno)

Livorno. La città dove era nato. Cresciuto fino a dodici anni.
Poi, il padre professore universitario, insegnava sanscrito alla facoltà di glottologia di Pisa in via Santa Maria non lontano da Campo dei Miracoli, per comodità aveva deciso di trasferirsi a Pisa. Non che Pisa fosse poi così lontano da Livorno. Avrebbe potuto anche rimanere a Livorno, e fare il pendolare.
E' vero che per un livornese vivere a Pisa è un po' come rinnegare la sua terra, grande è il campanilismo fra le due città.
Ma alla fine Saverio, si chiamava così il padre, era rimasto ammaliato dal clima dolce di Pisa. Dalla sua lentezza provinciale. Dall'Arno e dai colori che assume al tramonto tutta la città.
E' un posto buono per vivere e morire, aveva pensato dopo qualche mese trascorso a Pisa dopo aver ricevuto l'incarico. Voglio vivere qui con tutta la famiglia.
Pisa, è innegabile aveva la sua poesia. E molti poeti hanno soggiornato a Pisa. E non può essere un caso. Il caso non esiste. Nel caso credono quelli che credono a qualsiasi dabbenaggine gli venga raccontata. Chi ha un minimo di sale in zucca al caso non ci crede. Per ammettere il caso si dovrebbe ammettere che esiste qualcosa che è quantificamente separabile da tutto il resto invece di essere risonante, come di fatto è, con tutto il resto del sistema in cui cade.
Giorgio, a differenza del padre, a Pisa continuò ad amare Livorno. Ciò che amava di Livorno erano l'asprezza dei contorni, la ruvidità e lo scherno talora sardonico, guappo, tipico del livornese.
Amava la lingua dialettale, maschia, aggressiva ma in modo canzonatorio, ironica e comica, e non invece becera quale gli pareva quella di Pisa. Una lingua che strascicava, deformava i suoni e li rendeva sguaiati.
Ecco la parola "sguaiato" con la sua doppia dittonganzione ascendente all'interno della parola apriva talmente tantpo la pronuncia da illustrare bene le accentazioni sgarbate del pisano.
Una cosa però imparò a Pisa, che non aveva imparato a Livorno. La poesia.
Io ero, Giorgio - Livorno

Livorno. La città dove era nato. Cresciuto fino a dodici anni.
Poi, il padre professore universitario, insegnava sanscrito alla facoltà di glottologia di Pisa in via Santa Maria non lontano da Campo dei Miracoli, per comodità aveva deciso di trasferirsi a Pisa. Non che Pisa fosse poi così lontano da Livorno. Avrebbe potuto anche rimanere a Livorno, e fare il pendolare.
E' vero che per un livornese vivere a Pisa è un po' come rinnegare la sua terra, grande è il campanilismo fra le due città.
Ma alla fine Saverio, si chiamava così il padre, era rimasto ammaliato dal clima dolce di Pisa. Dalla sua lentezza provinciale. Dall'Arno e dai colori che assume al tramonto tutta la città.
E' un posto buono per vivere e morire, aveva pensato dopo qualche mese trascorso a Pisa dopo aver ricevuto l'incarico. Voglio vivere qui con tutta la famiglia.
Pisa, è innegabile aveva la sua poesia. E molti poeti hanno soggiornato a Pisa. E non può essere un caso. Il caso non esiste. Nel caso credono quelli che credono a qualsiasi dabbenaggine gli venga raccontata. Chi ha un minimo di sale in zucca al caso non ci crede.
Giorgio, a differenza del padre, a Pisa continuò ad amare Livorno. Ciò che amava di Livorno erano l'asprezza dei contorni, la ruvidità e lo scherno talora sardonico, guappo, tipico del livornese.
Amava la lingua dialettale, maschia, aggressiva ma in modo canzonatorio, ironica e comica, e non invece becera quale gli pareva quella di Pisa. Una lingua che strascicava, deformava i suoni e li rendeva sguaiati.
Ecco la parola "sguaiato" con la sua doppia dittonganzione ascendente all'interno della parola apriva talmente tantpo la pronuncia da illustrare bene le accentazioni sgarbate del pisano.
Una cosa però imparò a Pisa, che non aveva imparato a Livorno. La poesia.



