Alessio Brugnoli's Blog, page 13
December 16, 2021
Le statue crisoelefantine nell’antica Grecia

Può sembrare strano, ma l’utilizzo abbondante dell’oro nell’Arte non è tipico del mondo bizantino: nel mondo classico, a sentire le fonti antiche, tale materiale era di uso comune nell’arte, anche in ambiti che noi considereremmo peculiari, come le statue crisoelefantine. Queste statue, che secondo il gusto moderno probabilmente apparirebbero di un pacchiano esagerato, erano costituite da un’armatura lignea, ricoperta di materiali preziosi: si utilizzava l’avorio per il volto, le braccia, le gambe di una statua, mentre il panneggio delle vesti e i capelli venivano realizzati con l’oro. Specialista in questa tecnica, era Fidia, lo scultore del Partenone, che di solito associamo all’equilibrio e alla compostezza.
La sua prima opera in tale ambito è probabilmente, anche se le discussioni sulla cronologia, per colpa di un dettaglio citato da Pausania, di cui parlerò più avanti, sono degne di un’assemblea di condominio, l’ Atena Parthènos, l’Atena Vergine, in fondo noi cristiani, quando si tratta di attribuire epiteti nell’ambito religioso, non ci siamo inventati nulla, che era collocata nel nàos, la cella, del Partenone. Che aspetto avesse, lo sappiamo dalla descrizione, purtroppo sintetica, che ne da Pausania
La statua di Atena stà ritta in piedi con una veste talare, nel petto poi si vede incastrata la testa di Medusa di avorio, ed una vittoria di quattro cubiti. Nella mano tiene l’asta, e presso ai piedi da un lato le giace lo scudo, dalla parte dell’asta poi havvi il dragone, che forse è Erittonio. Sulla base della statua è espressa la nascita di Pandora. Esiodo, ed altri cantarono, che Pandora fu la prima donna, e che prima della sua nascita non vi era ancora il sesso femminile.
Plinio, che della statua dà anche le dimensioni (26 cubiti, cioè circa 12 metri), aggiunge che sulla faccia convessa dello scudo era rappresentata un’Amazzonomachia e sulla faccia concava la Gigantomachia, e sul taglio verticale delle suole dei sandali scene della battaglia dei Lapiti contro i Centauri; e, a proposito della nascita di Pandora, dice che alla scena assistevano venti divinità. Sempre Plinio, che andava pazzo per questi dettagli, ricorda come per la sua costruzione furono utilizzati, in unità di misure moderne, 1137 kg. Il costo totale fu di 750 talenti, il corrispondente del salario annuo di 12.750 lavoratori; ricordiamo come ogni talento attico equivale a 26 kg di argento puro. Di conseguenza, 19.500 kg di argento ossia, al prezzo medio di 700 euro a kg, farebbe circa 13.650.000 euro
In linea di massima, possiamo riconostruirne l’aspetto grazie a una serie di copie antiche. Due statuette in marmo del museo di Atene, trovate l’una sulla Pnice, detta Atena Lenormant, l’altra al Varvakeion possono considerarsi copie – piccole, ma nelle linee generali specialmente la seconda, sufficientemente fedeli – dell’opera originale. Inoltre esistono delle grandi figure statuarie, come quella firmata da Antiochos (o Metiochos) della Collezione Boncompagni-Ludovisi, che, se non ne sono copie fedeli, ne sono tuttavia delle derivazioni abbastanza istruttive. In migliori condizioni ci troviamo nei riguardi della testa. Un marmo policromato del museo di Berlino, proveniente da Roma, la riproduce di tutto tondo; un medaglione d’oro trovato a Kul-Oba, nella Russia meridionale, in rilievo di prospetto e di profilo la famosa gemma di Aspasio, ora al Museo delle Terme.
Per il particolare dello scudo abbiamo il sussidio dello scudo Strangford del Museo Britannico, di marmo, frammentato, che appunto sulla parte convessa rappresenta in rilievo la battaglia degli Ateniesi contro le Amazzoni, e nel quale si vede raffigurato tra i guerrieri un vecchio calvo nell’atto di vibrare un colpo di bipenne, che può corrispondere al ritratto di Fidia di cui parla Plutarco. Recentemente sono stati ricuperati nel porto del Pireo dei rilievi di marmo, alcuni dei quali con scene di Amazzonomachia, e si è pensato a riproduzioni dei gruppi componenti l’Amazzonomachia dello scudo. Ma tutto al più si può ammettere che siano libere derivazioni da quella composizione, non senza l’influenza di elementi di un’arte alquanto posteriore, rappresentata per esempio (nei riguardi dello stesso soggetto) dalle figure del donario di Attalo. Per l’altro particolare della decorazione a rilievi figurati del taglio verticale delle suole dei sandali, non per il soggetto e tanto meno per lo stile, ma semplicemente per la maniera della composizione, un’idea può darcela il piede colossale frammentato del Palazzo dei Conservatori.
Ora, nella litigiosa Atene dell’epoca, il cui sport principale era pugnalarsi alla schiena, Fidia, amico intimo di Pericle, impegnato in un’opera così colossale, non poteva dormire sogni tranquilli. Fu messo a processo di avere rubato parte dell’oro destinato all’Atena Parthenos, ma riuscì a scagionarsi facendo pesare il metallo prezioso impiegato per le vesti della dea e dimostrando di aver usato esattamente la quantità ricevuta. Ma i suoi accusatori, a sentire Plutarco, non si arresero: lo accusarono di empietà, per aver scolpito, sulla scudo della statua, due ritratti, uno di se stesso e uno di Pericle. Secondo una tradizione, riportata dalla Suda, l’enciclopedia bizantina, per cui va presa per quello che è, un pettegolezzo da bar, Pericle, sentendosi in certo modo coinvolto nello scandalo, per evitare di render conto del proprio operato, avesse scatenato la guerra del Peloponneso, per distrarre l’opinione pubblica.

Comunque, vista l’aria che tirava, Fidia presi attrezzi e bagagli e si trasferì a Olimpia, dove gli avevano commissionato un’altra statua crisoelefantina, che questa volta, rappresentava Zeus. Fidia operò probabilmente con numerosi aiuti e completò l’opera intorno al 433 a.C., visto che l’anno seguente tornò ad Atene, approfittando di un sorta di amnistia. La statua rimase nel santuario per oltre ottocento anni, suscitando sempre stupore e meraviglia nei fedeli.
Nel II secolo a. C. la statua fu restaurata da Damofone, scultore di Messene, una città del Peloponneso meridionale. Si dice che egli abbia operato molto abilmente, e può darsi che in quell’occasione siano state collocate sotto il sedile le quattro colonne di cui si è detto, per impedire che crollasse sotto l’enorme peso della figura soprastante.Circa alla stessa epoca (167 a. C.) il re di Siria Antioco IV dedicò al tempio di Zeus un drappo di lana «tessuta con motivi assiri e tintura fenicia». Forse questa cortina di origine asiatica, abbastanza importante da attrarre i commenti di Pausania, stava appesa dietro la statua. Antioco è lo stesso re che, saccheggiato il tempio di Salomone a Gerusalemme, aveva dato ordine di ribattezzarlo come tempio di Zeus Olimpio. Fra i tesori ch’egli sottrasse al tempio potrebbe esserci stato anche il grande velo che divideva l’interno. Con non molta fantasia si può asserire che proprio quella era la cortina dedicata poi da Antioco al padre dei suoi dèi a Olimpia.
L’imperatore romano Caligola (37-41), secondo Svetonio, cercò inutilmente di impossessarsi della statua con ogni mezzo per portarla a Roma. Furono spediti operai per escogitare il modo di trasportarla, ma la statua, secondo quanto racconta Svetonio
emise improvvisamente una cosí sonora risata che fece crollare l’impalcatura e scappar via gli uomini
Secondo la tradizione che risale a Cedreno, storico bizantino dell’XI secolo, all’inizio del V secolo, quando il santuario era ormai in abbandono, la statua entrò a far parte della collezione di opere d’arte pagane di Lauso, che la pose nel proprio palazzo a Costantinopoli, il quale andò distrutto assieme alla collezione nell’incendio del 475. Il santuario è rimasto distrutto, probabilmente a seguito dell’incendio dello stesso provocato in base a un editto di Teodosio II
Le dimensioni della statua sono state ricostruite sulla base delle numerose descrizioni provenienti dagli autori classici. Lo storico e geografo Strabone, ad esempio, riporta un episodio (Geografia, libro VIII 3, 30) secondo cui lo stesso Fidia avrebbe detto a Paneno (suo collaboratore nella realizzazione del simulacro, insieme a Kolotes) di aver tratto ispirazione per la scultura del suo Zeus da alcuni versi dell’Iliade:
“Disse, e con le nere sopracciglia il Cronide accennò; le chiome ambrosie del sire si scompigliarono sul capo immortale: scosse tutto l’Olimpo“.
Il basamento della statua crisoelefantina occupava un’area di più di sei metri per dieci, e doveva superare i 12 metri di altezza. L’impressione di monumentalità doveva essere accentuata dalla non troppo felice proporzione delle dimensioni tra essa e la struttura in cui era collocata: pur essendo il tempio di dimensioni considerevoli, la testa di Zeus, rappresentato seduto in trono, ne sfiorava il soffitto, tanto che Strabone ebbe a scrivere che, se il dio si fosse alzato in piedi, avrebbe scoperchiato il tempio
Di seguito, la descrizione che ne da Pausania, nella sua guida turistica dell’epoca
“Il dio, costruito d’oro e d’avorio, è assiso in trono: una corona che imita ramoscelli di olivo, gli sta sul capo. Egli porta nella mano destra una Vittoria, anch’essa di avorio e d’oro, che tiene una tenia e porta una corona in testa. Nella mano sinistra del dio è uno scettro ornato d’ogni genere di metalli. L’uccello che è posto in cima allo scettro è l’aquila. D’oro sono anche i calzari del dio e così pure il mantello. Sul mantello sono posti, come ornamento, piccole figure e fiori di giglio. Il trono è variamente ornato di oro e di pietre preziose, e anche di ebano e di avorio, e in esso ci sono figure rappresentate in pittura e figure scolpite. In ciascuna delle gambe del trono sono quattro Vittorie, che presentano lo schema delle danzatrici; ce ne sono poi due altre alla base di ciascuna gamba. Sopra ciascuna delle gambe anteriori si trovano dei fanciulli tebani rapiti da Sfingi, e, sotto le Sfingi, Apollo e Artemide saettano i figli di Niobe. Tra le gambe del trono sono quattro sbarre, ciascuna delle quali traversa dall’una all’altra gamba. Sulla sbarra anteriore (quella ch’è proprio dirimpetto all’entrata) si trovano sette statuette; l’ottava infatti non sanno in che modo sia sparita… Sopra alle restanti sbarre è rappresentata la schiera combattente con Eracle contro le Amazzoni. Il numero di queste e di quella insieme è di circa ventinove; anche Teseo è in mezzo ai compagni di Eracle. Non le sole gambe però sostengono il trono, ma anche colonne eguali alle gambe e poste tra esse. Non è poi possibile andare sotto il trono, così come noi in Amicle penetriamo nell’interno. In Olimpia sono d’impedimento certe barriere fatte a guisa di muri. Di queste barriere, quella che è di faccia alla porta è soltanto colorita in azzurro; le altre presentano pitture di Paneno… Nella più alta parte del trono ed a maggiore altezza del capo della statua, Fidia fece da una parte le Cariti e dall’altra le Ore, le une e le altre in numero di tre… Lo sgabello posto sotto i piedi di Zeus, chiamato thranion dagli abitanti dell’Attica, ha leoni d’oro, e, scolpita in rilievo, la battaglia di Teseo contro le Amazzoni, la prima prodezza degli Ateniesi contro gli stranieri. Sopra la base poi che sostiene il trono e tutti gli ornamenti posti intorno a Zeus, ci sono delle sculture d’oro: Elio che è salito sul carro, e Zeus e Era… e presso a lui Carite. Vicino a questa è Ermete e ad Ermete segue Estia. Dopo Estia è Eros che accoglie Afrodite sorgente dal mare; e Peitho che incorona Afrodite. Vi sono poi scolpiti Apollo con Artemide, Atena e Eracle, e presso l’estremità della base Anfitrite e Poseidone e Selene che cavalca, come mi sembra, un cavallo…”.
Pausania racconta anche che la statua veniva tenuta costantemente ricoperta di olio d’oliva per contrastare l’effetto dannoso sull’avorio causato dalla “palude” del boschetto di Altis . Il pavimento davanti all’immagine era pavimentato con piastrelle nere e circondato da un bordo rialzato di marmo per contenere l’olio. Questo serbatoio fungeva da specchio che raddoppiava l’altezza apparente della statua. Secondo lo storico romano Livio , il generale romano Emilio Paolo (il vincitore sulla Macedonia ) vide la statua e “si commosse nell’anima, come se avesse visto il dio in persona”, mentre il greco del I secolo d.C. l’oratore Dione Crisostomo dichiarò che un solo sguardo alla statua avrebbe fatto dimenticare all’uomo tutti i suoi problemi terreni
Si dice anche che lo scultore abbia immortalato Pantarkes, il vincitore della gara di lotta dell’ottantaseiesima Olimpiade, che si diceva fosse il suo “amato” ( eromenos ), scolpendo Pantarkes kalos (“Pantarkes è bello”) in il mignolo di Zeus, e ponendo ai piedi della statua un rilievo del fanciullo che si incorona. Sempre Pausania scrive
Si dice che il fanciullo che si cinge la testa con una tenia somigli nell’aspetto a Pantarkes, poiché si narra che Pantarkes, ragazzetto eleo, sia stato il favorito di Fidia: Pantarkes poi riportò anche una vittoria nella lotta di fanciulli nell’Olimpiade ottantesima sesta
Pettegolezzo che da un paio di secoli sta facendo scannare gli studiosi sulla cronologia delle opere di Fidia, perché se fosse vero, anticiperebbe la realizzazione dello Zeus rispetto all’Atena Parthenos, dato che è considerato come elemento di datazione della statua. In realtà, a leggerlo bene, è solo un ricordo del primo successo sportivo dell’atleta, che ai tempi in cui Fidia era ad Olimpia, aveva vinto un paio di competizioni di pancrazio. Dato che questo sport, terribilmente violento, spesso i combattimenti terminavano con la morte dello sconfitto, era la versione antica delle Arti Marziali Miste, Pantarkes, ai tempi della relazione con lo scultore, più che un delicato adolescente, doveva avere un fisico simile quello di Conor McGregor.
Sempre Pausania racconta
Quando la statua fu terminata, Fidia pregò il dio di manifestare con un segnale se l’opera era di suo gradimento; e subito, dicono, un fulmine cadde nel punto del pavimento dove fino ai miei tempi vi era per copertura un’anfora.
Tra l’altro, il Paneno citato da Pausania, era uno dei pittori piú famosi del suo tempo. Pausania lo indica come fratello di Fidia, Strabone come nipote. Qualunque fosse la loro parentela, la loro collaborazione nelle maggiori opere progettate da Fidia è sicura. Le pareti divisorie mostravano nove scene, forse una sequenza di riquadri, separate su ciascun lato del trono. La parte posteriore di questo era protetta dal muro dell’edificio. Il tema dei dipinti non era unico, ma molti erano chiaramente scelti per richiamare le sculture sui muri esterni del tempio. Due si riferivano alle sculture dei timpani, ossia gli spazi triangolari tra gli spioventi del tetto e i muri di sostegno. Le nozze di Piritoo, re dei Lapiti nella Tessaglia (Grecia settentrionale), e ritenuto figlio di Zeus, era il soggetto del timpano occidentale. Il re aveva invitato alla festa i Centauri, selvagge reature dei boschi montani, mezzo uomini e mezzo cavalli; ed essi, ubriachi, avevano aggredito le donne e tentato di rapire la sposa di Piritoo; tema usato da Fidia sulle metope, e cioè le lastre scolpite che ornavano l’esterno del Partenone
Altri affreschi di Paneno narravano di Ippodamia e che era celebrata nelle sculture del timpano orientale del tempio. Quest eroina era figlia di Enomao re di Pisa, ovviamente non la città toscana, ma l’onomica località in Grecia. un oracolo aveva predetto che il suo sposo avrebbe ucciso Enomao, perciò il padre si era sempre opposto al suo matrimonio. Per cui, tutti i numerosi pretendenti della ragazza erano costretti ad una gara di velocità con i cavalli contro il padre, che si svolgeva tra la città di Pisa vicino ad Olimpia fino a Corinto, chi avesse vinto la gara avrebbe dovuto uccidere l’avversario. Il padre concedeva al pretendente mezz’ora di vantaggio, ma dal momento che richiedeva che la figlia salisse sul cocchio dell’avversario per distrarlo e che i suoi animali, dono di Ares, erano magici ed imbattibili, riusciva sempre a raggiungere con grande velocità il cocchio del pretendente e ad ucciderlo con la sua lancia.
Un giorno Ippodamia, innamorata di Pelope, in combutta con il suo pretendente corruppe Mirtilo, l’auriga del padre, il quale sostituì alcuni chiodi delle ruote del cocchio di Enomao con altrettanti chiodi di cera. Quando durante la gara il padre stava per raggiungere il cocchio di Pelope, le ruote del suo carro si staccarono ed egli perì travolto dai cavalli. Così i Giochi Olimpici nacquero proprio come espiazione di tale delitto.
Anche le Fatiche d’Ercole erano illustrate da Paneno in tre affreschi, e pure rappresentate nel fregio scolpito lungo le pareti del tempio. Un’altra delle molte leggende intorno ad Eracle, rappresentata da Paneno vicino al dipinto di Ippodamia, mostrava Eracle che muove in aiuto del semidio Prometeo, punito da Giove per aver trasmesso agli uomini l’uso del fuoco. Prometeo era incatenato alla roccia e un’aquila gli divorava il fegato, che di notte ricresceva per quanto l’aquila poteva divorare di giorno. Tema, tra l’altro, che era stato trattato in una dei successi teatrali dell’Atene dell’epoca, la triologia di Prometeo di Eschilo.
Uno dei dipinti piú interessanti di Paneno si riferiva a un avvenimento storico di grande attualità e risonanza: la battaglia di Salamina, presso Atene, del 480 a. C., un evento solo di pochi anni anteriore alla costruzione del tempio di Zeus a Olimpia. Paneno, nella famosa Stoa dipinta nella piazza del mercato di Atene, aveva pure affrescato la battaglia di Maratona, quella in cui nel 490 un piccolo esercito ateniese aveva impedito lo sbarco in territorio greco, a Maratona, all’esercito molto piú grande del re persiano Dario. Come Salamina, anche quella battaglia era considerata la vittoriosa sfida dei Greci contro le genti barbare dell’Est.
Tornando al nostro Zeus, le copie antiche sono purtroppo rarissime: ci aiutano molto alcune monete di Elide del tempo di Adriano: alcune riproducono la statua quasi di prospetto, altre di profilo. Una figura di Zeus seduto su trono, in una pittura murale scoperta a Eleusi presso i grandi propilei, per quanto semplificata e composta in un atteggiamento teatrale, dipende certamente dall’opera di Fidia; ma si pensa che riproduca più direttamente, non l’originale, bensì la riduzione, egualmente in oro e avorio, che Adriano ordinò per l’Olimpieio di Atene. Un recente tentativo d’identificazione in una testa di marmo rivenuta a Cirene non ha incontrato l’approvazione dei dotti. Nella testa del Museo di Boston, proveniente da Milasa, nella Caria, si è visto solo un’opera ispirata dalla creazione di Fidia; né sappiamo fino a che punto possa essersi spinta quest’ispirazione. La sola riproduzione, che può ritenersi sicura, della testa dello Zeus di Olimpia è quella di un’altra moneta di Elide ; ma si tratta di opera molto rimpicciolita e imperfetta; tale cioè da non poter rendere la caratteristica espressione del volto piena di dolcezza e di bontà, tanto decantata da Dione Crisostomo; lo stesso si dica per alcune gemme, fra cui quella del Museo di Berlino.
Ma il vero tormento degli archeologi è stato sempre il trono, per il quale né le monete di Elide né la ceramografia, che pure indirettamente offre preziosi elementi di confronto, si sono rivelate sufficienti a illustrare le parole di Pausania. Comunque, tra i risultati che sembrano attendibili degli studî antichi e recenti, nei riguardi dei punti più oscuri e controversi, si possono ricordare i seguenti: che i braccioli fossero sorretti da figure di Sfingi; che la strage dei Niobidi fosse rappresentata sulle facce laterali del sedile; che le gambe del trono fossero ornate ciascuna di sei figure di Vittorie, quattro alla sommità (una per ciascuna faccia) e due alla base, perché a due delle quattro facce di questa si ritiene aderissero le barriere fatte “a guisa di muri”, che impedivano di penetrare sotto il trono e che altro non sarebbero state se non delle altre traverse più o meno analoghe, per lo meno nella struttura, a quelle che collegavano tra di loro le quattro gambe del trono; che il sedile fosse internamente sorretto da quattro colonne; che la spalliera fosse rettangolare e che i due gruppi delle Ore e delle Cariti ne adornassero gli angoli a guisa di acroterî; che, finalmente, nello sgabello la rappresentazione dell’Amazzonomachia fosse trattata a rilievo e che i leoni di cui parla Pausania fossero due, di tutto tondo, e fiancheggiassero lo sgabello vero e proprio.
Tuttavia, a Olimpia, nel 1955, fu scoperto l’officina a cui Fidia lavorò al Zeus, una sala rettangolare, orientata est-ovest, con l’ ingresso sul lato est con le stesse dimensioni (32 x18 x 14,50 m), della cella del tempio di Olimpia, probabilmente per facilitare la costruzione della statua. Negli scavi sono emersi attrezzi da lavoro, punteruoli, palette, martelli, lamine di piombo e altro, le matrici di argilla per le pieghe della veste della statua, pezzi di avorio e pietre semipreziose, petali di fiori di vetro, che abbiamo così scoperto decorare il manto della statua, cosa non citata dalle fonti antiche, e cosa più emozionante, un piccolo oinochoe (boccale) con la scritta: “Eimi Pheidio”, cioè “io sono di Fidia”
Una basilica paleocristiana fu successivamente eretta sulle fondamenta dell’antico edificio tra 435 e 451 d.C. Aveva un tetto in legno, a tre navate e un santuario absidale ad est. Lo schermo a basso presbiterio in marmo ancora sopravvive. Le pareti erano di mattoni e il pavimento di lastre di marmo, che sono stati smantellati dagli scavatori per consentire l’indagine dei livelli più antichi. L’ingresso era sul lato sud del nartece. Iscrizioni cristiane all’interno del nartece forniscono informazioni sulle diverse professioni della gente di quel tempo. La basilica paleocristiana fu distrutta dal terribile terremoto del 551 d.C.
Tra l’altro, questo, non è il solo legame tra Fidia e Cristianesimo… Il Cristo Pantocràtore è una raffigurazione di Gesù in gloria, tipica dell’arte bizantina e in genere paleocristiana e anche medievale, soprattutto presente nei mosaici e affreschi absidali, un’immagine di Dio in gloria, quale Origine, Signore e Giudice finale di tutte le cose create.
Egli è ritratto in atteggiamento maestoso e severo, vestito di porpora e seduto come giudice, alla fine dei tempi, su un trono prezioso. Con la mano destra è nell’atto di benedire con le tre dita alzate, secondo l’uso poi rimasto nella chiesa ortodossa. La disposizione delle dita di tale mano spesso tende a formare una “X” con indice e medio e una specie di “C” con pollice, anulare e mignolo, rappresentando le lettere iniziali e finali del nome “Cristo” in greco antico. Nell’altra mano tiene un libro, il Vangelo, che può essere chiuso o aperto sulle parole apocalittiche “Io sono l’Alfa e l’Omega” o salvifiche “Io sono la luce del mondo.” Spesso ai lati sono raffigurati la Madonna e San Giovanni Battista che si rivolgono a Cristo in atteggiamento supplice, quali intercessori dell’umanità.
Il prototipo di tale rappresentazione era nell’abside del Chrysotriclinos (la sala dell’imperatore) del Gran Palazzo, la cui fondazione si deve forse all’imperatore Marciano alla metà del V secolo, proprio quando lo Zeus di Fidia era ancora visibile a Costantinopoli. E di fatto, tale iconografia ricorda molto quella descritta da Pausania, per cui potrebbe anche essere una sorta di appropriazione e cristianizzazione della statua di Fidia. Tale evento è forse all’origine della storia del miracolo attribuito al patriarca di Costantinopoli Gennadio, che secondo la tradizione, guarì un pittore colpito da una grave malattia agli arti, dopo che, su istigazione di un pagano ritrasse Cristo alla maniera di Zeus, con i capelli folti e ondulati e la barba lunga, invece del giovane sbarbato della tradizione paleocristiana.
Sempre Pausania racconta di un’altra statua crisoelefantina, per l’Heraion di Argo ricostruito a causa di un incendio tra il 423 e il 400 a.C.; la statua è ricordata come il capolavoro dello scultore, nata in diretta competizione con Fidia. Così la descrive il nostro viaggiatore
La statua di hera di statura assai grande, di oro, ed avorio siede sopra un trono, ed è opera di Policleto. Stà sulla sua testa una corona, sulla quale sono scolpite le Grazie, e le Ore, e da una mano tiene un melogranato, e dall’altra lo scettro. Quello, che spetta al melogranato, sendo una tradizione assai segreta, il debbo omettere. Dicono poi che sullo scettro sieda il cuculo, perchè quando Giove amava Giunone ancor vergine in quell’augello mutosssi, che essa come un giuoco prese. Questo e tutti gli altri discorsi, che tengonsi intorno agli Iddii, non gli scrivo perchè io li ammetta; ma tuttavia li scrivo.
Dato che il melograno era legato ai miti di morte e rinascita connessi al culto dell’età del Bronzo della Potnia Theron, di fatto Pausania accenna a un antico tabù. La statua ci è nota attraverso riproduzioni su monete argive di epoca antoniniana, le quali riconducono ad una possibile copia della testa conservata al British Museum e anche se le fonti non sono esplicite sul tema, ne possiamo ipotizzare le dimensioni, attorno agli otto metri di altezza, dalle dimensione del Naos. Dato che non è citata dal catalogo di Plinio e che sarebbe l’unica opera non bronzea di Policleto tra quelle ricordate dalle fonti, alcuni studiosi la attribuiscono invece a Policleto II, un omonimo scultore, forse il nipote, attivo nella prima metà del IV secolo a.C
December 15, 2021
A spasso per la Casilina

Pochi se ne rendono conto, ma viaggiare sulla ferrovia Roma Giardinetti, è una sorta di tour archeologico della città: si incontrano infatti numerose rovine romane, alcune evidenti, come il Tempio di Minerva Medica, il complesso di Porta Maggiore, il Mausoleo di Elena o l’Osteria di Centocelle, altre quasi invisibili, come le catacombe di San Castulo o le catacombe ebraiche, altre di cui rimangono alcune tracce, però poco comprese dl viaggiatore distratto: questo vale soprattutto per le numerose tombe antiche.
Ad esempio, poco oltre il II miglio, la via Labicana antica è fiancheggiata dal Sepolcro di via Filarete, o meglio da ciò che ne è rimasto. Si tratta di un sepolcro in blocchi quadrati di pietra gabina, disposti su due filari; i blocchi probabilmente corrispondono all’angolo sud-ovest del podio di un edificio funerario oppure di una tomba a recinto riferibile al I secolo a.C. Più avanti, nel tratto della Casilina che va da Via Romolo Balzani a via Palmiro Togliatti, sono presenti numerosi resti di sepolcri antichi, rilevati sia dai topografi di fine Ottocento, sia negli scavi connessi alla costruzione della Roma Pantano, dell’attuale strada e della Metro C, a riprova del ruolo funerario che aveva nell’Antichità classica, il IV miglio di via Labicana.
Nel 1899, all’altezza del nostro incrocio tra la Casilina e via dei Gordiani, fu ritrovata un’iscrizione su una superficie convessa, a testimonianza come vi fosse in quel punto un sepolcro perduto pianta circolare, risalente, per lo stile dell’epigrafe al I secolo d.C. Nel 1940, in occasione dei lavori di sistemazione delle rotaie del trenino, in quel punto fu anche trovato un sepolcro in peperino. Tra il 1967 e il 1968, in occasione dell’allargamento della Casilina e dell sistemazione della ferrovia Roma-Pantano, tra la nostra Via della Primavera, all’epoca via di Villa Cellere, e via Valmontone, furono rinvenuto i resti della necropoli che si estendeva a Nord di Via Labicana. Una serie di fotografie scattate nel 1968 documenta i rinvenimenti e i lavori restauri, dato che i rovine furono poi distrutte a seguito dell’urbanizzazione della zona. Furono messi in luce alcuni colombari, forniti di nicchie e arcosoli, simili a quelli della necropoli di Isola Sacra, con una facciata realizzata in opera reticolata alternata con opera vittata con blocchetti di tudo, strutture in mattoni e frammenti architettonici in travertino, alcuni conservati nell’atrio del quasi ex istituto Pio XII. Tra i mausolei fu identificata una tomba a tumulo circolare, databile all’eta augustea, con struttura muraria in conglomerato cementizio con scapoli di tufo e lava leucitica e cella funeraria rivestita in opera reticolare. Del sepolcro, la cui chiusura fu rinvenuta intatta, fu recuperata un sarcofago in cui era inumato un uomo immerso in un mix di calce e resine, a testimoniare il rango e la ricchezza del defunto.
Anche se non è mai stata ritrovata, da un’iscrizione sappiamo che nella stessa zona, in via Labicana Summa, nel tratto più alto di quest strada, prima dell’inizio della discesa verso il fosso di Centocelle, vi era la Iulia Olimpia, una liberta di Giulio Cesare, che ricevette nel suo testamento un donativo spropositato, rendendola così una delle donne più ricche della Roma dell’epoca. In occasione dei lavori eseguiti nel 1999 per la costruzione del muro di cinta del bistrattato Parco Archeologico di Centocelle, sono stati ritrovati consistenti resti di sepolcri appartenenti a una sezione della necropoli precedente, in cuo sono state identificate diverse tipologie di tombe, da quelle a fossa, a un mausoleo con più ambienti, che potrebbe essere proprio quello di Iulia Olimpia, all’ipogeo scavato nel tufo.
Nel 1928, nei terreni di proprietà della famiglia Muti Bussi, di fronte alla nostra stazione di Centocelle, furono ritrovati 2 torsi di statue funerarie: uno rappresentava una figura femminile, l’altro un uomo togato. Al contempo, furono scoperti vari sepolcri di età imperiale. In particolare, saltarono fuori un edificio in mattoni, presso il quale si trovava un sarcofago fittile a forma di labrum, ossia di grande vasca, spesso marmorea, usata nell’architettura romana per ornamento di giardini o per abluzioni e un monumento blocco parallelepipedo con conglomerato a scheggie di tufo, a forma di arca baulata, lungo un m 1,40 e largo 1,10, rivestito con intonaco, che presentava murata nel nucleo cementizio un’anfora, forse contenente le ceneri del defunto: sul lato breve della struttura si trovava infiss un’iscrizione funeraria relativa ad Agria Zosime.
Fu poi ritrovato un altro sepolcro in opera laterizia a pianta rettangolare (m 1,64 m x 2,28 m) con ingresso sul lato breve; nelle parati della camera era ricavato un arcosolio; sui lati lunghi al di sopra degli arcosoli si sviluppava una cornice in mattoni, su cui si trovavano tre nicchie contenenti due olle funerarie ciascuna; il pavimento era decorato con un mosaico a tessere bianche e nere, con riquadratura a dentelli, doppia fascia, quattro quadrati agli angoli e un rettangolo al centro e treccia a doppia banda compresa tra il rettangolo ed i quadrati
December 14, 2021
Quando eruttò il Vesuvio ?

Mio zio si trovava a Miseno dove comandava la flotta. Il 24 agosto, nel primo pomeriggio, mia madre attirò la sua attenzione su una nube di straordinaria forma e grandezza. Egli aveva fatto il bagno di sole, poi quello d’acqua fredda, si era fatto servire una colazione a letto e in quel momento stava studiando. Fattesi portare le scarpe si recò su un luogo elevato da dove si poteva benissimo contemplare il fenomeno. Una nube si levava in alto, ed era di tale forma ed aspetto da non poter essere paragonata a nessun albero meglio che a un pino. Infatti, drizzandosi come su un tronco altissimo, si allargava poi in una specie di ramificazione; e questo perché, suppongo io, sollevata dal vento proprio nel tempo in cui essa si formava, poi, al cedere del vento, abbandonata a sé o vinta dal suo stesso peso, si diffondeva ampiamente per l’aria dissolvendosi a poco a poco, ora candida, ora sordida e macchiata, secondo che portasse con sé terra o cenere.
A mio zio, che era uomo dottissimo, tutto ciò parve un fenomeno importante e degno di essere osservato più da vicino, per cui ordinò che si preparasse una liburnica offrendomi se volevo, di andare con lui. Risposi che preferivo studiare: era stato lui stesso, infatti, ad assegnarmi qualcosa da scrivere. Mentre usciva di casa gli venne consegnato un biglietto di Retina, moglie di Casco, la quale, spaventata dall’imminente pericolo (perché la sua villa stava in basso e ormai non v’era altra via di scampo che montare su una nave), lo supplicava di liberarla da una situazione così tremenda.
Mio zio allora modificò il suo piano e compì con eroico coraggio quel che si era accinto a fare per ragioni di studio. Diede ordine di mettere in mare le quadriremi e vi salì egli stesso con l’intenzione di correre in aiuto non solo di Retina, ma di molti altri, perché quell’amenissima costa era fittamente popolata. In gran fretta si diresse là, da dove gli altri fuggivano, navigando diritto tenendo il timone verso il luogo del pericolo con animo così impavido da dettare o annotare egli stesso ogni nuova fase e ogni aspetto di quel terribile flagello, come gli si veniva presentando allo sguardo. Già la cenere cadeva sulle navi tanto più calda e fitta quanto più esse si avvicinavano; già cadevano anche pomici e pietre nere, arse e frantumate dal fuoco; poi improvvisamente si trovarono in acque basse e il lido per i massi rotolati giù dal monte era divenuto inaccessibile. Egli rimase un momento incerto se dovesse tornare indietro. Poi, al pilota che lo consigliava, disse: ‘La fortuna aiuta gli audaci; drizza la prora verso la villa di Pomponiano a Stabiae!’.
Questa località era sull’altra parte del golfo (perché la costa, girando e incurvandosi gradatamente, forma un’insenatura che il mare invade con le sue acque). Ivi, quando il pericolo non era ancora imminente, ma era stato veduto e, crescendo, s’era fatto più vicino, Pomponiano aveva imbarcato i suoi bagagli, deciso a fuggire nel caso il vento contrario si quietasse. Il vento favoriva in sommo grado la navigazione di mio zio, il quale, appena giunto, abbraccia l’amico tremante, lo conforta, lo incoraggia e, per calmare l’agitazione con l’esempio della propria tranquillità d’animo, si fa portare nel bagno; dopo essersi lavato, si mette a tavola e pranza tranquillamente o, cosa egualmente grande, in aspetto di persona serena.
Intanto su più parti del Vesuvio risplendevano larghe strisce di fuoco e alti incendi, il cui bagliore e la cui luce venivano aumentati dall’oscurità della notte. Lo zio, per liberare gli animi dalla paura, andava dicendo che quelli che ardevano erano fuochi lasciati accesi dai contadini nella loro fuga precipitosa, e ville abbandonate che bruciavano nella solitudine. Poi si mise a dormire, e dormì veramente poiché la respirazione, molto grave e sonora per la grossezza del corpo, era udita da tutti coloro che passavano davanti alla porta della sua camera. Ma il piano del cortile, a causa della grande quantità di cenere mista a pietre pomici da cui era stato riempito, si era talmente innalzato che lo zio, se fosse rimasto più a lungo nella camera da letto, non avrebbe potuto uscirne.
Svegliato venne fuori e si unì a Pomponiano e agli altri che avevano trascorso tutta la notte senza chiudere occhio. Si consultarono se dovessero rimanere in casa o tentare di uscire all’aperto: infatti per frequenti e lunghi terremoti la casa traballava e dava l’impressione di oscillare in un senso o nell’altro come squassata dalle fondamenta. Stando però all’aperto v’era da temere la caduta delle pietre pomici, anche se queste sono leggere e porose. Alla fine confrontati i pericoli, fu scelto quest’ultimo partito. Prevalse in mio zio la più ragionevole delle due soluzioni, negli altri invece il più forte dei timori. Si misero dei cuscini sul capo e li legarono con fazzoletti: e questo servì loro per protezione contro le pietre che cadevano dall’alto.
Mentre altrove faceva giorno, colà era notte, più oscura e più fitta di tutte le altre notti, sebbene fosse rischiarata da fiamme e bagliori. Fu deciso di recarsi alla spiaggia per vedere da vicino se fosse possibile mettersi in mare; ma il mare era ancora pericoloso perché agitato dalla tempesta. Allora fu steso un lenzuolo per terra e mio zio vi si adagiò sopra, poi chiese più volte acqua fresca da bere. In seguito le fiamme e un odor di zolfo annunciatore del fuoco costrinse agli altri di fuggire e a lui di alzarsi. Si tirò su appoggiandosi a due schiavi, ma ricadde presto a terra.
Secondo me, l’aria troppo impregnata di cenere deve avergli impedito il respiro ostruendogli la gola, che per natura era debole, angusta e soggetta a frequenti infiammazioni. Quando il giorno dopo tornò a risplendere (era il terzo da quello che egli aveva visto per l’ultima volta), il suo corpo fu trovato intatto, illeso, coperto dalle medesime vesti che aveva indosso al momento della partenza; l’aspetto era quello di un uomo addormentato, piuttosto che d’un morto
E’ un brano famosissimo della lettere di Plinio il giovane, che racconta la morte di suo zio, Plinio il vecchio, in occasione dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Plinio il vecchio, che ricordiamolo era un uomo dalla curiosità insaziabile e che era a capo della flotta romana di stanza a Capo Miseno, sacrificò la sua vita sia per salvare più persone possibili dalla catastrode, sia per capire di più un fenomeno che, all’epoca, pareva incomprensibile. Ricordiamo, infatti, come i romani non avessero la più pallida idea del fatto che il monte campano fosse un vulcano e furono totalmente presi alla sprovvista. Testimonianza del tragico stupore è anche una poesia di Marziale, che di solito affronta temi molto più leggeri
Ecco il Vesuvio, che ieri ancora era verde delle ombre di pampini:
qui celebre uva spremuta dal torchio aveva colmato i tini.
Questa giogaia Bacco amò più dei colli di Nisa:
su questo monte ieri ancora i Satiri eseguirono il girotondo.
Qui c’era la città di Venere, a lei più gradita di Sparta;
qui c’era la città che ripeteva nel nome la gloria di Ercole.
Tutto giace sommerso dalle fiamme e dall’oscura cenere:
gli dei avrebbero voluto che un tale scempio non fosse stato loro permesso
A riprova dell’entità dei danni, solo una cinquantina d’anni dopo fu possibile ripristinare tutte le infrastrutture di quella che, nell’età augustea era una delle zone più fiorenti d’Italia… Ma quando avviene, questa benedetta eruzione ? La datazione tradizionale, quella che ho riportato nel brano di apertura, parla del 24 agosto e deriva dalla lettura del manoscritto più antico delle lettere di Plinio il giovane, il codice Laurentianus Mediceus, risalente al IX secolo, in cui appare
Nonum kal. septembres hora fere septima mater mea indicat ei apparere nubem inusitata et magnitudine et specie
Dove si cita il nono giorno prima delle calende di settembre, ossia il nostro 24 agosto. Lezione che però non è univoca: il Codex venetus riporta la data del 1° novembre (Kal. Novembr.); altri, invece fanno riferimento alla data del 24 ottobre (nonum Kal. Novembres). C’è poi una fonte storiografica alternativa, quella di Dione Cassio, che parla esplicitamente di un’eruzione autunnale.
L’archeologia, tra l’altro non ha emesso ancora una sentenza definitiva. Nello scavo dell’area vesuviana, sigillati dai lapilli, sono stati ritrovati (carbonizzati o tramite indagini archeobotaniche) resti di frutta secca (come fichi secchi, datteri, susine), frutta tipicamente autunnale (come ad esempio melograni rinvenuti a Oplontis, castagne, uva, noci), si era completata la raccolta della canapa da semina (raccolta che si effettuava solitamente a settembre), la vendemmia (effettuata solitamente nel periodo di settembre e ottobre) era da tempo terminata e il mosto era stato sigillato nelle anfore (i dolea, dogli o vasi a forma tondeggiante nei quale i romani conservavano derrate liquide, come olio e vino, o secche, come grano e legumi) e interrato, come riscontrato a Villa Regina (Boscoreale). Tali anfore venivano chiuse soltanto dopo un periodo di fermentazione all’aria aperta della durata di una decina di giorni: dunque l’eruzione avvenne, se si considera attendibile questo elemento d’indagine, in un periodo successivo. Anche nel caso di una vendemmia anticipata, i giorni intercorsi tra la raccolta, la pigiatura e la prima fermentazione consentono di spostare la data avanti con una certa sicurezza. Inoltre erano già posti in uso nelle case oggetti tipicamente autunnali come i bracieri nella Casa di Menandro.
Ovviamente, i dati possono essere anche letti in altro modo: i dolia interrati e le anfore chiuse e pronte al commercio avrebbero potuto contenere, invece del vino, altre sostanze, oppure vini non destinati alla tavola o vini a lungo invecchiamento. Così come la frutta secca potrebbe essere stata una giacenza dalla scorsa stagione; le noci potrebbero essere state raccolte verdi e consumate fresche e non secche, e le melagrane raccolte verdi in modo da rallentarne il processo di maturazione per poi usarle per preparati medici oltre che per consumo alimentare. Anche la botanica propenderebbe per una datazione estiva; come prova, sono state trovate oltre duecento specie erbacee, arbustive e arboree di cui si sarebbero conservati sia i pollini, sia parte di fusti e foglie. Non sembra ci siano motivi poi per modificare il testo di Plinio, tanto più che questi, descrivendo le attività dello zio il giorno dell’eruzione, ricorda tra l’altro che dopo pranzo aveva fatto un bagno di sole e poi d’acqua fredda, attività che, come riporta un’altra lettera (Epist., III 5, 10-11) sono tipiche della stagione estiva. Inoltre, il viaggio per mare di Plinio il Vecchio, compiuto con le navi partendo da Miseno nel pomeriggio e approdando a Stabiae verso il tramonto, dopo aver tentato di raggiungere Ercolano, ben si addice ad una tipica giornata estiva e non ad una corta di un mese autunnale.
Un altro dato controverso è denario d’argento trovato il 7 giugno 1974 nello scavo a Pompei, sotto la Casa del bracciale d’oro, che porterebbe sul recto impressa l’iscrizione:
Imperatore Tito Cesare Vespasiano Augusto Pontefice Massimo, nona volta con la potestà tribunicia, imperatore per la quindicesima, console per la settima, padre della patria
Il ritrovamento del denario pompeiano (con l’indicazione della XV acclamazione) permette di affermare che l’eruzione avvenne, ovviamente, dopo l’emissione di questa moneta, quindi nell’anno in cui l’imperatore Tito ricoprì il settimo consolato (il 79), dopo l’assunzione per la nona volta della potestà tribunicia, cioè dopo il 1º luglio e dopo la quindicesima acclamazione a imperatore, consentendo di spostare ancora oltre luglio il terminus post quem. Due iscrizioni (conservate a Siviglia, Spagna, e al British Museum) datate al 7 settembre e all’8 settembre hanno consentito di accertare che l’eruzione avvenne certamente dopo queste date.
Il problema è che tutto questo ragionamento, a prima vista sensato, in realtà è stato contestato da diversi esperti di numismatica: la moneta è talmente mal conservata che la sua iscrizione è illeggibile: è stata ricostruita basandosi su un conio analogo. Però, in queste serie, vi sono almeno altre due emissioni, altrettanto simili alla moneta in questione, che però sono antecedenti al luglio del 79 d.C.
Allo stato attuale, l’unica prova che farebbe propendere per la datazione autunnale, consiste in un’iscrizione in carboncino trovate in una domus con giardino della Regio V di Pompei, che parrebbe datata al sedicesimo giorno prima delle calende di novembre, corrispondente al 17 ottobre e recita:
“XVI (ante) K(alendas) Nov(embres) in[d]ulsit pro masumis esurit[ioni] “
Il 17 ottobre lui indulse al cibo in modo smodato
o come lettura alternativa
“XVI (ante) K(alendas) Nov(embres) in olearia / proma sumserunt […]”
” Il 17 ottobre hanno preso nella dispensa olearia […]”
L’iscrizione appare in un ambiente (atrio) della casa che all’epoca dell’eruzione era in fase di ristrutturazione, a differenza del resto della stanze già completamente rinnovate. Ovviamente, si potrebbe obiettare che l’iscrizione possa risalire all’anno precedente, al 78 a.C., e che i lavori di restauro, per qualche motivo che noi ignoriamo, possano essere stati interrotti per qualche mese. Però, di carboncino, fragile e evanescente, che non avrebbe potuto resistere a lungo nel tempo.
Nell’ipotesi che la datazione autunnale sia esatta, allora Plinio il giovane è stato così scemo da non ricordare la data della morte dello zio ? Benché abbia scarsissima stima del personaggio, non me sento di dire questo. O si tratta di un monaco medievale distratto, oppure, in tarda antichità, un copista, decise, per motivi simbolici, di spostare la data, per farla coincidere con quella dei Volcanalia, che ricordiamolo, celebrava proprio Vulcano, il dio del fuoco distruttivo…
December 13, 2021
Atene contro Siracusa Parte XL
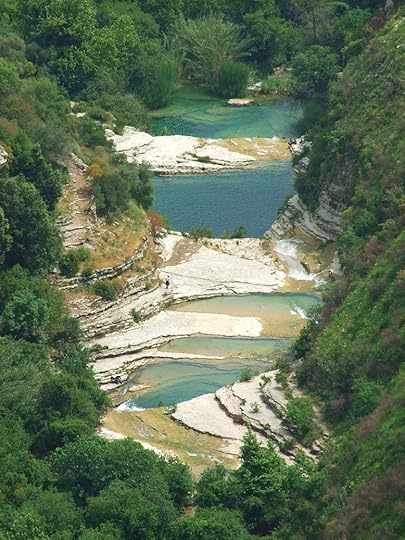
Il tentativo ateniese di sfondare il blocco nemico si scontrò il giorno successivo, con una altra enorme difficoltà. Gilippo, poco convinto del fatto che i suoi opliti potessero resistere a lungo all’impeto avversario, per non sapere nè leggere, nè scrivere, durante la notte aveva fatto costruire, in fretta furia una palizzata. Poi, aveva dato ordine ai lanciatori di giavellotto e agli arcieri di disporsi sulle creste del canalone che le truppe di Nicia e di Demostene dovevano percorrere per forza.
Per cui, quando gli ateniesi attaccarono all’alba, sperando di cogliere i siracusani nel sonno e di passare, si trovarono in trappola. Non riuscirono a superare la palizzata, dietro cui, per sì e per no, Gilippo aveva schierato i suoi opliti e nel frattempo, furono bersagliati dalle armi da lancio nemiche.
Per tempo, all’aurora del giorno dopo, tolsero le tende e proseguirono la marcia. Cercarono di forzare di slancio il passaggio che menava al colle, sbarrato da un muro. Ma urtarono, proprio davanti a sè, contro l’armata terrestre siracusana, tutta in ordine a difesa della barriera e schierata su una profondità di numerose file: il varco infatti si presentava angusto. Gli Ateniesi scattarono all’assalto tentando di scalare il muro, ma presi di mira da fitte schiere di tiratori appostati sul ciglio della collina, il cui pendio precipitava a picco (da quella postazione elevata il bersaglio era più facile da cogliere), delusi dal tentativo fallito di varcare la muraglia, si ritirarono per riprendere fiato.
A peggiorare la situazione per gli ateniesi, ci si mise pure un improvviso temporale: visto che non si tirava fuori un ragno dal buco, gli strateghi concessero alle loro truppe una tregua. Così Gilippo ne approfittò per fare scattare la seconda parte del piano: mandò un distaccamento alle spalle degli ateniesi, per costruire una seconda palizzata e chiuderli in trappola. Nicia se ne accorse, mandò un distaccamento di opliti,che dispersero i siracusani e per evitare che Gilippo tentasse la stessa mossa di notte, diede ordine alle sue truppe di ritirarsi in pianura
Principiava frattanto un brontolio di tuoni, con qualche scroscio di pioggia: come è normale in quella stagione estiva così avanzata, già declinante all’autunno. Ma ne nacque negli Ateniesi un eccessivo sgomento e si rammaricavano che anche gli eventi della natura cospirassero per annientarli. Mentre gli Ateniesi si concedevano un po’ di tregua, Gilippo e i Siracusani distaccarono una parte delle loro truppe ad ostruire con un secondo muro il passaggio alle spalle del nemico, per cui era entrato nella pianura. Ma gli Ateniesi pararono la mossa lanciando un reparto che li costrinse a desistere. Dopo questa scaramuccia, con l’esercito ormai riunito, gli Ateniesi si ritirarono piuttosto verso la pianura e lì stabilirono di bivaccare per quella notte.
Il giorno dopo, ripresero i combattimenti, con la cavalleria e le truppe leggere siracusane, alla faccia degli storici su Facebook, che si riempiono la bocca, senza neppure leggere le fonti, che le battaglie nell’antica Grecia erano combattute solo dalle fanterie pesanti, che tormentarono i nemici con la tattica del mordi e fuggi, tanto che in un’intera giornata, gli ateniesi non riuscirono che a percorrere tra i settecento e gli ottocento metri.
Il mattino seguente ripresero l’avanzata: ma i Siracusani, circuendoli, li attaccavano da ogni lato ferendone un grande numero. Era questa la tattica: quando l’armata ateniese accennava al contrattacco, le forze siracusane si ritraevano; quando il nemico iniziava la manovra di rientro, addosso con rinnovata furia. La retroguardia subiva il più distruttivo effetto della pressione siracusana, che tentava di scompaginare le intere colonne isolandone singole compagnie per poi disperderle. Il contrasto difensivo ateniese resse a lungo, in questa giornata: poi, percorsi altri cinque o sei stadi, si fermarono nella pianura a riposare. Anche i Siracusani colsero l’occasione per interrompere il contatto e rientrare
nei propri alloggiamenti.
Dinanzi a questo stillicidio e alla scarsità di cibo e di acqua, Nicia e Demostene, visto che la Rupe Acrea si stava trasformando in una trappola mortale, decisero di cambiare i loro piani: invece di puntare su Camarina e le città sicule, più o meno alleate, si decise di tornare a Catania. Poi, per non essere scoperti dai siracusani, la ritirata cominciò in piena notte, il che aumentò la confusione nel campo ateniese.
Quella notte Nicia e Demostene, davanti alle sofferenze dell’esercito, sfinito dalla scarsità di cibo che da tempo s’aggravava rapidamente, dissanguato dagli assalti nemici che s’erano susseguiti a ritmo incalzante ponendo reparti interi fuori combattimento per le ferite, presero la decisione di accendere il maggior numero di fuochi e di ritirare l’armata non più per la stessa strada prevista dal piano originario, ma nella direzione opposta a quella tenuta dai presidi siracusani, verso il mare (in complesso comunque, la via designata dal progetto di fuga, e che l’esercito doveva percorrere, non puntava su Catania, ma tendeva al versante opposto dell’isola, nel senso di Camarina, di Gela e dei centri greci o barbari che popolano quella regione della Sicilia). Così alla luce di molti fuochi si spostavano nella notte. E un brivido scosse e scompigliò le schiere: fenomeno frequente in tutti gli eserciti, specie in quelli numerosi, quest’improvviso fremere di terrore, soprattutto avanzando nella notte, circondati da terre ostili, con la vivida sensazione di un nemico che incalza a due passi.
Se Nicia mantenne una parvenza d’ordine, così non avvenne per Demostene e la colonna che in teoria comandava, in pieno caos, rimase indietro. Nonostante questo, perchè i siracusani si cullavano sugli allori, gli ateniesi riuscirono a raggiungere le rive del fiume Cacipari, il nostro Cassibile.
Per chi non lo conoscesse, Nasce presso Fontana Saraceni, Fontana Santa Lucia, Fontana Velardo e Fontana Pianette a pochi km da Palazzolo Acreide, in Provincia di Siracusa in località Serra Porcari. Il suo percorso di 30 km si snoda tra i comuni di Palazzolo Acreide e Avola, sfociando poi nel Mare Ionio fra Capo Negro e Punta del Cane a 23 km a sud di Siracusa tramite un estuario. In realtà l’estuario del fiume non è da considerare un vero e proprio estuario, ma un’immissione di acqua di mare, in quanto il fiume si ingrotta per sfociare parecchi chilometri in alto mare. Ricade nel territorio dei comuni di Avola, Siracusa e Noto.
Lo scorrere del fiume Cassibile, nel corso dei millenni ha creato una serie di profondi canyon, fenomeno assai diffuso nella provincia di Siracusa. La profondità maggiore raggiunta è di 520 m s.l.m., ma nei pressi del belvedere di Avola Antica con i suoi 507 metri raggiunge la massima profondità. Sempre in questo tratto il canyon raggiunge la massima ampiezza di 1200 metri.
Lungo il percorso del fiume si notano molte tombe scavate nella roccia che furono oggetto dello studio, nel secolo scorso, di Paolo Orsi. Sono tombe quasi tutte a grotticella, a pianta rettangolare o ellittica.
In circa 10 km forma numerosi laghetti, con acque fresche e limpide, fra cui spiccano per bellezza i piccoli laghi nei pressi di Avola Antica accessibili al pubblico tramite una scala storica, la “Scala Cruci”. Questa parte del suo percorso costituisce un’area di grande valore naturalistico che è divenuta, l’area protetta di Cavagrande del Cassibile.
Le divisioni guidate da Nicia che tenevano la testa dell’esercito marciavano a file serrate accumulando un discreto vantaggio; i reparti agli ordini di Demostene, metà circa dell’intero esercito, se non di più, persero contatto proseguendo con evidente indisciplina. All’aurora, tuttavia, raggiungevano il mare. Si misero sulla strada cosiddetta Elorina e cominciarono il viaggio per quella via col proposito di arrivare al fiume Cacipari, per addentrarsi, lungo le rive del fiume, verso le zone interne dell’isola. Speravano che i Siculi mandati ad avvisare si facessero incontro per quella strada.
Sfortuna volle che Gilippo, più per scrupolo che per altro, aveva messo a difesa del guado su questo fiume un piccolo presidio: i siracusani furono ovviamente travolti dalle forze avversarie, ma riuscirono a mandare una staffetta a cavallo, per avvertire il grosso dell’esercito posto a Rupe Acrea, dove intanto si era scatenato un manicomio. I siracusani si erano svagliati, si erano guardati attorno, non avevano più trovato gli ateniesi e dopo aver cominciato a litigare tra loro, avevano infine deciso di accusare Gilippo di tradimento. Cominciarno a volare parole grosse, ma per fortuna, arrivò il messaggero dal guado del Cacipari. Per cui, tornata la calma, Gilippo diede ordine alla cavalleria siracusana di inseguire gli ateniesi, cosa facilitata dalla loro disorganizzazione.
Dopo avere superato di slancio il Cacipari, le truppe di Nicia e Demostene puntarono a superare l’attuale all’attuale fiumara Miranda, chiamato anche fiume di Avola. Solo che mentre la colonna di Nicia avanzava a marce forzate, beh, quella di Demostene somigliava più a una gallina decapitata, tanto che la distanza tra le due era aumentata a circa tre chilometri. Così, fu facile, per i siracusani raggiungere i reparti di Demostene all’ora di pranzo
Ma, quando giunsero in vista del fiume, trovarono che anche qui un presidio siracusano era intento a bloccare con un muro e una palizzata il guado fluviale. Gli Ateniesi fecero impeto, e travolto lo sbarramento, si rimisero in cammino in direzione dell’altro fiume, l’Erineo. Era questa la strada a cui li invitavano le guide. Intanto i Siracusani e gli alleati quando alle prime luci del giorno appresero che gli Ateniesi avevano tolto le tende, si rivolsero per la maggior parte contro Gilippo con l’accusa d’aver lasciato deliberatamente via libera agli Ateniesi. Senza esitare si scagliarono ad inseguire il nemico, sulle tracce ancora ben chiare del suo passaggio. All’ora del rancio entrarono in contatto. Appena ebbero intercettato i reparti di Demostene, che si attardavano alla retroguardia avanzando svogliati e senza ordine per effetto di quel terrore notturno, li aggredirono di slancio aprendo la battaglia. Per la cavalleria siracusana fu comodo accerchiare quelle truppe isolate e inchiodarle in uno spazio via via più angusto. Le divisioni di Nicia s’erano avvantaggiate di circa cinquanta stadi. Nicia infatti aveva imposto alla marcia un ritmo più sostenuto, convinto che per ottenere la salvezza fosse indispensabile non prendere l’iniziativa di attestarsi volontariamente in quel punto, per difendersi ad oltranza. Piuttosto era urgente ritirarsi a tappe forzate, limitando allo stretto necessario la resistenza armata.
Truppe che furono circondate e logorate con la solita tattica della guerriglia
Così Demostene rimaneva esposto a un più feroce e implacabile tormento: marciando alla retroguardia, era sempre il primo a subire l’urto nemico. Anche in quel frangente, vedendosi incalzato dappresso dai Siracusani, egli preferiva distribuire le schiere per l’evenienza di una battaglia, piuttosto che affrettare la marcia di avanzamento. Ma questo ritardo concesse al nemico il tempo di circondarlo. Sicché Demostene e gli Ateniesi stretti a lui si fecero vincere dal panico. Trascinati dalla pressione siracusana in un terreno recintato tutto intorno da un muretto, con due strade che lo delimitavano ai lati, denso di una piantagione d’ulivi si offrivano completamente scoperti al tiro incrociato degli arcieri avversari. Ben a ragione i Siracusani sceglievano una tattica di questo genere: aggressioni fulminee, anziché grandi battaglie manovrate, corpo a corpo. Arrischiare eserciti interi, in giornate risolutive, contro un’armata ridotta ormai alla disperazione, avrebbe significato in quella fase della guerra la rinuncia ad un vantaggio strategico da parte dei Siracusani in favore degli Ateniesi. Nel fiore della fortuna, incamminati a un luminoso trionfo, nasceva nei Siracusani un sentimento di cautela, misto al desiderio di non correre troppo incerte avventure, per non pagare con una morte immatura il prezzo della vittoria. Si stimava valida anche la tattica descritta: finché, colto il nemico all’ultimo respiro, lo si sarebbe definitivamente piegato.
Giunto il tramonto, per prima cosa, Gilippo propose la resa alle città alleate degli ateniesi, per poi cominciare trattative serrate proprio con i nemici: alla fine si raggiunse un compromesso proprio con Demostene, consegna delle armi in cambio della vita. Così ottennero 6000 prigioneri, mentre Nicia, ignaro di tutto, proseguiva il suo cammino
Fino all’imbrunire, quel giorno le armi siracusane martellarono da tutti i lati gli Ateniesi e i loro amici: appena videro gli avversari stremati dalle ferite, esausti da tanto patire, Gilippo con i Siracusani e gli alleati proclamarono anzitutto un bando, con l’invito per chiunque volesse degli isolani di passare dalla loro parte, conservando la libertà: le truppe di qualche città si staccarono dagli Ateniesi, ma non furono molte. In un secondo momento si scese a trattare per tutti gli altri che erano rimasti fedeli a Demostene, su questa base: la consegna delle armi con in cambio la garanzia che nessun attentato sarebbe stato commesso alla vita degli uomini, né con esecuzioni sommarie, né con catene, né condannandoli alla morte per fame, negando il vitto necessario. Fu la resa generale per un complesso di seimila combattenti. Deposero tutto il denaro di cui erano ancora padroni, gettandolo nel cavo di scudi rovesciati: colmarono così quattro scudi. I Siracusani scortarono i prigionieri
direttamente in città. Nicia, alla guida dei suoi reparti, raggiunse in quello stesso giorno la riva del fiume Erineo e, guadatolo, piantò su un’altura il campo per il proprio esercito.
Sul vero luogo in cui effettivamente i soldati di Demostene si arresero non c’è un accordo tra gli storici. L’inglese Thirlwall, (vol. III, p. 455) è dell’avviso che la resa sia stata decretata esattamente a metà strada tra il fiume Cacipari e l’Erineo; non sembra però essere della stessa opinione Grote (Grote, vol. VII, p. 467) secondo il quale la resa avvenne ancora a nord del Cacipari. Un approccio più cauto è adoperato dallo storico tedesco Holm (Topografia, p. 235) in cui sostiene che le distanze in stadi scritte da Tucidide rappresenterebbero una distanza minore rispetto al normale, ognuno equivalente in questo caso a circa 150 m. La questione sta nella conversione degli ultimi 50 stadi del percorso di Demostene (VII, 81): equivalenti a 4,5 miglia (= 7,2 km), come scrivono Grote e Holm, oppure a 6 miglia (= 9,6 km), come sostenuto da Thirlwall?
December 12, 2021
Il tempio di Demetra ad Akragas

La Rupe Atenea è generalmente identificata con il sito dell’Acropoli della città greca che la testimonianza di Polibio colloca ad Est, “là dove sorge il sole”. Dei templi di Athena e Zeus Atabirio ricordati dalle fonti non sono state sinora ritrovate tracce, sebbene sia comunque accertata la natura sacra del sito (Tempio di Demetra) e scavi ancora in corso stiano svelando importanti resti. Le numerose campagne archeologiche effettuate hanno portato alla scoperta di diverse strutture fra cui un lungo muro, in cui si distinguono nettamente due tratti aventi cronologia differente ma di cui non si è ancora riusciti ad individuarne con sicurezza la funzione: in particolar modo per il tratto più antico, risalente alla fine del V secolo A.C., non si è in grado di stabilire se si tratta di un muro appartenente ad un edificio sacro, oppure di un muro di terrazzamento per la costruzione di un grande edificio, probabilmente un tempio, del quale però non è stata trovata alcuna traccia. Sono noti, invece, elementi riconducibili alla natura fortificata del sito. Si tratta dei resti di due torri databili alla fine del V secolo a.C. delle quali una fu obliterata dal tratto occidentale di un muro di terrazzamento costruito nel IV secolo a.C. quale sostegno di un impianto artigianale per la spremitura delle olive.
Le peculiarità della zona vanno ricercate anche nel sottosuolo che, così come in altre zone del centro storico di Agrigento e della Valle dei Templi, si presenta ricco di sorprese e di interessanti strutture ipogee. Sono infatti presenti, sia nella zona più alta della rupe che lungo le pareti del versante settentrionale, delle cavità artificiali, ossia scavate dall’uomo in epoche passate; in tutto le cavità censite e rilevate sono otto: una, la più interessante per sviluppo e caratteristiche, presenta un andamento tortuoso e cunicolare. Le altre sette cavità sono invece delle vere e proprie camere ipogee: alcune di queste presentano al loro interno dei fenomeni di crollo della volta che non permettono di stabilire con assoluta certezza il loro sviluppo planimetrico.
L’ipogeo ad andamento cunicolare – Ipogeo della Rupe – è ubicato al di sotto della zona interessata dalla presenza delle antenne, posta ad una quota di poco inferiore ai 350 m sul livello del mare. La sua peculiarità principale è dovuta alla presenta di ben sei ingressi, distribuiti lungo il periplo della parte alta della “Rupe Atenea”, e che permettono il controllo totale del territorio in tutti e quattro i punti cardinali. L’ubicazione e la strutturazione della cavità ben si presta agli scopi difensivi della stessa: a suffragare tale ipotesi vi è la presenza di due fortini militari, risalenti al periodo bellico.
Uno di queste grotte fu utilizzata come comando della 207^ divisione costiera durante l’ultima guerra, nella battaglia di Agrigento avvenuta tra il 12 e il 16 luglio del 1943 tra gli uomini del Regio Esercito e quelli della 3^ divisione americana del generale Truscott, che aveva avuto incarico dal generale Patton di catturare Agrigento e Porto Empedocle. A conferma di questa ipotesi la presenza di due osservatori militari e dei resti di un poligono di tiro in chiarissimo stile fascista
Proseguendo lungo la parete nord del costone calcarenitico si incontrano altre sette cavità la cui origine risulta ancora oggi abbastanza incerta, sia come datazione che come utilizzo. Questi ipogei sono costituiti da camere ipogee aventi sviluppi planimetrici diversi, ma comunque mai superiori a quindici metri. Le cavità della “Rupe Atenea” non presentano alcun elemento che le possa far ricondurre le stesse a strutture utilizzate per scopi idraulici come ad esempio buona parte di quelle scavate nell’area della Kolimbetra – Valle dei Templi –, ma anzi ci si sente di poter escludere tale ipotesi sia per la posizione altimetricamente elevata rispetto alla potenziale falda, testimoniata anche dall’assenza di acqua o di una sua passata presenza (concrezioni, cannule, ecc.), che per l’andamento plano-altimetrico complesso della cavità e l’elevato numero di sbocchi verso l’esterno. Per quanto riguarda l’Ipogeo della Rupe Atenea la sua posizione strategica rispetto al territorio circostante e la presenza di due fortini in cemento armato testimoniano la sua vocazione di struttura militare. Invece per le altre cavità, presenti sulla parete nord, una delle ipotesi più credibile è quella che le vede inizialmente come opere di sepoltura.
Ruolo che di fatto, è stato mantenuto anche di recente: l’area accanto alla chiesa sconsacrata della Madonna delle Forche, è stata utilizzata per scavare le fosse comuni durante l’epidemia di colera del 1837. Come accennato, gli unici resti archeologici sono quelli del cosiddetto Tempio di Demetra, che fu probabilmente costruito datato nel periodo compreso tra il 480 e il 470 a. C. Questo tempio, in stile dorico, offre un interessante esempio di edificio distilo in antis ovvero privo del colonnato esterno e costituito da una semplice cella preceduta da un pronao con due colonne. Della struttura originaria si conservano il basamento di m 30×13 c.a, ancora in parte visibile, i muri esterni della cella e quelli divisori tra cella e pronao; il basimento, che corrisponde all’abside della chiesa di San Biagio, evidenzia la caratteristica fondazione a “graticola”.
È identificato quale tempio di Demetra, anche se qualche studioso sostiene l’ipotesi alternativa di Artemide, per la presenza, sul fianco Nord dell’edificio, di due altari rotondi dei quali uno con pozzo votivo (bothros) ritrovato ricolmo di offerte rituali, tra cui dei kernoi (vasi rituali legati al culto di Perfesone) e dei resti appartenenti a dei busti fittili che dovevano raffigurare la stessa Demetra. Gli scavi (1925), oltre a mostrare come il tempio appartenesse a un Temenos, un recinto sacro, hanno portato alla luce, tra l’altro, elementi del geison (oggi all’interno della chiesa) e della sima a testa leonina (Museo archeologico); inoltre, da una cisterna ubicata nei pressi proviene la nota statua marmorea di Kouros, c.d. Efebo di Agrigento (Museo archeologico).
Ora, questo tempio, rispetto agli altri di Agrigento, non rispetta l’orientamento canonico, verso est, ma uno molto particolare, ivolto al tramonto della luna piena più vicina al solstizio d’inverno. Lo hanno notato i ricercatori Giulio Magli del Politecnico di Milano, Robert Hannah dell’università di Waikato, Nuova Zelanda, e Andrea Orlando dell’Osservatorio Astrofisico di Catania, che hanno cercato di darne una spiegazione: quel particolare orientamento vuole celebrare la riunione di Demetra con la figlia Persefone, rapita da Ade, dio dell’oltretomba, che la portò negli Inferi per sposarla.
Orientamento associato probabilmente anche a particolari riti religiosi: si ipotizza che questi riti prevedessero una processione notturna che partiva dalla fontana santuario posta poco lontano dal tempio (dove sono stati trovati depositi votivi, tra cui una statuetta raffigurante Persefone), saliva al tempio stesso e poi attraversava il corridoio tra il lato nord del tempio e la collina (forse gettando le offerte nel pozzo centrale) e infine si riuniva in un vasto piazzale retrostante il tempio da dove si assisteva allo spettacolo della luna piena che tramontava sulla collina dell’acropoli.
In epoca normanna, sui resti del Tempio fu eretta la chiesa di San Biagio, di cui si si ha notizia anche attraverso il tabulario della Magione (pergamena 116 dell’aprile 1267). In essa domina assoluto lo stile cistercense, con una facciata particolarmente curata nel taglio a faccia vista, nuda, vasta, monocuspidata a capanna, e un portale a sesto acuto sormontato in asse con l’oculo fiancheggiato da due monofore. L’edificio sacro, eretto nella minorità di Federico II, appartiene ai valori estetici “dell’architettura mendicante” delle “chiese capannone” e “chiese a granaio” destinate ai fedeli.
Probabilmente intorno al XV-XVI secolo, la pianta fu modificata con l’inserimento di due archi a tutto sesto retti da colonne e di arcatelle laterali e, infine, con il rialzamento del transetto attraverso due gradini. Le foto d’archivio mostrano anche la presenza di un campanile a vela, oggi non più esistente, forse aggiunto successivamente.
Nella parete rocciosa sottostante, collegato probabilmente ai culti del tempio, vi è un un importante complesso sacro di carattere ctonio nel quale gli elementi architettonici, di particolare rilievo, anche se non di facile interpretazione, si integrano con le caratteristiche naturali del sito, come spesso si riscontra nei santuari sacri alle divinità della terra. Questo santuario rupestre è costituito da un edificio rettangolare addossato alla parete rocciosa sulla quale si aprono due grotte comunicanti, ritrovati ricolmi di offerte votive. Una terza galleria, una sorta di cunicolo era, invece, utilizzata come acquedotto per l’adduzione dell’acqua raccolta da una vicina sorgente nel bacino dell’antistante edificio.
Quest’ultimo presenta una pianta rettangolare allungata (m 12,30×3); si articola su due livelli; quello inferiore, diviso in due settori, fungeva da bacino di raccolta dell’acqua che vi penetrava dal foro posto all’angolo Nord-Ovest. Ad Est, l’edificio si apre su uno spazio delimitato da un muro di peribolo (recinzione) che presenta tre pilastri sulla fronte orientale; all’interno si trova un sistema di vasche comunicanti, su diversi livelli, dove si raccoglieva l’acqua proveniente dall’edificio rettangolare. A causa di movimenti del terreno il muro della fronte orientale presenta una considerevole rotazione verso Sud-Est rispetto alla situazione d’origine.
Numerose le ipotesi formulate relativamente alla natura, funzione e cronologia del complesso rupestre: grotte-santuario frequentate dagli indigeni e monumentalizzazione operata dai greci sul finire del VII secolo a.C.; santuario di epoca arcaica (VI secolo a.C.), successivamente trasformato; un ninfeo di epoca ellenistica sorta su un più antico santuario. Una recente ipotesi, rilevando caratteri architettonici punici (pareti rastremate, cornici di coronamento, pilastri come betili), ricollega il santuario a quel settore di abitato databile al IV secolo a.C. (quartiere punico) scoperto sulle stesse pendici orientali della collina nei pressi di Porta II.
December 11, 2021
La Casa Professa (Parte I)
Oggi parliamo di una tra la più belle chiese barocche del mondo, la chiesa del Gesù nota anche come Casa Professa, che deve il suo nome ai Padri Gesuiti, detti anche Padri Professi in quanto avevano professato i quattro voti religiosi. Chiesa, che tra l’altro, appartiene al loro convento più vasto e rilevante in Italia, dopo quella di Roma, la cui struttura, sin dalla fondazione era molto articolata ed inglobava un vasto perimetro urbano del quartiere dell’Albergheria, con due ampi cortili porticati e vari corpi edilizi aggiunti che accolsero, nei secoli, aree abitative e spazi sacri, cappelle ed oratori.
La chiesa sorge in un’area dell’Albergheria, che ha avuto una storia tanto lunga, quanto complicata: essendo ricca di grotte, in epoca punica, queste furono utilizzate come luoghi di culto, successivamente cristianizzati. Ai tempi di Balarm, la ricchezza d’acqua fu utilizzata per la realizzazione di balnea e addirittura di due Miqweh, i bagni rituali di purificazione della religione ebraica.
Come accennato in passato, Palermo era uno dei principali centro di vita ebraica di tutta Italia; la città, infatti, ha ospitato fin dal VI secolo una fervente comunità (Aljama), capace di fondersi con la cultura araba dominante e di assimilarne persino la lingua. Basti pensare infatti all’antica Sinagoga, lungo la via Calderai, denominata “Moschita” in continuità con il luogo di culto precedentemente islamico. Gli ebrei palermitani, stabilitisi prevalentemente nel quartiere della Giudecca, erano abili falegnami, argentieri, vasai e fabbri, tuttavia era nella lavorazione del corallo e della seta che si ponevano in una posizione di quasi monopolio, fino all’espulsione dalla Sicilia, avvenuta nel 1492, per volontà dei regnanti di Spagna Ferdinando d’Aragona ed Isabella di Castiglia.
Tra i luoghi frequentati dalla comunità ebraica del tempo possiamo dunque citare la sinagoga, poi sostituita dalla Chiesa di San Nicolò da Tolentino, l’ospedale, il macello o “kosher” (dove si presume fu realizzato per la prima volta il pane “ca meusa”), il cimitero, poi trasferito fuori le mura, e almeno due bagni rituali. Il primo era situato alle spalle della Sinagoga sotto il cortile di Palazzo Marchesi, attuale sede dei manoscritti rari della Biblioteca comunale di Palermo, in piazza Santi Quaranta Martiri al Casalotto. Questo nome, alquanto bizzarro, deriva da due componenti: quella dei Quaranta Martiri, alquanto scontata, deriva un gruppo di soldato cristiani, appartenenti ad una legione romana, che nel 320 d.C. furono condannati ed uccisi tramite immersione in uno stagno gelato presso Sebasta in Armenia.
Più strana è la denominazione di Casalotto, invece, proviene probabilmente dall’unione dei nomi “Guzet” e “Luzet”, ovvero le antiche denominazioni quartieri che si trovavano in questa zona, poi accorpati nel rione Il Capo in epoca araba. Qui vi era la porta la “Porta del Mercato dei Polli” del Kitab Ghara’ib, che in In un documento del 1310 è segnalata con un nome diverso, “Porta Bebilbacal, nei pressi della Chiesa di Santo Stefano”.
Il termine Bebilbacal deriverebbe da Ba’at al-buqul (Venditore di erbe o di legumi) toponimo ricordato nello stesso Kitab Ghara’ib.Dunque si potrebbe credere che, tra le antiche porte “del Mare” e “del Ferro”, in età araba veniva aperta una porta che non aveva nome, successivamente chiamata “Porta del Mercato dei Polli” e più tardi ancora “Porta del Venditore di Erbeo Legumi”. Questa parte della città, in piena età medievale, era la zona dei mercati alimentari di cui resta vivo il toponimo Via Lattarini, dall’arabo al-‘attarin (speziali, droghieri) e “Vucciria” dal francese boucherie (macello, macellai).
In quest’area, dicevo, sorge quel che resta del grande “hospicium magnum” edificato alla fine del XV secolo dal magnifico Antonio de Cusenza attraverso l’ampliamento di un più antico edificio preesistente. La famiglia Cusenza mantenne la proprietà del palazzo fino al 1518, anno in cui fu comprato all’asta da Salvatore Marchesi potente castellano del Palazzo Reale di Palermo da cui deriva il nome. Ma il palazzo rimase proprietà di questa famiglia per meno di mezzo secolo, infatti nel 1556 Bartolomeo Marchesi vende il palazzo alla corona di Spagna che lo concede al Tribunale della Santa Inquisizione che lo utilizzò coime carcare fino al 1558, prima di trasferirsi a Castello a Mare e poi allo Steri.
Carcere, quello dello Steri, che presentava diverse tipologie di celle, che venivano utilizzate a seconda degli scopi e delle pene che i detenuti dovevano scontare. Le celle più diffuse erano quelle cosiddette Pubbliche, in cui venivano tenuti i prigionieri colpevoli di reati morali, ad esempio i sospettati di bigamia, blasfemia, falsa testimonianza e sodomia. Qui venivano anche rinchiusi i progionieri politici, con le accuse di opposizione allo stato o all’Inquisizione. Tra queste vi erano le celle della Penitenza, dove i condannati potevano essere riabilitati tramite un percorso di rieducazione religiosa, prima di essere rimessi in libertà.
Poi vi erano delle celle particolarmente comode e dotate anche di qualche confort. Qui stavano i cosiddetti familiari, delle vere e proprie spie che agivano per conto della stessa inquisizione.Infine vi erano le segrete, umide ed oscure, situate nei sotterranei. Qui venivano reclusi i sospettati dei reati più gravi, tra cui le streghe, i bestemmiatori e gli eretici. Tra questi, i più pericolosi venivano tenuti in isolamento nelle cosiddette perpetue, in modo da non consentirgli di entrare in contatto con altri detenuti ed “indottrinarli al peccato”.
Il buon .Giuseppe Pitrè (1841-1916), famosissimo etnografo palermitano, fu colui che tra il 1906 e il 1907, dopo aver scavato per oltre sei mesi negli intonaci che avevano coperto tutte le possibili tracce, scoprì i Graffiti dello Steri. “Linee sovrapposte a linee, disegni a disegni davano l’idea di una gara di sfaccendati ed erano sfoghi di sofferenza”, scrisse nei suoi appunti durante la scoperta il Pitrè, che battezzò quelle incisioni a parete, “palinsesti del carcere”.
I ricercatori hanno stimato che il più antico dei graffiti, datato 1632, è a firma di Battista Gradu e Thomasi Rizzo, ambedue di Messina. Le scritte sono in siciliano, latino, inglese, arabo-giudaico. Il più drammatico ricorda l’incipit del Canto III di Dante all’ingresso dell’Inferno, “Nisciti di speranza vui ch’intrati”. Il più ironico recita così: “Allegramenti o carcerati, ch’ quannu chiovi a buona banna siti” (Rallegratevi o’ carcerati, perché quando pioverà sarete in un buon posto riparato). Molto interessante è il graffito del giovane pescatore Francesco Mannarino, rapito in mare e venduto ad un Ra’is, finendo come mozzo di una nave corsara. Durante i tre mesi di prigionia allo Steri, Mannarino incise magnificamente la battaglia di Lepanto del 1571, che ricostruì grazie ai racconti dei suoi compagni di navigazione. La maggior parte dei graffiti gronda dolore, rabbia, pentimento, devozione a Dio, alla Patrona di Palermo, La Santuzza, Santa Rosalia, e poi alla Madonna, ai tanti santi. Riportiamo fedelmente alcune delle scritte incise: “Poco patire, eterno godere, poco godere eterno patire”; “Maledetto è l’uomo iniquo e rio che confidasi in uomo e non in Dio”; “Pochi giungono al ciel, stretta è la via”; “Santa Rosalia che hai salvato Palermo dalla peste salva anche me”. Le incisioni raffigurano per lo più il Cristo, la Madonna, i santi, gli angeli e i diavoli, mappe della Sicilia e di Paesi conosciuti, date e simboli; sono tante e tutte straordinariamente impressionanti e molto belle.
Tornando a Palazzo Marchesi, per circa undici anni fino al 1569, l’edificio resta in stato di abbandono per poi passare per delibera regia ai padri Gesuiti di Casa Professa che l’avevano chiesto per ampliare il loro limitrofo complesso religioso da poco edificato. I Gesuiti vengono espulsi dal Regno di Sicilia nel 1769 e di conseguenza perdono la proprietà del complesso; i religiosi se ne riappropriano al loro rientro nel 1805. Infine con le soppressioni degli ordini religiosi attuate dalle autorità sabaude l’edificio nel 1879 viene incamerato dal demanio dello stato che vi colloca il Genio Civile e, in seguito il Genio Militare.
Il Palazzo, nonostante le trasformazioni, mantiene ancora tracce dell’originaria struttura gotico catalana, come ad esempio Rimangono il patio d’ingresso con un bel loggiato stilisticamente riconducibile all’architettura gotico-catalana e la magnifica torre merlata sulla quale nel 1731 venne innalzato il barocco campanile della nostra Casa Professa.
La torre, vivace testimonianza di arte gotico-fiammeggiante che certamente accresceva il carattere nobile del palazzo, presenta tre livelli segnati da sottili cornici marcapiano: nella parte basamentale si trova una piccola finestra di gusto rinascimentale con architrave decorato da una coppia di puttini alati che recano l’insegna araldica della famiglia Cusenza. Nel secondo ordine spicca la magnifica finestra trifora centrale riccamente decorata, realizzata da maestri lapicidi maiorchini che rappresenta un “unicum” nell’architettura palermitana del XV secolo, mentre il terzo livello è caratterizzato da una bifora con archivolto rettangolare a bilanciere. Il suo spazioso atrio interno, di chiara impronta catalana, simile a quello del coevo palazzo di Gaspare Bonet alla “Misericordia” (oggi Galleria di arte Moderna), conserva ancora oggi gran parte delle antiche arcate a sesto acuto sorretti da pilastri ottagonali, una finestra gotica, una bella cornice a piccoli archi inflessi e una elegante “escalera escubierta” a doppia rampa, elementi architettonici dell’originaria costruzione di particolare pregio. Dalla scala esterna, un tempo si raggiungeva direttamente il vestibolo dal quale, attraverso una ampia porta, si accedeva alla grande sala magna del piano nobile.
Nel cortile, si trovano due singolari ambienti sotterranei: il primo è stato identificato come una camera dello scirocco, per sopravvivere alle calde estati palermitane, l’altra il Miqweh, una camera ipogea di forma quadrangolare circondata da sedili anch’essi scavati nella roccia, con al centro una grande vasca. Secondo le Scritture, l’immersione in acqua era necessaria per riacquistare la purità rituale e dunque poter accedere al luogo di culto. Era consuetudine inoltre che le donne si immergessero totalmente dopo mestruazioni o parto, che fossero immerse nuove stoviglie e posate prima di consumare i pasti (sono stati infatti ritrovati frammenti di ceramica sul fondo della vasca), e che si accostassero al bagno anche coloro i quali dovevano essere convertiti.
L’acqua che alimentava la vasca (secondo i dettami del Tanakh l’acqua del Miqweh doveva essere assolutamente pura) proveniva dalla falda freatica formatasi per effetto delle infiltrazioni superficiali e del vicino Kemonia, sorgente che riempiva con le sue limpide acque anche l’altro enorme locale adiacente, utilizzato un tempo come cisterna che, certamente secoli fa, serviva ad assicurare il fabbisogno idrico della città in caso di emergenza. Il secondo bagno, con una struttura analoga a quello precedente, si trova proprio nel chiostro di Casa Professa ed è stato identificato da pochissimi anni.
La prima testimonianza di un uso religioso dell’area, risale al 884 d.C., in piena epoca islamica; ebbene, non riguarda la fondazione di una moschea, come sarebbe logico aspettarsi, ma di una chiesa cristiana. Nella bios di San Filippo di Argira, scritta dal monaco Eusebio scrisse
Un uomo molto ricco viveva a Palermo con tristezza poiché non aveva figli. Ma, avendo sentito parlare dei tantissimi miracoli compiuti dal Beato Filippo di Agira, ispirato in sogno, decise di andare a trovarlo, per pregarlo di intercedere affinchè Dio gli concedesse il sospirato figlio. Giunto con alcuni suoi servitori, vide da lontano San Filippo che siedeva dinanzi alla porta del tempio. Rivolto ai servitori disse: – Ecco l’ uomo che ho visto in sogno, che mi ha invitato ad incontrarlo. Se la vìsione che ho avuto è stata voluta da Dio, quel sant’uomo nel vederci ci chiamerà; ci dirà di entrare nel tempio per pregare il Signore; ci domanderà da quale città veniamo, e per quale motivazione siamo venuti-. Filippo, alzatosi, in quello stesso momento, disse al compagno Eusebio: -Chiama coloro che vengono a noi da lontano. -Eusebio li chiamò subito: – O pellegrini, il sacerdote Filippo per cui siete venuti vi chiama -. Quel ricco uomo, dopo avere pregato, e posto ai piedi del Santo i doni che gli aveva portato, gli disse: -Padre, tu sai lo scopo della mia venuta-. Il Santo di rimando a lui: -Lo so; ed io ti dico, ritorna a casa, poichè ciò che brami ti sarà concesso da Dio in premio della tua fede. Ritornato a Palermo il ricco signore trovò la moglie felice, che andandogli incontro disse: -Ho visto in sogno il Beato Filippo che mi diceva:-Il tuo sposo ritorna; sappi che concepirai e partorirai un figlio, che chiamerai Filippo-. L’uomo raccontò poi alla donna come il Santo sapesse già la ragione del suo viaggio, e lo avesse fatto chiamare dal monaco Eusebio. La moglie diede alla luce un bambino, e quel ricco signore gli pose nome Filippo. Il padre alla età di otto anni, lo portò ad Agira per presentarlo al santo sacerdote Filippo, e glielo offrì, dicendogli:-Ecco, o padre, il frutto delle tue preghiere-.
E San Filippo, prendendolo nelle sue mani, l’offrì nel tempio a Dio; lo benedisse, dicendogli poi:-Va, o flgliuolo, alla terra dove sei nato, innalza un tempio al Signore, e la benedizione di lui sarà sempre con te-. Di ritorno a Palermo Filippello, che aveva avuto in dono, come ricordo, una tunica, un asciugatoio e una fascia con cui il maestro si cingeva i fianchi, avendo incontrato un uomo, che giaceva quasi morto (si poteva dire quasi paralizzato), perchè morsicato da un serpente, sciolta la fascia, l’applicò a quel misero, dicendogli: -In nome di San Filippo sii guarito-. Quell’uomo si alzò pienamente risanato, senza alcuna traccia del male, e lodò il Signore. Filippo rimase grandemente meravigliato dell’accaduto, perché il Santo non guariva le malattie di persona, ma le sue vesti stesse (reliquie ex contactu) vincevano le malattie. Quando fu cresciuto, venne consacrato Diacono dal vescovo di questa città(Palermo). Esortato dal maestro a non attaccarsi ai beni terreni, all’oro ed allo argento il giovane gli ubbidì, e fece virtuosamente quanto gli era stato suggerito, distribuì ai poveri il ricco patrimonio che aveva. Dio operò per mezzo del giovane vari prodigi. Quando poi i Palermitani seppero che Filippo, ritornato in patria, aveva portato i vestiti del santo maestro, e che per mezzo di essi operava molti prodigi, si rallegrarono sommamente. San Filippello ad un monaco posseduto dal demonio disse di recarsi ad Agira per essere liberato da San Filippo, che operò il miracolo, nonostante il monaco fosse arrivato ad Agira quando il taumaturgo era già morto.
Ovviamente, come in tutte le bios i fatti sono leggendari: però, è indubbio, che all’epoca, fosse fondato, nel centro di Balarm, una chiesa e un convento di padri basiliani, a riprova che lo scandalo dei pii viaggiatori musulmani sulla strana vita religiosa cittadina erano in fondo motivato. Nel 1072, Roberto il Guiscardo e la moglie Sichelgaita, nel tentativo di ottenere il consenso degli abitanti di Balarm di lingua greca e religione ortodossa, restaurarono e ampliano il complesso basiliano di San Filippo, trasformandolo nella la badia di Santa Maria alla Grotta, sempre affidata ai basiliani.
Convento che, sotto la protezione degli Altavilla e delle loro corte, divenne tra i più ricchi e potenti della Sicilia. Nel 1128, Cristodulo Rozio, ammiraglio antiocheno al servizio di Ruggero II di Sicilia, gli donò tutti i suoi beni: nello stesso periodo, sappiamo che i balnea araba presenti nell’area furono trasformati in chiese dedicate ai Santi Cosma e Damiano, a San Michele de Indulcis, a San Leonardo de Indulcis e a san Pantaleo, tutte dipendenti dalla Badia.
Nel 1130, Ruggero II di Sicilia dona al monastero di Santa Maria della Grotta dell’Ordine basiliano di Marsala l’isola di Mozia comprendente la chiesa di San Pantaleo e le Saline. A questi possedimenti si aggiungono la chiesa di San Giovanni Battista al Boeo sul promontorio Lilibeo e la chiesa di Santa Croce. Fuori città la chiesa di San Michele Arcangelo (o Sant’Angelo) al Rinazzo presso il feudo Farchina, la chiesa di Santa Venera e un ampio giardino in località Eraclia, l’odierna Rakalia. Nel maggio dell’anno successivo, sempre Ruggero II, sancisce l’elevazione del monastero del Santissimo Salvatore ubicato sulla “lingua phari” di Messina a «mandra» o «Mater Monasteriorum» ossia guida di tutti i monasteri basiliani di Sicilia e di Calabria, compresa quindi la badia palermitana, alla quale furono dati uno sproposito di privilegi, confermati sia da Enrico VII, sia da Federico II.
I Gesuiti arrivano in Sicilia nell’anno 1547, a seguito del vicerè Don Juan de Vega che intuisce l’utilità di affiancarsi un nucleo di religiosi che in pochi anni hanno già dimostrato notevoli qualità organizzative e ottime capacità di aggregare consenso. Ma soprattutto è la viceregina Donna Eleonora Osorio amica di Ignazio che garantisce protezione e favori per i padri Gesuiti. Nel 1549 Ignazio di Loyola invia a Palermo Padre Diego Laynez, uno dei fondatori della Compagnia, per iniziarvi, assieme ad altri 12 Gesuiti, un collegio d’istruzione richiesto dal Vicerè e dal Senato cittadino. Già Messina, città in cui la compagnia per la prima volta assume la cura di istruire la gioventù, aveva ottenuto l’anno precedente un collegio che fu modello a tutti gli altri dell’isola. La prima sede dei Padri Gesuiti a Palermo, fu nelle case di Sigismondo Platamone presso la chiesetta di S. Maria della Misericordia nella piazza oggi detta di Sant’Anna e successivamente, nel 1550, si trasferirono nella casa del nobile Girolamo Xirotta, presso la chiesa di S. Antonio Abate.
Dopo tutto questo vagare, fu affidata loro proprio nel 1553 l’antica Abazia normanna di S. Maria della Grotta che, con la crisi dell’ordine basiliano, era caduta in progressivo abbandono. Essendosi rivelata troppo angusta la chiesa di S. Maria della Grotta, nel 1564, i padri Gesuiti iniziarono la fondazione della loro nuova chiesa, inglobando anche quella dei Santi Filippo e Giacomo. I lavori per la fabbrica del nuovo complesso ecclesiastico su disegno del Consiliarum ferrarese Giovanni Tristano, e sotto la direzione dei fratelli Gesuiti Francesco Costa e Alfio Vinci furono ultimati nel 1578. Le prime manomissioni della chiesa avvennero già nel 1591, quando, investendo capitali non indifferenti, si diede via ad una serie di lavori che portarono all’abbattimento dei muri divisori delle cappelle che trasformarono la chiesa da una a tre navate, su progetto redatto dal Gesuita messinese Padre Natale Masuccio. Ma un’altra significativa trasformazione dell’edificio religioso avvenne agli inizi del secolo successivo, quando si pensò ad ulteriori ingrandimenti della struttura per adeguarla alle esigenze di fasto e grandiosità tipiche dell’architettura gesuita. Sempre secondo un disegno del Masuccio i lavori furono realizzati soltanto dopo l’acquisto dei locali della Confraternita dei Santi Cosma e Damiano avvenuto nel 1606. Fra la seconda e la terza decade del XVII secolo sotto la direzione dell’architetto Padre Tommaso Blandino, la chiesa fu oggetto di altri importanti ampliamenti, specie nella zona del transetto e dell’abside che diedero al tempio gesuita l’attuale e definitivo aspetto. Il 16 di agosto del 1636 avvenne la solenne consacrazione della chiesa presieduta dal cardinale Giannettino Doria.
Nel 1767, viene teoricamente soppressa la Compagnia di Gesù, perchè in pratica, almeno a Palermo, i gesuiti continuano a occuparsi dell’insegnamento: però, la Casa professa è affidata al parroco dell’Albergaria, che esce scemo nel gestirlo. Per salvarlo, da quella incombenza, durante i restauri della cattedrale di Palermo del 1781, visto che Marvuglia non vuole nessuno tra i piedi, il Capitolo metropolitano e gli uffici parrocchiali sono trasferiti presso Casa Professa che in tale frangente assume il titolo e ricopre le funzioni di Concattedrale. Nel 1805 la Casa Professa viene restituita ai Gesuiti, che la terranno sino all’arrivo di Garibaldi, che li caccia a pedate da Palermo: nel 1866, con le leggi eversive, la chiesa diviene proprietà del demanio e nel 1892, il cavaliere Salvatore Di Pietro, rettore di Casa Professa, ottiene tramite il ministro della pubblica istruzione Paolo Boselli che il tempio sia dichiarato monumento nazionale.
Il 9 maggio 1943, la chiesa è vittima dei bombardamenti anglo americani, con una loro bomba che colpisce la cupola della chiesa causandone il crollo che danneggiò i manufatti interni adiacenti. Andò perduta gran parte delle pitture del presbiterio e del transetto. La cupola fu interamente ricostruita con tecniche moderne che prevedevano l’utilizzo del calcestruzzo armato realizzando una struttura a doppia calotta nervata, dissimulata dai rivestimenti esterni. Il progetto ed i calcoli strutturali vennero redatti dall’ing. Giovanni Crinò, con i restauri che terminarono nel 1956, quando fu concluso l’affresco della volta della navata centrale opera di Federico Spoltore e Guido Gregorietti.
December 10, 2021
L’Adorazione dei Magi di Giorgione

L’Adorazione dei Magi di Giorgione è un olio su tavola di dimensione molto ridotte, di cui purtroppo sappiamo ben poco e di cui ci piacerebbe conoscere molto, molto di più. Da documentazioni certe sappiamo che nel 1882 l’opera apparteneva alla collezione Miles a Leigh Court (Inghilterra), dove era inventariata con l’assegnazione a Giovanni Bellini: tuttavia quest’inventario non ci dice nulla né della provenienza, nè quando fu acquistata.
Nel 1884 fu acquistata dalla National Gallery di Londra come opera attribuita a Vincenzo Catena, che ricordiamolo, era il socio di Giorgione: assegnazione avanzata dal Morelli nel 1880 e accolta con favore da altri storici dell’arte come Lionello Venturi e Berenson. Solo più tardi il Cavalcaselle propose il riferimento al Giorgione, che fu condiviso da molti critici anche in confronto con un dipinto stilisticamente affine come la
Natività Allendale
Questo quadro ha una caratteristica molto particolare: la forma allungata indica come fosse uno scomparto della predella di una pala d’altare, anche se queste erano rare nell’arte veneta dell’epoca, mentre al contrario, erano comunissime nell’area emiliana. Un esempio è L’Adorazione dei Magi di Lorenzo Costa, conservata a Brera, che tra l’altro ha delle analogie formali con il quadro del Giorgione, cosa molto interessante, perchè è uno dei tanti indizi del fatto che i due si possano essere incontrati.
Ora, l’Adorazione di Costa era in origine la predella della pala d’altare di Francesco Francia con la Natività di Cristo con santi, che era stata commissionata da Antonio Galeazzo Bentivoglio per la chiesa di Santa Maria della Misericordia a Bologna: la pala e la predella arrivarono a Brera nel 1809, mentre la cimasa con Cristo risorto tra la Vergine annunciata e l’Angelo annunciante, pure del Costa, rimase nella chiesa. La pala fece poi ritorno a Bologna nel 1816.
Per cui, è sensato ipotizzare che un committente di origine emiliana possa avere commissionato a inizio Cinquecento a Giorgione una pala d’altare secondo l’impostazione centro italiana, che magari rappresentava una Natività o una Mandonna in trono, che questa possa poi essere stata smembrata e in parte perduta. Il problema è che né le testimonianze di archivio, ne i reseconti di Vasari e degli altri biografi dell’epoca ne accennano.
In ogni caso, Giorgione ebbe qualche problemino nell’adattarsi al formato della predella, tanto che nella sua realizzazione cambiò spesso idea: analisi a raggi infrarossi hanno infatti mostrato il disegno sottostante che venne spesso modificato in fase esecutiva. Sempre analizzando la predella, possiamo trarre altri indizi sulla presunta pala: i panneggi hanno un andamento ancora frastagliato, legato sia alla conoscenza di Bosch, sia a quella di Durer.
Ricordiamo come il tedesco, nel 1505, era a Venezia, dove si stava dedicando alla bella vita: comprò nuovi abiti eleganti, descritti nelle lettere, e frequentò personaggi colti, estimatori d’arte e musicisti, come un perfetto gentiluomo. Raccontò che talvolta era così ricercato dagli amici da doversi nascondere per trovare un po’ di pace: sicuramente la sua figura slanciata e dal portamento elegante non doveva passare inosservata
Suscitava anche antipatie, soprattutto nei colleghi italiani che, come egli stesso scrisse nelle sue lettere,
“imitano la mia opera nelle chiese dovunque sia loro possibile, poi la criticano e dicono che non è eseguita secondo la maniera antica, e per questo non andrebbe bene”
Giorgione, che non fosse tanto fissato sul recupero della Classicità, potrebbe non essere tra i criticati. fa il nome di due soli artisti locali: Jacopo de’ Barbari e Giovanni Bellini. Quest’ultimo, di età ormai avanzata, era ritenuto da Dürer ancora il migliore sulla piazza ed aveva ricevuto da lui benevolenza e stima, andando a trovarlo ed esprimendo addirittura il desiderio di acquistare qualche suo lavoro, disponibile anche a pagarlo bene; un’altra volta il Bellini aveva elogiato il tedesco pubblicamente
Jacopo de’ Barbari, che non era presente a Venezia e Durer aveva conosciuto in Germania, detto “Meister Jakob”, era il protetto dell’editore norimberghese residente a Venezia Anton Kolb; per lui realizzò l’immensa (1,315 x 2,818 metri, sei pannelli) e impressionante xilografia Veduta di Venezia del 1500. Quest’opera, estremamente precisa e dettagliata, è basata e trae le sue fonti dal lavoro di molti topografi. Fu considerata subito un’impresa spettacolare e provocò sin dall’inizio un enorme stupore.In una stampa successiva fu lievemente aggiornata da altri artisti, per tener conto della costruzione e modifica di grandi edifici della città. La matrice xilografica originale è tuttora conservata ed esposta presso il Museo Correr di Venezia.
Perchè Durer cita Barbari, visto che non l’aveva incontrato nella Serenissima ? Perchè tempo prima il veneziano gli aveva dato ripetizioni sulle proporzioni umane, e il tedesco fu decisamente affascinato da quello che gli raccontò, nonostante l’impressione che egli non avesse rivelato tutte le conoscenze in suo possesso:
«…Non ho trovato nessuno che abbia scritto qualcosa sui canoni delle proporzioni umane, eccetto un uomo chiamato Jacob, nato a Venezia e pittore affascinante. Mi mostrò le figure di un uomo e una donna, che realizzò in base a dei canoni matematici di proporzione, così ebbi modo di vedere ciò che intendeva, anche se egli non volle mostrarmi completamente i suoi principi, come intesi chiaramente.»
Ora, che Giorgione e Durer si fossero incrociati ne abbiamo evidenza in diversi quadri: nella Festa del Rosario, il tedesco cita, nel paesaggio, sia le opere di Bellini, sia quelle di Giorgione. Viceversa, nei ritratti successivi di Giorgione ci saranno tanti riferimenti all’opera di Durer. Per cui, per queste attinenze stilistiche, la presunta pala a cui apparteneva come predella l’Adorazione dei Re Magi, deve essere stata dipinta tra il 1505 e il 1506.
Alcuni dettagli della predella, come il paggio all’estrema sinistra, furono poi riprodotti da numerosi artisti dell’epoca, cosa che ci fa pensare come, almeno sino al 1530, questa pala doveva essere ben nota e visibile e probabilmente posta a decorare l’altare di qualche chiesa veneziana.
Tra l’altro, il committente doveva avere una religiosità di tipo tradizionale, abbastanza lontana dai dettami della Devotio Moderna. Seguendo l’impostazione della predella di Costa dall’analogo soggetto, Giorgione suddivide la scena in due parti, partizione sottolineata dalla presenza di muro di mattoni :a sinistra, la Sacra Famiglia è avvolta da una quieta penombra, tranquillamente seduta con l’asino e il bue, in una forma semplice, ma tanto più maestosa nella sua solidità con le ampie pieghe dei voluminosi panneggi che fiammeggiano nella tiepida ombra.
Maria, avvolta in un manto azzurro e seduta su una roccia offre Gesù Bambino all’adorazione dei Magi, mentre San Giuseppe, seduto al suo fianco e con indosso un inconsueto mantello giallo-oro tiene in mano uno dei doni dei magi. Il colore, che era le virtù spirituali, è ritenuto simbolo di fede, clemenza, temperanza, carità e giustizia, assieme al blu della tunica, potrebbe essere un’indicazione dei colori araldici del committente. La capanna è posta fra i pilastri di sostegno di un edificio in rovina, simbolo della prossima caduta del Paganesimo.
A destra, i Magi, in in ginocchio indossano splendide vesti, portando i doni in preziose pissidi, che rispecchiano pienamente la simbologia tradizionale, delle tre età dell’uomo e delle tre parti del mondo allora conosciuto (Europa, Asia e Africa), a significare così l’universalità del messaggio di Cristo, che si manifesta a tutti perché nato per salvare l’umanità intera e l’omaggio di tutto il genere umano al Figlio di Dio. Il loro corteo, come nella predella di Costa, disposto in maniera tradizionale, procede orizzontalmente verso la capanna. Vi fanno parte paggi dagli sgargianti costumi, è in piena luce, ad una reverente distanza accentuata dalle verticali di piatti mattoni nel mezzo, la carovana reale, mondana e inquieta nella varietà dei colori; i palafrenieri all’estremità stanno, spensierati, presso i loro cavalli, nel pieno della luce meridiana. Il blu e il giallo oro dei loro abiti, che richiama i colori di quelli della Sacra Famiglia, permette a Giorgione di costruire l’unità visiva dell’intera predella, la cui spazialità non è costruita dalla geometria, ma dal contrappunto e dalla sintesi dei colori, la cui stesura, ora netta e corposa, ora indefinita e sfumata, che dimostra la straordinaria libertà espressiva dell’artista.
December 9, 2021
Ventura di Moro

Come accennato parlando dello Starnina, nonostante qualche recente mostra, il Gotico internazionale è sempre visto, in un’ottica vasariana, come il parente povero dell’arte fiorentina di fine Trecento e Inizio Quattrocento. Basti pensare come ne parla Bellosi in un suo saggio
Del gotico internazionale restano in Lorenzo Monaco lo scheletro e la sigla, l’onda lancinante di un ritmo, il filo teso e acuminato della linea; perfino la gamma cromatica, depurata e come sterilizzata, sembra celare un intento di acerba castità. Ma il gotico estremo di Toscana non si esaurisce nella sottile nevrastenia calligrafica del pittore camaldolese; la sua voce più alta è rappresentata anzi dall’attività di Masolino da Panicale fra il terzo e il quarto decennio del Quattrocento, anche se non si può chiamarla esclusivamente gotica (perché implicata nella vicenda di Masaccio), né esclusivamente toscana (perché svoltasi per la maggior parte oltre i confini della regione natia). E prima, contemporaneamente e dopo questi due artisti, si ha una rigogliosa fioritura di‘piccoli maestri’, talora anonimi, ma le cui capacità espressive sono spesso più che ragguardevoli.
In realtà la situazione è assai più complessa: i pittori del Gotico Internazionale, si percepivano e venivano percepiti, rispetto alla tradizione giottesca locale, altrettanto di rottura e di avanguardia. Inoltre, il Gotico Internazionale fiorentino, rispetto a quello delle corti del Nord e del Sud Italia, avevano sviluppato un linguaggio alternativo, legato alle specifiche condizioni locali: una committenza borghese, piuttosto che nobiliare, un ambito di fruizione e di comunicazione più pubblico che privato, un dialogo serrato con i modelli classici.
In più, i pittori fiorentini e in generale toscani sono tutt’altro che provinciali e isolati nel contesto artistico dell’epoca: Taddeo di Bartolo andò più volte a Nord, per dialogare con le esperienze liguri, milanesi e piemontesi, Gherardo Starnina a Valencia si aggiornò sulle novità spagnole, provenzali e borgognone, Agnolo Gaddi studiò l’arte bolognese e marchigiana dei suoi tempi. Lo stesso deve aver fatto Parri Spinelli, figlio di Spinello Aretino, che sia per le figure slanciate, sia per quanto testimoniato da Vasari, che afferma come fosse il primo pittore ad abbandonare l’utilizzo del verdaccio sotto gli incarnati, poi “velati” con successivi strati di colore rosato, tecnica in uso in tutto il Trecento italiano, può avere avuto anche contatti con l’arte d’Oltralpe.
Spinello, detto fra noi, che oltre a girare come una trottola per le città toscane, è forse troppo sottovalutato: uscito da un ambiente che non era proprio il massimo dell’avanguardia artistica dell’epoca, Arezzo, si mise a studiare sia la pittura, sia la scultura del Primo Trecento, per giungere a una pittura forte concezione dello spazio, all’interno del quale si articolano figure di solidità concretezza, sia una narrazione di vivace umanità. Pittura che, in fondo, è uno dei punti di partenza proprio del Gotico Internazionale toscano.
Uno dei cosiddetti maestri minori, che però influenzavano il gusto dell’uomo della strada, contribuendo alla nascita di una sensibilità comune, Ventura di Moro. Un tempo, era identificato con il Pseudo Ambrogio di Baldese, viste le somiglianze dei quadri della sua prima fase, per le figure dalle masse dilatate, con quelli del collega, il che fa pensare che avessero una formazione comune, probabilmente nella bottega di Mariotto di Nardo, che era il nipote di Andrea Orcagna, che all’epoca era una star: oltre a operare in ambito locale, aveva ricevuto commissioni dalla Corsica, da Genova e dalla Francia e il governo fiorentino lo aveva messo a disposizione di Pandolfo Malatesta, signore di Pesaro.
Inoltre, parte del suo catalogo era attribuito al collega Lippo d’Andrea, neppure lui così scarso, dato che assieme ad altri ottimi professionisti, come Bicci di Lorenzo, con cui forse studiò Masaccio, Giovanni dal Ponte e Rossello di Jacopo Franchi, tutti esponenti del Gotico Internazionale locale, a cui fu affidato il compito di dipingere affreschi degli apostoli nelle cappelle delle tribune della cattedrale di Firenze per celebrare la consacrazione della cupola di recente costruzione da parte di papa Eugenio IV.
Ventura è stato però identificato da Enzo Carli nel 1972 attraverso la lettura del nome del pittore sul manto della piccola Madonna con Bambino proveniente dal convento di Santa Maria Maddalena di Siena ed ora nella locale Pinacoteca Nazionale. Tutte le opere, numerosissime, attribuite allo Pseudo Ambrogio sono state così travasate entro il nuovo contenitore di Ventura di Moro.
Ventura di Moro è un artista ampiamente documentato dalle fonti: nel 1416 è iscritto alla Compagnia di San Luca: questa fondata nel 1339, era un’associazione di pittori fiorentini, che fungeva sia Confraternita, a scopi religiosi e devozionali, sia da associazione di categoria. ra intitolata a San Luca evangelista cui tradizionalmente si attribuisce la qualità di aver per primo ritratto la Vergine. Tale compagnia non aveva un luogo fisso di riunione anche se andò spesso radunandosi in spazi (tra cui almeno due diverse cappelle) messi a disposizione dell’ospedale di Santa Maria Nuova all’interno delle sue proprietà. Questa accolita di persone, di cui sopravvivono alcuni registri all’Archivio di Stato di Firenze, andò via via spegnendosi nel fervore e nella partecipazione.
Nel 1419, Ventura aderisce all’Arte dei Medici e Speziali, mentre intorno al 1427 aveva bottega in corso degli Adimari, dove adottava il modello di Raggruppamento di Impresa, introdotto da Starnina, composta da lui, Giuliano di Jacopo e, in posizione subordinata, da Marco di Filippo. Tale compagnia avrà vita lunga e articolata: nel 1442, scioltosi dal vincolo Marco di Filippo, vi entra, seppur ancora in qualità di aiuto, anche il giovane Jacopo di Antonio, nipote di Giuliano. Ma il fresco talento di Jacopo, decisamente orientato verso Pesellino, si spegne improvvisamente nel 1454, portando alla lenta ma inesorabile rovina finanziaria della compagnia che tuttavia sopravvivere sino la morte di Giuliano avvenuta nel 1460. Nel 1472 Ventura di Moro è troppo vecchio per esercitare la professione, rilevata da Bartolomeo, uno dei figli di Giuliano, che muore però nel 1480.
Nessuna delle opere menzionate dalle fonti come eseguite da Ventura di Moro si è apparentemente conservata, fatta eccezione per due Storie di San Pietro martire affrescate sulle facciate esterne dell’Oratorio fiorentino del Bigallo, eseguite nel 1446 in collaborazione con Rossello di Jacopo Franchi e con il fratello di quest’ultimo, Giunta, ora in cattive condizioni di conservazione, oltreché staccate. In uno, infatti, si riconoscono solo alcune bandiere.
Su quello meglio conservato si vede ancora chiaramente il santo che predica alla folla mentre un cavallo nero appare all’orizzonte. Si tratta di un fatto miracoloso citato in tutte le agiografie del martire: mentre egli stava predicando, secondo alcune fonti in questa piazza, secondo altre nella Piazza delle Cipolle, dove si teneva il mercato alimentare (attuale Piazza Strozzi), apparve all’improvviso dal niente un cavallo nero imbizzarrito, che si lanciò sulla folla disperdendola. Ma la presenza di spirito del santo riuscì a riconoscere in quell’apparizione una manifestazione del Demonio, riuscendo a cacciarlo con il solo segno della croce. Il cavallo si dileguò nel nulla come era apparso.
Decisiva è stata l’identificazione di alcuni affreschi, per i quali Ventura di Moro risulta pagato nel 1427, ora staccati, provenienti da San Jacopo in Campo Corbellini, con Angeli oranti e un Cristo passo, pertinenti ad un tabernacolo scolpito da Giusto da Settignano. Il confronto con la tavoletta senese prova che si tratta di opere uscite da una medesima, attardata frammistione di elementi arcaicizzanti e tardogotici con altri più aggiornati, soprattutto in senso plastico, e ha consentito la recente ricostruzione di un più verosimile catalogo di opere di Ventura di Moro, comprendente una Madonna in trono e due angeli in San Leolino a Panzano in Chianti e la Madonna dell’Umiltà del Museo Civico di Pescia, entrambe databili agli anni ’30. In ordine cronologico dovrebbe seguire il trittico con la Madonna tra San Clemente e San Bartolomeo proveniente da San Michele a Padule, ora nel Vescovado di Colle di Val d’Elsa.
Una testimonianza dello stile di Ventura in questo periodo è data dalla Madonna con Bambino della collezione Costner, commissionata da un ricco borghese fiorentino, che appare come donatore, riconoscibile per i ricchi abiti, per celebrare il noviziato del figlio cadetto, probabilmente di nome Antonio, visto che il Santo presenta il donatore alla Vergine, presso i benedettini. Nel dipingere quest’opera, da una parte Ventura guarda alla tradizione locale trecentesca, nella posizione giottesca della Madonna e del Bambino e nel loro trono, che richiama come modello aulico il tabernacolo dell’Orcagna a Orsanmichele. Dall’altra, vi una narrazione cordiale e popolaresca, nella rappresentazione delle figure, che grazie al fondo oro, si pone oltre il tempo, al di là dei limiti della vita, come a proporsi ad esempio della Pietà Cristiana.
Negli anni successivi, Ventura è influenzato dallo stile del Maestro del 1419, probabilmente Battista di Biagio Sanguigni, miniatore e pittore fiorentino, allievo di Lorenzo Monaco e maestro del Beato Angelico, sviluppando una maggiore eleganza e leggerezza delle figure. Nella fase finale della sua attività, invece sarà influenzato da Masolino, approfondendo l’interesse per la tridimensionalità delle immagini, ottenuta più per via di scorci e bilanciamenti compositivi che per architetture o volumetrie comprese in pieno, unita a ricercatezze nelle cromie in alcuni dettagli
December 8, 2021
La basilica neopitagorica di Porta Maggiore
La mattina del 23 aprile 1917 ai vertici delle Ferrovie va di traverso la colazione: in seguito a un cedimento del terreno, all’altezza di Porta Maggiore, la linea Roma-Cassino è interrotta: il primo pensiero, siamo durante la guerra, va un sabotaggio austro ungarico. Arriva di fretta in furia una commissione del Genio, per ripristinare la ferrovia e scoprire le tracce di qualche bomba nemica: fortuna, non è nulla di tutto ciò. Per conoscere la causa del cedimento le Ferrovie eseguono uno scavo rinvenendo a 3 m di profondità un pozzetto circolare di 90 cm di diametro costruito sopra la volta di una galleria.
Per capire cosa diavolo sia, si infilano delle sonde, che permettono di scoprire una profondissima cavità del terreno, un’aula interrata per un terzo della sua altezza. Potete immaginare l’espressione perplessa del Genio: per cui, per venire a capo del mistero, si decide di scavere un pozzo accanto ai binari attraverso per asportare la terra, in modo che si possa esplorare la sala sotterranea. Così. a ben 13,34 m sotto il livello della ferrovia, è scoperta la nostra cosiddetta Basilica Neopitagorica.
Così viene alla luce questo che è uno degli esempi più singolari e interessanti di edificio romano, sia pure di modeste dimensioni (m 12 di lunghezza per m 9 di larghezza). Lo schema è lo stesso che si ritroverà poi nelle basiliche cristiane a partire dall’età costantiniana (IV secolo d.C.): tre navate, con la centrale più grande e terminante in un’abside. L’unica differenza è che, trattandosi di un edificio sotterraneo (il pavimento è a 7,25 metri sotto il piano della via Prenestina), la luce arrivava attraverso un lucernario praticato nel vestibolo. Vi si accedeva in origine da un lungo andito discendente che si apriva in un luogo appartato, appena fuori delle mura.
Una volta liberata la basilica, per renderla acessibile si provvede a scavare un ingresso a livello della strada sottostante e fabbricare una lunga e comoda scala ellicoidale che raggiungesse il vestibolo della basilica, completamente interrato al momento della scoperta. Anche se siamo nel pieno della Grande Guerra, a Roma ci si rende subito conto che si trattava di una scoperta archeologica sensazionale, non solo dal punto di vista artistico, ma anche per la storia delle religioni. La basilica, infatti, conserva il complesso più ricco di stucchi decorativi che il mondo romano ci abbia finora tramandato. Essi si rifanno ad alcuni motivi fondamentali della mitologia greca che dovevano avere, quasi sicuramente, un preciso significato simbolico.
Francesco Fornari, già nel 1918, avanzò l’ipotesi che l’edificio fosse adibito al culto di qualche religione iniziatica legata al mondo ctonio, visto che la decorazione a stucchi, faceva intendere un legame con la trasmigrazione dell’anima. Nel 1923 lo studioso francese Jérôme Carcopino arrivò alla conclusione che la basilica dovesse appartenere a una setta neopitagorica. Per un caso fortunato, egli si era imbattuto in un passo di Plinio il Vecchio (Storia Naturale, XXII, 20) in cui si parla dell’erba, chiamata centocapi (centum capita), la cui radice aveva la prodigiosa proprietà di rendere irresistibile per l’altro sesso la persona che l’avesse trovata e raccolta. Cosa che accadde a Faone di Lesbo, di cui si innamorò perdutamente la poetessa Saffo, che, non venendo corrisposta, si suicidò gettandosi dalla rupe di Leucade. Aggiunge Plinio che a questa storia “credono non solo quelli che si interessano di magia, ma anche i Pitagorici”. Il fatto che la raffigurazione della morte di Saffo occupa una posizione importante tra le decorazioni della basilica, situata com’è nella parte superiore dell’abside, ha fatto pensare a Carcopino che il luogo avesse a che fare con la dottrina di Pitagora. Nel 1924 i gravi problemi di umidità portarono alla decisione di realizzare una cappa impermeabile di argilla plastica, che purtroppo non eliminò il problema. Nel 1951 il monumento fu incapsulato all’interno di una struttura in cemento armato, con un’intercapedine realizzata nel solettone di copertura.
Cominciamo la nostra visita virtuale: il corridoio di accesso è in piano nel breve tratto terminale dopo l’angolo, ed è a rampa con una inclinazione del 15% nel tratto lungo costruito a fianco di una parete della basilica; venne esplorato per di 25 m svuotando un cunicolo della terra che lo ostruiva ma ci si arrestò perchè la volta e le mura di sostegno erano franate; a 20,50 m dal primo pozzo si scoprì un secondo pozzo verticale; i pozzetti erano utilizzati per l’aerazione e per illuminare il corridoio. L’entrata originaria non è stata pertanto mai scoperta.
La volta si trova al di sotto del piano stradale della antica via Praenestina per cui il tempio era sotterraneo già all’epoca. La basilica è orientata da Ovest verso Est e risulta costruita scavando nel tufo profonde trincee dove venne inserita una colata di calcestruzzo in schegge di selce per le poderose mura portanti e i grandi pilastri. Le cèntine per gli archi dei pilastri vennero poggiate direttamente sul terreno; poi venne costruita la volta e infine venne portata fuori attraverso il lucernario la terra rimasta all’interno; per la particolare modalità di costruzione i pilastri sono leggermente sbilenchi e le mura non a piombo.
Il vestibolo ha un grande lucernario rettangolare sulla volta coperto da un muro di 60 cm in opus reticulatum fatto ad arte che doveva fungere da parapetto del foro per la luce; naturalmente il lucernario è stato richiuso con voltine in mattoni per evitare altri cedimenti. Il vestibolo, a pianta più o meno quadrata, misura 3,62 x 3,50 m; il pavimento è inclinato verso il centro dove è un pozzetto di cm 88 x 53 e profondo m 2,55 in fondo al quale, su uno dei lati, è scavato un cunicolo molto inclinato di circa 9 m che termina in una vasca; il tutto scavato nel cappellaccio e per drenare le acque piovane che potevano penetrare dal lucernario.
Il pavimento musivo a tessere bianche ha una doppia fascia di tessere nere lungo tutto il perimetro ed anche il pozzetto è circondato dalla doppia fascia nera con delle palmette ai quattro angoli. Le pareti sono decorate con bassorilievi di stucchi figurativi con uno zoccolo ed una fascia sotto la volta di colore rosso; la volta a riquadri alterna bassorilievi in stucco e affreschi. La qualità di entrambi è raffinatissima. Il vestibolo presenta due aperture arcuate: quella a nord, larga 140 cm, comunica con la galleria di ingresso mentre quella ad est, di 149 cm, conduce alla sala.
La sala vera e propria, a tre navate a volta, misura 12 x 9 m (quindi piuttosto vasta, di 108 mq) e 7 m di altezza. La navata centrale, larga 3 m, termina in un abside semicircolare; ognuna delle due navate laterali, larga 2 m, è separata dalla navata centrale da tre grossi pilastri di cm 95 per 125 che innalzano 4 archi a sesto ribassato. Dalla parte della navata centrale i pilastri hanno una riquadratura in stucco per alloggiare lastre di marmi tenute da grappe metalliche, già rimosse all’epoca; sotto ogni riquadro, sul pavimento a ridosso delle colonne, resti di muretti di 35 cm di spessore che dovevano servire come mensole per gli oggetti di culto. I pilastri dal lato opposto sono ornati da bassorilievi con ritratti di figure maschili e femminili, di cui ne rimangono solo tre.
Il pavimento è a tessere bianche con una doppia fascia nera a perimetro e a circondare i pilastri, con altri riquadri di doppie fasce nere nello spazio tra i pilastri e all’interno della navata centrale. Sul fondo della navata centrale si apre l’abside semicircolare con raggio di 155 cm; nel mezzo era disposta una cathedra, di cui si scorgono i resti del collegamento al muro; il pavimento ha una fossa fin sotto le fondazioni dove sono stati rinvenuti gli scheletri di un cane e di un maiale, evidentemente un sacrificio rituale. La basilica era illuminata da un pertugio sopra l’ingresso nel muro di separazione tra Basilica e Vestibolo, che consentiva alla luce del lucernario del pronao di penetrare nella sala; sotto gli archi tra i pilastri erano poste le lampade tramite fasce di metallo, di cui restano alcune tracce, illuminare le navate laterali.
Le pareti e le volte dell’intero edificio sono ancora intonacate e ricche di magnifiche decorazioni a stucco. Gli stucchi che ricoprono le volte della navata centrale rappresentano simboli misterici e scene tratte dalla mitologia greca: Medea che offre una bevanda al drago che custodisce il vello d’oro, Ercole e Atena, Paride ed Elena, uno dei Dioscuri che rapisce Leucippide, Oreste e Elettra, Ercole che lotta con un mostro marino, il centauro Chitone e Achille, un Arimaspe con un grifone. Nel riquadro centrale della volta il ratto di Ganimede da parte di un genio alato. Le navate laterali pullulano di simboli: teste di Medusa, baccanti, Danaidi, vittorie in volo, maschere gorgoniche, scene di sacrifici e liturgiche, gruppi sacri, i segni zodiacali del Toro e dei Gemelli, oggetti rituali, baccanti, eroti in corsa, il culto del serpente, Nereidi, oltre a Oreste e Polissena, Hermes e Alcesti, la danza di Agave, Apollo e Marsia, Fedra e Ippolito, il filo d’Arianna e altri ancora.
La scena della Morte di Saffo, la cui leggenda è stata pure cantata da Ovidio nelle Eroidi, doveva presumibilmente avere a Roma un ruolo significativo nell’iniziazione alla dottrina neopitagorica. brezza marina; ha in mano una cetra e sembra che stia per tuffarsi nel mare sottostante, la cui decorazione in blu nel tempo è stata purtroppo asportata. Un Erote la spinge, mentre al di sotto un Tritone stende un drappo per riceverla. Assistono alla scena sulla sinistra un giovane pensoso, da identificare forse con Faone, e Apollo, dio della poesia. L’episodio sembra apparentemente in contrasto con l’etica pitagorica che non consente all’uomo di porre fine alla propria vita. Ma la morte della poetessa può essere interpretata come un rito che lei affronta con grande fede: il salto nel mare è un simbolo di rinnovamento, e in questo senso lo si ritrova in altri racconti mitologici. Del resto anche la celebre “Tomba del tuffatore” di Paestum è stata interpretata in chiave pitagorica. Saffo non esprime il dramma di chi si dà la morte volontariamente, ma è, secondo Carcopino, “il classico esempio di una rigenerazione sacramentale e morale che trasforma gli iniziati”.
Molto importante doveva essere anche lo stucco con il Ratto di Ganimede. Secondo il mito, Ganimede era un fanciullo che, a causa della sua bellezza, fu rapito in cielo dall’aquila di Zeus per fare da coppiere agli dèi. In questo modo egli, che era nato mortale, raggiunse l’immortalità. Il fatto che questa raffigurazione sia al centro della volta della navata principale non è certo un caso; essa doveva sintetizzare il significato di tutte le altre rappresentazioni, l’aspirazione a Dio di ogni seguace di Pitagora.
Un altro rapimento è raffigurato nella stessa volta, nel primo quadro partendo dall’ingresso. Si tratta di un Dioscuro che rapisce una Leucippide nel giorno delle nozze. La fanciulla, il cui corpo è tenuto quasi orizzontalmente disteso, si dibatte disperatamente agitando le braccia. Le Leucippidi erano le due figlie di Leucippo, Febe e Ilaria, che erano state promesse in spose ai loro cugini, i gemelli Idas e Linceo. Ma i Dioscuri le rapirono provocando un feroce combattimento con i due gemelli loro rivali. Nella violenza del ratto è da vedere per la fanciulla un cambiamento di stato, la perdita della verginità e la trasformazione in donna.
Nel vicino sepolcreto degli Statili, dove sono stati sepolti gli artigiani (servi e liberti) che lavorarono per la ricca famiglia, è stata rinvenuta anche un’iscrizione marmorea con il nome di Secundus Tarianus, che viene definito tector (nell’iscrizione si legge tetor), ovvero decoratore. Anna De Santis, direttrice del monumento, pensa che possa essere stato lui a decorare con gli stucchi la basilica ipogea, insieme ad altri, perché si distinguono più mani di artisti. Da notare che nel sepolcreto venne rinvenuta un’urna in marmo greco, oggi al Museo delle Terme, con raffigurazioni dei Misteri di Eleusi e che un servo della famiglia aveva nome Mystes (iniziato ai misteri).
Infatti, è stato ipotizzato immediatamente dopo la scoperta che la basilica appartenesse ai proprietari del terreno, che con tutta la probabilità erano gli Statili, l’importante gens che si era affermata a Roma al tempo di Augusto con Tito Statilio Tauro, console nel 26 a.C., morto presumibilmente intorno al 10 a.C. Le fonti tramandano anche il ricordo di altri membri della famiglia e in particolare i fratelli Tito Statilio Tauro, console nel 44 d.C., e Tito Statilio Tauro Corvino, console nel 45 d.C. Quest’ultimo avrebbe organizzato una congiura ai danni dell’imperatore Claudio e non si sa che fine fece (forse venne giustiziato), mentre l’altro, Tito Statilio Tauro, venne denunciato per empietà e superstitiones (pratiche magiche) e coinvolto nel 53 d.C. in un processo diffamatorio che lo spinse al suicidio. Mandante dell’accusa, tramite Tarquizio Prisco, che era stato suo legato in Africa, fu Agrippina (madre di Nerone e moglie di Claudio), che era interessata alla confisca dei terreni dei ricchi Statili. Si è pensato che fosse proprio questo personaggio, vicino agli ambienti del neopitagorismo romano, ad aver fatto costruire l’ipogeo di Porta Maggiore, che venne immediatamente abbandonato, dopo il 53, perché le pratiche che vi si svolgevano erano ormai considerate fuorilegge.
A testimonianza della testimonianza della destinazione di tale luogo, vi anche il predominio del bianco sulle pareti, colore distintivo dei pitagorici e, in quanto leukòs, cioè luce, gradazione simbolica dell’apollineo. Lo spazio è inoltre ritmato secondo le proporzioni armoniche del numero aureo e della tetraktys pitagorica e sembra concepito per accogliere un numero di 28 accoliti, perché questa cifra ritenuta perfetta cioè compiuta è la somma dei numeri da 1 a 7, dall’unità divina dunque sino a questo numero, il sette, sacralizzato dall’esoterismo cabalistico.
Quindi il mistero è chiarito? Mica tanto, per un paio di incongruenze. Il primo è che i recenti studi datano la Basilica all’età augustea, ben prima di Statilio Tauro e della diffusione del Neopitagorismo a Roma; in più, la decorazione a cui possibile dare un’interpretazione misterica è, oggettivamente una minoranza rispetto alla globalità e di fatto è riconducibile ai motivi decorativi che andavano di moda in quel periodo. In più, c’è una questione culturale, su cui gli archeologici contemporanei, glissano.
L’archeologia romana di quel periodo è fortemente condizionata, a livello intellettuale, dal neopaganesimo di Boni e dall’ermetismo teosofico di Giuliano Kremmerz, all’anagrafe Ciro Formisano, che portava a interpretare i ritrovamenti archeologici in chiave mistica, anche quando questa non c’entrava nulla. Di questo, ne era consapevole Bendinelli, che provò, per andare oltre questa sovrastruttura ideologica, a elaborare un’interpretazione alternativa: come accennato, l’area di Porta Maggiore, nell’epoca Giulio Claudia, ha una forte destinazione funeraria, con numerosi sepolcri e colombari… Per cui ha ipotizzato come fosse un mausoleo monumentale. Il problema è che mancano celle tombali, di loculi o altri dettagli di architettura sepolcrale.
In ambito anglosassone e francese, meno conservatori e più propensi ad applicare il rasoio di Ockam rispetto ai nostri archeologi, hanno provato a formulare un ulteriore ipotesi: ora, sappiamo che la forma basilicale all’epoca, non aveva un valore religioso, ma in ambito privato, era destinata alla sale di banchetto e alle sale delle udienza. Inoltre, negli horti dell’Esquilino, esiste un ambiente sotterraneo, decorato però con affreschi, che svolgeva il ruolo di triclinio estivo, il nostro auditorium di Mecenate. Per cui, non è da escludere che la basilica svolgesse la stessa funzione per gli Horti Tauriani e la sua decorazione, invece che avere strane implicazioni misticheggianti, semplicemente richiamava le opere letterarie dell’epoca augustea, da Virgilio a Ovidio. In quest’ottica, è molto interessante del professore belga Hans van Kasteel, che ha pubblicato in francese sulla questione : “Le Temple de Virgile” (Éditions Beya 2016). Secondo questo lavoro, la decorazione della basilica sotterranea non sarebbe nient’altro che un commentario, versetto per versetto, di Virgilio stesso a testimonianza del livello culturale e degli interessi della committenza. Triclinio che fu abbandonato proprio a seguito della Damnatio Memoriae…
December 7, 2021
Athanasius Kircher

Oggi, parliamo di un personaggio della Roma Barocca, dal fascino straordinario, grande erudito, uomo di una curiosità infinità e ahimè, alquanto eccentrico: si tratta di Athanasius Kircher, che meriterebbe di essere il protagonista di centinaia di romanzi clockpunk per la sua straordinaria vita.
Il nostro eroe nasce il 2 maggio 1602 a Geisa (Turingia), in Germania, ultimo di nove figli. Suo padre, Johannes Kircher di Magonza, aveva studiato la filosofia e la teologia, ma avendo perso la testa per la mamma di Athanasius, convinto che fosse meglio per la collettività un buon impiegato che un pessimo prete, non aveva preso i voti, ma si era messo al servizio come capo cancelliere, responsabile della gestione dei tribunali e della raccolta delle tasse, del principe-abate Baldassare di Fulda. Per chi non lo sapesse, il Principe-abate (in tedesco: Fürstabt) è una delle tante stranezze istituzionali del Sacro Romano Impero: titolo riservato ad un chierico che è anche principe nella Germania Medievale, Rinascimentale e Barocca o ovvero ex officio ricopre l’incarico di signore temporale di un’entità feudale. Il territorio governato da un principe-abate è solitamente definito come “principato abbaziale” o “abbazia principesca” (abbazia imperiale). Chi detiene questo titolo ad ogni modo non ha il titolo di vescovo.
A titolo di curiosità, in teoria anche noi a Roma abbiamo un principe abate: si tratta dell’abate di San Paolo fuori le Mura, con diploma di Carlo IV risalente al 21 marzo 1369. Scherzando, dato che questo decreto non è mai stato abrogato e il relativo, assai ipotetico, stato ecclesiastico non è mai stato incamerato né dal Papa Re, ne dall’Italia, per il semplice motivo che nessuno si è giustamente mai posto il problema, quei benedettini potrebbero proclamare teoricamente dichiarare la secessione e l’indipendenza di Ostiense e Garbatella…
Ora a Fulda, a causa della guerra dei Trent’anni, vive un periodo alquanto convulso: nel 1570, Balthasar von Dernbach divenne principe-abate di Fulda. Per riformare il territorio dell’abbazia e difenderlo dalle crescenti pressioni dettate dal trovarsi in un’area fortemente esposta all’influenza del protestantesimo, questi convocò i gesuiti a Fulda nel 1571 e, dal 1602, si attivò particolarmente per incrementare le disposizioni della Controriforma, arrivando a danneggiare gli interessi della nobiltà locale, in gran parte di fede evangelica. Durante la Guerra dei Trent’anni, le truppe protestanti del vicino langraviato d’Assia-Kassel occuparono l’area del vescovato di Fulda nel 1631. Il langravio Guglielmo V ricevette Fulda come pegno da re Gustavo II Adolfo di Svezia che aveva conquistato l’area con le proprie truppe e governò l’area del monastero col titolo di principe di Buchen. Il principe-abate Johann Bernhard Schenk zu Schweinsberg dovette fuggire e morì nel 1632 durante la battaglia di Lützen. Fu solo il suo successore, Hermann Georg von Neuhof, ad ottenere la piena restituzione dell’abbazia e del principato clericale con la pace di Praga del 1635 e successivamente fece ritorno a Fulda.
Per cui, tra un’invasione e l’altra Johannes Kircher rimane disoccupato: non si perde d’animo e si dedica a una sua grande passione, l’insegnamento, diventando precettore di numerosi nobili tedeschi dell’epoca, sia cattolici, sia protestanti. Però, lo stipendio è quello che è: quindi, per sfamare i figli, decide di applicare la stessa strategia dei suoi genitori, appiopparli ai preti. Athanasius, che il più sveglio e studioso, nel 1616, all’età di 14 anni, entra come novizio nel Collegio Gesuita di Fulda, dove stupisce tutti, compresi i suoi genitori, che probabilmente lo sottovalutavano, imparando non solo il latino e il greco, ma anche l’ebraico.
A differenza del padre, non è appassionato di gonnelle, così entra nell’ordine gesuita a Paderborn il 2 ottobre 1618. Dopo il noviziato, approfondisce lo studio dell’arabo, il turco e il persiano e lo studio delle scienze (1618-1622), prima di studiare la filosofia a Münster e Colonia. A Würzburg riceve l’incarico di professore di filosofia, matematica e lingue orientali.La sua carriera, però, viene arrestata nel 1631, quando sempre i casini della guerra dei Guerra dei trent’anni lo costringono a cercare rifugio ad Avignone. Lì, allestisce un osservatorio e pubblica un saggio di gnomonica. Questa come sapete, è l’insieme dei calcoli e delle pratiche che permettono di progettare, costruire e calibrare le meridiane. Ora, siamo nel Seicento, e gli orologi meccanici erano diventati più precisi di queste, per cui si pensare che l’idea di Athanasius non sia poi cosi brillante: tuttavia, lui trova il modo di applicare tutta la teoria al calcolo della longitudine e della latitudine, migliorando, di parecchio la precisione delle carte geografiche dell’epoca.
Nel 1635 si reca a Roma, perché il papa Urbano VIII (Maffeo Barberini) gli assegna un posto di insegnante di scienze matematiche al Collegio Romano, ma dopo otto anni si dimette dalla docenza per dedicarsi ad una sua grande passione: lo studio dell’antichità. Il Collegio Romano, sarebbe il palazzo dove ha sede il nostro Liceo Visconti: fondato da Ignazio da Loyola per coprire tutto il corso degli studi dalle elementari all’Università, fu progettato dal fiorentino Bartolomeo Ammannati. Vi lavorarono poi Paolo Maruscelli come direttore dei lavori, che noi quasi ignoriamo, ma cui dobbiamo la sistemazione di Palazzo Madama e di Palazzo Spada, e che è stato uno degli primi sperimentatori del Barocco Romano e Antonio Del Grande, che con le Carceri Nuove, è l’inventore del moderno concetto di penitenziario.
Immediatamente spicca nell’ambiente culturale dell’Urbe per la sua poliedricità e versatilità, che lo porta a pubblicare opere su studi orientali, geologia, medicina, ma anche musica e architettura. Athanasius uore a Roma, all’età di 78 anni, il 28 novembre 1680. Il suo cuore è ancora conservato presso il santuario della Mentorella, come preannunciato in un altro post. Il luogo di sepoltura del corpo è incerto, ma si crede sia nel sotterraneo (ora inaccessibile) che collega la chiesa di Sant’Ignazio di Loyola in Campo Marzio con la chiesa del Gesù, insieme ad altre tombe di prelati e insigni personaggi dell’ordine.
Ora Athanasius era scrittore instancabile: da la quantità industriale di libri che aveva prodotto, potrebbe pensare che egli fosse soprattutto un uomo di studio, ma in realtà era anche un uomo d’azione, tanto che osò calarsi nel cratere del Vesuvio per osservare i segni premonitori di un’eruzione vulcanica. Tra l’altro, il racconto di questa esperienza ispirò Verne, nel comporre il suo libro Viaggio al Centro della Terra. Restaurò la chiesa del Gesù, collaborò con William Gascoignes alla messa a punto del cannocchiale astronomico, insegnò la prospettiva a Nicolas Poussin e l’acustica a Francesco Borromini in occasione della realizzazione dell’Oratorio dei Filippini.
A testimonianza della pluralità dei suoi interessi, inventa metodi sulla decrittazione e sulla scrittura stenografica sulla scia del catalano Raimondo Lullo e la sua “Arte della Memoria”: metodi di cui molti sovrani d’Europa si contenderanno l’esclusiva per i loro servizi segreti
Fu anche uno studioso approfondito di usi, costumi e lingua della Cina, soprattutto servendosi dei resoconti e delle testimonianze riportate dai confratelli missionari. Nel Mundus Subterraneus e nel De Arte Magnetica si occupa di geologia e mineralogia, prendendo in esame vulcani e fossili.
Nonostante la sua posizione saldamente radicata nell’ambiente cristiano cattolico, Kircher insegue tutto ciò che di inspiegabile,misterioso e meraviglioso il mondo offre e frequenta numerosi negromanti ed alchimisti, interessandosi lui stesso alla cabala ebraica (nel Cabbala Haebraicae vetus et Christiana) e agli esperimenti della nascente chimica, cosa che influenzò molto il Marchese di Palombara.
Fu affascinato dai primi microscopi e fu forse il primo ad osservarvi dei microbi, postulando la moderna tesi che la peste fosse causata da microrganismi infettivi e proponendo efficaci metodi per prevenire e circoscrivere il contagio. Tuttavia è nelle invenzioni meccaniche e tecnologiche che Athanasius Kircher raggiunge le massime vette di genialità: nell’Ars magna lucis et umbrae, ovvero la grande opera della luce e dell’ombra, vengono trattati i raggi luminosi (visione diretta, riflessa e rifratta) e il funzionamento dell’occhio, insieme alle nozioni fondamentali riguardanti la scenografia e la prospettiva. È in questo libro che egli spiega il funzionamento della camera oscura, della lanterna magica e del Proteo catottrico.
Il congegno della camera oscura, conosciuta già dal Quattrocento, è costituito da due parallelepipedi inseriti uno dentro l’altro. Attraverso fori delle pareti esterne i raggi luminosi entrano nel sistema ottico e proiettano le immagini invertite sulle superfici traslucide (di carta sottile) del cubo interno. L’osservatore è collocato all’interno del congegno e vengono riprodotti gli elementi naturali del paesaggio circostante.
Il principio ottico della lanterna magica, descritto per la prima volta da Kircher, permette di generare immagini partendo da dipinti su vetro. All’interno di un contenitore si ha una fonte luminosa e un foro dotato di un tubo ottico che riporta alle due estremità una lente e le lastrine colorate. Il fascio di luce della lanterna attraversa i dipinti su vetro e ne proietta le sagome colorate in una parete dell’ambiente in cui è posizionata la scatola. La lanterna magica deriva direttamente dalla camera oscura, ma, a differenza di quest’ultima, le immagini non sono create all’interno di una scatola, ma all’esterno. I principi proiettivi usati sono gli stessi, ma variano le posizioni relative alle sorgenti di luce (centro di proiezione), del vetro dipinto (oggetto da proiettare) e dello “schermo” (piano di proiezione) dove si genera l’immagine.
Quanto al Proteo catottrico, si tratta dello strumento che trasforma gli uomini in animali. È costituito da un parallelepipedo ottagonale che riporta sulle facce laterali la rappresentazione di diverse teste di animali. Questa speciale ruota, che può essere mossa da una manovella, è sormontata da uno specchio piano. Nel primo esperimento descritto da Kircher nel suo libro, la ruota risulta nascosta all’osservatore, che, invece di vedere riflesso il proprio ritratto, trova di volta in volta quello di un animale.
Athanasius si era poi profondamente interessato agli studi galileiani, diventando un aperto sostenitore delle teorie ottiche dello scienziato eretico. Anche dal punto di vista astronomico e cosmologico, Kircher si schiera dalla parte di intellettuali “scomodi”: intuisce l’infinità del cosmo come Giorano Bruno, pur non ammettendolo mai esplicitamente, ed elabora una teoria eliocentrica più moderata e meno “di rottura”, ove i pianeti girano attorno alla Terrae dove tutto questo sistema ruota poi attorno al Sole.
Progetta inoltre numerose macchine idrauliche, orologi, carillon e macchine musicali, ove la sua conoscenza dell’armonia e delle frequenze fisiche dei suoni si mescolano con l’elemento magico, occulto e meraviglioso, imprescindibili per Kircher: le melodie prodotte da queste macchine, avevano, secondo il suo creatore, poteri taumaturgici e potevano guarire delle patologie specifiche a seconda del timbro e della durata dei suoni emessi. Kircher fu egli stesso un ottimo musicista dilettante e un valente compositore, compilando sull’argomento il trattato “Musurgia Universalis”(1650).
Tra le sue molteplici invenzioni, si ricorda anche l’antenato del megafono, da lui chiamato “tromba stentorofonica” e il famigerato Organum Mathematicum, che certo non era l’antenato dei nostri computer, ma sicuramente anticipava parecchi moderni database., fungendo da una sorta di enciclopedia portatile, o di sistema globale di classificazione del Sapere.
Questo accrocco era costituito da un contenitore di legno impiallacciato, con coperchio incernierato. Sul coperchio e sulla parte anteriore si trovano due quadrelli rotanti di rame dipinto. Sul retro, uno sportellino incernierato nasconde un piccolo vano. L’interno del contenitore è suddiviso in nove scomparti, corrispondenti ad altrettanti ambiti disciplinari: Aritmetica, Geometria, Fortificatoria, Cronologia, Horografia, Astronomia, Astrologia, Steganografia, Musica. Ognuno degli scomparti contiene ventiquattro asticelle che terminano con una punta triangolare colorata. Su ognuna delle nove serie di ventiquattro asticelle sono vergate definizioni e informazioni pertinenti ai relativi ambiti disciplinari. Almeno un’asticella di ognuno dei nove scomparti ha la punta colorata di nero e costituisce la tabella applicatoria, che fornisce la regola del corretto funzionamento. Per moltiplicare 74 x 8, ad esempio, si estrae l’asticella con la punta nera dello scomparto Aritmetica e la si affianca alle asticelle contrassegnate in alto dai numeri 7 e 4. Leggendo sull’asticella con punta nera la riga ottava, vi si trova il prodotto cercato.
Verso la fine del 1615, Pietro Della Valle, cavaliere e patrizio romano, durante un viaggio in Egitto trova nella città del Cairo un antico vocabolario copto-arabo. Questo vocabolario, secondo le sue parole, era «nascosto tra uomini le cui menti ignoranti erano incapaci di apprezzarlo»: così lo riporta a Roma, dove è sicuro sarà un valido aiuto per riscoprire la lingua degli antichi egizi. A Roma, Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, senatore nel parlamento di Aix, vuole tradurlo in latino: per farlo contatta proprio Kircher, suo buon amico. Malgrado la ritrosia iniziale, non sentendosi all’altezza dell’operazione, alla fine egli accetta.
Nell’arco di due anni la traduzione è pronta, ma ne viene rimandata la pubblicazione a causa di un viaggio intrapreso da Kircher in Sicilia ed a Malta. A causa anche della mancanza di attrezzatura per stampare i caratteri geroglifici, la traduzione rimarrà inedita per alcuni anni, tanto da spingere l’autore a rinunciare a pubblicarla.
La situazione si sblocca solo con l’intervento dell’Imperatore del Sacro Romano Impero, che stanzia personalmente i fondi per stampare i caratteri orientali e per coprire le spese totali dell’operazione. Kircher è estasiato da questo aiuto inaspettato, tanto da elogiare più volte, nell’introduzione della sua opera,
questo ferreo imperatore che non era tanto sopraffatto dalla barbarie della guerra e da ondate su ondate di invasioni da dedicarsi interamente a Marte dimenticando Pallade Atena
Da quel momento in poi Athanasius si mette in testa di tradurre i geroglifici: da una parte, ha intuizione geniale, riconoscendo il legame tra antico egizio e copto, dall’altra, influenzato da parallelo da Orapollo (“Ieroglifica”) e Valeriano, improvvisa un metodo di decifrazione che, seppur errato nei presupposti, sarà indispensabile a Champollion sotto l’aspetto metodologico. Athanasius adottò infatti un tipo di interpretazione dei geroglifici radicalmente diversa da quella di oggi: egli pensava che ogni simbolo racchiudesse in sé una molteplicità infinita di significati, rivelati dalla divinità direttamente a chi li aveva scritti: in questo modo Kircher poté riscontrare elementi religiosi propri del cristianesimo della sua epoca anche nei segni geroglifici, ascrivendo questa presunta coincidenza di significati alla comune origine divina della rivelazione cristiana e della sapienza egizia
La natura “magica” del geroglifico rispetto all’alfabeto normale richiedeva dunque, per Kircher, un atteggiamento diverso da quello del traduttore che compila un vocabolario (questo è stato l’approccio moderno ai geroglifici), cercando un’attitudine più simile a quella dell’iniziato o del sapiente, che gli permettesse di penetrare i significati ermeticamente “sigillati” nei segni sacri. I significati ottenuti non sarebbero però stabili, rinviando continuamente ad altri sensi: geroglifico per Kircher è ogni segno che dia origine a uno slittamento continuo di senso. Però, la bizzarra traduzione di Athanasius lo mise in contatto con il buon Bernini, impegnato a riutilizzare in qualche modo gli obelischi che spesso saltavano fuori nei lavori nel centro di Roma.
I due collaborano soprattutto per la Fontana dei Fiumi a Piazza Navona e l’elefantino di Piazza della Minerva. Il pontefice Alessandro VII, della famiglia dei Chigi, decise di far erigere unobelisco nella piazza antistante la chiesa della Minerva e numerosi architetti proposero i loro progetti per una base che potesse sostenere l’antico monolite. Tra questi il modesto progetto del domenicano padre Domenico Paglia, che prevedeva un basamento composto da sei piccoli colli (il monte a sei cime sormontato da una stella ad otto raggi è proprio lo stemma della famiglia Chigi) con un cane a ciascuno dei quattro angoli con una torcia in bocca (emblema dei frati, soprannominati anche Domini Canes).
Il progetto fu però respinto dal papa che non voleva un monumento in suo onore ma un simbolo della Divina Sapienza e che, per questo, si rivolse a Gian Lorenzo Bernini, il quale eseguì insieme alla sua bottega, ben 10 diversi progetti, tre dei quali, firmati da lui personalmente, conservati nella Biblioteca Apostolica Vaticana (Cod. Chigi). Il progetto più audace, e più tipicamente berniniano, raffigura un gigante che sostiene in un precario equilibrio l’obelisco con le braccia.
Ma il pontefice preferì a tutte le altre soluzioni, quella dell’elefantino che tiene l’obelisco sul dorso, elaborata dal Bernini, ispirandosi alla Hypteronomachia Poliphili (la battaglia d’amore in sogno di Polifilo), scritta dal domenicano Francesco Colonna e pubblicata a Venezia nel 1499 dal tipografo ed editore Aldo Manuzio (Francesco Colonna, Hypnerotomachia Poliphili). E’ probabile che proprio il Papa Alessandro VII, che possedeva una copia dell’Hypteronomachia, postillata di sua mano, abbia suggerito a Bernini questa iconografia molto simile all’incisione, con un elefante sormontato da un monolite, contenuta nella prima edizione del testo, in cui il protagonista, durante una bizzarra avventura onirica, incontra un elefante di pietra con un obelisco sul dorso, anche ispirato da una riflessione di Athanasius,
..solo una robusta mente può sostenere una solida sapienza
Athanasius è anche studioso di pittura antica, collezionista ed estimatore d’arte: conserva nella sua residenza due dipinti di Raffaello, uno di Lorenzo Lotto e il suo favorito, la “Fuga in Egitto” di Federico Barocci, al quale il gesuita attribuisce dei significati simbolici e cabalistici particolari e delle proprietà mistiche e magiche. Tuttavia padre Athanasius non colleziona solo dipinti, ma tutto quanto possa parlare dell’uomo e della sua vicenda terrena, soprattutto se vissuta secoli addietro o a migliaia di chilometri da Roma e in modo del tutto diverso da quello che conosce: è infatti avido di tutti quegli oggetti, antichi come moderni, che i gesuiti portano dai loro viaggi negli angoli più remoti della Terra.
Dal 1651 Kircher trasferisce al Collegio Romano questa “collezione personale” unendola con la donazione del “gabinetto delle curiosità” di Alfonso Donnini, patrizio di Tuscania, un aristocratico e antiquario italiano, che aveva posto come condizione la sua apertura al pubblico e la sua utilizzazione per l’istruzione degli studenti.
Cosi Athanasius crea una Wunderkammern sottintende grazie alle idee del proprio fondatore una complessa struttura del pensiero: la filosofia neoplatonico-rinascimentale di Marsilio Ficino, che tende a considerare ogni elemento del mondo sensibile una emanazione del mondo ultraterreno, unendoli entrambi attraverso una moltitudine di simboli. La realtà fisica è l’ultima emanazione di un assoluto da raggiungere per via associativa e sintetica, affidandosi alla forza dei simboli ed alla catena delle analogie: ogni cosa rimanda ad un’altra, essendo tutte emanazioni di Dio. La conoscenza e la verità possono essere raggiunte per via analogica, anche attraverso l’uso della magia o di altri strumenti di interpretazione del reale, perciò la Magia, come la Filosofia, le Arti e la Storia, è un altro strumento utile per spiegare il mondo. Il procedimento conoscitivo è solo intuitivo ed unisce simultaneamente il particolare ad un universale oscuro ed intangibile. Le affermazioni di Kircher come ad esempio: “La natura divina ama rimanere nascosta“, “Dio si nasconde ai sensi degli uomini volgari e dei profani con similitudini e parabole“, il riferimento ad un codice simbolico come quello dei geroglifici, manifestano una concezione del sapere che considera l’oscurità e l’enigma come unico modo per avvicinarsi a Dio: per Kircher la luce divina è troppo forte perché l’uomo vi si possa accostare direttamente. Da questa visione gnoseologica appare evidente come l’interesse di Kircher nei confronti dell’alchimia, dell’esoterismo, della cabala, del mondo ebraico, di Ermete Trismegisto, del mondo egizio, quale depositario delle antiche verità cosmologiche e dell’Oriente in genere, sia soltanto un mezzo per poter arrivare più facilmente alla conoscenza dell’assoluto. La necessità di Kircher di rivolgere i propri studi all’Egitto ed alle religioni orientali è, quindi, espressione sia del neoplatonismo rinascimentale, che vede ogni singolo oggetto dell’universo come “l’ombra di Dio e l’immagine del Paradiso interiore“, sia del nuovo gusto barocco per l’insolito e per l’esotico.
Il museo rappresenta poi chiaramente le idee ermetiche ed universalistiche del suo fondatore e la sistemazione dei singoli oggetti, che a prima vista sembra lasciata al caso, in realtà, vuole ricreare un microcosmo come rappresentazione del macrocosmo visto come unità organica. Su tutto il soffitto sono affrescate immagini che esprimono la concezione filosofica del gesuita tedesco e in corrispondenza dei cinque ovali dipinti sul soffitto sono collocati altrettanti piccoli obelischi. L’intera composizione ha un chiaro significato gnoseologico legato all’ermetismo: il passaggio simbolico, attraverso gli obelischi, dall’Assoluto, enunciato in ogni singolo ovale, al molteplice, rappresentato dai vari oggetti esposti lungo le pareti del museo. Al di sotto di ogni singolo ovale vi è una frase tratta da diverse culture (caldea, egizia, ebraica, latina, etiope), proprio a significare il desiderio di ogni civiltà di voler riunificare tutto quello che sembra diviso
Il museo divenne subito popolare e ospitò molti visitatori. Un primo catalogo venne pubblicato nel 1678 da Giorgio de Sepibus e comprendeva alcune tavole illustrate, oggi unica testimonianza dell’allestimento. Dopo la morte di Kircher nel 1680 il museo attraversò un periodo di abbandono. Riprese nuova vita e vigore grazie all’attività del nuovo curatore Filippo Bonanni che pubblicò un secondo catalogo nel 1709. Dal confronto tra i due cataloghi si può constatare che molti oggetti erano già scomparsi dalla collezione. Con il tempo il museo riacquistò il suo antico splendore e grazie agli aiuti ricevuti e alle molte donazioni, divenne sede di molte importanti collezioni che toccavano tutti i campi della conoscenza, dalla filosofia sperimentale all’esoterismo alla tecnologia. La collezione di archeologia fu ampliata dal gesuita Contuccio Contucci, direttore del museo tra il 1735 e il 1765.
L’ultimo direttore gesuita del Museo fu il letterato Antonio Maria Ambrogi (1713-1788). Nel 1773, a seguito della soppressione della Compagnia di Gesù da parte di Clemente XIV, il Collegio Romano fu affidato al clero di Roma e le collezioni iniziarono a subire le prime drastiche alterazioni: molti reperti finirono al museo Pio-Clementino nei Musei Vaticani. Nel 1814 la Compagnia di Gesù fu ricostituita da Pio VII e nel 1824 Leone XII restituì collegio e museo ai gesuiti. Dal 1839 in poi il museo fu diretto per quasi vent’anni da Giuseppe Marchi, che tentò una riorganizzazione e produsse una monografia sulle monete antiche ivi conservate, L’aes grave del Museo Kircheriano.
Quando nel 1870 Roma fu conquistata e divenne la capitale del Regno d’Italia, gran parte delle proprietà ecclesiastiche furono espropriate dal nuovo Stato unitario: al Collegio romano furono posti il Liceo ginnasio Visconti e la Biblioteca nazionale centrale. Anche il Museo kircheriano divenne un museo statale e tra il 1881 e il 1913 fu diretto da Luigi Pigorini, che lo incrementò affiancandogli il Museo nazionale preistorico etnografico.
Solo nel 1913 un decreto del Ministero della pubblica istruzione autorizzò la definitiva dispersione delle collezioni, che furono ripartite nei nuovi musei statali della capitale: le antichità etrusche e italiche andarono al Museo nazionale etrusco, quelle romane al Museo nazionale romano, i reperti medievali e rinascimentali a Castel Sant’Angelo e, dal 1916, al nuovo Museo nazionale del Palazzo di Venezia. Al Collegio rimasero alcune curiosità, come i modellini in legno degli obelischi romani, e il Museo nazionale preistorico etnografico, poi trasferito all’EUR negli anni ’60.
Alessio Brugnoli's Blog



