Alessio Brugnoli's Blog, page 100
August 10, 2019
Cold and dry climate could have been responsible for the extinction of Neanderthals
Ancient periods of cold and dry climate helped our species replace Neanderthals in Europe, a study suggests.
View original post 1.528 altre parole
Ma chi sei, Cacini? (Cacini a Primavalle)
Di Gustavo Cacini rimane poco, almeno nella memoria dei romani.
Rarissime e sconosciute immagini, nessun titolo di rivista, nessuna battuta. Persino sul fisico del personaggio rimane qualche dubbio: Sordi lo descrive nero e lungo (come appare nei manifesti), Claudio Buccilli (il fornaio di Sacchetti/Primavalle) magro e basso.
Recitò in un mondo artistico, quello del vaudeville dell’epoca fascista, spontaneo, ricco d’improvvisazioni, popolare, a tratti scurrile, eppure straordinariamente vivo (Totò, Nino Taranto, Anna Magnani, Tino Scotti, Carlo Dapporto e decine attori di vaglia vengono di qui).
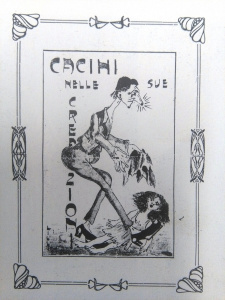
Di Cacini, in modo certo, sopravvive solo il detto originato dalla strafottenza esibita sul palco (“Ma chi sei, Cacini?“), da gradasso vanaglorioso (si atteggiava a erede di Carnera) e attaccabrighe.
L’Enciclopedia di Roma di Claudio Rendina resoconta con stringatezza:
“Cacini Gustavo detto Cacini. Attore di rivista (Roma 1890 – Nettuno 1969). La sua ribalta fu ai teatri Jovinelli, principe e Volturno…
View original post 402 altre parole
Supplicia Canum (3 agosto)
Tutti gli anni, il 3 agosto, i Romani celebravano un barbaro rituale che consisteva nel crocifiggere o appendere a una forca un cane e portarlo in processione, in una sorta di pubblica umiliazione e punizione; nella stessa processione, si rendeva invece ogni tipo di onore alle oche.
La data in cui si svolgeva questa bizzarra cerimonia ci è stata tramandata solo da Giovanni Lido (De mensibus, IV, 114), un tardo scrittore del VI secolo d.C., ma l’esistenza di un rito così disturbante per la nostra sensibilità moderna è attestata da numerosi autori, tra cui Plinio il Vecchio, Plutarco, Eliano e Servio.
 Statua di molosso d’Epiro, copia romana di originale greco di età ellenistica, British Museum, Londra
Statua di molosso d’Epiro, copia romana di originale greco di età ellenistica, British Museum, Londra
L’origine di questa rituale veniva fatto risalire dagli scrittori antichi al famoso saccheggio di Roma da parte dei Galli Senoni nel 390 a.C., e precisamente all’episodio in cui le oche del Campidoglio, col loro…
View original post 143 altre parole
Villa Giulia
[image error]
Uno dei parchi più affascinanti di Palermo è Villa Giulia, i cui lavori ebbero inizio nel 1777, essendo viceré Marcantonio Colonna, omonimo e discendente del vincitore di Lepanto e pretore della città il marchese Regalmici.
Estesa circa 62.500 metri quadrati e progettata dall’architetto regio Nicolò Palma sul piano di San Erasmo, fuori della cinta muraria della città, dove anticamente vi era l’aristocratico giardino della famiglia Chiaramonte, conti di Modica, prende il nome dalla moglie del Colonna, la viceregina Donna “Giulia” d’Avalos Guevara.
Il piano di Sant’Erasmo per secoli fu utilizzato per vari usi. Infatti abitualmente i pescatori stendevano ad asciugare le loro reti, ma si svolgevano anche rassegne e parate militari e vi aveva luogo la “fiera dei crasti” durante il periodo pasquale. Ma nella memoria popolare tale piano è tristemente ricordato soprattutto per gli “ Atti di Fede” da parte del Sant’ Uffizio. Non era l’unico luogo dove avvenivano tali “manifestazioni” pero era uno dei più usati ,soprattutto per la possibilità di poter accogliere migliaia di “spettatori”
La villa fu inaugurata l’11 giugno 1778 dalle più importanti autorità civile e religiose e dai rappresentanti del Senato palermitano, con spari di mortaretti e con la “calata della tela”, che copriva l’ingresso della villa orientato verso il mare.
Johann Wolfgang Goethe si fermava qui per leggere Omero. Tra l’altro, quando fu costruita, il Foro Italico ancora non esisteva, essendo stato costruito con le macerie dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, e la villa si trovava proprio a ridosso del mare. .
Concepita secondo un rigoroso e classico disegno geometrico, la villa, nonostante la sua notevole regolarità, si rivelò esteticamente gradevole e agevolmente accessibile da quattro ingressi, posti ognuno al centro di ogni lato, dei quali il più importante era quello che guardava il mare.
Il suddetto ingresso, progettato da Vincenzo Di Martino è realizzato tra il 1787 e il 1788 con un arco monumentale porticato e con colonne tuscaniche, sarà poi sostituito, nel suo ruolo di ingresso più importante della villa, da un ottocentesco ingresso con colonne di ordine dorico, prospettante sullo stradone di S. Antonino (attuale via Lincoln).
La villa, a pianta perfettamente quadrata, ha al suo centro un ampio piano circolare da cui si dipartono a raggiera viali orientati secondo gli assi meridiani e le diagonali del giardino e intersecati da quattro viali ubicati sul perimetro di un quadrato ruotato di 45°, mentre tutti i viali, delimitati da alberi di alto fusto e da siepi, costituiti da otto viali maggiori e da sedici minori avente funzione di raccordo dei primi, originano, intersecandosi, aree triangolari e quadrilatere impiantate ad aiole e a boschetti.
Il perimetro del suddetto piano è delimitato da sedili in marmo e da panchine in ferro, ai quali fanno da coronamento quattro esedre armoniche a pianta semicircolare e in stile neoclassico pompeiano, progettate dall’architetto capuano Giuseppe Damiani Almeyda, aventi la copertura costituita da una volta a botte e da un bacino emisferico, sormontate ognuna da una lira in ferro e precedute da un portico delimitato lateralmente da due loggette con colonne e lesene di ordine ionico.
Architetto che mutò l’aspetto originale della villa, costruendo teatrini della musica, quattro esedre (incavi semicircolari, sovrastati da una semi-cupola), alterando, assieme ai vari monumenti in onore delle glorie patrie, come Leopardi e Verdi, quella che era il messaggio simbolico di un’opera pubblica concepita in quella che era una delle capitali della Massoneria in Europa.
I due leoni, a guardia dell’ingresso Est, si trovano sulla difensiva, pronti ad intervenire, essi proteggono due urne chiuse da un coperchio, indicando che non è il momento della rivelazione, questa avverrà soltanto alla fine del percorso interiore, pieno di sfide e pericoli.
Percorso che avviene in un spazio geometricamente definito, immagine dell’ordine del Kosmos, frutto dell’azione del Grande Architetto dell’Universo, delimitato dalla pentalfa, metafora della volontà umana e dalla stella fiammeggiante, simbolo dell’Intelligenza e della Scienza.
Le statue originali presenti nella Villa rappresentano bambini, l’invito a osservare il mondo con curiosità e libero dai pregiudizi, e Apollo, l’illuminazione che deve perseguire l’iniziato, basata sulla triade Saggezza, Forza e Bellezza.
Una tappa fondamentale è il “giardino della memoria” nel quale furono realizzati dei monumenti funerari in onore di grandi personalità del passato: per citarne alcuni, ritroviamo Teocrito, il fondatore della poesia bucolica, Empedocle, importante filosofo e Diodoro Siculo, grande storico, per non parlare della tomba di Archimede. Giardino in cui si evidenzia quanto raccontato da Vico, letto, studiato e travisato nella Palermo delle Settecento, ossia come l’illuminazione non sia nulla più che la riscoperta della Sapienza degli Antichi.
Singolare è la statua di Diogene, uomo che vive e che si trova al di fuori della città, come villa Giulia, ma che la protegge attraverso la sua saggezza.
[image error]
La tappa successivo del viaggio iniziatico è il Genio di Palermo, protettore della città, duca e garante della pace. L’opera fu realizzata da Ignazio Marabitti nel 1778 ed è costituitada una vasca circolare in pietra di Billiemi, al centro si erge una roccia su cui domina la scultura del Genio in marmo di carrara. Il protettore della città nutre dal petto una serpe, simbolo di salute e prudenza: in una mano tiene uno scettro, simbolo regale, mentre al suo fianco vi è un’aquila, allegoria delle vittorie militari, sulla roccia una cornucopia simboleggia l’abbondanza, invece il fascio littorio allude alla giustizia e al potere, ai suoi piedi, un cane incarna la fedeltà. Infine, una targa in latino recita “Prima Sedes, Corona Regis et Regni Caput” riferendosi ai tre antichi privilegi della città: prima sede dei re di Sicilia, luogo deputato alla loro incoronazione e il suo rango di capitale.
Lo circondano pregevoli statue allegoriche disposte in semicerchio, rappresentanti la “Gloria che abbatte l’Invidia”, l’”Abbondanza che scaccia la Carestia”, l’”Eresia”, l’”Islamismo”, lo “Scisma d’Oriente”, l’”Intemperanza”, l’”Orgoglio”, la “Superbia”. Così il Genio di Palermo metafora del perfetto massone, che vince tutti vizi che generano le finte opinioni che provocano le divisioni nel genere umano.
[image error]
Il viaggio termina al centro della Villa, in cui si trova una vasca circolare nel centro della quale un putto sorregge un orologio dodecaedrico con facce pentagonali. Su dieci delle dodici facce sono incisi i quadranti solari, in cui si ribadisce il ruolo dell’Uomo, illuminato dalla Sapienza, come misura di tutte le cose.
L’orologio del Dodecaedro ovvero un dodecaedro in marmo dove per ogni faccia si trova un orologio solare, è stato progettato dal matematico Lorenzo Federici. Il complesso sembra risalga al 1783. La statua è ritenuta opera dello scultore palermitano Ignazio Marabitti ed è alta circa un metro mentre 73,5 cm è la distanza tra le due facce piane del dodecaedro. Nel 1998 Francesco Grifasi e Maria Luisa Tuscano hanno fatto uno studio approfondito del manufatto, effettuando ricerche storiche ed iconografiche, ed alla fine hanno ricalcolato, utilizzando di concerto con i responsabili del restauro generale della villa l’ora francese, i dieci quadranti.
Le facce pentagonali sono in marmo bianco di Carrara con lato di 33 cm. La faccia piana superiore del dodecaedro non possiede indicazioni gnomoniche perché non visibile da chi, da terra, osserva l’orologio. I tracciati forniscono l’ora solare vera locale. Su due tabelle, situate ai piedi del monumento, sono riportati i valori relativi all’equazione del tempo ed alla costante locale. Gli gnomoni polari, a vela, sono in ottone. Una delle facce del dodecaedro è rivolta esattamente a sud; le altre, superiori ed inferiori, declinanti secondo angoli di 36°, permettono di fornire indicazioni orarie per tutto l’arco diurno e per tutto l’anno. Le linee diurne sono state calcolate, ma non disegnate, mentre quelle solstiziali sono evidenziate dagli estremi delle linee orarie.
Prima di finire, una piccola curiosità: sul lato meridionale della villa si trovano recinti per molti animali e voliere per uccelli rari, dimora, anni fa, di un vecchio leone, chiamato Ciccio, donato nella seconda metà degli sessanta dal cavaliere De Furlanis all’amministrazione comunale che pensò di acccasarlo in una gabbia della Villa Giulia. Rimase alla villa sino a quando, agli inizi degli anni ’90 si decise di trasferirlo nella proprietà del dottor Quatra, uno zoo di Terrasini dove morì quasi 5 anni
Il povero leone è talmente rimasto nella memoria dei palermitani, che ogni tanto salta fuori la proposta di erigere una statua in suo onore a Villa Giulia.
Per terminare questa chiacchierata, ecco il ricordo che aveva Goethe di Villa Giulia.
Nel giardino pubblico vicino alla marina ho passato ore di quiete soavissima. E’ il luogo più stupendo del mondo. Nonostante la regolarità del suo disegno, ha un che di fatato; risale a pochi anni or sono ma ci trasporta in tempi remoti. Verdi aiuole circondano piante esotiche, spalliere di limoni s’incurvano in eleganti pergolati, alte palizzate di oleandri screziate di mille fiori rossi, simili a garofani, avvincono lo sguardo. Alberi esotici, a me sconosciuti, ancora privi di foglie, probabilmente d’origine tropicale, si espandono in bizzarre ramature. Da un rilievo in fondo al tratto pianeggiante la vista abbraccia un incredibile groviglio di vegetazione (…). Ma ciò che dava all’insieme un fascino eccezionale era un’intensa vaporosità che si stendeva uniforme su ogni cosa (…). Quale fantastico aspetto conferisca tale nebulosità agli oggetti lontani, alle navi, ai promontori, è cosa che colpisce un occhio pittorico (…).
Ma il ricordo di quel giardino incantato m’era rimasto troppo impresso nell’animo: le onde nerastre a nord dell’orizzonte, il loro accavallarsi nelle sinuosità del golfo, perfino l’odore caratteristico dell’evaporazione marina, tutto richiamava ai sensi e alla memoria l’isola beata dei Feaci.” La descrizione continua qualche giorno più tardi: “Stamani andai al giardino pubblico (…). Molte piante, ch’ero abituato a vedere in cassette o in vasi, o addirittura chiuse dietro i vetri d’una serra per la maggior parte dell’anno, crescono qui felici sotto il libero cielo (…). Di fronte a tante forme nuove o rinnovate si ridestò in me la vecchia idea fissa se non sia possibile scoprire fra quell’abbondanza la pianta originaria – Urpflanze -. E’ impossibile che non esista! Come riconoscerei altrimenti che questa o quella forma è una pianta, se non corrispondessero tutte a un unico modello?”
August 9, 2019
La tomba di Adelasia del Vasto
[image error]
Il mio viaggio alla ricerca delle tombe degli Altavilla, oggi mi porta a Patti, nella basilica di San Bartolomeo, l’apostolo le cui spoglie, come dire, hanno avuto una storia alquanto romanzesca.
Non si sa bene come, dato che secondo la tradizione fu scuoiato nella Media Atropatene, circa corrispondente al nostro Azerbaigian, nel 264 d.C. finirono a Lipari, dove rimasero sono al 410, quando il san Maruta vescovo di Maiferqat (oggi la città curda di Silvan) le comprò, pagandole a peso d’oro.
Il perché di tale acquisto è facile a dirsi: lo shah Yazdgard I, sia perché il il vescovo di Ctesifonte, Abdaas, aveva tentato di bruciare il tempio del Grande Fuoco della capitale sasanide, sia perchè li considerava una quinta colonna di Costantinopoli, aveva ordinato una grande persecuzione dei cristiani di Persia.
Maruta, ottimo medico, dopo avere curato lo shah Yazdgard I da una fastidiosa borsite, lo convinse a rinunciare a tale proposito e ad adottare una politica di tolleranza; per cui, per celebrare tale successo diplomatico e invocare la protezione divina, affinché in futuro non venissero di nuovo queste strane idee ai sasanidi, cominciò a raccogliere reliquie a destra e manca, tanto che Maiferqat cambiò nome in Martiropoli.
L’imperatore Anastasio I, ottenne le reliquie di Bartolomeo in una clausola del trattato di pace del 507, portandole a Darae, nell’Iraq settentrionale. Ai tempi di Giustiniano, non si sa bene perché, il vescovo di Darae le vendette a un mercante ebreo proveniente dalla Spagna, che in maniera alquanto salomonica, le rivendette a Lipari, dove rimasero sino a una razzia araba.
Essendo i saraceni più interessati all’oro che a vecchie ossa, si salvarono: però, per evitare il rischio di profanazioni future, furono affidate in gran segreto al principe longobardo Sicardo, il quale mette al sicuro il corpo dell’apostolo a Sorrento e infine a Benevento.
Nel 983 Ottone II di Sassonia pretese la consegna di tali reliquie, minacciando, in caso contrario, terribili rappresaglie. Per evitare problemi, i beneventani tentarono un colpo gobbo: gli fu infatti consegnato il corpo di san Paolino, vescovo di Nola. Accortosi dell’imbroglio l’imperatore cinse la città d’assedio, ma non riuscendo a espugnarla fece ritorno a Roma, dove peraltro fece edificare una basilica dedicata a San Bartolomeo sull’Isola Tiberina.
Ora, nel tentativo di incrementare il controllo del territorio appena conquistato e di latinizzare la Sicilia, convertendo i musulmani e riportando gli ortodossi sotto il controllo del Papato, Ruggero I fece costruire a Patti una fortezza, un monastero benedettino dedicato al Santissimo Salvatore e la basilica dedicata a San Bartolomeo.
Della basilica originale è rimasta solo la facciata, caratterizzata da un portale centrale in stile gotico costituito da tre colonne per lato inframezzate da colonnine più esili che reggono capitelli con figure zoomorfe, mentre l’articolato manufatto prospettico in laterizi sorregge un arco acuto con più ordini di strombatura.
Il secondo ordine è contraddistinto da altrettante cornici di bifore cieche con archi a tutto sesto, le monofore esterne includono oculi ciechi. L’edicola interna priva di rivestimento lavico reca un oculo sede della moderna vetrata raffigurante il volto di Cristo. Cornicioni delimitano un terzo ordine con paraste intermedie sormontato da timpano triangolare.
I due ordini presentano una decorazione lavica che insieme agli inserti di candido marmo delle cornici e del reticolo, creano un finissimo effetto cromatico. A metà strada dalle cave di pietre e materiali lavici, con riferimento alle ricchissime colate laviche delle falde dell’Etna o estratte e importate dalle prospicienti Isole Eolie, la facciata presenta l’utilizzo di conci di lava per scopi decorativi. Peculiarità che accomunano la cattedrale alle costruzioni di matrice bizantino – araba, cube e metochi del circondario, l’utilizzo di conci di pietra lavica denominatore comune alle rifiniture esterne delle absidi del Duomo di Palermo e del Duomo di Monreale, ai castelli di Milazzo e di Santa Lucia del Mela.
Il resto della basilica normanna crollò a seguito del terremoto del Val di Noto del 1693, in cui l’undici gennaio le scosse distrussero ompletamente l’ultima elevazione della torre campanaria caratterizzata dalle aperture a trifore, le tre absidi coeve e identiche a quelle del duomo di Cefalù, la volta e le cappelle laterali. I canonici riuniti per le funzioni si salvano perché l’orologio del campanile a causa della scossa del 9 e le tre della domenica, di cui l’ultima catastrofica, segna l’ora in avanti di mezzora e anticipano l’uscita prima dei crolli.
[image error]
In questa basilica è sepolta una delle donne più affascinanti del Medioevo, Adelasia del Vasto, figlia del Marchese Manfredo Incisa del Vasto, marchese di Savona e della Liguria Occidentale, ucciso durante la rivolta dei suoi tartassati sudditi.
In punto di morte Manfredo aveva affidato al fratello Anselmo figli e beni. Tuttavia, anche il tutore era presto deceduto e la cospicua eredità affettiva e patrimoniale era finita nelle mani del terzogenito della casata: l’avido Bonifacio, Signore di Gravina. Per porre un’ipoteca su quei congrui beni, egli contrasse matrimonio con la vedova del germano, in dispregio delle interdizioni sancite dal diritto canonico e delle vivaci proteste espresse da Papa Gregorio VII e dai Vescovi di Asti, Torino ed Acqui.
Bonifacio, fregandosene altamente della minaccia di scomunica, si impadronì dei beni dei nipoti e per toglierseli dalle scatole, combinò il matrimonio tra Adelasia e Ruggero I di Sicilia, che nei due procedenti matrimoni, aveva avuto solo figlie femmine, tranne Malgerio, conte di Troina, che, non si sa per quale motivo, rinunciò all’eredità paterna, per rinchiudersi in solitario esilio in un castello in Calabria, e Goffredo, uomo di straordinaria intelligenza, ma che la lebbra aveva escluso dalla successione.
In più, Giordano, il figlio legittimato, nato da un’amante bizantina di Ruggero, abile e ambizioso, era morto all’improvviso. Per cui, serviva a ogni costo una nuova moglie, per avere un sospirato erede. Così Adelasia giunse al porto di Messina in pompa magna su navi da cui sbarcarono dote, scorta e un nutrito seguito di suoi conterranei piemontesi che l’avevano seguita per insediarsi nella parte centro-orientale dell’isola. Fu una prima avanguardia di un flusso migratorio poi massicciamente favorito per decenni fino al XIII secolo, ancora oggi testimoniato dall’esistenza di alcune isole linguistiche alloglotte nel cuore della Sicilia, chiamate colonie lombarde, dove si parla un antico dialetto Gallo-Italico.
Adelasia tenne fede al suo compito e partorì due figli maschi, Simone, morto giovanissimo e Ruggero II: alla morte del Conte di Sicilia, divenne reggente, governando con straordinario rigore: scaltra, ambiziosa, capace, lucida e di temperamento generoso ed ardito per l’epoca, a fronte della rivolta di Patti, ove un gruppo di Baroni ribelli si era asserragliato nel castello di Focerò, ella dette prova di inaspettata intransigenza reagendo con una spietata repressione.
Nel consiglio della Corona, oltre ai fratelli, ad assisterla vi fu Cristodulo o Cristoforo, uomo di mare che nel 1094 aveva avuto da Ruggero il titolo di protonobilissimo. Si vuole che egli fosse l’arabo Abd-er- Rahmân-en- Nasrâni: un nome che, da convertito, si traduce in schiavo del misericordioso. Egli era forte di un rispettabile passato e di larga autorità riconosciutagli dal Gran Conte, quando era stato designato uomo/ponte fra gli interessi normanni e le popolazioni greche della Calabria e Sicilia orientale. Accanto alla Sovrana, ora, benché esperto in materia finanziaria, Cristodulo aveva promosso la costruzione di chiese e monasteri e concorso agli equilibri fra le varie forze etniche e religiose presenti nello Stato.
In quegli anni, Adelasia rafforzò l’edificio istituzionale ponendo evidente attenzione alla giustizia, all’ordine ed alla pace sociale: seguendo le orme del marito, che nella strategica Messina aveva fondato nel 1081 una sede vescovile cui nel 1096 aveva aggregato la diocesi di Troina, ella elesse la città sede permanente di Corte e fissò la capitale a Palermo. Morto, intanto, il figlio di Roberto il Guiscardo, il minorenne Ruggero II ereditò anche la Puglia, consolidando quella tradizione dinastica che trasformò in Regno di Siciliae et Italiae, con una estensione dal Tronto sull’Adriatico, al Garigliano sul Tirreno: confini restati immutati per sette secoli.
Energica, autorevole ed illuminata, come Goffredo Malaterra la descrisse, Adelasia rappresentò il più sostanziale elemento d’unione fra Ruggero I e Ruggero II: tollerante in materia religiosa, privilegiò i Musulmani rendendoli fortemente lealisti verso la Corona e manifestò attenzione politico/garantista anche nei confronti della Chiesa Greca, in particolare del monachesimo basiliano. Protesse, anzi, con forte impegno due prestigiose figure del Clero calabrese, delle quali apprezzò la vivacità intellettuale: Luca da Melicuccà, Vescovo di Isola Capo Rizzuto, legatissimo al Patriarca di Costantinopoli, e Bartolomeo da Simeri: il vero riformatore del monachesimo nella Sicilia normanna. Perseguendo la linea tracciata dal coniuge, che nel 1092 aveva elargito donazioni a Luca, anch’ella fornì sostegno economico alla sua causa aiutandolo, nel 1111, nella fondazione del monastero di Monte Vioterito.
A Bartolomeo, invece, fece larghe concessioni sicché, nel 1105, egli ottenne da Papa Pasquale II la conferma della protezione della Chiesa del Patirion di Rossano: un atto dalle rilevanti implicazioni politiche, poiché il monachesimo italo/greco veniva a porsi come trait-d’union fra gli Hauteville ed il cenobitismo basiliano che, in linea di continuità, Ruggero II sottopose al patronato giuridico e politico della Corona, ordinando la costruzione del convento del SS. Salvatore di Messina: iniziato nel 1122 e terminato nel 1132.
Fu durante il periodo di reggenza che redasse ciò che oggi è conosciuto come il documento cartaceo più antico d’Europa. È il cosiddetto “Mandato di Adelasia”, scritto nel 1109. Si tratta di un documento bilingue, in greco nella sezione superiore e in arabo in quella inferiore, con cui si ordinava ai vicecomitali della terra di Castrogiovanni di proteggere il monastero di San Filippo di Demenna, sito nella valle di San Marco. Adelasia adottò la carta perché non si trattava di un diploma o di un privilegio ufficiale, per i quali veniva adoperata la più solenne pergamena, ma piuttosto di un atto di natura transitoria. L’uso della carta era già stato mediato dal mondo arabo. Il documento, prima conservato presso l’abbazia di San Filippo di Fragalà, venne poi acquistato dall’Archivio di Stato di Palermo, dove si trova tuttora
Sul finire del 1112, quando il figlio ebbe assunto le responsabilità ereditarie, la vanità femminile della quarantenne Adelasia fu gratificata dalla proposta matrimoniale del Re di Gerusalemme Baldovino I di Fiandra, fratello di Goffredo di Bouillon: attratto più dalla consistenza patrimoniale che dalla avvenenza della vedova, egli si impegnava alla clausola di cedere il proprio trono al Conte di Sicilia e Calabria, ove nessuna nascita avesse allietato quelle nozze. Clausola su cui si basarono le pretese di Ruggero e dei suoi discendenti su Gerusalemme, che venne esaltata e celebrata nelle loro tombe.
o spregiudicato Sovrano aveva già sposato Arda, figlia del Conte di Edessa, per garantirsi il sostegno politico/militare degli Armeni nel caso di un’aggressione turca ai suoi territori. Diventato Re di Gerusalemme, ella non gli era più utile e, dopo averla confinata nel locale convento di Sant’Anna con la surrettizia accusa di immoralità, sollecitava l’annullamento del vincolo. Di fatto, il collasso finanziario ed il rischio che gli Egiziani riconquistassero la Città Santa, lo avevano orientato verso la madre del già potente Ruggero II di Sicilia.
Il progetto, pur condiviso dalla sua âme damnée: il Patriarca Arnoldo Malecorno, era ostacolato dalla circostanza che Arda, nel frattempo fuggita a Costantinopoli, fosse ancora viva; che nessuna disposizione pontificia si prestasse a quelle mire e che il mai giuridicamente cessato connubio esponesse Baldovino ad una condizione di conclamata bigamia. Pertanto, l’ambasceria inviata nell’isola sollecitò Adelasia a sfruttare le sue strette relazioni di amicizia con la Chiesa, onde ottenerne il consenso alla seconda unione, previo lo scioglimento della prima.
Ignara dell’avidità dell’aspirante marito, ella si prestò e nell’estate del 1113 si imbarcò per l’Oriente: il figlio aveva allestito una flotta imponente per dare un segnale della sua potenza e per degnamente scortarla col suo tesoro di gioielli, oro, pietre, argenti, stoffe, tessuti preziosi, armi ed un corpo scelto di arcieri siculo/arabi. Il Sovrano l’attendeva a San Giovanni d’Acri, assieme ad una folla traboccante d’entusiasmo e testimone della sfarzosa cerimonia officiata da Arnoldo.
Il farsesco legame, che l’Episcopato gerosolimitano continuava a ritenerlo nullo, entrò presto in crisi: dopo aver concorso ad incamerare i beni della sposa, Arnoldo aveva preso ad insinuare nel Re la situazione canonica di una presunta parentela coniugale, in contrasto con le norme vigenti. Il Papa aprì un’inchiesta e, approfondita la vicenda, depose il Patriarca che, recatosi tuttavia a Roma nel luglio del 1116, riottenne la reintegra nell’incarico, previo impegno a stroncare la scandalosa relazione.
Gli eventi precipitarono quando, al ritorno da una spedizione militare a Wâdî ‘Araba nel marzo del 1117, gravemente ammalato ed assalito dai rimorsi, nel presunto punto di morte proprio Baldovino chiese al confessore di richiamare Arda e cacciare Adelasia. Se l’una ignorò la supplica, l’altra, il venticinque aprile, a fronte della nullità nuziale pronunciata a Tolemaide da un sinodo presieduto da Arnoldo, umiliata tornò in Sicilia portando con sé per la prima volta in suolo italiano i religiosi che seguivano la regola dell’Ordine della Beata Vergine del Monte Carmelo, i cosiddetti Carmelitani – ordine religioso sorto in Terra Santa – ai quali si era legata ancora di più in seguito alle sofferenze derivate dalla separazione matrimoniale
Secondo la leggenda, il dolore le provocò la lebbra e si salvò dalla malattia per un miracolo, bagnandosi nella dove sant’Agatone aveva battezzato Febronia, patrona di Patti. E’ certo invece che si ritirasse nel convento benedettino della città, dove morì nel 1118.
Inizialmente fu sepolta nel convento; nel 1122, l’abate Giovanni ordinò la costruzione del sarcofago reale. Successivamente fu migrato nella cattedrale e nel 1557 fu sostituito con uno in stile rinascimentale che raffigura dormiente la splendida tribolata sovrana, celebrata dall’iscrizione
HIC JACET CORPUS NOBILIS DNE ANDILASIE REGINAE MULIERIS SERENISSIMI DNI ROGERII PRIMI REGIS SICILIE CVIVS ANIMA PER MISERICORDIAM DEI REQUIESCAT IN PACE AMEM MCXVIII
Writing in Neolithic China?
In this post we present selected parts of the very interesting and informative paper titled “The Origins of Chinese Writing: the Neolithic Evidence“, by Paola Demattè.
View original post 2.962 altre parole
Fantapolitica, capi carismatici e autoritari e “Progetto NO”
Si parla de Il Canto Oscuro (e non me ne ero accorto)
Le opere di letteratura distopiche possono dar corpo (carta) ad una ipotetica società del futuro in cui si scorgono facilmente caratteristiche della situazione presente spesso degenerate, oppure far riferimento a fatti accaduti e persone esistenti immaginandone risvolti o mosse non ancora rivelate, o descrivere dichiaratamente l’evoluzione futura di una situazione politica attuale.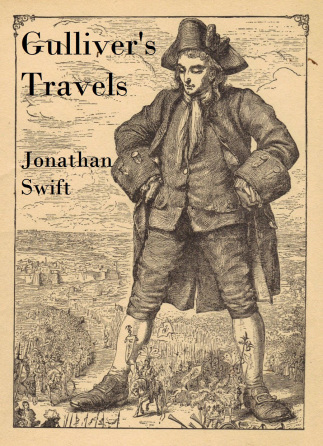
Invece l’esempio classico di romanzo di fantapolitica ambientato in un mondo immaginario, di chiaro significato allegorico finalizzato alla stigmatizzazione satirica e moraleggiante di vizi e difetti ampiamente diffusi nella società, è “I viaggi di Gulliver” di Jonathan Swift, del 1726, parodia della narrativa avventurosa di viaggio, di moda all’epoca, ma anche opera in cui il mascheramento fantasioso dell’intento satirico tradisce però, agli occhi dei lettori adulti (inizialmente il romanzo era considerato di letteratura per ragazzi) un deciso pessimismo circa le possibilità di miglioramento degli esseri umani. È fantapolitica satirica ed apocalittica (per il finale) “
View original post 2.124 altre parole
August 8, 2019
Sinagoghe, San Paolo e Giufà
A dire il vero, la prima testimonianza di una comunità ebraica nella chora di Rhegion non è la sinagoga di Bova Marina, ma un piccolo frammento di marmo, alto 14,5 cm, largo 16,7 e spesso cm 2,2, che passa quasi inosservato nel grande Museo della Magna Grecia.
Frammento in cui, con lettere alte poco meno di 3 cm, è presente una scritta in greco ΙΟΥΔΑΙΩΝ, Iuodaion ossia Giudei.
Esaminando attentamente la lapide, si nota ancora chiara sopra le ultime tre lettere della prima riga, la traccia inferiore delle lettere ΩΝ. Il Ferrua che la studiò e pubblicò per primo ha integrato la scritta in questo modo: [ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΩΝ] ΙΟΥΔΑΙΩΝ, [Synagogé ton] Ioudaion ossia La sinagoga dei Giudei
Ferrua è convinto che l’epigrafe doveva fingere da insegna, da Titulus, della sinagoga degli ebrei di Reggio Calabria. Purtroppo il luogo del rinvenimento dell’epigrafe non ci aiuta ad avere maggiori informazioni sulla collocazione della comunità ebraica reggina. Infatti, il titolo ebraico fu rinvenuto in uno degli scarichi di materiale, dopo il sisma del 1908 che distrusse la città reggina. I dati paleografici ci attesterebbero che l’epigrafe può risalire alla prima metà del secolo IV d.C.
In ogni caso, anche se l’epigrafe non fosse riferita alla sinagoga, è una testimonianza dell’esistenza, nel Tardo Impero Romano, di una comunità ebraica, probabilmente legata alla presenza del porto di Reggio, che proprio dall’età tetrarchica in poi vive una seconda giovinezza.
Una testimonianza importante ci viene dal libro degli Atti degli Apostoli, dove viene narrato il viaggio di San Paolo da Gerusalemme a Roma, per essere giudicato dal tribunale imperiale. Dopo essere naufragato a Malta e svernato in attesa delle bella stagione, prima fece sosta a Siracusa, poi,
“Circumlegentes Devenimus Rhegium”.
La sosta a Reggio consentì all’apostolo di predicare, per la sua prima volta in Italia, alla folla radunata per il festeggiamento della dea Diana nel santuario di Artemide Fascelide sul promontorio di Calamizzi; trascurando tutte le leggende fiorite sull’episodio, date le abitudine paoline, era assai probabile che tra i suoi ascoltatori vi fossero giudei ellenizzanti.
Altro dato importante è la lingua dell’iscrizione, il greco, che implica come questo fosse comunemente parlato sino all’epoca costantiniana, il che è un forte indizio di una continuità che dai tempi dell’Ellade porta all’attuale Grecanico.
Altra importante testimonianza della presenza ebraica a Reggio e in generale della sua dimensione multiculturale è legata alla figura folkloristica di Giufà, testimonianza della capacità delle storie di mutare forma, pur rimanendo sempre uguali.
Nel corpus dei racconti vi è sicuramente un substrato di origine pre islamica, visto le somiglianze con quelle associate alla figura di al-Khidr, a cui, tramite la mediazione persiana, ai tempi degli Abbasidi si sovrappose una componente di orgine indiana.
Questo insieme di racconti si diffuse in tutti i paesi del dār al-Islām, assumendo a seconda del luogo, caratteristiche peculiari: ad esempio, nelle zone turcofone, fu associato al maestro sufi Nasreddin Khoja che dovrebbe essere nato nacque nell’anno 605 dell’Egira e che era un grande amico del mistico e poeta Rûmî.
Nei paesi del del Maghreb e nell’Ifriqiya il ciclo narrativo fu invece associato a Djehà (pron. giuhà). Con la conquista aghlabita, le storie giunsero in Sicilia e da quello che riusciamo a capire dell’evoluzione del dialetto arabo di Balarm, simile a quanto avvenuto in Al-Andalus, Giuhà divenne Giufa e per un fenomeno di acculturazione, entrò nel patrimonio folcloristico delle comunità ebraiche spagnole e palermitane
Comunità che aggiunsero un ulteriore componente alla narrazione, visto che alcune storie di Giufa sono molto simili a quelle che a seconda dell’area geografica di provenienza, gli ebrei ambientavano alle città di Chelm, di Schilda, di Campli e di Cuneo.
Giufà giunse poi a Reggio, seguendo due strade parallele: la prima, ovviamente, legata alla comunità ebraica, la seconda, meno ovvia, tramite i profughi islamici di obbedienza sunnita, che mal sopportavano il dominio fatimide di obbedienza sciita.
Alcuni studi hanno evidenziato come circa il 20% della popolazione della zona di Rhegion dell’epoca avesse un’onomastica di origine araba, cosa che spiegherebbe sia l’insistenza da parte degli emiri di Sicilia per l’apertura di una moschea in quella città, sia le lunghe disposizioni sui matrimoni misti emanate dal patriarca Fozio per i sudditi italiani.
Giufà a Reggio divenne un ossimoro: caltro e sciocco, abile e pasticcione, coraggioso e vigliacchetto, laborioso ed infingardo, sincero e bugiardo, pronto ad assumere connotazioni diverse a seconda delle circostanze e amare, ricambiato, la fata Morgana…
August 7, 2019
Rebab, Rabab,Viole e Ribeca
Pochi conoscono al-Farabi ed è un vero peccato, perchè si tratta di uno dei rari geni universali della storia umana: fu filosofo, uno dei primi a sviluppare una logica alternativa a quella aristotelica, psicologo, esaltando le facoltà dell’immaginazione come base dell’intelletto attivo, sociologo e politologo, riscrisse in chiave islamica la Repubblica di Platone, mistico sufi e musicologo, inventando un buon numero di strumenti musicali e il sistema tonale ancora in uso nella musica tradizionale araba.
Al-Farabi era un appassionato suonatore di rebab, strumento ad arco forse inventato in Afghanistan intorno all’Ottavo secolo, l’equivalente islamico della lira bizantina, sia per la longevità, sia per la sua enorme capacità di generare varianti: nell’Asia di sud-est, infatti il rebab è un grosso strumento simile alla viola da gamba mentre spostandosi verso ovest gli strumenti tendono ad essere più piccoli e dal suono più acuto.
Nella versione afghana, quella più vicina all’originale, il rebab ha una cassa armonica lunga e stretta, ricavata da un unico pezzo di legno, da cui deriva anche il manico, ed è fornito da tre o quattro corde, di cui una doppia, che vibra in simpatia con la compagna accordate di quinta, che si suonano pizzicandolo.
In particolare, in Egitto, è presente una versione chiamata rabab, a due corde, dalla forma stretta e convessa, suonato con un arco, in un modo assai simile a quello comunemente conosciuto per suonare il contrabbasso europeo.
Il rebab ha un’importanza fondamentale, anche se misconosciuta della storia della musica europea: in Al-Andalus, la Spagna islamica, si era sviluppata una peculiare versione di questo strumento, dal corpo allungato e sottile con lati rettilinei divergenti ed estremità inferiore arrotondata, cavigliere fortemente angolato, due corde, e una netta divisione fra le due parti del piano armonico, l’inferiore in pergamena e la superiore in legno con rosette ornamentali.
Con la Reconquista, il rebab, a quanto pare il Cid ne era un appassionato suonatore, nella zona di Valencia subì un’ulteriore evoluzione: si allungò ulteriormente, sono a superare il mezzo metro, con un’unica rosetta più grande che andava a sostituire le diverse aperture precedenti, il cavigliere che venne prendendo una forma a falcetto con una testa di animale scolpita, spesso un leone. Anche il numero di corde aumentò passando da tre, a sei corde, mantenendo però la forma piatta del ponticello, al quale esse venivano fissate. Dato che le taglie erano molto diverse anche l’accordatura poteva variare. L’estensione non poteva andare oltre a una nona maggiore. Il rebab valenziano veniva suonato verticalmente, in due modi differenti: in alcuni casi, le sue corde venivano pizzicate, in altri, invece, si usava l’archetto.
Sempre a Valencia, dal rebab pizzicato, che aveva la cassa armonica lievemente più ampia dell’altro, nacque la vihuela de mano, o come fu chiamata in Italia “viola da mano”, uno strumento di forma ampia e dai fianchi con rientranze, e con corde che venivano pizzicate. La successiva evoluzione avvenne in Sicilia, nell’ambito della corte dei Chiaramonte, in cui un intraprendente musicista, decise di suonarla come un liuto.
In parallelo, il rebab suonato con l’archetto, accogliendo alcune influenze della viella provenzale, sempre a Valencia, si trasformò nella vihuela de arco o viola d’arco, più piccole quelle della vihuela de mano, con manico lungo e sottile, con cavigliere ad angolo e rientranze a spigolo; inoltre, questo strumento continuava a essere suonato in posizione verticale.
Una contemporanea evoluzione avveniva intanto nel regno di Castiglia, in cui il rebab dava origine alla ribeca, la cui cassa aveva la foggia di una mezza pera che si prolungava nel manico, su cui si trova la tastiera. Come nell’antenato islamico, a cassa dello strumento non era assemblata unendo più liste di legno opportunamente sagomate, bensì ricavata in un pezzo unico insieme al manico, scavando un singolo blocco di legno massiccio. Costruita con legno piuttosto duro, la ribeca acveva la tavola armonica piana su cui erano praticati due fori a forma semicircolare. Lo strumento aveva da due a cinque corde, accordate per intervalli di quinta, sempre suonate tramite un archetto.
Ora grazie ad Alfonso d’Aragona, che conquistò il regno di Napoli, e introdusse la vihuela de mano e vihuela de arco e ai Borgia, che le portarono a Roma e le utilizzarono nelle prestigiose cappelle pontificie, i due strumenti ebbero un enorme successo: la vihuela de mano divenne il capostipite della grande famiglia delle chitarre, mentre vihuela de arco, come si può bene immaginare fu l’antenato dei violini e delle viole.
Invece per il matrimonio tra Enrico VIII e Caterina d’Aragona, la ribeca ebbe invece un enorme successo in Inghilterra, per essere poi progressivamente sostituita dal violino ai tempi degli Stuart.
August 6, 2019
La sinagoga di Bova Marina
[image error]
Anche quest’anno, con un poco di difficoltà, a causa delle rogne di lavoro, riesco a scendere a Rhegion, terra dalle infinite anime: se spesso ha parlato delle sue radici greca, in questi giorni parlerò invece di quelle ebraiche, assai meno note. Secondo una leggenda, infatti, Rhegion fu fondata da Aschenez, pronipote di Noé.
Il mio viaggio comincia a Bova Marina, che probabilmente ai tempi dell’Impero Romano coincideva con l’antica Scyle, stazione di sosta e di servizio sulla strada costiera che congiungeva Reggio con Crotone e Taranto, di cui è rimasta memoria a livello topografico nel toponimo Pagliopoli (in greco: la città antica) localizzato nella vallata dove nel 1985, nella contrada Deri, alla foce della fiumara San Pasquale, i lavori per la realizzazione di una delle tanti varianti della Statale 106 Jonica portarono alla luce i resti di una sinagoga tardo-romana, la seconda più antica d’Italia dopo quella di Ostia Antica.
L’edificio faceva parte di un insediamento derivato dall’evoluzione di una villa romana sorta probabilmente nel II secolo d.C. All’inizio del IV secolo, forse come conseguenza della guerra civile tra Massenzio e Costantino, il proprietario era probabilmente un senatore schierato dalla parte del primo contendente, la parte residenziale fu abbandonata, mentre la pars rustica aumento di popolazione ed estensione, diventando un vicus autonomo.
Lo scavo della sinagoga ha permesso di distinguere tre diversi complessi di ambienti. Il complesso centrale ha orientamento NW-SE e si articola in una sequenza di due aule affiancate da tre vani rettangolari, ai quali si aggiungono altri ambienti, forse di servizio. La pavimentazione musiva e la presenza di una nicchia, destinata verosimilmente al Sefer Torah, indicano nell’aula quadrata interna (m 7×6) l’ambiente centrale del complesso. Tra i vari motivi decorativi del mosaico, spicca un candelabro a sette bracci eseguito secondo i dettami biblici (Esodo 25,31-37). Esso è affiancato da altri simboli giudaici: sul lato destro da un cedro e da un lulav, un ramo verde di palma (il ramo che cresce al suo centro) utilizzato durante il Sukot,sul sinistro dallo shofar, uno strumento a fiato ricavato dal corno dell’ariete, suonato in occasione di Rosh haShana, il capodanno religioso ebraico, e del digiuno di Yom Kippur.
La sinagoga comunicava con un vano, pavimentato in laterizi, che potrebbe essere identificato con un cortile, o altro ambiente, destinato a scuola oppure ad ospizio di viaggiatori e poveri. Nell’angolo Est dell’edificio è stato ritrovato un dolio, utilizzato probabilmente come ripostiglio (genizah) per paramenti e oggetti liturgici disusati. Al suo interno c’erano frammenti vitrei e sette reggistoppino in piombo, che facevano certamente parte del lampadario che illuminava la sinagoga, e un gancio per sospensione in bronzo. Nello scavo sono stati trovate anche tre anse di anfore (tipo Keay LII) con bollo impresso raffigurante la menorah.
In un ambiente attiguo al complesso sinagogale è venuto alla luce un altro dolio infossato nel terreno, al cui interno, racchiuso in una brocchetta acroma, è stato rinvenuto un tesoretto di 3079 monete bronzee di piccolo valore riferibili per la maggior parte all’inizio del V secolo d. C. Le monete rappresentano verosimilmente, come in casi analoghi, il tesoretto della comunità messo insieme con le offerte dei fedeli. Gli scavi hanno individuato anche due aree sepolcrali, appartenenti a due fasi successive della vita dell’insediamento, che vide nella seconda fase anche una ristrutturazione del complesso sinagogale. Nell’aula, infatti, fu aggiunta un’abside destinata alla custodia permanente dei rotoli della Torah; davanti fu posato un nuovo mosaico di fattura diversa e più modesta, a testimonianza del possibile impoverimento della comunità, a seguito di una probabile razzia vandala.
In una tomba della necropoli più antica è stata rinvenuta una moneta dell’imperatore Arcadio. consunta dall’uso. Il che, come testimonia una legge, relativa all’occupazione abusiva di edifici statali ad opera di privati, che fu voluta dallo stesso, regnante a Costantinopoli, ma venne promulgata a Rhegiom, fa pensare che in zoina si sentissero più sudditi d’Oriente, che di Occidente.
Sia per quanto emerso dagli scavi nella necropoli, sia per l’assenza della chiesa cristiana, è probabile che la popolazione di Scyle fosse principalmente di religione ebraica. Su quando il vicus sia stato abbandonato, vi sono diverse ipotesi: la datazione bassa la inquadra ai tempi della riconquista di Giustiniano, come conseguenza delle sue leggi anti ebraiche, che avrebbero portato alla chiusura della sinagoga e alla trasformazione del complesso in un’area sepolcrare. La media data tutto ai tempi di Eraclio, che a seguito della rivolta di Gerusalemme, ordinò una persecuzione anti ebraica. La tarda e meno probabile, ipotizza invece come l’abbandono del vicus avvenga nel IX secolo, come conseguenza della ridistribuzione della popolazione rurale dalla costa alle motte dell’interno, più facilmente difendibili dalle incursioni saracene.
Alessio Brugnoli's Blog







