Andrea Viscusi's Blog: Unknown to Millions, page 31
November 14, 2017
Coppi Night 05/11/2017 - Ratatouille
Ma come, non avevi visto Ratatouille? No, non l'avevo visto. Se è per quello non ho mai visto nemmeno Apocalypse Now o Citizen Kane. Un po' alla volta cercheremo di rimediare, e a questo giro è toccato a uno dei primi film Pixar di successo.
Ratatouille, manco a dirlo, segue una ricetta perfetta. È scritto seguendo il più classico dei manuali di sceneggiatura, rispetta una struttura tipica e riconoscibile, crea conflitti e li risolve, rende i personaggi relatable e ci fa empatizzare con loro. Le tematiche di fondo sono comuni a tutti, e valgono per entrambi i protagonisti, bipedi e quadrupedi: l'inadeguatezza, la ricerca di un proprio ruolo in un mondo che sembra già assegnarcene uno, il tradimento delle aspettative di chi abbiamo intorno. In più, tratta un argomento non molto seguito dal cinema (la cucina), e riesce lungo il percorso a essere abbastanza divertente.
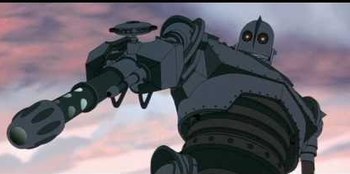 Quindi c'è poco da dire su un film del genere, che nella sua semplicità (intesa come aderenza ai principi base della cinematografia) funziona al meglio su tutti i fronti. No, ok, una cosa da dire ce l'ho: la sceneggiatura è stata scritta da Brad Bird, autore di diversi altri film di grande successo, come Gli Iincredibili (anche questo mi manca), Tomorrowland alcune puntate dei Simpson, e soprattutto
Il gigante di ferro
, che è una delle opere d'animazione che è stata capace di farmi piangere. Ora, vedendo quest'ultimo film si possono notare diverse affinità con Ratatouille. Per esempio, quali sono i temi di fondo nel Gigante di ferro, che riguardano sia i protagonisti organici che quelli meccanici? Così a naso direi l'inadeguatezza, la ricerca di un proprio ruolo in un mondo che sembra... ehi, ma è la stessa cosa del topo cuoco!
Quindi c'è poco da dire su un film del genere, che nella sua semplicità (intesa come aderenza ai principi base della cinematografia) funziona al meglio su tutti i fronti. No, ok, una cosa da dire ce l'ho: la sceneggiatura è stata scritta da Brad Bird, autore di diversi altri film di grande successo, come Gli Iincredibili (anche questo mi manca), Tomorrowland alcune puntate dei Simpson, e soprattutto
Il gigante di ferro
, che è una delle opere d'animazione che è stata capace di farmi piangere. Ora, vedendo quest'ultimo film si possono notare diverse affinità con Ratatouille. Per esempio, quali sono i temi di fondo nel Gigante di ferro, che riguardano sia i protagonisti organici che quelli meccanici? Così a naso direi l'inadeguatezza, la ricerca di un proprio ruolo in un mondo che sembra... ehi, ma è la stessa cosa del topo cuoco!
Esatto, ci troviamo con due storie che hanno un tema di fondo praticamente identico, eppure sfido chiunque a dire che siano uguali tra loro, o a sostenere che una volta visto Il gigante di ferro, non c'è nessuna ragione per guardare Ratatouille e viceversa. Tutto questo come efficace esempio di come sia possibile raccontare la stessa storia, trasmettere lo stesso messaggio, in modi diversi e sempre validi, mantenendo potenzialmente all'infinito l'interesse e l'intrattenimento dello spettatore. È una bella lezione di tecnica narrativa mi è balzata davanti, forse per via del mio interessamento recente all'aspetto teorico di questa disciplina.
Lo so, è una digressione totalmente slegata dal contenuto del film, ma d'altra parte quando si parla di un lavoro universalmente conosciuto e apprezzato, non avrei comunque molto da aggiungere ai chilometri di post e giorni di conversazioni già esistenti.
Ratatouille, manco a dirlo, segue una ricetta perfetta. È scritto seguendo il più classico dei manuali di sceneggiatura, rispetta una struttura tipica e riconoscibile, crea conflitti e li risolve, rende i personaggi relatable e ci fa empatizzare con loro. Le tematiche di fondo sono comuni a tutti, e valgono per entrambi i protagonisti, bipedi e quadrupedi: l'inadeguatezza, la ricerca di un proprio ruolo in un mondo che sembra già assegnarcene uno, il tradimento delle aspettative di chi abbiamo intorno. In più, tratta un argomento non molto seguito dal cinema (la cucina), e riesce lungo il percorso a essere abbastanza divertente.
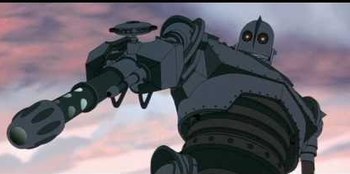 Quindi c'è poco da dire su un film del genere, che nella sua semplicità (intesa come aderenza ai principi base della cinematografia) funziona al meglio su tutti i fronti. No, ok, una cosa da dire ce l'ho: la sceneggiatura è stata scritta da Brad Bird, autore di diversi altri film di grande successo, come Gli Iincredibili (anche questo mi manca), Tomorrowland alcune puntate dei Simpson, e soprattutto
Il gigante di ferro
, che è una delle opere d'animazione che è stata capace di farmi piangere. Ora, vedendo quest'ultimo film si possono notare diverse affinità con Ratatouille. Per esempio, quali sono i temi di fondo nel Gigante di ferro, che riguardano sia i protagonisti organici che quelli meccanici? Così a naso direi l'inadeguatezza, la ricerca di un proprio ruolo in un mondo che sembra... ehi, ma è la stessa cosa del topo cuoco!
Quindi c'è poco da dire su un film del genere, che nella sua semplicità (intesa come aderenza ai principi base della cinematografia) funziona al meglio su tutti i fronti. No, ok, una cosa da dire ce l'ho: la sceneggiatura è stata scritta da Brad Bird, autore di diversi altri film di grande successo, come Gli Iincredibili (anche questo mi manca), Tomorrowland alcune puntate dei Simpson, e soprattutto
Il gigante di ferro
, che è una delle opere d'animazione che è stata capace di farmi piangere. Ora, vedendo quest'ultimo film si possono notare diverse affinità con Ratatouille. Per esempio, quali sono i temi di fondo nel Gigante di ferro, che riguardano sia i protagonisti organici che quelli meccanici? Così a naso direi l'inadeguatezza, la ricerca di un proprio ruolo in un mondo che sembra... ehi, ma è la stessa cosa del topo cuoco!Esatto, ci troviamo con due storie che hanno un tema di fondo praticamente identico, eppure sfido chiunque a dire che siano uguali tra loro, o a sostenere che una volta visto Il gigante di ferro, non c'è nessuna ragione per guardare Ratatouille e viceversa. Tutto questo come efficace esempio di come sia possibile raccontare la stessa storia, trasmettere lo stesso messaggio, in modi diversi e sempre validi, mantenendo potenzialmente all'infinito l'interesse e l'intrattenimento dello spettatore. È una bella lezione di tecnica narrativa mi è balzata davanti, forse per via del mio interessamento recente all'aspetto teorico di questa disciplina.
Lo so, è una digressione totalmente slegata dal contenuto del film, ma d'altra parte quando si parla di un lavoro universalmente conosciuto e apprezzato, non avrei comunque molto da aggiungere ai chilometri di post e giorni di conversazioni già esistenti.
Published on November 14, 2017 02:27
November 9, 2017
Rapporto letture - Ottobre 2017
Considerando che ho passato la prima metà del mese in giro per siti Maya, penso che due letture totalizzate siano un buon risultato. Una delle due è peraltro un libro che mi ero promesso di iniziare da diversi anni.
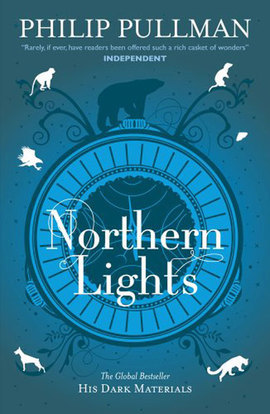 Sto parlando de La bussola d'oro, o come da titolo originale
Northern Lights
, il primo libro della trilogia His Dark Materials di Philip Pullman. Avevo sentito consigliare questo libro spesso, come esempio virtuoso di young adult scritto quando ancora questo termine non esisteva, e che unisce alla classica storia di formazione temi profondi sull'autoderminazione e il potere della religione. Non avendo nemmeno visto il film mi sono approcciato senza nessuna aspettativa, e sono rimasto prima di tutto folgorato dalla ricchezza dell'ambientazione. Il mondo alternativo in cui si svolge la storia, chiaramente una Terra che non è la nostra Terra, è carico di particolari interessanti: la tecnoogia, le materie di studio, gli orsi corazzati, le streghe, e soprattutto i daemon. Quello del compagno animale legato alla propria anima, una sorta di totem vivente mutaforma, è una delle idee più formidabili che mi sia capitato di leggere ultimamente. Mentre scrivo questo commento ho da poco finito di leggere anche il secondo volume della raccolta, quindi so già molto più sull'arco narrativo completo di quando ho finito Northern Lights, tuttavia posso dire che il viaggio di Lyra mi ha catturato e trascinato, anche se non sono riuscito a entrare in completa sintonia con la giovane protagonista. Per quanto determinata e brillante, in molti casi mi è sembrata motivata solo dal suo capriccio, o forse dalla profezia che si porta addosso. Questo però non toglie niente alla bellezza del percorso, mi sono trovato letteralmente attaccato alle pagine per scoprire di più su quel mondo e sapere come finisce. E qui arriva il secondo problema, perché Northern Lights non finisce, quindi è difficile da valutare per sé. Al netto quindi di quanto so già dal secondo libro, devo comunque limitarmi a un voto 7/10 per la piacevolezza di un viaggio di cui ancora non so la destinazione.
Sto parlando de La bussola d'oro, o come da titolo originale
Northern Lights
, il primo libro della trilogia His Dark Materials di Philip Pullman. Avevo sentito consigliare questo libro spesso, come esempio virtuoso di young adult scritto quando ancora questo termine non esisteva, e che unisce alla classica storia di formazione temi profondi sull'autoderminazione e il potere della religione. Non avendo nemmeno visto il film mi sono approcciato senza nessuna aspettativa, e sono rimasto prima di tutto folgorato dalla ricchezza dell'ambientazione. Il mondo alternativo in cui si svolge la storia, chiaramente una Terra che non è la nostra Terra, è carico di particolari interessanti: la tecnoogia, le materie di studio, gli orsi corazzati, le streghe, e soprattutto i daemon. Quello del compagno animale legato alla propria anima, una sorta di totem vivente mutaforma, è una delle idee più formidabili che mi sia capitato di leggere ultimamente. Mentre scrivo questo commento ho da poco finito di leggere anche il secondo volume della raccolta, quindi so già molto più sull'arco narrativo completo di quando ho finito Northern Lights, tuttavia posso dire che il viaggio di Lyra mi ha catturato e trascinato, anche se non sono riuscito a entrare in completa sintonia con la giovane protagonista. Per quanto determinata e brillante, in molti casi mi è sembrata motivata solo dal suo capriccio, o forse dalla profezia che si porta addosso. Questo però non toglie niente alla bellezza del percorso, mi sono trovato letteralmente attaccato alle pagine per scoprire di più su quel mondo e sapere come finisce. E qui arriva il secondo problema, perché Northern Lights non finisce, quindi è difficile da valutare per sé. Al netto quindi di quanto so già dal secondo libro, devo comunque limitarmi a un voto 7/10 per la piacevolezza di un viaggio di cui ancora non so la destinazione.
 Come defaticamento prima di passare a The Subtle Knife, ho scelto uno degli ultimi titoli di Future Fiction, nello specifico il piiù recente autore italiano pubblicato... me escluso. Nicoletta Vallorani è un'autrice d'esperienza, che si è occupata di generi diversi e in Il catalogo delle vergini affronta in tre racconti diversi un tema comune, quello dello sfruttamento, in particolare delle donne e del loro corpo. Le tre storie sono indipendenti tra loro, ma si capisce che si svolgono nello stesso futuro vicino e difficilmente definibile distopico, nel senso che oggi ci sono già tutti gli indizi che potrebbero portarci a un futuro del genere, senza bisogno di catastrofi, guerre o dittatori. Donne senza identità, senza vita, o alle quali tutto ciò viene sottratto, e che trovano riscatto solo combattendo con gli stessi mezzi che dovrebbero renderle schiave. Se c'è un appunto che posso fare è che alcune parti sono fin troppo raccontate, quasi come la narrazione introduttiva di un film, e si fatica a capire quello che sta accadendo ora all'interno della toria. La qualità e drammaticità della scrittura compensa comunque questi momenti di azione sospesa, e la lettura rimane quindi densa di suggestioni. Voto: 7/10
Come defaticamento prima di passare a The Subtle Knife, ho scelto uno degli ultimi titoli di Future Fiction, nello specifico il piiù recente autore italiano pubblicato... me escluso. Nicoletta Vallorani è un'autrice d'esperienza, che si è occupata di generi diversi e in Il catalogo delle vergini affronta in tre racconti diversi un tema comune, quello dello sfruttamento, in particolare delle donne e del loro corpo. Le tre storie sono indipendenti tra loro, ma si capisce che si svolgono nello stesso futuro vicino e difficilmente definibile distopico, nel senso che oggi ci sono già tutti gli indizi che potrebbero portarci a un futuro del genere, senza bisogno di catastrofi, guerre o dittatori. Donne senza identità, senza vita, o alle quali tutto ciò viene sottratto, e che trovano riscatto solo combattendo con gli stessi mezzi che dovrebbero renderle schiave. Se c'è un appunto che posso fare è che alcune parti sono fin troppo raccontate, quasi come la narrazione introduttiva di un film, e si fatica a capire quello che sta accadendo ora all'interno della toria. La qualità e drammaticità della scrittura compensa comunque questi momenti di azione sospesa, e la lettura rimane quindi densa di suggestioni. Voto: 7/10
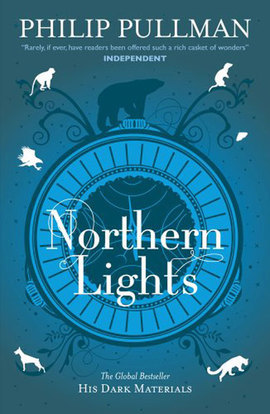 Sto parlando de La bussola d'oro, o come da titolo originale
Northern Lights
, il primo libro della trilogia His Dark Materials di Philip Pullman. Avevo sentito consigliare questo libro spesso, come esempio virtuoso di young adult scritto quando ancora questo termine non esisteva, e che unisce alla classica storia di formazione temi profondi sull'autoderminazione e il potere della religione. Non avendo nemmeno visto il film mi sono approcciato senza nessuna aspettativa, e sono rimasto prima di tutto folgorato dalla ricchezza dell'ambientazione. Il mondo alternativo in cui si svolge la storia, chiaramente una Terra che non è la nostra Terra, è carico di particolari interessanti: la tecnoogia, le materie di studio, gli orsi corazzati, le streghe, e soprattutto i daemon. Quello del compagno animale legato alla propria anima, una sorta di totem vivente mutaforma, è una delle idee più formidabili che mi sia capitato di leggere ultimamente. Mentre scrivo questo commento ho da poco finito di leggere anche il secondo volume della raccolta, quindi so già molto più sull'arco narrativo completo di quando ho finito Northern Lights, tuttavia posso dire che il viaggio di Lyra mi ha catturato e trascinato, anche se non sono riuscito a entrare in completa sintonia con la giovane protagonista. Per quanto determinata e brillante, in molti casi mi è sembrata motivata solo dal suo capriccio, o forse dalla profezia che si porta addosso. Questo però non toglie niente alla bellezza del percorso, mi sono trovato letteralmente attaccato alle pagine per scoprire di più su quel mondo e sapere come finisce. E qui arriva il secondo problema, perché Northern Lights non finisce, quindi è difficile da valutare per sé. Al netto quindi di quanto so già dal secondo libro, devo comunque limitarmi a un voto 7/10 per la piacevolezza di un viaggio di cui ancora non so la destinazione.
Sto parlando de La bussola d'oro, o come da titolo originale
Northern Lights
, il primo libro della trilogia His Dark Materials di Philip Pullman. Avevo sentito consigliare questo libro spesso, come esempio virtuoso di young adult scritto quando ancora questo termine non esisteva, e che unisce alla classica storia di formazione temi profondi sull'autoderminazione e il potere della religione. Non avendo nemmeno visto il film mi sono approcciato senza nessuna aspettativa, e sono rimasto prima di tutto folgorato dalla ricchezza dell'ambientazione. Il mondo alternativo in cui si svolge la storia, chiaramente una Terra che non è la nostra Terra, è carico di particolari interessanti: la tecnoogia, le materie di studio, gli orsi corazzati, le streghe, e soprattutto i daemon. Quello del compagno animale legato alla propria anima, una sorta di totem vivente mutaforma, è una delle idee più formidabili che mi sia capitato di leggere ultimamente. Mentre scrivo questo commento ho da poco finito di leggere anche il secondo volume della raccolta, quindi so già molto più sull'arco narrativo completo di quando ho finito Northern Lights, tuttavia posso dire che il viaggio di Lyra mi ha catturato e trascinato, anche se non sono riuscito a entrare in completa sintonia con la giovane protagonista. Per quanto determinata e brillante, in molti casi mi è sembrata motivata solo dal suo capriccio, o forse dalla profezia che si porta addosso. Questo però non toglie niente alla bellezza del percorso, mi sono trovato letteralmente attaccato alle pagine per scoprire di più su quel mondo e sapere come finisce. E qui arriva il secondo problema, perché Northern Lights non finisce, quindi è difficile da valutare per sé. Al netto quindi di quanto so già dal secondo libro, devo comunque limitarmi a un voto 7/10 per la piacevolezza di un viaggio di cui ancora non so la destinazione. Come defaticamento prima di passare a The Subtle Knife, ho scelto uno degli ultimi titoli di Future Fiction, nello specifico il piiù recente autore italiano pubblicato... me escluso. Nicoletta Vallorani è un'autrice d'esperienza, che si è occupata di generi diversi e in Il catalogo delle vergini affronta in tre racconti diversi un tema comune, quello dello sfruttamento, in particolare delle donne e del loro corpo. Le tre storie sono indipendenti tra loro, ma si capisce che si svolgono nello stesso futuro vicino e difficilmente definibile distopico, nel senso che oggi ci sono già tutti gli indizi che potrebbero portarci a un futuro del genere, senza bisogno di catastrofi, guerre o dittatori. Donne senza identità, senza vita, o alle quali tutto ciò viene sottratto, e che trovano riscatto solo combattendo con gli stessi mezzi che dovrebbero renderle schiave. Se c'è un appunto che posso fare è che alcune parti sono fin troppo raccontate, quasi come la narrazione introduttiva di un film, e si fatica a capire quello che sta accadendo ora all'interno della toria. La qualità e drammaticità della scrittura compensa comunque questi momenti di azione sospesa, e la lettura rimane quindi densa di suggestioni. Voto: 7/10
Come defaticamento prima di passare a The Subtle Knife, ho scelto uno degli ultimi titoli di Future Fiction, nello specifico il piiù recente autore italiano pubblicato... me escluso. Nicoletta Vallorani è un'autrice d'esperienza, che si è occupata di generi diversi e in Il catalogo delle vergini affronta in tre racconti diversi un tema comune, quello dello sfruttamento, in particolare delle donne e del loro corpo. Le tre storie sono indipendenti tra loro, ma si capisce che si svolgono nello stesso futuro vicino e difficilmente definibile distopico, nel senso che oggi ci sono già tutti gli indizi che potrebbero portarci a un futuro del genere, senza bisogno di catastrofi, guerre o dittatori. Donne senza identità, senza vita, o alle quali tutto ciò viene sottratto, e che trovano riscatto solo combattendo con gli stessi mezzi che dovrebbero renderle schiave. Se c'è un appunto che posso fare è che alcune parti sono fin troppo raccontate, quasi come la narrazione introduttiva di un film, e si fatica a capire quello che sta accadendo ora all'interno della toria. La qualità e drammaticità della scrittura compensa comunque questi momenti di azione sospesa, e la lettura rimane quindi densa di suggestioni. Voto: 7/10
Published on November 09, 2017 23:00
November 6, 2017
Coppi Club 29/10/2017 - Mindhorn
Il revival anni 80 è una delle tendenze che tira di più ultimamente, vedi il successo di serie come Stranger Things, ma anche film tipo il nuovo It, e il continuo fiorire di remake/reboot di franchise di successo di quegli anni. Sappiamo tutti che finirà presto, ma come usano dire tutti i produttori di cinema, "finché dura fa verdura". E in questo solco si inserisce anche Mindhorn, action comedy prodotto da Netflix e uscito pochi mesi fa.
 La storia è quella di attore in disgrazia, popolare ai tempi del poliziesco degli anni '80 (Mindhorn, appunto) di cui era il protagonista, che cerca di far sopravvivere la sua carriera nonostante la palese assenza di qualsivoglia talento, e un nome che ormai non apre più nessuna porta. Abbandonato dal suo agente, dimenticato dai colleghi, e costretto a dubbie performance nella pubblicità, coglie l'occasione di un killer che sembra ossessianto dal vecchio telefilm e dichiara di voler parlare solo con lui. L'attore viene convovato dalla polizia sull'isola di Man per collaborare alle indagini, ed è qui che mette in scena la sua nuova performance, certo dell'attenzione mediatica che il caso riceverà.
La storia è quella di attore in disgrazia, popolare ai tempi del poliziesco degli anni '80 (Mindhorn, appunto) di cui era il protagonista, che cerca di far sopravvivere la sua carriera nonostante la palese assenza di qualsivoglia talento, e un nome che ormai non apre più nessuna porta. Abbandonato dal suo agente, dimenticato dai colleghi, e costretto a dubbie performance nella pubblicità, coglie l'occasione di un killer che sembra ossessianto dal vecchio telefilm e dichiara di voler parlare solo con lui. L'attore viene convovato dalla polizia sull'isola di Man per collaborare alle indagini, ed è qui che mette in scena la sua nuova performance, certo dell'attenzione mediatica che il caso riceverà.
Il film si muove quindi su due piani, da una parte seguendo l'omicidio e il mistero che si nasconde dietro a questo, che va oltre un "normale" killer; dall'altra i tentativi dell'ex Mindhorn di riguadagnare la sua popolarità, rientrando in contatto con i colleghi dell'epoca, tutti passati a nuove fasi della loro vita, a differenza di lui. Il protagonista è un personaggio egocentrico e presuntuoso, convinto che il mondo debba riconoscere il suo talento. Si appoggia anche a personaggi di caratura simile, falliti che vivono delle briciole lasciate dalle altre star. La maggior parte delle gag deriva quindi da questo contrasto tra le illusioni del protagonista e la realtà di un mondo che è andato avanti per trent'anni.
Ma questo è allo stesso tempo anche il punto debole del film. Dopo la sequenza iniziale durante le riprese di Mindhorn e le prime scene che servono a capire l'attitudine del protagonista, il resto del film prosegue sempre sulla stessa strada, proponendo a oltranza le stesse situazioni. Rimane quindi difficile empatizzare con un personaggio che di per sé è odioso, e dopo mezz'ora di film non è più nemmeno simpatico. Oltre a questo, anche la soluzione degli omicidi avviene in modo del tutto indipendente dalle sue azioni, e per tutto il film è soltanto un agente passivo, capace solo di autocompiacersi.
Mindhorn avrebbe funzionato meglio se invece di durare un'ora e mezzo fosse durante venticinque minuti, una specie di mediometraggio alla Kung Fury, dove l'assurdità delle situazioni e l'incoerenza dei personaggi non pesa troppo, visto che tutto è talmente concentrato da non dare il tempo di pensare. In questa forma allungata invece tutto appare molto presto annacquato e stantio, a danno di un'idea di base valida e interpretazioni efficaci.
 La storia è quella di attore in disgrazia, popolare ai tempi del poliziesco degli anni '80 (Mindhorn, appunto) di cui era il protagonista, che cerca di far sopravvivere la sua carriera nonostante la palese assenza di qualsivoglia talento, e un nome che ormai non apre più nessuna porta. Abbandonato dal suo agente, dimenticato dai colleghi, e costretto a dubbie performance nella pubblicità, coglie l'occasione di un killer che sembra ossessianto dal vecchio telefilm e dichiara di voler parlare solo con lui. L'attore viene convovato dalla polizia sull'isola di Man per collaborare alle indagini, ed è qui che mette in scena la sua nuova performance, certo dell'attenzione mediatica che il caso riceverà.
La storia è quella di attore in disgrazia, popolare ai tempi del poliziesco degli anni '80 (Mindhorn, appunto) di cui era il protagonista, che cerca di far sopravvivere la sua carriera nonostante la palese assenza di qualsivoglia talento, e un nome che ormai non apre più nessuna porta. Abbandonato dal suo agente, dimenticato dai colleghi, e costretto a dubbie performance nella pubblicità, coglie l'occasione di un killer che sembra ossessianto dal vecchio telefilm e dichiara di voler parlare solo con lui. L'attore viene convovato dalla polizia sull'isola di Man per collaborare alle indagini, ed è qui che mette in scena la sua nuova performance, certo dell'attenzione mediatica che il caso riceverà.Il film si muove quindi su due piani, da una parte seguendo l'omicidio e il mistero che si nasconde dietro a questo, che va oltre un "normale" killer; dall'altra i tentativi dell'ex Mindhorn di riguadagnare la sua popolarità, rientrando in contatto con i colleghi dell'epoca, tutti passati a nuove fasi della loro vita, a differenza di lui. Il protagonista è un personaggio egocentrico e presuntuoso, convinto che il mondo debba riconoscere il suo talento. Si appoggia anche a personaggi di caratura simile, falliti che vivono delle briciole lasciate dalle altre star. La maggior parte delle gag deriva quindi da questo contrasto tra le illusioni del protagonista e la realtà di un mondo che è andato avanti per trent'anni.
Ma questo è allo stesso tempo anche il punto debole del film. Dopo la sequenza iniziale durante le riprese di Mindhorn e le prime scene che servono a capire l'attitudine del protagonista, il resto del film prosegue sempre sulla stessa strada, proponendo a oltranza le stesse situazioni. Rimane quindi difficile empatizzare con un personaggio che di per sé è odioso, e dopo mezz'ora di film non è più nemmeno simpatico. Oltre a questo, anche la soluzione degli omicidi avviene in modo del tutto indipendente dalle sue azioni, e per tutto il film è soltanto un agente passivo, capace solo di autocompiacersi.
Mindhorn avrebbe funzionato meglio se invece di durare un'ora e mezzo fosse durante venticinque minuti, una specie di mediometraggio alla Kung Fury, dove l'assurdità delle situazioni e l'incoerenza dei personaggi non pesa troppo, visto che tutto è talmente concentrato da non dare il tempo di pensare. In questa forma allungata invece tutto appare molto presto annacquato e stantio, a danno di un'idea di base valida e interpretazioni efficaci.
Published on November 06, 2017 10:10
October 30, 2017
Coppi Night 22/10/2017 - El Bar
Ho già avuto modo di constatare in passato come i film di genere spagnoli si rivelino più interessanti di quello che si direbbe, e che forse vale la pena approfondire l'argomento. La scelta di El bar deriva in parte da questo tentativo di conoscere meglio la produzione cinematografica spagnola e anche in questo caso posso dire che ci si trova di fronte a un film per lo meno interessante e ben costruito.
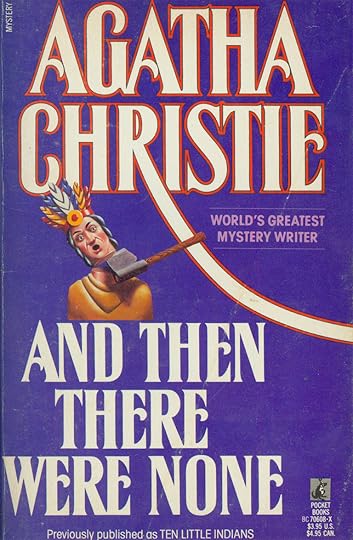 La base della storia è piuttosto semplice: un gruppo di sconosciuti rimane chiusa in un bar nel centro di Madrid e deve cercare di uscirne. La complicazione sta nel fatto che a quanto pare chiunque metta la testa fuori viene abbattuto da dei cecchini. La ragione di questo stillicidio viene chiarita nel corso del film, ma fin da subito risulta evidente che c'è qualcuno, all'interno di quel piccolo gruppo, che nasconde un segreto per il quale c'è gente disposta ad uccidere.
La base della storia è piuttosto semplice: un gruppo di sconosciuti rimane chiusa in un bar nel centro di Madrid e deve cercare di uscirne. La complicazione sta nel fatto che a quanto pare chiunque metta la testa fuori viene abbattuto da dei cecchini. La ragione di questo stillicidio viene chiarita nel corso del film, ma fin da subito risulta evidente che c'è qualcuno, all'interno di quel piccolo gruppo, che nasconde un segreto per il quale c'è gente disposta ad uccidere.
Il meccanismo quindi è quello dell'ambiente chiuso e sospetto reciproco. Tutti sanno di trovarsi in una situazione dalla quale potranno uscire soltanto agendo prima degli altri, tenendo nascoste le proprie conoscenze e capacità, alimentando i conflitti per approfittare della confusione. Le alleanze tra i vari personaggi si formano e si sciolgono, i contrasti esplodono e si arriva presto alle mani. La situazione peggiora quando, una volta compresa l'origine della loro situazione, si rende chiaro che sarà impossibile uscirne tutti vivi, e sono richiesti dei sacrifici.
Personalmente lo trovo uno spunto sempre valido, da cui possono nascere dinamiche differenti ogni volta (penso ad esempio a Cube). Certo la sfida in questo caso è quella di caratterizzare i personaggi senza farli cadere nello stereotipo, cosa in cui il film in questione riesce solo in parte. Mentre alcuni dei protagonisti hanno effettivamente una dimensione reale e plurisfaccettata, altri agiscono un po' da macchietta. Chiaramente quando ci sono 7-8 protagonisti è ovvio che non tutti possono ottenere lo stesso sviluppo, e maggiore cura sarà data a quelli che alla fine si riveleranno gli attori del climax. In generale comunque i personaggi funzionano e si possono considerare coerenti con le proprie intenzioni.
C'è anche da dire che a visione ultimata non rimane molto di questo film, non ci sono particolari temi che emergono, anche in forma allegorica/metaforica, e rendono le vicende mostrate più significative. Il tutto va preso per il suo senso letterale e lì ci si ferma. Ma insomma, un film senza livelli di lettura ulteriori può comunque funzionare, se è ben realizzato, e in questo senso El bar si può considerare soddisfacente.
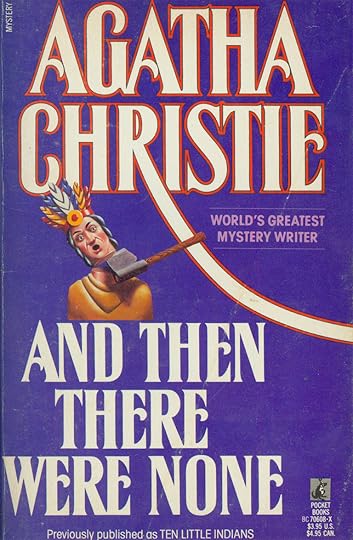 La base della storia è piuttosto semplice: un gruppo di sconosciuti rimane chiusa in un bar nel centro di Madrid e deve cercare di uscirne. La complicazione sta nel fatto che a quanto pare chiunque metta la testa fuori viene abbattuto da dei cecchini. La ragione di questo stillicidio viene chiarita nel corso del film, ma fin da subito risulta evidente che c'è qualcuno, all'interno di quel piccolo gruppo, che nasconde un segreto per il quale c'è gente disposta ad uccidere.
La base della storia è piuttosto semplice: un gruppo di sconosciuti rimane chiusa in un bar nel centro di Madrid e deve cercare di uscirne. La complicazione sta nel fatto che a quanto pare chiunque metta la testa fuori viene abbattuto da dei cecchini. La ragione di questo stillicidio viene chiarita nel corso del film, ma fin da subito risulta evidente che c'è qualcuno, all'interno di quel piccolo gruppo, che nasconde un segreto per il quale c'è gente disposta ad uccidere.Il meccanismo quindi è quello dell'ambiente chiuso e sospetto reciproco. Tutti sanno di trovarsi in una situazione dalla quale potranno uscire soltanto agendo prima degli altri, tenendo nascoste le proprie conoscenze e capacità, alimentando i conflitti per approfittare della confusione. Le alleanze tra i vari personaggi si formano e si sciolgono, i contrasti esplodono e si arriva presto alle mani. La situazione peggiora quando, una volta compresa l'origine della loro situazione, si rende chiaro che sarà impossibile uscirne tutti vivi, e sono richiesti dei sacrifici.
Personalmente lo trovo uno spunto sempre valido, da cui possono nascere dinamiche differenti ogni volta (penso ad esempio a Cube). Certo la sfida in questo caso è quella di caratterizzare i personaggi senza farli cadere nello stereotipo, cosa in cui il film in questione riesce solo in parte. Mentre alcuni dei protagonisti hanno effettivamente una dimensione reale e plurisfaccettata, altri agiscono un po' da macchietta. Chiaramente quando ci sono 7-8 protagonisti è ovvio che non tutti possono ottenere lo stesso sviluppo, e maggiore cura sarà data a quelli che alla fine si riveleranno gli attori del climax. In generale comunque i personaggi funzionano e si possono considerare coerenti con le proprie intenzioni.
C'è anche da dire che a visione ultimata non rimane molto di questo film, non ci sono particolari temi che emergono, anche in forma allegorica/metaforica, e rendono le vicende mostrate più significative. Il tutto va preso per il suo senso letterale e lì ci si ferma. Ma insomma, un film senza livelli di lettura ulteriori può comunque funzionare, se è ben realizzato, e in questo senso El bar si può considerare soddisfacente.
Published on October 30, 2017 10:00
October 26, 2017
Che fine hanno fatto le colonne sonore?
La settimana scorsa sono stato al cinema tre volte, battendo il mio record di frequenza cinematografica. Certo non era un record difficile da battere, con una media di 4-5 volte all'anno, spazzato via da due film al cinema nello stesso giorno. Ho visto due volte Blade Runner 2049 (mai successo prima di rivedere al cinema lo stesso film, questa è stata una mirabile eccezione con validi motivi) e una volta It. La visione di quest'ultimo è stata una delle esperienze al cinema più terribili che io ricordi, visto che ho passato buona parte del film a zittire i ragazzetti in sala invece che a seguire lo schermo. Ma questo post non parla né di Blade Runner 2049 né di It, almeno non in maniera diretta.
Forse la riflessione mi è sorta confrontando a distanza di poche ore l'impianto musicale del primo film (prepotente, ossessivo, coerente) con il secondo (marginale, prevedibile, generico), ma il discorso si applica in termini molto più ampi di questo caso specifico. E la questione è: perché nei film di oggi si sta perdendo la componente musicale?
È una cosa che emerge in modo evidente se vado a ripercorrere gli ultimi film che ho visto, sia al cinema che in altre occasioni (vedi Coppi Night, ma anche l'abuso di Netflix). Sembra che la tendenza attuale sia quella di tenere la musica come un elemento di contorno, un plus che serve a sottolineare qua e là alcuni momenti salienti, ma che di fatto non fa parte del film, al pari ad esempio dei titoli di coda... anzi meno ancora, negli ultimi anni i titoli di coda stanno acquisendo sempre più importanza con le scene bonus. Ovviamente ci sono delle notabili eccezioni, vedi appunto Blade Runner 2049 che riesce nell'arduo a ricordare la musica di Vangelis senza copiarla paroparo.
Eppure mi pare che il ruolo della musica in un film sia tutt'altro che secondario. Per dire se io adesso riascolto questo pezzo, riesco a rivedere distintamente la scena, e in parte provo di nuovo le stesse emozioni provate in quel momento, o quantomeno ricordo quello che ho provato.
E se ripercorro in rapida successione i film che in tempi recenti mi hanno catturato di più, non ce n'è uno di cui non riesca a ricordare la musica. Prendendo come campione solo quelli di cui ho parlato su questo blog, posso pensare ad Arrival, Predestination, Upstream Color, Mad Max: Fury Road, Chappie.
Lo stesso esercizio non riesco a compierlo invece per tanti altri, e secondo me è un gran peccato che l'attenzione il livello di attenzione per la colonna sonora stia calando, forse per via di meccanismi di produzione che privilegiano altri aspetti: si chiama colonna sonora, si capisce che è qualcosa di importante che serve a sorreggere il film.
Parlando di colonna sonora non mi riferisco solo alla musica originale composta per un film, ma anche una soundtrack composta da pezzi appropriatamente scelti. In questo caso mi vengono decine di altri esempi validi, da Trainspotting all'altrettanto valido Trainspotting 2, da Scott Pilgrim vs The World a pressoché tutti gli altri film di Edgar Wright (e ancora non ho visto Baby Driver). Si può pensare che comporre una soundtrack in questo modo sia la strada più semplice, ma in realtà riuscire a inserire dei pezzi già noti al di fuori del film in modo che lo spettatore si sintonizzi sul giusto stato emotivo (indipendentemente da ciò che lui associa con un pezzo che magari già conosce) è tutt'altro che banale. Anzi, sbagliare in questo caso è molto più facile, quando si scambia la popolarità di una canzone per la reazione che susciterà (Suicide Squad, presente?).
Forse sono io che esagero il problema, può darsi che sia perché ho una predisposizione abbastanza spiccata per la parte uditiva piuttosto che quella visiva di un'opera. Per dire, la fotografia mi suscita effetti molto blandi, quindi un film esteticamente perfetto mi cattura meno di uno con una musica fenomenale. Ma al di là delle percezioni personali, credo che il problema della musica all'interno dei film esista davvero, e che si ricolleghi in ultima analisi a quel grande carrozzone senza conducente che sta diventando l'industria cinematografica globalizzata.
Purtroppo sono praticamente digiuno di teoria musicale per cui non sono in grado di affrontare un discorso ragionato su questo tema. Ma è un argomento che mi sta molto a cuore, per cui mi sono un po' documentato negli ultimi giorni e voglio proporre una selezione di video interessanti che sono cruciali per capire il problema della moderna composizione musicale nell'ambito del cinema. Li lascio qui, così potete seguirli e farvi una vostra idea sulla questione.
Forse la riflessione mi è sorta confrontando a distanza di poche ore l'impianto musicale del primo film (prepotente, ossessivo, coerente) con il secondo (marginale, prevedibile, generico), ma il discorso si applica in termini molto più ampi di questo caso specifico. E la questione è: perché nei film di oggi si sta perdendo la componente musicale?
È una cosa che emerge in modo evidente se vado a ripercorrere gli ultimi film che ho visto, sia al cinema che in altre occasioni (vedi Coppi Night, ma anche l'abuso di Netflix). Sembra che la tendenza attuale sia quella di tenere la musica come un elemento di contorno, un plus che serve a sottolineare qua e là alcuni momenti salienti, ma che di fatto non fa parte del film, al pari ad esempio dei titoli di coda... anzi meno ancora, negli ultimi anni i titoli di coda stanno acquisendo sempre più importanza con le scene bonus. Ovviamente ci sono delle notabili eccezioni, vedi appunto Blade Runner 2049 che riesce nell'arduo a ricordare la musica di Vangelis senza copiarla paroparo.
Eppure mi pare che il ruolo della musica in un film sia tutt'altro che secondario. Per dire se io adesso riascolto questo pezzo, riesco a rivedere distintamente la scena, e in parte provo di nuovo le stesse emozioni provate in quel momento, o quantomeno ricordo quello che ho provato.
E se ripercorro in rapida successione i film che in tempi recenti mi hanno catturato di più, non ce n'è uno di cui non riesca a ricordare la musica. Prendendo come campione solo quelli di cui ho parlato su questo blog, posso pensare ad Arrival, Predestination, Upstream Color, Mad Max: Fury Road, Chappie.
Lo stesso esercizio non riesco a compierlo invece per tanti altri, e secondo me è un gran peccato che l'attenzione il livello di attenzione per la colonna sonora stia calando, forse per via di meccanismi di produzione che privilegiano altri aspetti: si chiama colonna sonora, si capisce che è qualcosa di importante che serve a sorreggere il film.
Parlando di colonna sonora non mi riferisco solo alla musica originale composta per un film, ma anche una soundtrack composta da pezzi appropriatamente scelti. In questo caso mi vengono decine di altri esempi validi, da Trainspotting all'altrettanto valido Trainspotting 2, da Scott Pilgrim vs The World a pressoché tutti gli altri film di Edgar Wright (e ancora non ho visto Baby Driver). Si può pensare che comporre una soundtrack in questo modo sia la strada più semplice, ma in realtà riuscire a inserire dei pezzi già noti al di fuori del film in modo che lo spettatore si sintonizzi sul giusto stato emotivo (indipendentemente da ciò che lui associa con un pezzo che magari già conosce) è tutt'altro che banale. Anzi, sbagliare in questo caso è molto più facile, quando si scambia la popolarità di una canzone per la reazione che susciterà (Suicide Squad, presente?).
Forse sono io che esagero il problema, può darsi che sia perché ho una predisposizione abbastanza spiccata per la parte uditiva piuttosto che quella visiva di un'opera. Per dire, la fotografia mi suscita effetti molto blandi, quindi un film esteticamente perfetto mi cattura meno di uno con una musica fenomenale. Ma al di là delle percezioni personali, credo che il problema della musica all'interno dei film esista davvero, e che si ricolleghi in ultima analisi a quel grande carrozzone senza conducente che sta diventando l'industria cinematografica globalizzata.
Purtroppo sono praticamente digiuno di teoria musicale per cui non sono in grado di affrontare un discorso ragionato su questo tema. Ma è un argomento che mi sta molto a cuore, per cui mi sono un po' documentato negli ultimi giorni e voglio proporre una selezione di video interessanti che sono cruciali per capire il problema della moderna composizione musicale nell'ambito del cinema. Li lascio qui, così potete seguirli e farvi una vostra idea sulla questione.
Published on October 26, 2017 11:25
October 23, 2017
Memehunter
Dopo qualche settimana di silenzio radio, torno a pubblicare sul blog con una segnalazione fresca fresca. Era da un po' di tempo che non annunciavo una nuova pubblicazione, ma nonostante le turbolenze dell'ultimo anno e mezzo ho continuato a lavorare nell'ombra, anche se meno del solito, ed eccoci qui con un titolo su cui ho investito parecchio.
A fine settimana sarà disponibile in ebook Memehunter , un racconto lungo pubblicato sotto il marchio di Future Fiction . Se il nome della casa editrice vi suona familiare, può essere perché ne ho parlato diverse volte nei miei rapporti letture, visto che ho letto diversi titoli nel catalogo, e lo ritengo uno dei progetti più interessanti nel panorama attuale della sf italiana, con il suo obiettivo di curare la "biodiversità narrativa". Ho proposto tempo fa la mia storia a Francesco Verso, e dopo parecchi mesi di lavoro siamo arrivati alla versione finale, che vede ora la luce.
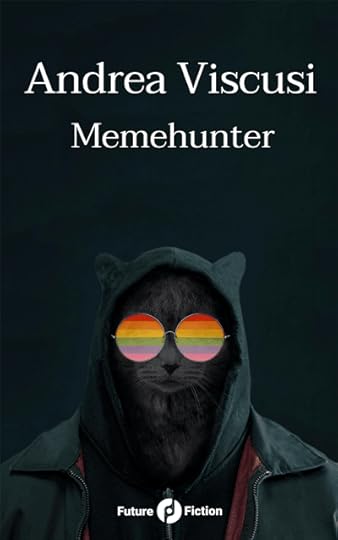
Volendo dar retta alle etichette, Memehunter si può definire un racconto cyberpunk. Lo è nella misura in cui i protagonisti sono dei giovani hacker, impegnati in una missione oltre la loro portata, e perché buona parte della storia si svolge nella Rete. Ma, signori miei, il mondo è andato avanti parecchio dai tempi di Mirrorshades, e quello stesso cyberpunk oggi ha poco senso. Oggi gli hacker non combattono tanto le multinazionale ma le bufale, e il terreno di gioco non è il cyberspazio ma i social network. È in questo contesto che si muovono Derek, un memehunter e il suo amico e socio Jo, uno snark. Insieme sono assunti da un committente misterioso per compiere la caccia al meme dei memi.
Quindi Memehunter è un po' la mia versione aggiornata di La notte che bruciammo Chrome, ma con facebook, gattini e droni. Vi si trova un po' di quella ideologia anarchica disillusa che riecheggia anche in Mr. Robot (si nota il riferimento in copertina?) e che è a sua volta una riproposizione degli ideali del movimento hacker delle origini. Ma soprattutto ribolle del caos della Rete di oggi, che come in molti addetti ai lavori hanno ammesso, è completamente sfuggita al nostro controllo, ed è diventata molto più e molto di peggio di quello strumento di comunicazione universale e democrazia diretta che tutti si aspettavano vent'anni fa.
Ne consegue anche che Memehunter potrebbe soffire di obsolescenza precoce. Soprattutto l'aspetto tecnologico e lessicale potrebbero venire superati nel giro di un paio di anni, al ritmo con cui queste cose si evolvono oggigiorno. Uno ci prova a estrapolare e speculare, ma siamo nell'era pre-singolarità, in cui le macchine si insegnano da sole i giochi da tavolo, per cui c'è un limite alla capacità di fare previsioni del nostro scadente wetware mammaliano. Tutto questo per dire che volete leggere il racconto, mai come stavolta è importante farlo ora invece che tra sei mesi!
Se siete abbonati a Future Fiction lo avete già ricevuto, altrimenti Memehunter sarà disponibile per l'acquisto da venerdì, sul sito di Future Fiction e sui maggiori store online.
A fine settimana sarà disponibile in ebook Memehunter , un racconto lungo pubblicato sotto il marchio di Future Fiction . Se il nome della casa editrice vi suona familiare, può essere perché ne ho parlato diverse volte nei miei rapporti letture, visto che ho letto diversi titoli nel catalogo, e lo ritengo uno dei progetti più interessanti nel panorama attuale della sf italiana, con il suo obiettivo di curare la "biodiversità narrativa". Ho proposto tempo fa la mia storia a Francesco Verso, e dopo parecchi mesi di lavoro siamo arrivati alla versione finale, che vede ora la luce.
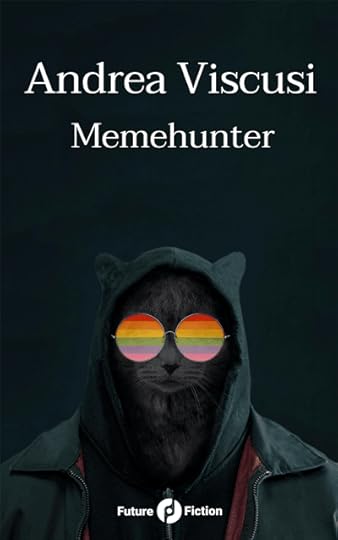
Volendo dar retta alle etichette, Memehunter si può definire un racconto cyberpunk. Lo è nella misura in cui i protagonisti sono dei giovani hacker, impegnati in una missione oltre la loro portata, e perché buona parte della storia si svolge nella Rete. Ma, signori miei, il mondo è andato avanti parecchio dai tempi di Mirrorshades, e quello stesso cyberpunk oggi ha poco senso. Oggi gli hacker non combattono tanto le multinazionale ma le bufale, e il terreno di gioco non è il cyberspazio ma i social network. È in questo contesto che si muovono Derek, un memehunter e il suo amico e socio Jo, uno snark. Insieme sono assunti da un committente misterioso per compiere la caccia al meme dei memi.
Quindi Memehunter è un po' la mia versione aggiornata di La notte che bruciammo Chrome, ma con facebook, gattini e droni. Vi si trova un po' di quella ideologia anarchica disillusa che riecheggia anche in Mr. Robot (si nota il riferimento in copertina?) e che è a sua volta una riproposizione degli ideali del movimento hacker delle origini. Ma soprattutto ribolle del caos della Rete di oggi, che come in molti addetti ai lavori hanno ammesso, è completamente sfuggita al nostro controllo, ed è diventata molto più e molto di peggio di quello strumento di comunicazione universale e democrazia diretta che tutti si aspettavano vent'anni fa.
Ne consegue anche che Memehunter potrebbe soffire di obsolescenza precoce. Soprattutto l'aspetto tecnologico e lessicale potrebbero venire superati nel giro di un paio di anni, al ritmo con cui queste cose si evolvono oggigiorno. Uno ci prova a estrapolare e speculare, ma siamo nell'era pre-singolarità, in cui le macchine si insegnano da sole i giochi da tavolo, per cui c'è un limite alla capacità di fare previsioni del nostro scadente wetware mammaliano. Tutto questo per dire che volete leggere il racconto, mai come stavolta è importante farlo ora invece che tra sei mesi!
Se siete abbonati a Future Fiction lo avete già ricevuto, altrimenti Memehunter sarà disponibile per l'acquisto da venerdì, sul sito di Future Fiction e sui maggiori store online.
Published on October 23, 2017 09:00
October 10, 2017
Coppi Night 1/10/2017 - Okja
Okja mi era stato presentato come un film controverso che sollevava interrogativi importanti sull'alimentazione e il rapporto tra l'uomo e gli animali. E forse, scavando un po', queste cose si ritrovano davvero, ma il problema è che bisogna scavare sotto strati di noia per raggiungere questo nucleo.
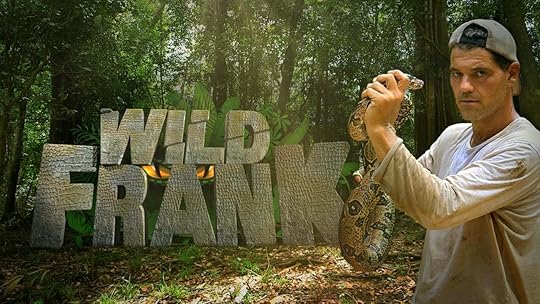 Metto le mani avanti come ho già fatto in occasioni simili, dichiarando la mia scarsa familiarità col cinema coreano. In questo caso la produzione è un mix di coreano e americano, ma in certe parti si percepisce molto l'influenza di una cinematografia diverda da quella di Hollywood, di cui ammetto non essere un esperto. Ciò detto, rimane il fatto che personalmente ho trovato Okja estremamente blando, incapace di impressionare davvero nonostante il tema trattato consentisse scene forti ed emotivamente devastanti.
Metto le mani avanti come ho già fatto in occasioni simili, dichiarando la mia scarsa familiarità col cinema coreano. In questo caso la produzione è un mix di coreano e americano, ma in certe parti si percepisce molto l'influenza di una cinematografia diverda da quella di Hollywood, di cui ammetto non essere un esperto. Ciò detto, rimane il fatto che personalmente ho trovato Okja estremamente blando, incapace di impressionare davvero nonostante il tema trattato consentisse scene forti ed emotivamente devastanti.
La multinazionale cattiva alter ego della Monsanto ci tiene tanto a fare bella figura col suo nuovo megamaiale OGM (e nessuno sembra rendersi conto che assomiglia molto di più a un ippopotamo), e forse questo piano di marketing di durata decennale è una delle parti meglio riuscite della storia. Il rapporto tra la ragazzina e l'animale viene mostrato inizialmente con qualche scena idilliaca, ma a parte abbracci e corse nel bosco non si riesce mai a percepire un vero legame. Ma peggio ancora, la bambina protagonista manca completamente di caratterizzazione, visto che parla poco e agisce sempre dietro manipolazione di qualcun altro. Il suo personaggio esiste solo in quanto controparte del maiale gigante, per questo mi è stato davvero difficile fare il tifo per lei, e di conseguenza anche per la pover bestia vittima di tutto ciò.
Paradossalmente, alcuni personaggi secondari sembrano avere una complessità molto maggiore e suggeriscono uno sviluppo narrativo tragico non indifferente. L'amminstratice della multionazionale col suo rapporto difficile con padre e sorella e i tentativi di tenere sotto controllo un'azienda troppo grande; alcuni degli animalisti, combattuti tra l'adesione ai principi del loro manifesto e la necessità di agire in modo diretto e violento; ma soprattutto, il presentatore amico degli animali interpretato da Jake Gyllenhaal, una specie di Wild Frank caduto in disgrazia e costretto a fare da testimonial a un'azienda che lucra su ciò che lui ha sempre amato. Mi sarebbe piaciuto quasi di più conoscere la sua storia, che quella della ragazzina e del suo nonno avaro.
Quindi alla fine, Okja non riesce a raggiungere la forza che potrebbe, anche nelle sequenze finali in cui viene mostrato esplicitamente il macello dove gli animali sono ammazzati e processati per farne bistecche, hamburger e salsicce. Quello che avrebbe dovuto essere un momento estremamente drammatico mi è sembrato solo una prevedibile arma tirata fuori all'ultimo momento per scioccare lo spettatore, che però, se è come me, a quel punto ha già perso interese. Peccato, perché il tema merita acute riflessioni e io stesso ci sto pensando molto nell'ultimo periodo. Non sarà però un'opera del genere a farmi propendere in una direzione o l'altra.
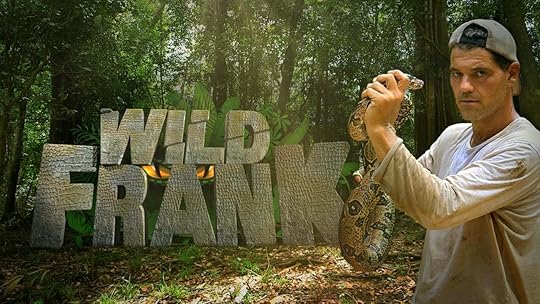 Metto le mani avanti come ho già fatto in occasioni simili, dichiarando la mia scarsa familiarità col cinema coreano. In questo caso la produzione è un mix di coreano e americano, ma in certe parti si percepisce molto l'influenza di una cinematografia diverda da quella di Hollywood, di cui ammetto non essere un esperto. Ciò detto, rimane il fatto che personalmente ho trovato Okja estremamente blando, incapace di impressionare davvero nonostante il tema trattato consentisse scene forti ed emotivamente devastanti.
Metto le mani avanti come ho già fatto in occasioni simili, dichiarando la mia scarsa familiarità col cinema coreano. In questo caso la produzione è un mix di coreano e americano, ma in certe parti si percepisce molto l'influenza di una cinematografia diverda da quella di Hollywood, di cui ammetto non essere un esperto. Ciò detto, rimane il fatto che personalmente ho trovato Okja estremamente blando, incapace di impressionare davvero nonostante il tema trattato consentisse scene forti ed emotivamente devastanti.La multinazionale cattiva alter ego della Monsanto ci tiene tanto a fare bella figura col suo nuovo megamaiale OGM (e nessuno sembra rendersi conto che assomiglia molto di più a un ippopotamo), e forse questo piano di marketing di durata decennale è una delle parti meglio riuscite della storia. Il rapporto tra la ragazzina e l'animale viene mostrato inizialmente con qualche scena idilliaca, ma a parte abbracci e corse nel bosco non si riesce mai a percepire un vero legame. Ma peggio ancora, la bambina protagonista manca completamente di caratterizzazione, visto che parla poco e agisce sempre dietro manipolazione di qualcun altro. Il suo personaggio esiste solo in quanto controparte del maiale gigante, per questo mi è stato davvero difficile fare il tifo per lei, e di conseguenza anche per la pover bestia vittima di tutto ciò.
Paradossalmente, alcuni personaggi secondari sembrano avere una complessità molto maggiore e suggeriscono uno sviluppo narrativo tragico non indifferente. L'amminstratice della multionazionale col suo rapporto difficile con padre e sorella e i tentativi di tenere sotto controllo un'azienda troppo grande; alcuni degli animalisti, combattuti tra l'adesione ai principi del loro manifesto e la necessità di agire in modo diretto e violento; ma soprattutto, il presentatore amico degli animali interpretato da Jake Gyllenhaal, una specie di Wild Frank caduto in disgrazia e costretto a fare da testimonial a un'azienda che lucra su ciò che lui ha sempre amato. Mi sarebbe piaciuto quasi di più conoscere la sua storia, che quella della ragazzina e del suo nonno avaro.
Quindi alla fine, Okja non riesce a raggiungere la forza che potrebbe, anche nelle sequenze finali in cui viene mostrato esplicitamente il macello dove gli animali sono ammazzati e processati per farne bistecche, hamburger e salsicce. Quello che avrebbe dovuto essere un momento estremamente drammatico mi è sembrato solo una prevedibile arma tirata fuori all'ultimo momento per scioccare lo spettatore, che però, se è come me, a quel punto ha già perso interese. Peccato, perché il tema merita acute riflessioni e io stesso ci sto pensando molto nell'ultimo periodo. Non sarà però un'opera del genere a farmi propendere in una direzione o l'altra.
Published on October 10, 2017 00:00
October 2, 2017
Rapporto letture - Settembre 2017
Settembre è stato un mese piuttosto impegnativo sul fronte personale, come testimonia la scarsità di entry sul blog di cui accennavo nel post precedente. Niente di imprevisto comunque, anzi tutto ampiamente programmato da quasi un anno, solo che quando poi ti ci trovi sotto, puoi programmare in anticipo quanto ti pare, ma il tempo non ti basta comunque. Tuttavia la lettura non ne ha risentito più di tanto, e due bei libretti sono comunque riuscito ad assimilarli.
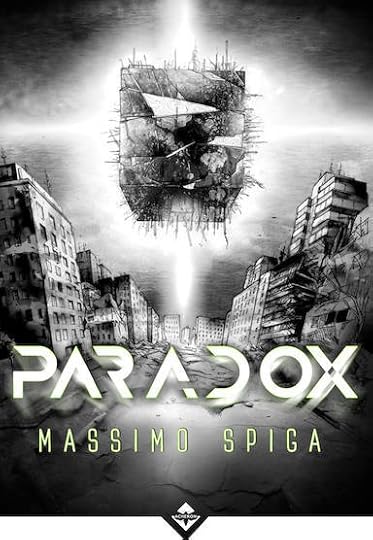 Il primo è
Paradox
, romanzo di fantascienza visionaria di Massimo Spiga, pubblicato l'autunno scorso da Acheron. È una lettura particolare, e di certo non facile sotto diversi punti di vista. Il lettore non viene messo a proprio agio, lo stile a tratti è ermetico e la trama non si sforza più di tanto di farsi spiegare. Si parla di conflitti che abbracciano tutto lo spazio e il tempo, di cui l'umanità è un pedina inerme. Questa guerra cosmica piomba però nella quotidianità dei protagonisti, in particolare di Perla, giovane ragazza romana che si trova ad affrontare in prima persona lo scontro tra due avversari non del tutto umani, ma nemmeno completamente alieni, dai poteri inimmaginabili e dalle motivazioni oscure. La cosa più interessante del romanzo è sicuramente il vasto e appena visibile universo narrativo che cela, di cui non solo la ragazza, ma anche gli invasori postumani non conoscono tutte le sfaccettature. Questo è però in qualche modo anche la debolezza del libro, perché vedere questo schieramento di forze onnipotenti ridimensiona in modo drastico la rilevanza delle piccole vite umane e delle motivazioni della ragazza. Soprattutto perché, per una buona parte centrale del libro, la storia si concentra più su D (quello che siamo portati a considerare "il buono" nella guerra in atto) che su di lei. Per il resto rimane solo da rilevare che l'autore indugia un po' troppo su qualche riferimento e citazione (Finnegan's Wake di Joyce, prima di tutto), ma in sostanza l'insieme funziona. La storia non può considerarsi autoconclusiva, anche perché fa parte di un universo narrativo più ampio che comprende altre opere, altri autori, e altri media. Nonostante qualche piccola sbavatura rimane comunque una buona lettura. Voto: 7.5/10
Il primo è
Paradox
, romanzo di fantascienza visionaria di Massimo Spiga, pubblicato l'autunno scorso da Acheron. È una lettura particolare, e di certo non facile sotto diversi punti di vista. Il lettore non viene messo a proprio agio, lo stile a tratti è ermetico e la trama non si sforza più di tanto di farsi spiegare. Si parla di conflitti che abbracciano tutto lo spazio e il tempo, di cui l'umanità è un pedina inerme. Questa guerra cosmica piomba però nella quotidianità dei protagonisti, in particolare di Perla, giovane ragazza romana che si trova ad affrontare in prima persona lo scontro tra due avversari non del tutto umani, ma nemmeno completamente alieni, dai poteri inimmaginabili e dalle motivazioni oscure. La cosa più interessante del romanzo è sicuramente il vasto e appena visibile universo narrativo che cela, di cui non solo la ragazza, ma anche gli invasori postumani non conoscono tutte le sfaccettature. Questo è però in qualche modo anche la debolezza del libro, perché vedere questo schieramento di forze onnipotenti ridimensiona in modo drastico la rilevanza delle piccole vite umane e delle motivazioni della ragazza. Soprattutto perché, per una buona parte centrale del libro, la storia si concentra più su D (quello che siamo portati a considerare "il buono" nella guerra in atto) che su di lei. Per il resto rimane solo da rilevare che l'autore indugia un po' troppo su qualche riferimento e citazione (Finnegan's Wake di Joyce, prima di tutto), ma in sostanza l'insieme funziona. La storia non può considerarsi autoconclusiva, anche perché fa parte di un universo narrativo più ampio che comprende altre opere, altri autori, e altri media. Nonostante qualche piccola sbavatura rimane comunque una buona lettura. Voto: 7.5/10
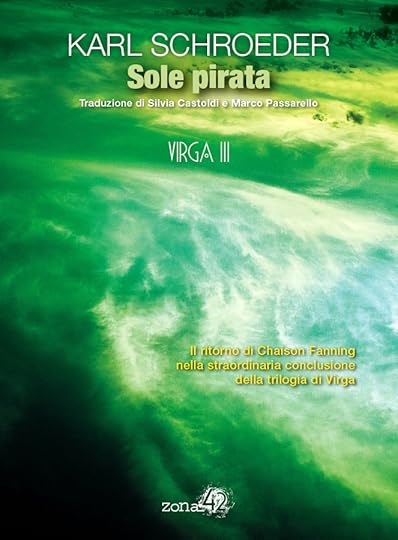 Secondo libro letto a settembre è
Sole pirata
, il terzo e ultimo volume della trilogia di Virga di Karl Schroeder, pubblicata in italia da Zona 42. Dopo Il sole dei soli e
Regina del sole
, si torna alle avventure nell'enorme sfera cava artificiale in cui si librano varie nazioni in conflitto tra loro. Cambia di nuovo il protagonista principale della vicenda, che stavolta è Chaison Fanning, il coraggioso ammiraglio che ha condotto la grande battaglia nel primo libro, e che ritroviamo in prigione. Fatto evadere da sua moglie (come sappiamo dal secondo libro), Chaison ha intenzione di tornare al suo paese, ma viene intercettato da nuovi personaggi che lo costringono ad allungare parecchio la strada. In Sole pirata si scopre finalmente l'origine di Virga e le minacce esterne che la mettono a rischio, purtroppo però questi elementi, che sembrano i più interessanti, sono appena menzionati, mentre il libro si concentra soprattutto sulle avventure di Fanning e compagni, alcune delle quali hanno poco a che fare con la missione principale. Non che sia noioso, ma vedere i protagonisti cimentarsi con la resistenza di una piccola e sconosciuta città, quando sappiamo che nemici esterni potentissimi stanno progettando la loro invasione, sembra quasi una distrazione. Il plot viene chiuso poi in poche pagine, con un rapido confronto finale e una riunione brevissima con i personaggi dei libri precedenti. Rimane un buon libro, ma sembra quasi che l'autore non avesse più tanta voglia di raccontare la storia di questi personaggi. Voto: 7/10
Secondo libro letto a settembre è
Sole pirata
, il terzo e ultimo volume della trilogia di Virga di Karl Schroeder, pubblicata in italia da Zona 42. Dopo Il sole dei soli e
Regina del sole
, si torna alle avventure nell'enorme sfera cava artificiale in cui si librano varie nazioni in conflitto tra loro. Cambia di nuovo il protagonista principale della vicenda, che stavolta è Chaison Fanning, il coraggioso ammiraglio che ha condotto la grande battaglia nel primo libro, e che ritroviamo in prigione. Fatto evadere da sua moglie (come sappiamo dal secondo libro), Chaison ha intenzione di tornare al suo paese, ma viene intercettato da nuovi personaggi che lo costringono ad allungare parecchio la strada. In Sole pirata si scopre finalmente l'origine di Virga e le minacce esterne che la mettono a rischio, purtroppo però questi elementi, che sembrano i più interessanti, sono appena menzionati, mentre il libro si concentra soprattutto sulle avventure di Fanning e compagni, alcune delle quali hanno poco a che fare con la missione principale. Non che sia noioso, ma vedere i protagonisti cimentarsi con la resistenza di una piccola e sconosciuta città, quando sappiamo che nemici esterni potentissimi stanno progettando la loro invasione, sembra quasi una distrazione. Il plot viene chiuso poi in poche pagine, con un rapido confronto finale e una riunione brevissima con i personaggi dei libri precedenti. Rimane un buon libro, ma sembra quasi che l'autore non avesse più tanta voglia di raccontare la storia di questi personaggi. Voto: 7/10
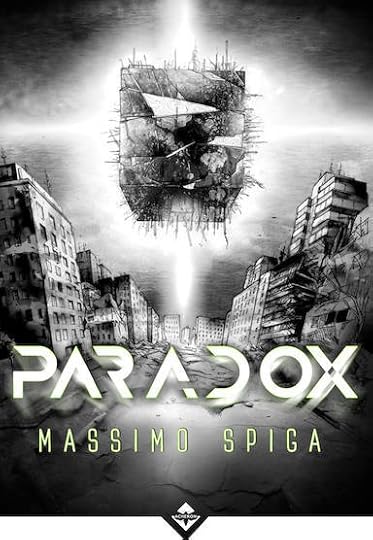 Il primo è
Paradox
, romanzo di fantascienza visionaria di Massimo Spiga, pubblicato l'autunno scorso da Acheron. È una lettura particolare, e di certo non facile sotto diversi punti di vista. Il lettore non viene messo a proprio agio, lo stile a tratti è ermetico e la trama non si sforza più di tanto di farsi spiegare. Si parla di conflitti che abbracciano tutto lo spazio e il tempo, di cui l'umanità è un pedina inerme. Questa guerra cosmica piomba però nella quotidianità dei protagonisti, in particolare di Perla, giovane ragazza romana che si trova ad affrontare in prima persona lo scontro tra due avversari non del tutto umani, ma nemmeno completamente alieni, dai poteri inimmaginabili e dalle motivazioni oscure. La cosa più interessante del romanzo è sicuramente il vasto e appena visibile universo narrativo che cela, di cui non solo la ragazza, ma anche gli invasori postumani non conoscono tutte le sfaccettature. Questo è però in qualche modo anche la debolezza del libro, perché vedere questo schieramento di forze onnipotenti ridimensiona in modo drastico la rilevanza delle piccole vite umane e delle motivazioni della ragazza. Soprattutto perché, per una buona parte centrale del libro, la storia si concentra più su D (quello che siamo portati a considerare "il buono" nella guerra in atto) che su di lei. Per il resto rimane solo da rilevare che l'autore indugia un po' troppo su qualche riferimento e citazione (Finnegan's Wake di Joyce, prima di tutto), ma in sostanza l'insieme funziona. La storia non può considerarsi autoconclusiva, anche perché fa parte di un universo narrativo più ampio che comprende altre opere, altri autori, e altri media. Nonostante qualche piccola sbavatura rimane comunque una buona lettura. Voto: 7.5/10
Il primo è
Paradox
, romanzo di fantascienza visionaria di Massimo Spiga, pubblicato l'autunno scorso da Acheron. È una lettura particolare, e di certo non facile sotto diversi punti di vista. Il lettore non viene messo a proprio agio, lo stile a tratti è ermetico e la trama non si sforza più di tanto di farsi spiegare. Si parla di conflitti che abbracciano tutto lo spazio e il tempo, di cui l'umanità è un pedina inerme. Questa guerra cosmica piomba però nella quotidianità dei protagonisti, in particolare di Perla, giovane ragazza romana che si trova ad affrontare in prima persona lo scontro tra due avversari non del tutto umani, ma nemmeno completamente alieni, dai poteri inimmaginabili e dalle motivazioni oscure. La cosa più interessante del romanzo è sicuramente il vasto e appena visibile universo narrativo che cela, di cui non solo la ragazza, ma anche gli invasori postumani non conoscono tutte le sfaccettature. Questo è però in qualche modo anche la debolezza del libro, perché vedere questo schieramento di forze onnipotenti ridimensiona in modo drastico la rilevanza delle piccole vite umane e delle motivazioni della ragazza. Soprattutto perché, per una buona parte centrale del libro, la storia si concentra più su D (quello che siamo portati a considerare "il buono" nella guerra in atto) che su di lei. Per il resto rimane solo da rilevare che l'autore indugia un po' troppo su qualche riferimento e citazione (Finnegan's Wake di Joyce, prima di tutto), ma in sostanza l'insieme funziona. La storia non può considerarsi autoconclusiva, anche perché fa parte di un universo narrativo più ampio che comprende altre opere, altri autori, e altri media. Nonostante qualche piccola sbavatura rimane comunque una buona lettura. Voto: 7.5/10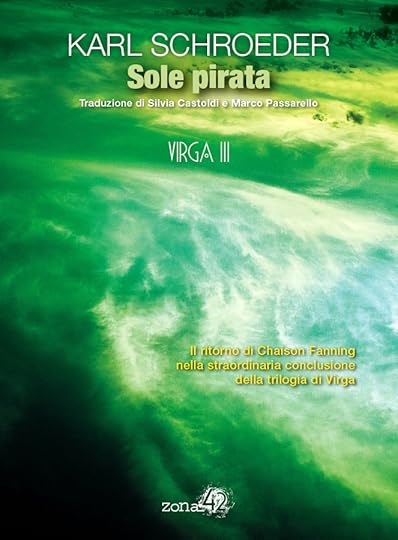 Secondo libro letto a settembre è
Sole pirata
, il terzo e ultimo volume della trilogia di Virga di Karl Schroeder, pubblicata in italia da Zona 42. Dopo Il sole dei soli e
Regina del sole
, si torna alle avventure nell'enorme sfera cava artificiale in cui si librano varie nazioni in conflitto tra loro. Cambia di nuovo il protagonista principale della vicenda, che stavolta è Chaison Fanning, il coraggioso ammiraglio che ha condotto la grande battaglia nel primo libro, e che ritroviamo in prigione. Fatto evadere da sua moglie (come sappiamo dal secondo libro), Chaison ha intenzione di tornare al suo paese, ma viene intercettato da nuovi personaggi che lo costringono ad allungare parecchio la strada. In Sole pirata si scopre finalmente l'origine di Virga e le minacce esterne che la mettono a rischio, purtroppo però questi elementi, che sembrano i più interessanti, sono appena menzionati, mentre il libro si concentra soprattutto sulle avventure di Fanning e compagni, alcune delle quali hanno poco a che fare con la missione principale. Non che sia noioso, ma vedere i protagonisti cimentarsi con la resistenza di una piccola e sconosciuta città, quando sappiamo che nemici esterni potentissimi stanno progettando la loro invasione, sembra quasi una distrazione. Il plot viene chiuso poi in poche pagine, con un rapido confronto finale e una riunione brevissima con i personaggi dei libri precedenti. Rimane un buon libro, ma sembra quasi che l'autore non avesse più tanta voglia di raccontare la storia di questi personaggi. Voto: 7/10
Secondo libro letto a settembre è
Sole pirata
, il terzo e ultimo volume della trilogia di Virga di Karl Schroeder, pubblicata in italia da Zona 42. Dopo Il sole dei soli e
Regina del sole
, si torna alle avventure nell'enorme sfera cava artificiale in cui si librano varie nazioni in conflitto tra loro. Cambia di nuovo il protagonista principale della vicenda, che stavolta è Chaison Fanning, il coraggioso ammiraglio che ha condotto la grande battaglia nel primo libro, e che ritroviamo in prigione. Fatto evadere da sua moglie (come sappiamo dal secondo libro), Chaison ha intenzione di tornare al suo paese, ma viene intercettato da nuovi personaggi che lo costringono ad allungare parecchio la strada. In Sole pirata si scopre finalmente l'origine di Virga e le minacce esterne che la mettono a rischio, purtroppo però questi elementi, che sembrano i più interessanti, sono appena menzionati, mentre il libro si concentra soprattutto sulle avventure di Fanning e compagni, alcune delle quali hanno poco a che fare con la missione principale. Non che sia noioso, ma vedere i protagonisti cimentarsi con la resistenza di una piccola e sconosciuta città, quando sappiamo che nemici esterni potentissimi stanno progettando la loro invasione, sembra quasi una distrazione. Il plot viene chiuso poi in poche pagine, con un rapido confronto finale e una riunione brevissima con i personaggi dei libri precedenti. Rimane un buon libro, ma sembra quasi che l'autore non avesse più tanta voglia di raccontare la storia di questi personaggi. Voto: 7/10
Published on October 02, 2017 23:20
September 25, 2017
Coppi Night 24/09/2017 - Dragon Trainer
Il blog è in standby da più tempo del solito, ma queste ultime sono state settimane piuttosto movimentate che hanno tenuto impegnato il mio "tempo libero" lontano da questo spazio. Peraltro, anche le prime settimane di ottobre potrebbero essere simili, quindi nessuno si stupisca se salto fuori con un paio di post o poco più: non sto mollando, ho solo di meglio da fare.
Riprendiamo quindi con un film che negli anni trascorsi da quando è uscito si è guadagnao una certa fama. È risaputo che tra i due grandi studi di animazione digitale Pixar e Dreamworks, il secondo è nettamente inferiore e tende anzi a seguire le orme del primo (vedi Pets che è praticamente Toy Story con gli animali). Nel caso di Dragon Trainer devo ammettere però che c'è del merito, sempre proporzionando le aspettative al prodotto.
 La storia del giovane allenatore di draghi ha dei bei momenti, e qualche scena di azione e di volo abbastanza intensa, tanto che ora mi pare che una recente puntata di Game of Thrones possa quasi essere vista come un omaggio a questo film (vedi immagine allegata). La parte più interessante è sicuramente quella in cui vediamo il protagonista iniziare a instaurare il rapporto con il drago, e riconoscere poco per volta che tutto quanto la sua gente aveva sempre pensato delle bestie era errato, viziato da una prospettiva parziale e distorta. Avevo quasi sperato che ci fosse una componente in più di integrazione biomeccanica tra il drago, il cavaliere e i macchinari, creando un insieme uomo-drago-macchina squisistamente steampunk. Il finale fa un passetto in più in questa direzione, ma non credo che sia questo il nucleo principale della vicenda. Certo un uomo-drago bio-meccanico sarebbe stato davvero fantastico.
La storia del giovane allenatore di draghi ha dei bei momenti, e qualche scena di azione e di volo abbastanza intensa, tanto che ora mi pare che una recente puntata di Game of Thrones possa quasi essere vista come un omaggio a questo film (vedi immagine allegata). La parte più interessante è sicuramente quella in cui vediamo il protagonista iniziare a instaurare il rapporto con il drago, e riconoscere poco per volta che tutto quanto la sua gente aveva sempre pensato delle bestie era errato, viziato da una prospettiva parziale e distorta. Avevo quasi sperato che ci fosse una componente in più di integrazione biomeccanica tra il drago, il cavaliere e i macchinari, creando un insieme uomo-drago-macchina squisistamente steampunk. Il finale fa un passetto in più in questa direzione, ma non credo che sia questo il nucleo principale della vicenda. Certo un uomo-drago bio-meccanico sarebbe stato davvero fantastico.
Ci sono ovviamente anche dei difetti. La storia è in buona parte prevedibile, e diversi anacronismi punteggiano la storia. Certo non si guarda un film del genere pensandolo come un documentario, ma se mi parli di vichinghi e non di una popolazione di un regno inventato, allora mi aspetto che non abbiano i libri stampati. In realtà mi sembra anche che i draghi non siano creature della mitologia nordica, per cui mi suona un po' strano che abbiano scelto questa popolazione invece di un'altra, oppure che appunto non ne abbiano inventata una tipo, chessò, le Isole di Ferro. Forse l'aspetto più fastidioso però è il modo in cui gli altri ragazzetti nella parte finale montano sui draghi e riescono a dirigerli senza alcuno sforzo, cosa che invalida tutta la parte centrale del film in cui Hic costruisce con fatica un rapporto di fiducia con il suo drago. Bisogna anche che qualcuno vada ad Hollywood a spiegare agli autori come funziona il fuoco, e fargli presente che se ti trovi dietro una colonna di legno che sta brucando su tutti i lati, non sei salvo solo perché il fuoco non ti ha toccato. Sai, il calore, le ustioni, la pelle che si squama...? In definitiva, un po' di cura in più avrebbe reso tutto il film più solido e godibile, e quindi insomma, in effetti siamo ancora lontani da Wall-E o Zootopia, fatevene una ragione.
Per la rubrica dei titoli tradotti con fantasia, di cui abbiamo parlato anche in occasione dell'ultimo Coppi Club, qui c'è da notare quell'altra curiosa tendenza a prendere un titolo in inglese e tradurlo con un altro titolo in inglese, che di per sé non è tanto più accessibile dell'originale. Capita più spesso diquanto pensate.
Riprendiamo quindi con un film che negli anni trascorsi da quando è uscito si è guadagnao una certa fama. È risaputo che tra i due grandi studi di animazione digitale Pixar e Dreamworks, il secondo è nettamente inferiore e tende anzi a seguire le orme del primo (vedi Pets che è praticamente Toy Story con gli animali). Nel caso di Dragon Trainer devo ammettere però che c'è del merito, sempre proporzionando le aspettative al prodotto.
 La storia del giovane allenatore di draghi ha dei bei momenti, e qualche scena di azione e di volo abbastanza intensa, tanto che ora mi pare che una recente puntata di Game of Thrones possa quasi essere vista come un omaggio a questo film (vedi immagine allegata). La parte più interessante è sicuramente quella in cui vediamo il protagonista iniziare a instaurare il rapporto con il drago, e riconoscere poco per volta che tutto quanto la sua gente aveva sempre pensato delle bestie era errato, viziato da una prospettiva parziale e distorta. Avevo quasi sperato che ci fosse una componente in più di integrazione biomeccanica tra il drago, il cavaliere e i macchinari, creando un insieme uomo-drago-macchina squisistamente steampunk. Il finale fa un passetto in più in questa direzione, ma non credo che sia questo il nucleo principale della vicenda. Certo un uomo-drago bio-meccanico sarebbe stato davvero fantastico.
La storia del giovane allenatore di draghi ha dei bei momenti, e qualche scena di azione e di volo abbastanza intensa, tanto che ora mi pare che una recente puntata di Game of Thrones possa quasi essere vista come un omaggio a questo film (vedi immagine allegata). La parte più interessante è sicuramente quella in cui vediamo il protagonista iniziare a instaurare il rapporto con il drago, e riconoscere poco per volta che tutto quanto la sua gente aveva sempre pensato delle bestie era errato, viziato da una prospettiva parziale e distorta. Avevo quasi sperato che ci fosse una componente in più di integrazione biomeccanica tra il drago, il cavaliere e i macchinari, creando un insieme uomo-drago-macchina squisistamente steampunk. Il finale fa un passetto in più in questa direzione, ma non credo che sia questo il nucleo principale della vicenda. Certo un uomo-drago bio-meccanico sarebbe stato davvero fantastico.Ci sono ovviamente anche dei difetti. La storia è in buona parte prevedibile, e diversi anacronismi punteggiano la storia. Certo non si guarda un film del genere pensandolo come un documentario, ma se mi parli di vichinghi e non di una popolazione di un regno inventato, allora mi aspetto che non abbiano i libri stampati. In realtà mi sembra anche che i draghi non siano creature della mitologia nordica, per cui mi suona un po' strano che abbiano scelto questa popolazione invece di un'altra, oppure che appunto non ne abbiano inventata una tipo, chessò, le Isole di Ferro. Forse l'aspetto più fastidioso però è il modo in cui gli altri ragazzetti nella parte finale montano sui draghi e riescono a dirigerli senza alcuno sforzo, cosa che invalida tutta la parte centrale del film in cui Hic costruisce con fatica un rapporto di fiducia con il suo drago. Bisogna anche che qualcuno vada ad Hollywood a spiegare agli autori come funziona il fuoco, e fargli presente che se ti trovi dietro una colonna di legno che sta brucando su tutti i lati, non sei salvo solo perché il fuoco non ti ha toccato. Sai, il calore, le ustioni, la pelle che si squama...? In definitiva, un po' di cura in più avrebbe reso tutto il film più solido e godibile, e quindi insomma, in effetti siamo ancora lontani da Wall-E o Zootopia, fatevene una ragione.
Per la rubrica dei titoli tradotti con fantasia, di cui abbiamo parlato anche in occasione dell'ultimo Coppi Club, qui c'è da notare quell'altra curiosa tendenza a prendere un titolo in inglese e tradurlo con un altro titolo in inglese, che di per sé non è tanto più accessibile dell'originale. Capita più spesso diquanto pensate.
Published on September 25, 2017 10:47
September 10, 2017
BoJack Horseman è il Boris di Hollywoo(d)?
Pochi giorni fa è comparsa su Netflix la quarta stagione di
BoJack Horseman
, serie animata ideata nel 2014 da Raphael Bob-Waksberg e prodotta dalla stessa Netflix che ha come protagonista il BoJack del titolo, un uomo-cavallo (in un universo in cui umani e animali antropomorfi convivono normalmente) star di una sitcom degli anni 90, che si sforza per mantenere viva la propria fama vent'anni dopo il successo e dare un senso alla sua vita. Ho scoperto la serie l'anno scorso, quando erano già disponibili le prime tre stagioni, e sto centellinando le puntate di questa quarta, perché sono contrario per principio al binge watching (o al binge-qualunque cosa, per la verità).
 BoJack Horseman si presenta come una commedia, con episodi leggeri e ricchi di gag, spesso incentrate sul mondo dello spettacolo e tutto quanto vi gravita intorno. Con il procedere delle puntate inizia però un cambio di tono, e si vira verso il dramma, o quanto meno il dramedy, soprattutto seguendo il tentativo di BoJack di uscire dal tunnel di insoddisfazione e depressione della star in declino, che trascina tanto lui quanto chi gli sta intorno in un baratro di colpa e autolesionismo. Hollywood (o Hollywoo senza la D, come diventa ben presto nella prima stagione) viene rappresentata come una macchina spietata che fagocita e macina la vita delle persone che ne fanno parte, e in qualche modo tutti i personaggi principali sono compromessi dal loro ruolo nello show business.
BoJack Horseman si presenta come una commedia, con episodi leggeri e ricchi di gag, spesso incentrate sul mondo dello spettacolo e tutto quanto vi gravita intorno. Con il procedere delle puntate inizia però un cambio di tono, e si vira verso il dramma, o quanto meno il dramedy, soprattutto seguendo il tentativo di BoJack di uscire dal tunnel di insoddisfazione e depressione della star in declino, che trascina tanto lui quanto chi gli sta intorno in un baratro di colpa e autolesionismo. Hollywood (o Hollywoo senza la D, come diventa ben presto nella prima stagione) viene rappresentata come una macchina spietata che fagocita e macina la vita delle persone che ne fanno parte, e in qualche modo tutti i personaggi principali sono compromessi dal loro ruolo nello show business.
Questo nucleo della serie mi ha portato a considerare che BoJack Horseman si può considerare, con le dovute proporzioni, una versione hollywoodiana della nostrana serie Boris . Boris è una serie italiana ormai diventata di culto, ambientata sul set di una brutta fiction italiana, in cui si viene a conoscere tutto il mondo di attori, autori, produttori e tecnici che gira intorno alla produzione di una brutta serie tv italiana. Nel cast di Boris ci sono molti nomi che proprio dalla fiction italiana sono emersi, ma che appaiono qui in una luce del tutto diversa (in senso letterale e metaforico), a dimostrazione di come spesso gli attori cani (presenti anche in BoJack Horseman, ma lì sono cani per davvero) non siano il vero problema di queste fiction.
Prima di provare a elencare le attinenze tra le due serie, chiariamo un punto importante. Il protagonista di Boris non è Alessandro, lo stagista che fa da narratore e punto di vista iniziale nella prima stagione: il protagonista è René Ferretti, il regista straordinariamente interpretato da Francesco Pannofino, che prima di questa performance era conosciuto principalmente come doppiatore. Tutti i nodi principali della trama, soprattutto dalla fine della prima stagione al (non riuscitissimo) film, convergono su di lui, mentre gli altri personaggi sono comprimari. Ma è Ferretti il personaggio di cui seguiamo l'arco di sviluppo e delle cui azioni ci importa davvero qualcosa.
Ora, è evidente che BoJack e René non sono del tutto assimilabili, ricoprono ruoli e hanno atteggiamenti diversi. BoJack è manipolatore ed egocentrico; René pavido e disilluso. Eppure entrambi si ritrovano incastrati in una posizione che sentono non gli appartiene, e hanno il proposito di cambiare se stessi e il loro mondo, cercando di fare qualcosa di buon e di meglio. BoJack ci prova interpretando il ruolo del suo eroe di gioventù Secretariat, René tenta in tutti i modi di fare buona televisione invece della solita merda a cazzo di cane che gli viene richiesta. Entrambi sono però destinati al fallimento, tanto per la loro incapacità di superare i loro personali limiti quanto per la pressione esercitata dall'esterno, che li costringe a ripetere gli stessi errori. Entrambi quindi, pur essendo in apparenza apprezzati dagli altri, si sentono vuoti e persi, e sono in cerca di una via d'uscita da questo circolo autodistruttivo.
 Anche altri personaggi principali delle due serie possono essere accostati tra loro. Diane in BoJack ha qualcosa di Arianna di Boris: la ragazza forte, che cerca di mantenere il controllo e far funzionare le cose come dovrebbero, ma si scontra con la superficialità con cui gli altri affrontano i problemi. Mr Peanutbutter ha dei tratti in comune con Stanis LaRochelle, un attore a suo agio con se stesso, che non si pone problemi su ciò che lo circonda e sembra vivere sempre a favore di telecamera. Princess Carolyne può per certi versi assomigliare a Diego Lopez: entrambi si muovono nei meccanismi che stanno dietro il set, cercando far girare gli ingranaggi e trovare la miglior combinazione possibile. Todd e Alessandro sono entrambi degli estranei dell'ambiente, anche se reagiscono alle novità in maniera del tutto diversa. La quantità di personaggi secondari e comparse per entrambe le serie è elevata, per cui è complicato tratteggiare uno per uno i ruoli, ma si possono trovare molte similitudini di questo tipo.
Anche altri personaggi principali delle due serie possono essere accostati tra loro. Diane in BoJack ha qualcosa di Arianna di Boris: la ragazza forte, che cerca di mantenere il controllo e far funzionare le cose come dovrebbero, ma si scontra con la superficialità con cui gli altri affrontano i problemi. Mr Peanutbutter ha dei tratti in comune con Stanis LaRochelle, un attore a suo agio con se stesso, che non si pone problemi su ciò che lo circonda e sembra vivere sempre a favore di telecamera. Princess Carolyne può per certi versi assomigliare a Diego Lopez: entrambi si muovono nei meccanismi che stanno dietro il set, cercando far girare gli ingranaggi e trovare la miglior combinazione possibile. Todd e Alessandro sono entrambi degli estranei dell'ambiente, anche se reagiscono alle novità in maniera del tutto diversa. La quantità di personaggi secondari e comparse per entrambe le serie è elevata, per cui è complicato tratteggiare uno per uno i ruoli, ma si possono trovare molte similitudini di questo tipo.
È importante notare che Cinecittà non è Hollywood, per cui la componente parodistica e satirica differisce molto nelle due serie. Boris è profondamente italiana, e un pubblico diverso non potrebbe mai capire i riferimenti alla cultura pop e al contesto sociale che contiene, mentre il mondo del cinema americano è più conosciuto al di fuori, per cui BoJack Horseman risulta fruibile anche al di fuori della California. Ma come dicevo prima, considerando i giusti rapporti tra i due ambienti, si può notare che molte dinamiche si ripetono in modo simile. Anche gli archi narrativi seguono percorsi simili, basta pensare al tentato riscatto artistico di René e BoJack, oppure alla commistione tra spettacolo e politica.
Boris nel corso delle stagioni ha mantenuto un tono più leggero, continuando a essere principalmente una commedia, ma non per questo superficiale, in quanto il livello metanarrativo di una serie sulla produzione di una serie aggiune in molti casi una dimensione ulteriore. Dall'altra parte BoJack Horseman proseguendo riesce a toccare temi più universali e si fa decisamente più cupa, arrivando alla morte di alcuni personaggi principali e sfiorando quella del protagonista stesso. Ma in entrambe rimane sempre viva l'idea di sdrammatizzare anche le situazioni più tragiche, tanto che nella presente stagione di BoJack (no spoiler qui!) l'evento tragico della precedente è già diventato una farsa.
Il titolo di questo post naturalmente non vuole insinuare che BoJack Horseman sia un plagio di Boris. Ma è evidente che due show che partono da premesse simili, cioè mostrare la vita dei protagonisti riconosciuti e più nascosti del "mondo dello spettacolo" porta a situazioni e personaggi simili. Per cui, a mio avviso chi ha visto una serie non potrà non apprezzare l'altra, e viceversa. Quindi, alla fine dei conti, prendete questo post come un lungo e articolato consiglio di visione. Peraltro, sono entrambe disponibili su Netflix, quindi vista una si può passare agilmente all'altra. Ma niente binge watching, mi raccomando.
 BoJack Horseman si presenta come una commedia, con episodi leggeri e ricchi di gag, spesso incentrate sul mondo dello spettacolo e tutto quanto vi gravita intorno. Con il procedere delle puntate inizia però un cambio di tono, e si vira verso il dramma, o quanto meno il dramedy, soprattutto seguendo il tentativo di BoJack di uscire dal tunnel di insoddisfazione e depressione della star in declino, che trascina tanto lui quanto chi gli sta intorno in un baratro di colpa e autolesionismo. Hollywood (o Hollywoo senza la D, come diventa ben presto nella prima stagione) viene rappresentata come una macchina spietata che fagocita e macina la vita delle persone che ne fanno parte, e in qualche modo tutti i personaggi principali sono compromessi dal loro ruolo nello show business.
BoJack Horseman si presenta come una commedia, con episodi leggeri e ricchi di gag, spesso incentrate sul mondo dello spettacolo e tutto quanto vi gravita intorno. Con il procedere delle puntate inizia però un cambio di tono, e si vira verso il dramma, o quanto meno il dramedy, soprattutto seguendo il tentativo di BoJack di uscire dal tunnel di insoddisfazione e depressione della star in declino, che trascina tanto lui quanto chi gli sta intorno in un baratro di colpa e autolesionismo. Hollywood (o Hollywoo senza la D, come diventa ben presto nella prima stagione) viene rappresentata come una macchina spietata che fagocita e macina la vita delle persone che ne fanno parte, e in qualche modo tutti i personaggi principali sono compromessi dal loro ruolo nello show business.Questo nucleo della serie mi ha portato a considerare che BoJack Horseman si può considerare, con le dovute proporzioni, una versione hollywoodiana della nostrana serie Boris . Boris è una serie italiana ormai diventata di culto, ambientata sul set di una brutta fiction italiana, in cui si viene a conoscere tutto il mondo di attori, autori, produttori e tecnici che gira intorno alla produzione di una brutta serie tv italiana. Nel cast di Boris ci sono molti nomi che proprio dalla fiction italiana sono emersi, ma che appaiono qui in una luce del tutto diversa (in senso letterale e metaforico), a dimostrazione di come spesso gli attori cani (presenti anche in BoJack Horseman, ma lì sono cani per davvero) non siano il vero problema di queste fiction.
Prima di provare a elencare le attinenze tra le due serie, chiariamo un punto importante. Il protagonista di Boris non è Alessandro, lo stagista che fa da narratore e punto di vista iniziale nella prima stagione: il protagonista è René Ferretti, il regista straordinariamente interpretato da Francesco Pannofino, che prima di questa performance era conosciuto principalmente come doppiatore. Tutti i nodi principali della trama, soprattutto dalla fine della prima stagione al (non riuscitissimo) film, convergono su di lui, mentre gli altri personaggi sono comprimari. Ma è Ferretti il personaggio di cui seguiamo l'arco di sviluppo e delle cui azioni ci importa davvero qualcosa.
Ora, è evidente che BoJack e René non sono del tutto assimilabili, ricoprono ruoli e hanno atteggiamenti diversi. BoJack è manipolatore ed egocentrico; René pavido e disilluso. Eppure entrambi si ritrovano incastrati in una posizione che sentono non gli appartiene, e hanno il proposito di cambiare se stessi e il loro mondo, cercando di fare qualcosa di buon e di meglio. BoJack ci prova interpretando il ruolo del suo eroe di gioventù Secretariat, René tenta in tutti i modi di fare buona televisione invece della solita merda a cazzo di cane che gli viene richiesta. Entrambi sono però destinati al fallimento, tanto per la loro incapacità di superare i loro personali limiti quanto per la pressione esercitata dall'esterno, che li costringe a ripetere gli stessi errori. Entrambi quindi, pur essendo in apparenza apprezzati dagli altri, si sentono vuoti e persi, e sono in cerca di una via d'uscita da questo circolo autodistruttivo.
 Anche altri personaggi principali delle due serie possono essere accostati tra loro. Diane in BoJack ha qualcosa di Arianna di Boris: la ragazza forte, che cerca di mantenere il controllo e far funzionare le cose come dovrebbero, ma si scontra con la superficialità con cui gli altri affrontano i problemi. Mr Peanutbutter ha dei tratti in comune con Stanis LaRochelle, un attore a suo agio con se stesso, che non si pone problemi su ciò che lo circonda e sembra vivere sempre a favore di telecamera. Princess Carolyne può per certi versi assomigliare a Diego Lopez: entrambi si muovono nei meccanismi che stanno dietro il set, cercando far girare gli ingranaggi e trovare la miglior combinazione possibile. Todd e Alessandro sono entrambi degli estranei dell'ambiente, anche se reagiscono alle novità in maniera del tutto diversa. La quantità di personaggi secondari e comparse per entrambe le serie è elevata, per cui è complicato tratteggiare uno per uno i ruoli, ma si possono trovare molte similitudini di questo tipo.
Anche altri personaggi principali delle due serie possono essere accostati tra loro. Diane in BoJack ha qualcosa di Arianna di Boris: la ragazza forte, che cerca di mantenere il controllo e far funzionare le cose come dovrebbero, ma si scontra con la superficialità con cui gli altri affrontano i problemi. Mr Peanutbutter ha dei tratti in comune con Stanis LaRochelle, un attore a suo agio con se stesso, che non si pone problemi su ciò che lo circonda e sembra vivere sempre a favore di telecamera. Princess Carolyne può per certi versi assomigliare a Diego Lopez: entrambi si muovono nei meccanismi che stanno dietro il set, cercando far girare gli ingranaggi e trovare la miglior combinazione possibile. Todd e Alessandro sono entrambi degli estranei dell'ambiente, anche se reagiscono alle novità in maniera del tutto diversa. La quantità di personaggi secondari e comparse per entrambe le serie è elevata, per cui è complicato tratteggiare uno per uno i ruoli, ma si possono trovare molte similitudini di questo tipo.È importante notare che Cinecittà non è Hollywood, per cui la componente parodistica e satirica differisce molto nelle due serie. Boris è profondamente italiana, e un pubblico diverso non potrebbe mai capire i riferimenti alla cultura pop e al contesto sociale che contiene, mentre il mondo del cinema americano è più conosciuto al di fuori, per cui BoJack Horseman risulta fruibile anche al di fuori della California. Ma come dicevo prima, considerando i giusti rapporti tra i due ambienti, si può notare che molte dinamiche si ripetono in modo simile. Anche gli archi narrativi seguono percorsi simili, basta pensare al tentato riscatto artistico di René e BoJack, oppure alla commistione tra spettacolo e politica.
Boris nel corso delle stagioni ha mantenuto un tono più leggero, continuando a essere principalmente una commedia, ma non per questo superficiale, in quanto il livello metanarrativo di una serie sulla produzione di una serie aggiune in molti casi una dimensione ulteriore. Dall'altra parte BoJack Horseman proseguendo riesce a toccare temi più universali e si fa decisamente più cupa, arrivando alla morte di alcuni personaggi principali e sfiorando quella del protagonista stesso. Ma in entrambe rimane sempre viva l'idea di sdrammatizzare anche le situazioni più tragiche, tanto che nella presente stagione di BoJack (no spoiler qui!) l'evento tragico della precedente è già diventato una farsa.
Il titolo di questo post naturalmente non vuole insinuare che BoJack Horseman sia un plagio di Boris. Ma è evidente che due show che partono da premesse simili, cioè mostrare la vita dei protagonisti riconosciuti e più nascosti del "mondo dello spettacolo" porta a situazioni e personaggi simili. Per cui, a mio avviso chi ha visto una serie non potrà non apprezzare l'altra, e viceversa. Quindi, alla fine dei conti, prendete questo post come un lungo e articolato consiglio di visione. Peraltro, sono entrambe disponibili su Netflix, quindi vista una si può passare agilmente all'altra. Ma niente binge watching, mi raccomando.
Published on September 10, 2017 02:04
Unknown to Millions
Il blog di Andrea Viscusi since 2010
Libri, fantascienza, serie tv, Futurama, Doctor Who
Libri, fantascienza, serie tv, Futurama, Doctor Who
- Andrea Viscusi's profile
- 81 followers



