Andrea Viscusi's Blog: Unknown to Millions, page 28
May 5, 2018
Coppi Night 29/04/2018 - Ares
C'è stata una certa presenza di film spagnoli in Coppi Night recenti, ma a mia memoria non ne è passato nemmeno uno francese, questo è il primo. E quando dici "film francese" pensi o a quelle commediacce che non fanno ridere o a quella roba autoriale da belle epoque. E invece no, questo è un film di botte in un contesto distopico.
Ares è ambientato in un futuro abbastanza vicino, un'epoca in cui la devastazione economica ha colpito tutti i paesi occidentali (così si intuisce, ma di fatto vediamo solo la Francia) e la disparità tra classi ricche e popolo si è accentuta all'estremo, e fin qui tutto plausibile. I diritti civili sono stati quasi del tutto cancellati, lo Stato ha perso la sua autorità e il potere è detenuto in pratica dalle industrie farmaceutiche. La popolazione si sollazza esclusivamente seguendo i match dell'Arena, combattimenti brutali tra gladiatori geneticamente migliorati e potenziati con droghe di vario genere. Ares è uno di questi guerrieri, un tempo uno dei migliori ma ormai finito nei ranghi più bassi della competizone. Almeno fino a quando una di queste malefiche case farmaceutiche non gli mette gli occhi addosso per farne il test subject di una nuova droga, capace di provocare qualche minuto di forza inarrestabile prima di un crollo totale. Ares, ricattato dalla necessità di salvare sua sorella dalla prigione (e prendersi cura delle nipoti rimaste sole), accetta quindi di partecipare all'esperimento e combattere sotto l'effetto della sostanza.
Ci sono due forze trainanti opposte in questo film. Da una parte abbiamo il protagonista, un personaggio costruito in maniera superba, che racchiude in sé diversi archetipi, e percorre un arco di trasformazione davvero magistrale. Le sue motivazioni sono personali, forti, convincenti. Anche quando sbaglia, lo fa per ragioni del tutto coerenti con la sua storia e i suoi principi. E quando trionfa, la sua vittoria è davvero meritata e notevole. Anche altri personaggi principali sono ben delineati, pur essendo caratterizzati in poco tempo: la nipote attivista, il vicino di casa, l'allenatore/broker. Le dinamiche che si instaurano tra questi funzionano in modo impeccabile.
 Dall'altra però abbiamo un plot con dei risvolti poco chiari, non sempre credibili. C'è innanzitutto lo strapotere di queste enormi aziende farmaceutiche, che di per sé potrebbe anche reggere, ma a un'analisi più approfondita si sgretola. Infatti, se la maggior parte della popolazione è talmente povera da vendersi per le sperimentazioni, i farmaci che vengono elaborati a chi li vendono? Possibile che quella ridotta élite di super ricchi possa reggere tutto il mercato? E poi, se anche è vero che durante questi esperimenti vengono uccise migliaia di cavie, davvero questo può far scatenare la ribellione del popolo, quando si tratta di un fatto ben noto e non c'è nessun potere costituito capace di far rispettare i loro diritti? E se anche i piani della Evil Corporation (o megio, Corporation Mauvaise) vengono sventati dagli eroi, siamo davvero sicuri che basti questo piccolo fallimento a far crollare il loro dominio economico e politico? Insomma, da questo punto di vista la storia è attaccabile in più modi, e sembra quasi che si sia voluto forzare un messaggio politico in un racconto che invece avrebbe retto benissimo come vicenda personale di affermazione e riscatto.
Dall'altra però abbiamo un plot con dei risvolti poco chiari, non sempre credibili. C'è innanzitutto lo strapotere di queste enormi aziende farmaceutiche, che di per sé potrebbe anche reggere, ma a un'analisi più approfondita si sgretola. Infatti, se la maggior parte della popolazione è talmente povera da vendersi per le sperimentazioni, i farmaci che vengono elaborati a chi li vendono? Possibile che quella ridotta élite di super ricchi possa reggere tutto il mercato? E poi, se anche è vero che durante questi esperimenti vengono uccise migliaia di cavie, davvero questo può far scatenare la ribellione del popolo, quando si tratta di un fatto ben noto e non c'è nessun potere costituito capace di far rispettare i loro diritti? E se anche i piani della Evil Corporation (o megio, Corporation Mauvaise) vengono sventati dagli eroi, siamo davvero sicuri che basti questo piccolo fallimento a far crollare il loro dominio economico e politico? Insomma, da questo punto di vista la storia è attaccabile in più modi, e sembra quasi che si sia voluto forzare un messaggio politico in un racconto che invece avrebbe retto benissimo come vicenda personale di affermazione e riscatto.
Comunque alla fine dei conti il bilancio è positivo, un Gladiatore meets Hunger Games con delle belle sequenze di combattimento e qualche colpo di scena azzeccato. Inaspettatamente meritevole, soprattutto per essere, come dicevamo, un film francese.
Ares è ambientato in un futuro abbastanza vicino, un'epoca in cui la devastazione economica ha colpito tutti i paesi occidentali (così si intuisce, ma di fatto vediamo solo la Francia) e la disparità tra classi ricche e popolo si è accentuta all'estremo, e fin qui tutto plausibile. I diritti civili sono stati quasi del tutto cancellati, lo Stato ha perso la sua autorità e il potere è detenuto in pratica dalle industrie farmaceutiche. La popolazione si sollazza esclusivamente seguendo i match dell'Arena, combattimenti brutali tra gladiatori geneticamente migliorati e potenziati con droghe di vario genere. Ares è uno di questi guerrieri, un tempo uno dei migliori ma ormai finito nei ranghi più bassi della competizone. Almeno fino a quando una di queste malefiche case farmaceutiche non gli mette gli occhi addosso per farne il test subject di una nuova droga, capace di provocare qualche minuto di forza inarrestabile prima di un crollo totale. Ares, ricattato dalla necessità di salvare sua sorella dalla prigione (e prendersi cura delle nipoti rimaste sole), accetta quindi di partecipare all'esperimento e combattere sotto l'effetto della sostanza.
Ci sono due forze trainanti opposte in questo film. Da una parte abbiamo il protagonista, un personaggio costruito in maniera superba, che racchiude in sé diversi archetipi, e percorre un arco di trasformazione davvero magistrale. Le sue motivazioni sono personali, forti, convincenti. Anche quando sbaglia, lo fa per ragioni del tutto coerenti con la sua storia e i suoi principi. E quando trionfa, la sua vittoria è davvero meritata e notevole. Anche altri personaggi principali sono ben delineati, pur essendo caratterizzati in poco tempo: la nipote attivista, il vicino di casa, l'allenatore/broker. Le dinamiche che si instaurano tra questi funzionano in modo impeccabile.
 Dall'altra però abbiamo un plot con dei risvolti poco chiari, non sempre credibili. C'è innanzitutto lo strapotere di queste enormi aziende farmaceutiche, che di per sé potrebbe anche reggere, ma a un'analisi più approfondita si sgretola. Infatti, se la maggior parte della popolazione è talmente povera da vendersi per le sperimentazioni, i farmaci che vengono elaborati a chi li vendono? Possibile che quella ridotta élite di super ricchi possa reggere tutto il mercato? E poi, se anche è vero che durante questi esperimenti vengono uccise migliaia di cavie, davvero questo può far scatenare la ribellione del popolo, quando si tratta di un fatto ben noto e non c'è nessun potere costituito capace di far rispettare i loro diritti? E se anche i piani della Evil Corporation (o megio, Corporation Mauvaise) vengono sventati dagli eroi, siamo davvero sicuri che basti questo piccolo fallimento a far crollare il loro dominio economico e politico? Insomma, da questo punto di vista la storia è attaccabile in più modi, e sembra quasi che si sia voluto forzare un messaggio politico in un racconto che invece avrebbe retto benissimo come vicenda personale di affermazione e riscatto.
Dall'altra però abbiamo un plot con dei risvolti poco chiari, non sempre credibili. C'è innanzitutto lo strapotere di queste enormi aziende farmaceutiche, che di per sé potrebbe anche reggere, ma a un'analisi più approfondita si sgretola. Infatti, se la maggior parte della popolazione è talmente povera da vendersi per le sperimentazioni, i farmaci che vengono elaborati a chi li vendono? Possibile che quella ridotta élite di super ricchi possa reggere tutto il mercato? E poi, se anche è vero che durante questi esperimenti vengono uccise migliaia di cavie, davvero questo può far scatenare la ribellione del popolo, quando si tratta di un fatto ben noto e non c'è nessun potere costituito capace di far rispettare i loro diritti? E se anche i piani della Evil Corporation (o megio, Corporation Mauvaise) vengono sventati dagli eroi, siamo davvero sicuri che basti questo piccolo fallimento a far crollare il loro dominio economico e politico? Insomma, da questo punto di vista la storia è attaccabile in più modi, e sembra quasi che si sia voluto forzare un messaggio politico in un racconto che invece avrebbe retto benissimo come vicenda personale di affermazione e riscatto.Comunque alla fine dei conti il bilancio è positivo, un Gladiatore meets Hunger Games con delle belle sequenze di combattimento e qualche colpo di scena azzeccato. Inaspettatamente meritevole, soprattutto per essere, come dicevamo, un film francese.
Published on May 05, 2018 01:30
April 28, 2018
Coppi Night 22/04/2018 - Assunto dai guai
Mentre tutto il mondo là fuori parla di Infinity War e di come Thanos sia finalmente un villain profondo e credibile, con una solida backstory e una motivazione capace di suscitare empatia, io sono qui a dover dire qualcosa di questa roba.
 "Questa roba" è poco più di un film amatoriale, ma anche la parola film non è del tutto adatta perché si tratta di una serie di sketch filmati e messi insieme, con attori tutt'altro che professionisti e una cura pressoché assente per regia, montaggio e sonoro. E uno si chiede, ma come ci arrivi a una cosa del genere? Per semplificare possiamo parlare di passaparola, perché l'intero "film" è girato nelle zone in cui vivo, e anche molti dei personaggi presenti sono interpretati da gente della zona che conosco direttamente o indirettamente. Quindi diciamo che il valore massimo di vedere questo filmettino è quello di riconoscere la strada o il bar, il tizio che era quello che ti ricordi guidava il pulmino della scuola, oppure quella è la mamma di.
"Questa roba" è poco più di un film amatoriale, ma anche la parola film non è del tutto adatta perché si tratta di una serie di sketch filmati e messi insieme, con attori tutt'altro che professionisti e una cura pressoché assente per regia, montaggio e sonoro. E uno si chiede, ma come ci arrivi a una cosa del genere? Per semplificare possiamo parlare di passaparola, perché l'intero "film" è girato nelle zone in cui vivo, e anche molti dei personaggi presenti sono interpretati da gente della zona che conosco direttamente o indirettamente. Quindi diciamo che il valore massimo di vedere questo filmettino è quello di riconoscere la strada o il bar, il tizio che era quello che ti ricordi guidava il pulmino della scuola, oppure quella è la mamma di.
Una trama ci sarebbe, quella di un ragazzotto cazzone che cerca lavoro ma per lo più passa la giornata al bar o al campo di calcetto dove ha una faida con l'allenatore della squadra dei bambini del paese, e per questo cerca di convincere il sindaco a licenziarlo. Poi incontra un prete e uno che gli vuole offrire lavoro, e alla fine viene convocata un'assemblea cittadina in chiesa alla presenza del parroco (!?!) per informare tutti di non ho capito cosa. Fine.
Per il resto non c'è davvero niente da dire. Il film è oggettivamente bruttarello e poco divertente, che dovrebbe essere il suo obiettivo. Qualche singola freddura può essere simpatica (la più memorabile è "stasera tutti davanti la televisione, perché dietro non si vede nulla"), ma si tratta di quelle battute che se le senti durante una serata al bar ti fanno sganasciare, ma viste recitate sullo schermo non hanno lo stesso effetto. Non mi sento però di demolire del tutto la cosa, che come viene ripetuto più volte nella lunga introduzione del protagonista al video caricato su youtube, è stato realizzato senza budget e senza mezzi. Quindi valutato come lavoro amatoriale, come fosse la recita di fine anno della seconda media, non gli si può nemmeno dire che vadano a potare le siepi. Va preso per quello che è.
Come dicevo sopra, il film si trova interamente su Youtube, ma non ne consiglio la visione. La comicità toscana di cui dovrebbe essere un'espressione è presente, ma piuttosto posticcia, quindi non funziona. Se volete farvi due risate su questo tipo di umorismo, fate meglio ad andare a vedere un torneo di burraco al circolo ARCI di un qualunque paesino della provincia toscana.
 "Questa roba" è poco più di un film amatoriale, ma anche la parola film non è del tutto adatta perché si tratta di una serie di sketch filmati e messi insieme, con attori tutt'altro che professionisti e una cura pressoché assente per regia, montaggio e sonoro. E uno si chiede, ma come ci arrivi a una cosa del genere? Per semplificare possiamo parlare di passaparola, perché l'intero "film" è girato nelle zone in cui vivo, e anche molti dei personaggi presenti sono interpretati da gente della zona che conosco direttamente o indirettamente. Quindi diciamo che il valore massimo di vedere questo filmettino è quello di riconoscere la strada o il bar, il tizio che era quello che ti ricordi guidava il pulmino della scuola, oppure quella è la mamma di.
"Questa roba" è poco più di un film amatoriale, ma anche la parola film non è del tutto adatta perché si tratta di una serie di sketch filmati e messi insieme, con attori tutt'altro che professionisti e una cura pressoché assente per regia, montaggio e sonoro. E uno si chiede, ma come ci arrivi a una cosa del genere? Per semplificare possiamo parlare di passaparola, perché l'intero "film" è girato nelle zone in cui vivo, e anche molti dei personaggi presenti sono interpretati da gente della zona che conosco direttamente o indirettamente. Quindi diciamo che il valore massimo di vedere questo filmettino è quello di riconoscere la strada o il bar, il tizio che era quello che ti ricordi guidava il pulmino della scuola, oppure quella è la mamma di.Una trama ci sarebbe, quella di un ragazzotto cazzone che cerca lavoro ma per lo più passa la giornata al bar o al campo di calcetto dove ha una faida con l'allenatore della squadra dei bambini del paese, e per questo cerca di convincere il sindaco a licenziarlo. Poi incontra un prete e uno che gli vuole offrire lavoro, e alla fine viene convocata un'assemblea cittadina in chiesa alla presenza del parroco (!?!) per informare tutti di non ho capito cosa. Fine.
Per il resto non c'è davvero niente da dire. Il film è oggettivamente bruttarello e poco divertente, che dovrebbe essere il suo obiettivo. Qualche singola freddura può essere simpatica (la più memorabile è "stasera tutti davanti la televisione, perché dietro non si vede nulla"), ma si tratta di quelle battute che se le senti durante una serata al bar ti fanno sganasciare, ma viste recitate sullo schermo non hanno lo stesso effetto. Non mi sento però di demolire del tutto la cosa, che come viene ripetuto più volte nella lunga introduzione del protagonista al video caricato su youtube, è stato realizzato senza budget e senza mezzi. Quindi valutato come lavoro amatoriale, come fosse la recita di fine anno della seconda media, non gli si può nemmeno dire che vadano a potare le siepi. Va preso per quello che è.
Come dicevo sopra, il film si trova interamente su Youtube, ma non ne consiglio la visione. La comicità toscana di cui dovrebbe essere un'espressione è presente, ma piuttosto posticcia, quindi non funziona. Se volete farvi due risate su questo tipo di umorismo, fate meglio ad andare a vedere un torneo di burraco al circolo ARCI di un qualunque paesino della provincia toscana.
Published on April 28, 2018 02:56
April 24, 2018
In morte di Tim Bergling
Pochi giorni fa il mondo ha appreso della morte di Avicii, dj e producer svedese asceso alla fama globale con un paio di pezzi azzeccati, trovato senza vita in una stanza d'albergo durante una vacanza, a ventotto anni. Sui media italiani la vicenda non è stata affrontata molto oltre la notizia, ennesima tragedia annunciata di un ragazzino troppo ricco e troppo famoso, probabilmente drogato, comunque senza alcun valore artistico. Mi piacerebbe spendere qualche parola in più, un po' perché da qualche anno ho iniziato a dare tutto un altro peso alla morte, un po' perché credo che non gli sia stata resa giustizia.
Non parlo da fanboy. La musica di Avicii non rientra pienamente nei generi che più apprezzo, anche se devo ammettere che, nell'ambito di questa euro house cheesy che sta girando negli ultimi anni, lui mi sembrava forse l'unico che aveva davvero qualcosa da dire, e la cui musica non era soltanto un'assemblaggio di kick, bassi, phaser e autotune. Non parlerò comunque della qualità della sua musica, lascio che ognuno valuti questo aspetto secondo i propri gusti.
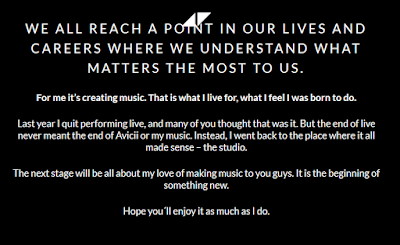 Avicii, o Tim Bergling come lo chiamavano a casa sua, non stava bene. Aveva avuto problemi di salute, dovuti principalmente all'alcool. La cosa risale a un paio di anni fa, quindi parliamo di problemi di alcolismo a venticinque anni. All'apice della sua carriera, si era ritirato dalla scena, annunciando che non si sarebbe più esibito in giro per il mondo, e il mondo lo ha girato parecchio, in pochi anni. Quasi un anno dopo questo annuncio, appena qualche mese fa, un altro che ancora si trova sul suo sito: avrebbe ripreso a fare musica, ma non i concerti: We all reach a point in our lives when we understand what matters the most to us.
Avicii, o Tim Bergling come lo chiamavano a casa sua, non stava bene. Aveva avuto problemi di salute, dovuti principalmente all'alcool. La cosa risale a un paio di anni fa, quindi parliamo di problemi di alcolismo a venticinque anni. All'apice della sua carriera, si era ritirato dalla scena, annunciando che non si sarebbe più esibito in giro per il mondo, e il mondo lo ha girato parecchio, in pochi anni. Quasi un anno dopo questo annuncio, appena qualche mese fa, un altro che ancora si trova sul suo sito: avrebbe ripreso a fare musica, ma non i concerti: We all reach a point in our lives when we understand what matters the most to us.
Avicii, o Tim, ha raggiunto quel punto a ventisei anni. Mi sembra quasi di vederlo, aizzare una folla di diecimila persone, e poi tornare in una stanza d'albergo, taggato in migliaia di foto e video, e sdraiarsi sul letto, da solo. Spremuto da un'industria che ha bisogno di personaggi come lui, prosciugato da chi ha bisogno di una traccia di talento per costruire un idolo da far adorare al pubblico, troppo ricco e troppo famoso. Non è stato il primo e non sarà l'ultimo a bruciarsi in questo gioco perverso del too much too fast, in cui di solito chi si arricchisce davvero è qualcuno di cui nessuno conosce il volto. È uscito poco tempo fa su Netflix un documentario dedicato proprio a lui, dove sono ripercorse le tappe della sua fulminante carriera. Col senno di poi, appare evidente che qualcosa non era come doveva essere, e lui stesso lo ammette.
Le circostanze della morte non sono state rese pubbliche dalle autorità per rispetto nei confronti della famiglia, sono esclusi comunque azioni criminali. Nessun omicidio o avvelenamento. E forse non è stato nemmeno un suicidio, ma si percepisce comunque una cappa di oscurità su questa morte. La sensazione diffusa è che non è morto per un incidente, e che c'era comunque qualcosa, nella sua vita, che non ha funzionato. Nonostante la fama, nonostante l'amore incondizionato del suo pubblico, nonostante la possibilità di parlare a milioni di persone, notte dopo notte.
Tim, o Avicii, aveva davvero qualcosa da dire, ma forse non ci è riuscito. Proviamo ad ascoltare meglio la prossima volta, se non altro per chi abbiamo vicino.
Non parlo da fanboy. La musica di Avicii non rientra pienamente nei generi che più apprezzo, anche se devo ammettere che, nell'ambito di questa euro house cheesy che sta girando negli ultimi anni, lui mi sembrava forse l'unico che aveva davvero qualcosa da dire, e la cui musica non era soltanto un'assemblaggio di kick, bassi, phaser e autotune. Non parlerò comunque della qualità della sua musica, lascio che ognuno valuti questo aspetto secondo i propri gusti.
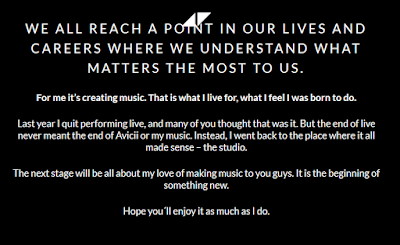 Avicii, o Tim Bergling come lo chiamavano a casa sua, non stava bene. Aveva avuto problemi di salute, dovuti principalmente all'alcool. La cosa risale a un paio di anni fa, quindi parliamo di problemi di alcolismo a venticinque anni. All'apice della sua carriera, si era ritirato dalla scena, annunciando che non si sarebbe più esibito in giro per il mondo, e il mondo lo ha girato parecchio, in pochi anni. Quasi un anno dopo questo annuncio, appena qualche mese fa, un altro che ancora si trova sul suo sito: avrebbe ripreso a fare musica, ma non i concerti: We all reach a point in our lives when we understand what matters the most to us.
Avicii, o Tim Bergling come lo chiamavano a casa sua, non stava bene. Aveva avuto problemi di salute, dovuti principalmente all'alcool. La cosa risale a un paio di anni fa, quindi parliamo di problemi di alcolismo a venticinque anni. All'apice della sua carriera, si era ritirato dalla scena, annunciando che non si sarebbe più esibito in giro per il mondo, e il mondo lo ha girato parecchio, in pochi anni. Quasi un anno dopo questo annuncio, appena qualche mese fa, un altro che ancora si trova sul suo sito: avrebbe ripreso a fare musica, ma non i concerti: We all reach a point in our lives when we understand what matters the most to us.Avicii, o Tim, ha raggiunto quel punto a ventisei anni. Mi sembra quasi di vederlo, aizzare una folla di diecimila persone, e poi tornare in una stanza d'albergo, taggato in migliaia di foto e video, e sdraiarsi sul letto, da solo. Spremuto da un'industria che ha bisogno di personaggi come lui, prosciugato da chi ha bisogno di una traccia di talento per costruire un idolo da far adorare al pubblico, troppo ricco e troppo famoso. Non è stato il primo e non sarà l'ultimo a bruciarsi in questo gioco perverso del too much too fast, in cui di solito chi si arricchisce davvero è qualcuno di cui nessuno conosce il volto. È uscito poco tempo fa su Netflix un documentario dedicato proprio a lui, dove sono ripercorse le tappe della sua fulminante carriera. Col senno di poi, appare evidente che qualcosa non era come doveva essere, e lui stesso lo ammette.
Le circostanze della morte non sono state rese pubbliche dalle autorità per rispetto nei confronti della famiglia, sono esclusi comunque azioni criminali. Nessun omicidio o avvelenamento. E forse non è stato nemmeno un suicidio, ma si percepisce comunque una cappa di oscurità su questa morte. La sensazione diffusa è che non è morto per un incidente, e che c'era comunque qualcosa, nella sua vita, che non ha funzionato. Nonostante la fama, nonostante l'amore incondizionato del suo pubblico, nonostante la possibilità di parlare a milioni di persone, notte dopo notte.
Tim, o Avicii, aveva davvero qualcosa da dire, ma forse non ci è riuscito. Proviamo ad ascoltare meglio la prossima volta, se non altro per chi abbiamo vicino.
Published on April 24, 2018 02:00
April 20, 2018
Rapporto letture - Marzo 2018
Questo potrebbe anche chiamarsi "rapporto lettura", perché come accennavo un paio di post fa, sarà un post molto scarno. Di fatti a marzo ho completato un solo libro, e per la verità anche piuttosto corto. Il mio criterio per l'inclusione dei libri nei rapporti letture è i libri finiti nel mese, per cui in questo caso, pur avendo avuto per le mani un altro libro per buona parte di marzo, l'ho finito ad aprile e quindi dovrà finire nel rapporto del prossimo mese.
 Quindi il piccolo volume di cui si parla è uno della collana Future Fiction, ovvero
MeccanicaMente
di Carme Torras, ricercatrice informatica spagnola dedita allo studio sull'intelligenza artificiale. E proprio di AI si parla in questa raccolta, che contiene due racconti e due brevi saggi scritti per conferenze sul tema. Si nota anche il taglio dei racconti, che in effetti è poco "narrativo" e molto "didattico", con storie dalla struttura lineare e prevedibile, che forse mancano di quel filo di tensione che potrebbe tenere più alta l'attenzione del lettore. Si parla comunque di intelligenza artificiale e della sua integrazione nella vita quotidiana, con personaggi che si confrontano con derivazioni, palesi o meno, di questa tecnologia. Nei successivi testi l'argomento è ancora quello, trattato chiaramente in maniera più tecnica ma non pesante, peccato che alcune sezioni dei due saggi siano praticamente uguali (probabilmente riproposte in occasione diverse). Nel complesso una lettura non molto varia, dagli spunti interessanti ma un po' carente quanto a potenziale di coinvolgimento. Voto: 5/10
Quindi il piccolo volume di cui si parla è uno della collana Future Fiction, ovvero
MeccanicaMente
di Carme Torras, ricercatrice informatica spagnola dedita allo studio sull'intelligenza artificiale. E proprio di AI si parla in questa raccolta, che contiene due racconti e due brevi saggi scritti per conferenze sul tema. Si nota anche il taglio dei racconti, che in effetti è poco "narrativo" e molto "didattico", con storie dalla struttura lineare e prevedibile, che forse mancano di quel filo di tensione che potrebbe tenere più alta l'attenzione del lettore. Si parla comunque di intelligenza artificiale e della sua integrazione nella vita quotidiana, con personaggi che si confrontano con derivazioni, palesi o meno, di questa tecnologia. Nei successivi testi l'argomento è ancora quello, trattato chiaramente in maniera più tecnica ma non pesante, peccato che alcune sezioni dei due saggi siano praticamente uguali (probabilmente riproposte in occasione diverse). Nel complesso una lettura non molto varia, dagli spunti interessanti ma un po' carente quanto a potenziale di coinvolgimento. Voto: 5/10
Quindi per parlare di cosa mi ha tenuto occupato buona parte di marzo e la prima settimana di aprile dovremo aspettare ancora un mesetto, ma se intanto volete un indizio, pensate a Mumon.
 Quindi il piccolo volume di cui si parla è uno della collana Future Fiction, ovvero
MeccanicaMente
di Carme Torras, ricercatrice informatica spagnola dedita allo studio sull'intelligenza artificiale. E proprio di AI si parla in questa raccolta, che contiene due racconti e due brevi saggi scritti per conferenze sul tema. Si nota anche il taglio dei racconti, che in effetti è poco "narrativo" e molto "didattico", con storie dalla struttura lineare e prevedibile, che forse mancano di quel filo di tensione che potrebbe tenere più alta l'attenzione del lettore. Si parla comunque di intelligenza artificiale e della sua integrazione nella vita quotidiana, con personaggi che si confrontano con derivazioni, palesi o meno, di questa tecnologia. Nei successivi testi l'argomento è ancora quello, trattato chiaramente in maniera più tecnica ma non pesante, peccato che alcune sezioni dei due saggi siano praticamente uguali (probabilmente riproposte in occasione diverse). Nel complesso una lettura non molto varia, dagli spunti interessanti ma un po' carente quanto a potenziale di coinvolgimento. Voto: 5/10
Quindi il piccolo volume di cui si parla è uno della collana Future Fiction, ovvero
MeccanicaMente
di Carme Torras, ricercatrice informatica spagnola dedita allo studio sull'intelligenza artificiale. E proprio di AI si parla in questa raccolta, che contiene due racconti e due brevi saggi scritti per conferenze sul tema. Si nota anche il taglio dei racconti, che in effetti è poco "narrativo" e molto "didattico", con storie dalla struttura lineare e prevedibile, che forse mancano di quel filo di tensione che potrebbe tenere più alta l'attenzione del lettore. Si parla comunque di intelligenza artificiale e della sua integrazione nella vita quotidiana, con personaggi che si confrontano con derivazioni, palesi o meno, di questa tecnologia. Nei successivi testi l'argomento è ancora quello, trattato chiaramente in maniera più tecnica ma non pesante, peccato che alcune sezioni dei due saggi siano praticamente uguali (probabilmente riproposte in occasione diverse). Nel complesso una lettura non molto varia, dagli spunti interessanti ma un po' carente quanto a potenziale di coinvolgimento. Voto: 5/10Quindi per parlare di cosa mi ha tenuto occupato buona parte di marzo e la prima settimana di aprile dovremo aspettare ancora un mesetto, ma se intanto volete un indizio, pensate a Mumon.
Published on April 20, 2018 10:51
April 15, 2018
Le serie tv che ho smesso di guardare
 La prossima settimana inizierà la seconda stagione di Westworld e a distanza di pochi giorni anche la seconda stagione di 3%. E di settimana in settimana, sbocciano qua è là tra le varie piattaforme e canali a pagamento altri show e vengono lanciati annunci per i progetti futuri: dal Signore degli anelli alla Torre Nera passando per
Queste Oscure Materie
, da Star Wars a Star Trek passando per la Fondazione... e questo solo considerando l'ambito delle serie di genere "fantastico" che è quello che mi interessa di più e per cui di conseguenza conosco gli sviluppi, ma al di fuori dal fantastico ce ne sono sicuramente altrettante annunciate o in uscita. Si dice che stiamo vivendo l'epoca d'oro delle serie tv, e probabilmente è vero nel senso che l'attenzione del pubblico e gli investimenti confluiscono in maniera massiccia su questo settore. Ma è cosa risaputa che quantità e qualità vanno raramente di pari passo, e soprattutto, il tempo per dedicarsi a ognuna di queste non può bastare a chiunque voglia mantenere in equilibrio le proprie funzioni fisiologiche e psichiche.
La prossima settimana inizierà la seconda stagione di Westworld e a distanza di pochi giorni anche la seconda stagione di 3%. E di settimana in settimana, sbocciano qua è là tra le varie piattaforme e canali a pagamento altri show e vengono lanciati annunci per i progetti futuri: dal Signore degli anelli alla Torre Nera passando per
Queste Oscure Materie
, da Star Wars a Star Trek passando per la Fondazione... e questo solo considerando l'ambito delle serie di genere "fantastico" che è quello che mi interessa di più e per cui di conseguenza conosco gli sviluppi, ma al di fuori dal fantastico ce ne sono sicuramente altrettante annunciate o in uscita. Si dice che stiamo vivendo l'epoca d'oro delle serie tv, e probabilmente è vero nel senso che l'attenzione del pubblico e gli investimenti confluiscono in maniera massiccia su questo settore. Ma è cosa risaputa che quantità e qualità vanno raramente di pari passo, e soprattutto, il tempo per dedicarsi a ognuna di queste non può bastare a chiunque voglia mantenere in equilibrio le proprie funzioni fisiologiche e psichiche.La soluzione quindi, è solo una: come l'unica strategia vincente al casino è quella di non giocare, per le serie l'unica possibilità di riuscita è di abbandonarle.
No, questo non è un post anarchico che invita alla lotta non violenta verso l'industria dell'intrattenimento che sta prosciugando la nostra capacità critica (ne trovate molti altri ben più validi in giro), ma soltanto una presa di coscienza. Appurato che non si può seguire ogni serie solo per poterne discutere su facebook dieci minuti dopo la fine dell'episodio (o dell'intera stagione bingiata su Netflix), ci si accorge che non si deve farlo, ovvero che non c'è niente che ci obblighi a continuare a dedicare il nostro tempo a un prodotto che non ha niente da offrire, semplicemente per inerzia, accidia o noia. Conosco molte persone che non hanno nessuna motivazione per seguire una serie al di là di "ormai l'ho iniziata sei anni fa, che faccio smetto ora?" Sì, è proprio quello che dovreste fare!
Per stimolare la riflessione e l'autoanalisi butto giù la mia lista di serie recenti rimaste incompiute, che ho iniziato a vedere e che ho interrotto, a volte molto presto, a volte a pochi minuti dalla fine, quando ho capito che non valevano il mio tempo.
The Walking Dead. Ho smesso di guardarlo verso l'inizio della quarta stagione, dopo la fine della storyline del Governatore (che già avrebbe dovuto concludersi alla fine della stagione precedente, ma invece è stato trascinato per qualche altro episodio). A differenza di molti avevo trovato la seconda stagione abbastanza valida, mentre i primi segni di insofferenza erano arrivati nel corso della terza. Ammetto però che ogni tanto mi leggo i recap delle nuove puntate, giusto per sapere dove la storia chiaramente senza sbocco sta andando (spoiler: da nessuna parte). Per la verità da quello che sento e leggo in giro mi pare che non esista un solo spettatore soddisfatto di quello che vede, eppure la serie fa ancora dei numeri rilevanti. Questo è quindi uno dei casi più emblematici.
Penny Dreadful. Una prima stagione piuttosto interessante, grazie all'intreccio di questi personaggi iconici (anche se si era già visto nella Lega degli Uomini Straordinari). Seconda stagione così così, abbandono a metà della terza che, anche in questo caso, sembrava girare su se stessa, forse prigioniera dell'incertezza sul futuro della serie (che poi è una delle ragioni principali per cui molte sembrano concludersi-ma-non-del-tutto a ogni stagione).
Una serie di sfortunati eventi. L'ultimo episodio della prima stagione è rimasto lì da solo, e Netflix ogni tanto mi chiede se voglia continuare a vederlo ma no, non accadrà. In effetti ho visto anche en passant parte del primo episodio della seconda staigone, ma mi sono addormentato e non me ne pento. Nonostante lo stile gradevole, la formula risulta noiosa e ripetitiva molto presto. Inoltre, a differenza del film omonimo di diversi anni fa, le personalità e i "poteri" dei protagonisti sono molto blande e poco rilevanti. E poi siamo onesti, la performance di Jim Carrey è inarrivabile.
Dirk Gently Agenzia di Investigazione Olistica. Vista tutta la prima stagione, ma non ho nessun inteesse per la seconda. Questo Dirk Gently è a mio avviso molto inferiore a quello del primo tentativo di trasposizione, e si affida fin troppo al caos e al surreale, confondendo il significato dell'olismo con quello di casualità.
Legion. Gustosa fino a metà per il modo in cui realtà, memoria e spazio mentale si sovrappongono e come questa confusione è resa. Il gioco però non basta da sé a reggere tutta la serie e le varie incoerenze minano la credibilità. Finita con sforzo la prima stagione, non continuerò.
Zoo. In questo caso non sono sicuro al cento per cento di averla abbandonata. Ho vissuto la prima stagione come un prodotto semiparodistico, a volte talmente assurdo nelle nozioni e nello svolgimento da sembrare qualcosa tipo Una pallottola spuntata. In questo modo me lo sono quasi goduto, ma ora che so di cosa si tratta, non sono sicuro di avere bisogno di una seconda e terza stagione. Non lo escludo del tutto, ma probabilmente non saprò mai come andrà a finire la ribellione degli animali.
Game of Thrones. Questo è un caso particolare, perché ci sto ancora riflettendo. Manca ancora un anno per la stagione finale, e onestamente sto vivendo l'attesa con tutta la serenità di Kermit che sorseggia il tè. Le ultime due stagioni hanno completamente sovvertito lo scopo iniziale della serie, virando da un prodotto decostruttivo dell'epica fantasy a una fanfiction di una sessione di D&D. C'è da dire che si parla in questo caso di un prodotto di fattura davvero ottima, sempre impressionante da vedere, ma quando su ogni puntata puoi basarci sopra un drinking game vuol dire che la serietà si è persa per strada.
Stranger Things. Visto il primo episodio. Non ho bisogno di questa ruffianata, grazie.
Analogamente, ci sono molte serie che sulla carta potrebbero interessarmi ma di cui per il momento mi sto tenendo lontano, perché prima di invischiarmi in qualcosa che non mi porti da nessuna parte voglio essere sicuro di quello che faccio. Mi riferisco ad esempio a Dark, American Gods, The Handmaid's Tale, Altered Carbon, Lost in Space: tutte serie che in molti mi hanno consigliato, e che io stesso sono sicuro potrebbero piacermi, ma... non lo so. Ci penserò, ok?
Invito tutti a fare lo stesso esercizio, prendere le serie abbandonate (se ne avete) e capire perché lo avete fatto. Sarà molto utile a realizzare che cosa cercate davvero in una serie, e separare quindi quelle che ha senso continuare a seguire da quelle che dovrete abbandonare. Sarà traumatico, all'inizio, ma poi proverete tanto sollievo.
Published on April 15, 2018 09:41
April 9, 2018
Neal Stephenson & Nicole Galland - The Rise and Fall of D.O.D.O.
 Dato che il rapporto letture di marzo, come vedrete presto, sarà molto breve, ho pensato che fosse il caso di approfondire invece un libro di cui ho già detto qualcosa nel rapporto letture del mese prima. The Rise and Fall of D.O.D.O. è un romanzo scritto a quattro mani da Neal Stephenson e Nicole Galland, pubblicato nel 2017 e al momento inedito in Italia. Su questo blog si tiene in estrema considerazione il signor Stephenson, perciò capitando sottomano il volume in questione è stato prontamente acquistato e letto a distanza di pochi mesi, saltando pile di letture promesse risalenti all'era precedente ai social network. Il fatto che in copertina comparisse anche il nome di un altro autore di cui non sapevo nulla (e in effetti anche ora ne so ben poco) non mi ha scoraggiato né insospettito troppo. Mi fido troppo di Neal.
Dato che il rapporto letture di marzo, come vedrete presto, sarà molto breve, ho pensato che fosse il caso di approfondire invece un libro di cui ho già detto qualcosa nel rapporto letture del mese prima. The Rise and Fall of D.O.D.O. è un romanzo scritto a quattro mani da Neal Stephenson e Nicole Galland, pubblicato nel 2017 e al momento inedito in Italia. Su questo blog si tiene in estrema considerazione il signor Stephenson, perciò capitando sottomano il volume in questione è stato prontamente acquistato e letto a distanza di pochi mesi, saltando pile di letture promesse risalenti all'era precedente ai social network. Il fatto che in copertina comparisse anche il nome di un altro autore di cui non sapevo nulla (e in effetti anche ora ne so ben poco) non mi ha scoraggiato né insospettito troppo. Mi fido troppo di Neal.La prima domanda che viene in mente, leggendo il titolo e vedendo la copertina con un dodo e dei gatti a testa in giù, è sicuramente "che cos'è il D.O.D.O.?" È una domanda che anche Melisande Stokes, una delle protagoniste e narratrici del libro, si pone per qualche centinaio di pagine, anche quando del D.O.D.O. è già entrata a far parte: la sigla sta per Department of Diachronic Operations , ovvero "Dipartimento per le operazioni diacroniche". E allora, cos'è la "diacronica"? In una parola: viaggio nel tempo.
Quindi The Rise and Fall of D.O.D.O. (che potremmo chiamare per comodità TRAFODODO, ma non so quanto sarebbe davvero comodo) è soltanto un'altra storia sui viaggio nel tempo? Sì, ma no. Sì, perché tutto il nucleo centrale della storia verte intorno alla possibilità del viaggio nel tempo e il modo in cui questa possibilità viene sfruttata in modo strategico dall'apparato militare degli USA. Niente di nuovo quindi. Ma dicevamo: anche no, perché per arrivare al viaggio nel tempo si fa un giro molto largo, che inizia con la magia.
Con "magia" si intende proprio la stregoneria: incantesimi e sortilegi operati dalle streghe. Nella continuity del romanzo, la magia è stata comune e nota per buona parte della storia umana, fino alla metà dell'Ottocento, quando ha iniziato a dissiparsi e sparire, per una ragione ben precisa. Il coinvolgimento iniziale di Melisande, dopo essere stata reclutata da Tristan Lyons, consiste infatti in un lavoro di traduzione di antichi documenti che parlano proprio della magia come qualcosa di perfettamente quotidiano. Solo in tempi recenti si è perso l'uso di questa disciplina, e l'obiettivo del D.O.D.O. è recuperarne l'uso. Per farlo servono però delle congiunture molto particolari: innanzitutto c'è bisogno di una strega, ovvero una donna (e solo una donna, nessun uomo può farlo) che conosce la magia e può praticarla; in secondo luogo serve un ambiente quanticamente indipendente dalla realtà circostante.
Se avete familiarità con Neal Stephenson, lo conoscete come un autore capace di scrivere paginate di nozioni e speculazioni scientifiche e filosofiche all'interno delle sue storie, senza perdere per una pagina l'attenzione del lettore. Uno che si diverte coi concetti, le ipotesi e le estrapolazioni. In questo caso, sono convinto che l'interpretazione della magia sia una sua idea: la magia è "solo" la selezione di un percorso probabilistico diverso a livello quantistico degli stati della materia. Le streghe sono capaci (in modo intuitivo, non certo conoscendo la fisica teorica sottostante) di "selezionare" un ramo probabilistico diverso da quello in cui si trovano e renderlo vero. In questo modo possono trasformare una persona in una rana, cambiare colore a un vestito, curare una ferita, e fare tante altre cose utili... come spedire altra gente indietro nel tempo. Il problema è che qualcosa nel 1851 ha reso la magia inutilizzabile, per cui per riuscire a praticarla è necessario creare un ambiente isolato all'interno del quale sia possibile operare separatamente dalla realtà circostante: una sorta di cabina di Schrodinger, per farsi un'idea.
Questi due elementi cruciali sono messi in campo dal professor Oda e da Miss Erszbet Karpathy, rispettivamente fisico teorico radiato dall'università e strega balcanica desiderosa di praticare la sua arte. Dopodiché, alla squadra del D.O.D.O., composta inizialmente solo da questi pochi operativi, non rimane che tentare i primi esperimenti e sperare che i fondi del governo continuino a scorrere. Infatti, la loro prima missione ha il nobile intento di portare nel presente il primo libro stampato in America in modo da poterlo vendere all'asta e farci una vagonata di soldi con cui mantenere il progetto. A complicare tutte le operazioni diacroniche c'è inoltre il fatto che alterare la storia è meno facile di quello che si pensa, perché ogni azione nel passato deve essere ripetuta più e più volte, su diverse "ramificazioni" (strand) della storia, fino a quando non si raggiunge una massa critica di cambiamenti tale che la realtà non può fare a meno che prenderne atto e modifiarsi di conseguenza. Chiaramente, giocare con la trama della realtà non è una cosa da poco, e si tira troppo quel tessuto si può rompere, innescando eventi di portata devastante. Tutto questo senza contare che fare a botte nel medioevo è tutt'altra cosa rispetto a quello che si pensa comunemente.
Il D.O.D.O. non ha vita facile, perché deve districarsi tra il bisogno di segretezza assoluta, e la necessità di controllo capillare da parte dell'esercito e gli enti statali che lo sovvenzionano. Man mano che cresce, che nuovo personale viene assunto e nuove sezioni sono aperte, si instaura una rigida burocrazia fatta di intranet, memo, codici di comportamento, lessico e sigle ufficiali, feste aziendali, e così via. Tutta la parte centrale del libro consiste praticamente nel racconto surreale di come un progetto che si regge sulla magia e il viaggio nel tempo viene gestito come una startup. Crescendo, il D.O.D.O. sfugge dalle mani dei suoi iniziali creatori, ed è allora che le incrinature nell'organizzazione iniziano a espandersi e si hanno le prime avvisaglie del disastro che comporterà la caduta del Dipartimento.
Se leggete The Rise and Fall of D.O.D.O. in cerca di una storia "alla Neal Stephenson" allora potreste rimanere delusi. Questo romanzo ha ben poco della struttura e della portata di un Seveneves ma anche di un Reamde . Tuttavia, si intuisce la vastità delle idee sottostanti e viene offerta più di un'occhiata all'abisso di nozioni e teorie che possono sorreggere i concetti che vengono affrontati per lo più nella loro espressione più pragmatica. Probabilmente l'apporto di Nicole Galland è stato principalmente quello di trasporre la storia in una forma più leggera, composta principalmente di stralci di diario scritti dalle protagoniste femminili, con una notevole dose di humor a volte esplicito e molte altre celato. Se quindi non sopportate la presunta pesantezza di Stephenson, allora leggere TRAFODODO può essere la soluzione per farvelo assaporare a dosi meno letali, per poi passare a qualche altra delle sue immense opere. Magari il salto diretto ad Anathem sarebbe esagerato, ma un po' per volta ci si può arrivare.
Non è dato di sapere se questo libro arriverà mai in Italia, ma considerando che anche Seveneves ancora non si vede, e che per di più il volume è tipograficamente complesso, con un sacco di stili di composizione diversa del testo e un lessico estremamente e doppiamente gergale (gergo e gergo interno al gergo), mi viene da pensare che pochi editori possano avere voglia di impegnarsi in un lavoro del genere. Quindi con ogni probabilità per leggerlo dovrete farlo in lingua originale. Oppure trovare una KCW che possa entrare in un ODEC e wendare su una strand dove il libro è già stato tradotto e procurarvelo.
Published on April 09, 2018 23:20
March 28, 2018
Coppi Night 25/03/2018 - Swiss Army Man
Avrei dovuto fidarmi di più di chi diceva che questo era un film che meritava la visione. Mi è passato sottomano un paio di volte ma non avevo trovato sufficiente stimolo a guardarlo, valutando che sì, poteva essere interessante, ma in fondo, dai, Daniel Radcliffe dove vuoi che ti porti, quando ho provato a guardarlo al di fuori di Hogwarts non è andata bene (per la verità nemmeno Harry Potter mi è mai piaciuto così tanto, ma per il suo pubblico di riferimento di certo funziona). Poi come succede quasi sempre negli ultimi tempi, è arrivato su Netflix e allora, vabbè, proviamolo.
E ora dopo averlo visto due volte in due giorni posso dire che Swiss Army Man è un capolavoro. Non sono solito tenere una lista dei miei "film preferiti", ma di certo se ne dovessi stilare una in questo momento rientrerebbe di sicuro nei primi dieci.
La storia inizia con un naufrago (Hank, interpretato da Paul Dano) abbandonato su qualche imprecisata isola del Pacifico, che proprio quando ha deciso di suicidarsi scorge un corpo sulla spiaggia. Ma già dopo le prime interazioni tra lui e il cadavere (Daniel Radcliffe, appunto) si capisce subito che questo non è Robinson Crusoe e nemmeno Cast Away. L'isola viene abbandonata subito e il film non tiene a mostrarci la sopravvivenza e spirito di adattamento del naufrago. Certo, le strabilianti abilità del morto (un "uomo-coltellino svizzero", come da titolo) sono determinanti nel raggiungere la salvezza e la civiltà, ma la vera storia non è questa.
La vera storia, sommersa sotto uno strato spesso e denso di gag visive, flatulenze, assurdità biologiche e fisiche, travestimenti e musica accappella, è quasi banale nella sua universalità. È la storia di una persona che si perde non perché è finita su un'isola deserta, ma perché non sa cosa il mondo voglia da lui, per cui si fa in disparte, incapace di esprimere le sue passioni, si intiepidisce fino a rischiare di spegnersi del tutto. Ed è poi dal suo confronto con il morto, che invece poco per volta si rianima e riacquisisce le sue capacità, che inizia a emergere qualcosa. Ma non per questo il tutto si riduce a una morale alla Anna dai capelli rossi "la vita è meravigliosa", anzi, il confronto con il mondo esterno (il mondo "reale") è proprio quello che più ci può destabilizzare, ed è proprio lì che Manny, il morto ormai tornato in possesso di tutte le sue facoltà, fallisce. Ma tutto questo è aperto all'interpretazione, può anche trattarsi soltanto di una storia sgangherata di un allucinato introverso che merita di andare in galera per stalking.
Ci sono poi due aspetti in particolare che voglio però sottolineare. Il primo è il valore simbolico della scoreggia in questo film. La flatulenza è il primo segno di quasi-vita di Manny e rimane un elemento costante in tutta la vicenda, i due protagonisti ne parlano spesso. "Alla gente non piace quando gli scoreggi davanti" insegna Hank all'amico cadavere. E quando poi le cose si incrinano tra loro, Manny si chiede "Se il tuo migliore amico si nasconde quando deve scoreggiare, cos'altro ti sta nascondendo?" E nelle scene finali, quando il mondo reale ha schiacciato tutti i sogni dei due amici, è proprio con una scoreggia, e la teatrale ammissione "Sono stato io" che Hank afferma la sua rinnovata prospettiva, il suo desiderio di prendere il controllo della propria vita. A mia memoria non esiste nessun film che abbia trattato la flatulenza diversamente da uno strumento per qualche facile risata grossolana, ma Swiss Army Man la nobilita completamente.
E in secondo luogo, ma con un valore preponderante su tutto il resto, la colonna sonora. Il modo in cui la musica, composta dalle stesse voci dei due attori, si integra nel film, a mio avviso è rivoluzionario. Una concezione totalmente nuova della musica "di accompagnamento" in un film. Sicuramente in molti film la musica riveste un ruolo importante, con la ripetizione di temi oppure (anche senza entrare nel campo dei musical) mettendo in bocca le parole ai personaggi. Ma qui è diverso ed è, per quanto ne so, totalmente nuovo. Peraltro, è ciò che rende questo film sostanzialmente indoppiabile, a meno di non voler reinterpretare anche tutte le tracce della OST. Tempo fa parlavo del fatto che la musica nei film iniziasse a ricoprire un ruolo sempre più marginale, tanto da venire dimenticata subito dopo: questo era quello che volevo, senza sapere di volerlo. A rischio di fornire un piccolo spoiler (ma si tratta proprio dei primi minuti del film), metto un esempio di come il tema del film viene sviluppato la prima volta. Se esistono altri film che usano la colonna sonora come questo, vi prego, segnalatemeli
Swiss Army Man merita di più. Ha ricevuto qualche nomination in festival del cinema indipendente, e Daniel Radcliffe ha vinto anche il premio come miglior attore al Sundance. Ma questo è un film che ha in sé le caratteristiche per segnare qualcosa, oltre a qualcuno. Quindi non fate come me, e date retta a chi vidice di guardarlo. Come sto facendo io adesso, se non si è capito.
E ora dopo averlo visto due volte in due giorni posso dire che Swiss Army Man è un capolavoro. Non sono solito tenere una lista dei miei "film preferiti", ma di certo se ne dovessi stilare una in questo momento rientrerebbe di sicuro nei primi dieci.
La storia inizia con un naufrago (Hank, interpretato da Paul Dano) abbandonato su qualche imprecisata isola del Pacifico, che proprio quando ha deciso di suicidarsi scorge un corpo sulla spiaggia. Ma già dopo le prime interazioni tra lui e il cadavere (Daniel Radcliffe, appunto) si capisce subito che questo non è Robinson Crusoe e nemmeno Cast Away. L'isola viene abbandonata subito e il film non tiene a mostrarci la sopravvivenza e spirito di adattamento del naufrago. Certo, le strabilianti abilità del morto (un "uomo-coltellino svizzero", come da titolo) sono determinanti nel raggiungere la salvezza e la civiltà, ma la vera storia non è questa.
La vera storia, sommersa sotto uno strato spesso e denso di gag visive, flatulenze, assurdità biologiche e fisiche, travestimenti e musica accappella, è quasi banale nella sua universalità. È la storia di una persona che si perde non perché è finita su un'isola deserta, ma perché non sa cosa il mondo voglia da lui, per cui si fa in disparte, incapace di esprimere le sue passioni, si intiepidisce fino a rischiare di spegnersi del tutto. Ed è poi dal suo confronto con il morto, che invece poco per volta si rianima e riacquisisce le sue capacità, che inizia a emergere qualcosa. Ma non per questo il tutto si riduce a una morale alla Anna dai capelli rossi "la vita è meravigliosa", anzi, il confronto con il mondo esterno (il mondo "reale") è proprio quello che più ci può destabilizzare, ed è proprio lì che Manny, il morto ormai tornato in possesso di tutte le sue facoltà, fallisce. Ma tutto questo è aperto all'interpretazione, può anche trattarsi soltanto di una storia sgangherata di un allucinato introverso che merita di andare in galera per stalking.
Ci sono poi due aspetti in particolare che voglio però sottolineare. Il primo è il valore simbolico della scoreggia in questo film. La flatulenza è il primo segno di quasi-vita di Manny e rimane un elemento costante in tutta la vicenda, i due protagonisti ne parlano spesso. "Alla gente non piace quando gli scoreggi davanti" insegna Hank all'amico cadavere. E quando poi le cose si incrinano tra loro, Manny si chiede "Se il tuo migliore amico si nasconde quando deve scoreggiare, cos'altro ti sta nascondendo?" E nelle scene finali, quando il mondo reale ha schiacciato tutti i sogni dei due amici, è proprio con una scoreggia, e la teatrale ammissione "Sono stato io" che Hank afferma la sua rinnovata prospettiva, il suo desiderio di prendere il controllo della propria vita. A mia memoria non esiste nessun film che abbia trattato la flatulenza diversamente da uno strumento per qualche facile risata grossolana, ma Swiss Army Man la nobilita completamente.
E in secondo luogo, ma con un valore preponderante su tutto il resto, la colonna sonora. Il modo in cui la musica, composta dalle stesse voci dei due attori, si integra nel film, a mio avviso è rivoluzionario. Una concezione totalmente nuova della musica "di accompagnamento" in un film. Sicuramente in molti film la musica riveste un ruolo importante, con la ripetizione di temi oppure (anche senza entrare nel campo dei musical) mettendo in bocca le parole ai personaggi. Ma qui è diverso ed è, per quanto ne so, totalmente nuovo. Peraltro, è ciò che rende questo film sostanzialmente indoppiabile, a meno di non voler reinterpretare anche tutte le tracce della OST. Tempo fa parlavo del fatto che la musica nei film iniziasse a ricoprire un ruolo sempre più marginale, tanto da venire dimenticata subito dopo: questo era quello che volevo, senza sapere di volerlo. A rischio di fornire un piccolo spoiler (ma si tratta proprio dei primi minuti del film), metto un esempio di come il tema del film viene sviluppato la prima volta. Se esistono altri film che usano la colonna sonora come questo, vi prego, segnalatemeli
Swiss Army Man merita di più. Ha ricevuto qualche nomination in festival del cinema indipendente, e Daniel Radcliffe ha vinto anche il premio come miglior attore al Sundance. Ma questo è un film che ha in sé le caratteristiche per segnare qualcosa, oltre a qualcuno. Quindi non fate come me, e date retta a chi vidice di guardarlo. Come sto facendo io adesso, se non si è capito.
Published on March 28, 2018 10:35
March 22, 2018
Annienta-mente, o WTF did i just see?!
La settimana scorsa è uscito su Netfilx Annientamento, film di Alex Garland "liberamente tratto da" l'omonimo romanzo di Jeff Vandermeer (Annihilation in origine). Storia di produzione e distribuzione travagliata, di cui si è parlato tanto, fino a farne un esempio del basso livello di considerazione in cui è tenuto il grande pubblico dei cinema. Annientamento è un film troppo intelligente per il quoziente medio di chi va al cinema, hanno detto, e forse non era proprio così la storia, ma forso sotto sotto un pochino sì, e comunque qui non parleremo di questo.
Personalmente ho gradito molto Annientamento, quando invece avevo trovato poco entusiasmante il precedente lavoro di Garland Ex Machina, che mi era sembrato interessante nella concezione ma scontato nell'esecuzione. In questo caso invece siamo di fronte a qualcosa di diverso, un completo mindfuck che già poco dopo le scene iniziali lascia lo spettatore privo di punti di riferimento, in un viaggio senza cinture di sicurezza verso una destinazione ignota. Sarò più stupido del pubblico medio del cinema, ma io adoro quando un film mi tratta così.
 La cosa interessante è che mi sembra che negli ultimi anni ci sia una certa tendenza verso questo tipo produzioni, un'attenzione particolare per quei film per i quali la reazione standard è WTF did i just see?!. Penso ad esempio a Under the Skin, oppure le ahimè scarse opere di Shane Carruth come Primer e
Upstream Color
, ma anche in misura minore
Arrival
. Ammetto che la mia conoscenza dell'ambiente cinematografico è piuttosto lacunosa, per cui potrei essere in errore a notare solo ora un fenomeno che è sempre esistito, d'altra parte Solaris e 2001 Odissea nello Spazio sono usciti diversi decenni fa. Eppure la mia impressione è che in tempi recenti l'attenzione verso il WTF su schermo sia incrementata, e mediata nella maggior parte dei casi dal linguaggio della fantascienza. Forse perché il modo più semplice per introdurre qualcosa di alieno, che trascende i limiti dell'umana comprensione, è di metterci dentro proprio un alieno.
La cosa interessante è che mi sembra che negli ultimi anni ci sia una certa tendenza verso questo tipo produzioni, un'attenzione particolare per quei film per i quali la reazione standard è WTF did i just see?!. Penso ad esempio a Under the Skin, oppure le ahimè scarse opere di Shane Carruth come Primer e
Upstream Color
, ma anche in misura minore
Arrival
. Ammetto che la mia conoscenza dell'ambiente cinematografico è piuttosto lacunosa, per cui potrei essere in errore a notare solo ora un fenomeno che è sempre esistito, d'altra parte Solaris e 2001 Odissea nello Spazio sono usciti diversi decenni fa. Eppure la mia impressione è che in tempi recenti l'attenzione verso il WTF su schermo sia incrementata, e mediata nella maggior parte dei casi dal linguaggio della fantascienza. Forse perché il modo più semplice per introdurre qualcosa di alieno, che trascende i limiti dell'umana comprensione, è di metterci dentro proprio un alieno.
Se questa tendenza esiste davvero, ci dice qualcosa? È solo un ciclico movimento della moda e sensibilità collettiva, come lo sono i cinecomics, o implica qualcosa di più profondo? La mia umile interpretazione è che questo desiderio di avvicinarci a qualcosa di complesso per comprenderlo, e venirne rimbalzati, riflessi, annientati (nella mente quanto nel corpo), è un'espressione di quel diffuso senso di disagio implicito che buona parte della popolazione mondiale avverte, quel germe di solida incertezza, la consapevolezza sopita di non essere in grado di comprendere un mondo/ambiente/società/ecosistema oggi diventato troppo grande e interconnesso per essere recepito da una sola mente, almeno con gli strumenti della ragione.
E quindi cerchiamoaltro: l'autodistruzione, che sembra essere uno dei temi portanti di Annientamento (almeno del film, non ho letto il romanzo), è l'ultima fase di questo smarrimento, quella in cui l'unico modo per rispondere alla domanda è disinnescarla, esplodere in un annienta-mente che ci permette non solo di non trovare la risposta ma di cancellare anche la domanda. Uno zen cosmico che non viene più tramandato dai maestri ma di cui forse abbiamo bisogno come mai nella storia.
Come dicevo quando parlavo della fantascienza contemporanea italiana, mi pare che questo desiderio di mindfuck (che almeno io e Garland e Carruth proviamo, non so voi) sia alla fine dei conti una manifestazione di qualcosa che c'è sotto, e che può essere espressa solo in termini che sfuggono all'interpretazione. Non rimane quindi che annichilirsi, e ripartire. Se qualcosa è rimasto.
Personalmente ho gradito molto Annientamento, quando invece avevo trovato poco entusiasmante il precedente lavoro di Garland Ex Machina, che mi era sembrato interessante nella concezione ma scontato nell'esecuzione. In questo caso invece siamo di fronte a qualcosa di diverso, un completo mindfuck che già poco dopo le scene iniziali lascia lo spettatore privo di punti di riferimento, in un viaggio senza cinture di sicurezza verso una destinazione ignota. Sarò più stupido del pubblico medio del cinema, ma io adoro quando un film mi tratta così.
 La cosa interessante è che mi sembra che negli ultimi anni ci sia una certa tendenza verso questo tipo produzioni, un'attenzione particolare per quei film per i quali la reazione standard è WTF did i just see?!. Penso ad esempio a Under the Skin, oppure le ahimè scarse opere di Shane Carruth come Primer e
Upstream Color
, ma anche in misura minore
Arrival
. Ammetto che la mia conoscenza dell'ambiente cinematografico è piuttosto lacunosa, per cui potrei essere in errore a notare solo ora un fenomeno che è sempre esistito, d'altra parte Solaris e 2001 Odissea nello Spazio sono usciti diversi decenni fa. Eppure la mia impressione è che in tempi recenti l'attenzione verso il WTF su schermo sia incrementata, e mediata nella maggior parte dei casi dal linguaggio della fantascienza. Forse perché il modo più semplice per introdurre qualcosa di alieno, che trascende i limiti dell'umana comprensione, è di metterci dentro proprio un alieno.
La cosa interessante è che mi sembra che negli ultimi anni ci sia una certa tendenza verso questo tipo produzioni, un'attenzione particolare per quei film per i quali la reazione standard è WTF did i just see?!. Penso ad esempio a Under the Skin, oppure le ahimè scarse opere di Shane Carruth come Primer e
Upstream Color
, ma anche in misura minore
Arrival
. Ammetto che la mia conoscenza dell'ambiente cinematografico è piuttosto lacunosa, per cui potrei essere in errore a notare solo ora un fenomeno che è sempre esistito, d'altra parte Solaris e 2001 Odissea nello Spazio sono usciti diversi decenni fa. Eppure la mia impressione è che in tempi recenti l'attenzione verso il WTF su schermo sia incrementata, e mediata nella maggior parte dei casi dal linguaggio della fantascienza. Forse perché il modo più semplice per introdurre qualcosa di alieno, che trascende i limiti dell'umana comprensione, è di metterci dentro proprio un alieno.Se questa tendenza esiste davvero, ci dice qualcosa? È solo un ciclico movimento della moda e sensibilità collettiva, come lo sono i cinecomics, o implica qualcosa di più profondo? La mia umile interpretazione è che questo desiderio di avvicinarci a qualcosa di complesso per comprenderlo, e venirne rimbalzati, riflessi, annientati (nella mente quanto nel corpo), è un'espressione di quel diffuso senso di disagio implicito che buona parte della popolazione mondiale avverte, quel germe di solida incertezza, la consapevolezza sopita di non essere in grado di comprendere un mondo/ambiente/società/ecosistema oggi diventato troppo grande e interconnesso per essere recepito da una sola mente, almeno con gli strumenti della ragione.
E quindi cerchiamoaltro: l'autodistruzione, che sembra essere uno dei temi portanti di Annientamento (almeno del film, non ho letto il romanzo), è l'ultima fase di questo smarrimento, quella in cui l'unico modo per rispondere alla domanda è disinnescarla, esplodere in un annienta-mente che ci permette non solo di non trovare la risposta ma di cancellare anche la domanda. Uno zen cosmico che non viene più tramandato dai maestri ma di cui forse abbiamo bisogno come mai nella storia.
Come dicevo quando parlavo della fantascienza contemporanea italiana, mi pare che questo desiderio di mindfuck (che almeno io e Garland e Carruth proviamo, non so voi) sia alla fine dei conti una manifestazione di qualcosa che c'è sotto, e che può essere espressa solo in termini che sfuggono all'interpretazione. Non rimane quindi che annichilirsi, e ripartire. Se qualcosa è rimasto.
Published on March 22, 2018 12:18
March 17, 2018
Coppi Night 11/03/2018 - I don't feel at home in this world anymore
Che poi un titolo del genere non ci sarebbe niente di male a tradurlo, a volte si sprecano per tradurre un'unica parola comprensibilissima, e invece una frase intera che non tutti potrebbero capire te la lasciano intera. Ma vabbè.
 Mi aspettavo forse qualcosa di un po' diverso, ma com'è noto le descrizioni di Netflix non aiutano. Una storia che comincia come il riscatto del bravo cittadino che comincia a rispondere alle ingiustizie della vita (prendine quanti ne vuoi, a partire da Io me e Irene), con la protagonista abituata ad abbassare la testa che dopo aver subito un furto in casa decide di reagire, e trova un improbabile alleato in un vicino di casa un po' stravagante (un Elijah Wood che sembra aver assorbito la personalità del Dirk Gently a cui fa l'assistente nella serie accanto). La cosa sfugge un po' di mano e i due si ritrovano invischiati in affari ben più loschi, fino a una conclusione piuttosto sanguinosa.
Mi aspettavo forse qualcosa di un po' diverso, ma com'è noto le descrizioni di Netflix non aiutano. Una storia che comincia come il riscatto del bravo cittadino che comincia a rispondere alle ingiustizie della vita (prendine quanti ne vuoi, a partire da Io me e Irene), con la protagonista abituata ad abbassare la testa che dopo aver subito un furto in casa decide di reagire, e trova un improbabile alleato in un vicino di casa un po' stravagante (un Elijah Wood che sembra aver assorbito la personalità del Dirk Gently a cui fa l'assistente nella serie accanto). La cosa sfugge un po' di mano e i due si ritrovano invischiati in affari ben più loschi, fino a una conclusione piuttosto sanguinosa.
La cosa che ho gradito maggiormente in questo film è l'imprevedibilità, che forse (forse) può essere anche il tema di fondo dell'intera storia. Vediamo le cose anche da altri punti di vista oltre a quello dei due eroi, e così sappiamo anche qualcosa dei "cattivi", che alla fine dei conti sono dei disperati arruffoni tanto quanto gli altri. L'imprevedibilità è quella cosa che ti manda all'aria i piani, perché una macchina ti passa davanti nel momento sbagliato o perché pesti una merda nel vialetto di casa, e allora devi pensare veloce e cambiare le cose in corsa ma non è detto che tu ne sia capace, anche perché un altro ingranaggio del tuo infallibile nuovo piano potrebbe incepparsi e allora devi pensare di nuovo, ancora più in fretta.
Questo elemento sembra essere la forza motrice dell'intera vicenda, anche se in certi casi si avvicina fin troppo alla coincidenza estrema, come una pallottola che rimbalza e guarda caso ti colpisce proprio in testa. Scorporata la Legge di Murphy dalla storia però abbiamo però un percorso incompleto nell'evoluzione della protagonista: si parte appunto dal proposito di riprendere il controllo della propria vita, si muovno i primi passi, qualcuno un po' esagerato, ma dopo la tragicommedia finale tutto sembra come prima. Non basta la scena di un barbecue in giardino con gli amici a far capire se qualcosa è cambiato, e anzi, l'impressione è che in effetti tutto sia tornato come prima, e la lezione imparata sia "stai con la testa bassa ché sennò succede un casino".
Un film quindi passabile, facile da assorbire ma non così sfaccettato come vorrebbe far credere, che nella parte finale si arrota su se stesso e non riesce a sciogliere i nodi che ha creato. Da questo punto di vista, Jim Carrey aveva fatto di meglio.
 Mi aspettavo forse qualcosa di un po' diverso, ma com'è noto le descrizioni di Netflix non aiutano. Una storia che comincia come il riscatto del bravo cittadino che comincia a rispondere alle ingiustizie della vita (prendine quanti ne vuoi, a partire da Io me e Irene), con la protagonista abituata ad abbassare la testa che dopo aver subito un furto in casa decide di reagire, e trova un improbabile alleato in un vicino di casa un po' stravagante (un Elijah Wood che sembra aver assorbito la personalità del Dirk Gently a cui fa l'assistente nella serie accanto). La cosa sfugge un po' di mano e i due si ritrovano invischiati in affari ben più loschi, fino a una conclusione piuttosto sanguinosa.
Mi aspettavo forse qualcosa di un po' diverso, ma com'è noto le descrizioni di Netflix non aiutano. Una storia che comincia come il riscatto del bravo cittadino che comincia a rispondere alle ingiustizie della vita (prendine quanti ne vuoi, a partire da Io me e Irene), con la protagonista abituata ad abbassare la testa che dopo aver subito un furto in casa decide di reagire, e trova un improbabile alleato in un vicino di casa un po' stravagante (un Elijah Wood che sembra aver assorbito la personalità del Dirk Gently a cui fa l'assistente nella serie accanto). La cosa sfugge un po' di mano e i due si ritrovano invischiati in affari ben più loschi, fino a una conclusione piuttosto sanguinosa.La cosa che ho gradito maggiormente in questo film è l'imprevedibilità, che forse (forse) può essere anche il tema di fondo dell'intera storia. Vediamo le cose anche da altri punti di vista oltre a quello dei due eroi, e così sappiamo anche qualcosa dei "cattivi", che alla fine dei conti sono dei disperati arruffoni tanto quanto gli altri. L'imprevedibilità è quella cosa che ti manda all'aria i piani, perché una macchina ti passa davanti nel momento sbagliato o perché pesti una merda nel vialetto di casa, e allora devi pensare veloce e cambiare le cose in corsa ma non è detto che tu ne sia capace, anche perché un altro ingranaggio del tuo infallibile nuovo piano potrebbe incepparsi e allora devi pensare di nuovo, ancora più in fretta.
Questo elemento sembra essere la forza motrice dell'intera vicenda, anche se in certi casi si avvicina fin troppo alla coincidenza estrema, come una pallottola che rimbalza e guarda caso ti colpisce proprio in testa. Scorporata la Legge di Murphy dalla storia però abbiamo però un percorso incompleto nell'evoluzione della protagonista: si parte appunto dal proposito di riprendere il controllo della propria vita, si muovno i primi passi, qualcuno un po' esagerato, ma dopo la tragicommedia finale tutto sembra come prima. Non basta la scena di un barbecue in giardino con gli amici a far capire se qualcosa è cambiato, e anzi, l'impressione è che in effetti tutto sia tornato come prima, e la lezione imparata sia "stai con la testa bassa ché sennò succede un casino".
Un film quindi passabile, facile da assorbire ma non così sfaccettato come vorrebbe far credere, che nella parte finale si arrota su se stesso e non riesce a sciogliere i nodi che ha creato. Da questo punto di vista, Jim Carrey aveva fatto di meglio.
Published on March 17, 2018 02:17
March 13, 2018
Fringe vs me
So bene che arrivo dopo i botti, e che parlare di Fringe nel 2018 è come parlare del telegrafo nel 1988. È passato abbastanza tempo dalla sua fine perché si sia potuto dire tutto della serie tv ideata e prodotta da J.J. Abrams, sull'onda del successo di Lost, che riprende e aggiorna la formula di X-Files, con la sua struttura di procedural investigativo con un arco narrativo che emerge e si concretizza nel corso delle stagioni.
 Ma sta di fatto che, a causa della mia stringente policy di fruizione delle serie tv, ho visto Fringe solo di recente, pressappocco a partire da settembre dell'anno scorso, e l'ho finito solo da qualche settimana. Questo post in ogni caso non vuole essere una recensione della serie, quanto una constatazione di come, ancora una volta, viene fuori che le idee non sono di nessuno e l'originalità è un valore molto aleatorio per chi inventa storie.
Ma sta di fatto che, a causa della mia stringente policy di fruizione delle serie tv, ho visto Fringe solo di recente, pressappocco a partire da settembre dell'anno scorso, e l'ho finito solo da qualche settimana. Questo post in ogni caso non vuole essere una recensione della serie, quanto una constatazione di come, ancora una volta, viene fuori che le idee non sono di nessuno e l'originalità è un valore molto aleatorio per chi inventa storie.
È successo infatti che, man mano che procedevo nella visione di Fringe, mi sono trovato di fronte a decine di spunti e idee che io stesso ho usato o ho pensato di usare in qualche racconto. La cosa mi è sembrata inizialmente curiosa, poi si è fatta frustrante e infine mi sono arreso all'evidenza che non c'è più niente da inventare.
Uno dei temi portanti della serie (si, vabbè, spoiler alert, ma vi devo anche spiegare come funziona il telegrafo?) è l'esistenza di più universi paralleli, anche se in particolare ne vengono mostrati due e non è mai specificato se, come in genere si intende, ne esistano in realtà infiniti. L'interazione tra questi universi è possibile, a volte in modo fisico e altre solo come un collegamento tra gli stessi individui delle due dimensioni. Più avanti si assiste anche alla rimozione di una persona dall'esistenza, con la conseguente alterazione della timeline vista fino a quel momento, se non che, in particolari circostanze, questa persona può tornare a farsi presente. La più semplice di queste circostanze è il sogno: le persone coinvolte sognano una versione diversa della storia, un universo che è stato, come potrei dire... retconizzato, ecco. È curioso anche notare come gli Osservatori, le entità post-umane che compaiono per raccogliere la storia, si chiamino con i nomi dei mesi, per cui abbiamo Settembre, Agosto, Dicembre... e presumibilmente, da qualche parte, anche un Novembre.
Naturalmente so di non aver inventato la retcon come meccanismo narrativo, ma il punto è che questo non è l'unico spunto che Fringe mi ha messo in scena sotto il naso, mentre io ero impegnato a fare altro per una decina d'anni prima di scoprirlo. Senza entrare troppo nello specifico delle varie trame, ecco una carrellata delle idee che ho trovato nella serie dopo averle già sfruttate in alcune mie storie:Colone di funghi che formano una rete neurale capaci di entrare in contatto con gli umani.L'accesso a un universo parallelo che provoca una "falla" dalla quale si estende un'anomalia in grado di destabilizzare la struttura di entrambi gli universi.Lo stato di sogno utilizzato per accedere a universi diversi o versioni precedenti dell'universo.Umani del futuro che possono viaggiare nel tempo e tornano nel passato per pilotare l'evoluzione della specie in modo da poter raggiungere il punto in cui si trovano loro.Crescita accelerata che fa nascere un bambino già semiadulto.La probabilità come forza primaria da cui si origina l'universo.Musica/suoni e vibrazioni che permettono di sincronizzare menti diverse.Un astronauta che durante una missione entra in contatto con una qualche entità che gli rimane poi "attaccata".Di nuovo, non voglio dire che Fringe mi abbia rubato le idee (ma nemmeno il contrario, considerato che l'ho visto solo ora!), né che le mie siano idee tanto geniali che ci avrei potuto scrivere io una serie del genere e JJ avrebbe dovuto pagare me invece dei suoi sceneggiatori. Mi piace però notare come certi spunti probabilmente sono "nell'aria" e possono essere colti in momenti e da persone diverse, dato un contesto comune di partenza. Con ogni probabilità, tra altri vent'anni le suggestioni mie e di Fringe saranno superate, e a nessuno verrà in mente di costruire storie basate su queste stesse idee, ma in questo momento e in questo tempo, temi del genere continuano a emergere anche da fonti indipendenti, in una sorta di convergenza evolutiva memetica.
Insomma, alla fine dei conti non si inventa mai nulla, o quanto meno, io non invento nulla, e ciò che conta è soprattutto il modo in cui la stessa storia viene raccontata, ancora e ancora.
 Ma sta di fatto che, a causa della mia stringente policy di fruizione delle serie tv, ho visto Fringe solo di recente, pressappocco a partire da settembre dell'anno scorso, e l'ho finito solo da qualche settimana. Questo post in ogni caso non vuole essere una recensione della serie, quanto una constatazione di come, ancora una volta, viene fuori che le idee non sono di nessuno e l'originalità è un valore molto aleatorio per chi inventa storie.
Ma sta di fatto che, a causa della mia stringente policy di fruizione delle serie tv, ho visto Fringe solo di recente, pressappocco a partire da settembre dell'anno scorso, e l'ho finito solo da qualche settimana. Questo post in ogni caso non vuole essere una recensione della serie, quanto una constatazione di come, ancora una volta, viene fuori che le idee non sono di nessuno e l'originalità è un valore molto aleatorio per chi inventa storie.È successo infatti che, man mano che procedevo nella visione di Fringe, mi sono trovato di fronte a decine di spunti e idee che io stesso ho usato o ho pensato di usare in qualche racconto. La cosa mi è sembrata inizialmente curiosa, poi si è fatta frustrante e infine mi sono arreso all'evidenza che non c'è più niente da inventare.
Uno dei temi portanti della serie (si, vabbè, spoiler alert, ma vi devo anche spiegare come funziona il telegrafo?) è l'esistenza di più universi paralleli, anche se in particolare ne vengono mostrati due e non è mai specificato se, come in genere si intende, ne esistano in realtà infiniti. L'interazione tra questi universi è possibile, a volte in modo fisico e altre solo come un collegamento tra gli stessi individui delle due dimensioni. Più avanti si assiste anche alla rimozione di una persona dall'esistenza, con la conseguente alterazione della timeline vista fino a quel momento, se non che, in particolari circostanze, questa persona può tornare a farsi presente. La più semplice di queste circostanze è il sogno: le persone coinvolte sognano una versione diversa della storia, un universo che è stato, come potrei dire... retconizzato, ecco. È curioso anche notare come gli Osservatori, le entità post-umane che compaiono per raccogliere la storia, si chiamino con i nomi dei mesi, per cui abbiamo Settembre, Agosto, Dicembre... e presumibilmente, da qualche parte, anche un Novembre.
Naturalmente so di non aver inventato la retcon come meccanismo narrativo, ma il punto è che questo non è l'unico spunto che Fringe mi ha messo in scena sotto il naso, mentre io ero impegnato a fare altro per una decina d'anni prima di scoprirlo. Senza entrare troppo nello specifico delle varie trame, ecco una carrellata delle idee che ho trovato nella serie dopo averle già sfruttate in alcune mie storie:Colone di funghi che formano una rete neurale capaci di entrare in contatto con gli umani.L'accesso a un universo parallelo che provoca una "falla" dalla quale si estende un'anomalia in grado di destabilizzare la struttura di entrambi gli universi.Lo stato di sogno utilizzato per accedere a universi diversi o versioni precedenti dell'universo.Umani del futuro che possono viaggiare nel tempo e tornano nel passato per pilotare l'evoluzione della specie in modo da poter raggiungere il punto in cui si trovano loro.Crescita accelerata che fa nascere un bambino già semiadulto.La probabilità come forza primaria da cui si origina l'universo.Musica/suoni e vibrazioni che permettono di sincronizzare menti diverse.Un astronauta che durante una missione entra in contatto con una qualche entità che gli rimane poi "attaccata".Di nuovo, non voglio dire che Fringe mi abbia rubato le idee (ma nemmeno il contrario, considerato che l'ho visto solo ora!), né che le mie siano idee tanto geniali che ci avrei potuto scrivere io una serie del genere e JJ avrebbe dovuto pagare me invece dei suoi sceneggiatori. Mi piace però notare come certi spunti probabilmente sono "nell'aria" e possono essere colti in momenti e da persone diverse, dato un contesto comune di partenza. Con ogni probabilità, tra altri vent'anni le suggestioni mie e di Fringe saranno superate, e a nessuno verrà in mente di costruire storie basate su queste stesse idee, ma in questo momento e in questo tempo, temi del genere continuano a emergere anche da fonti indipendenti, in una sorta di convergenza evolutiva memetica.
Insomma, alla fine dei conti non si inventa mai nulla, o quanto meno, io non invento nulla, e ciò che conta è soprattutto il modo in cui la stessa storia viene raccontata, ancora e ancora.
Published on March 13, 2018 00:40
Unknown to Millions
Il blog di Andrea Viscusi since 2010
Libri, fantascienza, serie tv, Futurama, Doctor Who
Libri, fantascienza, serie tv, Futurama, Doctor Who
- Andrea Viscusi's profile
- 81 followers



