Andrea Viscusi's Blog: Unknown to Millions, page 26
September 25, 2018
Il lettore universale live @ Stranimondi - Milano 6 ottobre
Ne è passato di tempo dall'ultima volta che ho annunciato un "evento live", come mi piace chiamarlo convinto di sembrare un influencer. Che poi significa semplicemente che io sarò in un posto, a parlare di qualcosa che mi riguarda, e altra gente a dio piacendo potrà stare lì ad ascoltarmi.
Nel caso specifico, io mi troverò a Stranimondi , per la quarta edizione della fiera dedicata alla narrativa di genere (fantascienza, horror, fantasy, weird) che si tiene poco fuori Milano e che in questi pochi anni è già diventata un punto di riferimento per gli appassionati. E in tale occasione avremo una mezz'oretta per parlare de Il lettore universale , la mia raccolta pubblicata in estate da Moscabianca. L'appuntamento è per sabato 6 ottobre, alle ore 18:30 nella sala presentazioni. Ad accompagnarmi oltre agli editori del libro ci sarà anche Giorgio Raffaelli di Zona 42 a fare da moderatore.

Questa è la prima presentazione de Il lettore universale (ci auguriamo di poterne fare altre in seguito), ma sarà anche la prima uscita pubblica di Moscabianca, che oltre al mio libro porterà a Stranimondi anche le altre novità pronte a uscire. Sfrutteremo quindi lo spazio per parlare anche delle altre attività e progetti di questo piccola realtà svolazzante, e può anche darsi che non sarò l'unico al centro dell'attenzione.
E poi come già dimostrato nelle edizioni precedenti, Stranimondi è una manifestazione ricca di eventi, ospiti, dibattiti, e soprattutto libri e tanta gente che se è lì ci sarà pure un motivo. Quindi consultate il ricco programma e se proprio non volete venire ad ascoltare me, fatelo per qualche altra validissima ragione, e ci possiamo comunque vedere lì.
Nel caso specifico, io mi troverò a Stranimondi , per la quarta edizione della fiera dedicata alla narrativa di genere (fantascienza, horror, fantasy, weird) che si tiene poco fuori Milano e che in questi pochi anni è già diventata un punto di riferimento per gli appassionati. E in tale occasione avremo una mezz'oretta per parlare de Il lettore universale , la mia raccolta pubblicata in estate da Moscabianca. L'appuntamento è per sabato 6 ottobre, alle ore 18:30 nella sala presentazioni. Ad accompagnarmi oltre agli editori del libro ci sarà anche Giorgio Raffaelli di Zona 42 a fare da moderatore.

Questa è la prima presentazione de Il lettore universale (ci auguriamo di poterne fare altre in seguito), ma sarà anche la prima uscita pubblica di Moscabianca, che oltre al mio libro porterà a Stranimondi anche le altre novità pronte a uscire. Sfrutteremo quindi lo spazio per parlare anche delle altre attività e progetti di questo piccola realtà svolazzante, e può anche darsi che non sarò l'unico al centro dell'attenzione.
E poi come già dimostrato nelle edizioni precedenti, Stranimondi è una manifestazione ricca di eventi, ospiti, dibattiti, e soprattutto libri e tanta gente che se è lì ci sarà pure un motivo. Quindi consultate il ricco programma e se proprio non volete venire ad ascoltare me, fatelo per qualche altra validissima ragione, e ci possiamo comunque vedere lì.
Published on September 25, 2018 23:40
September 21, 2018
Rapporto letture - Agosto 2018
Yay, le ferie! Yuppi, il momentaneo distacco che il capitalismo concede ai suoi piccoli schiavi affinché possano illudersi per un altro anno di disporre della propria vita e di poter occupare il proprio tempo con le cose che gli piacciono di più! Che epoca d'oro che viviamo, eh? Comunque, anche questo mese si è letto, e in fondo non poco.
 Cominciamo non benissimo con
Houdini - passione oscura,
che già come titolo non è così accattivante (l'originale è meglio) e poi la copertina lo fa sembrare un po' un erotosadochicklit. Questo romanzetto di Lisa Mannetti racconta in parte la storia di Houdini attraverso il punto di vista di una delle sue assistenti. Il nucleo principale della storia ruota intorno alla morte di Houdinni, avvenuta a quanto pare per mano dei circoli di occultismo che lui si adoperava a smascherare. Ma c'è anche tempo per flashback e flashforward, nella vita della protagonista, in cui vediamo quando e come la presenza di Houdini ha fatto la differenza. Il tutto però è estremamente confuso. Ora, io non avrò il QI di Moriarty ma riesco a seguire trame complesse e non lineari. Qui però mi sembra che ci sia solo miscuglio e contraddizione: non si capisce bene quando si racconta il passato, quando il presente; non è chiaro se la magia esiste e funziona davvero, se ci sono mondi ultraterreni che possono essere contattati; se (diotipregono) alla fine è tutta un'illusione di una matta chiusa in manicomio. Probabilmente conoscendo il personaggio e la storia di Houdini si potrebbe trarre molto di più da questo racconto, ma per me che so ben poco al di là del suo nome è sembrata una serie sconclusionata di eventi, non sempre rilevanti. Voto: 5/10
Cominciamo non benissimo con
Houdini - passione oscura,
che già come titolo non è così accattivante (l'originale è meglio) e poi la copertina lo fa sembrare un po' un erotosadochicklit. Questo romanzetto di Lisa Mannetti racconta in parte la storia di Houdini attraverso il punto di vista di una delle sue assistenti. Il nucleo principale della storia ruota intorno alla morte di Houdinni, avvenuta a quanto pare per mano dei circoli di occultismo che lui si adoperava a smascherare. Ma c'è anche tempo per flashback e flashforward, nella vita della protagonista, in cui vediamo quando e come la presenza di Houdini ha fatto la differenza. Il tutto però è estremamente confuso. Ora, io non avrò il QI di Moriarty ma riesco a seguire trame complesse e non lineari. Qui però mi sembra che ci sia solo miscuglio e contraddizione: non si capisce bene quando si racconta il passato, quando il presente; non è chiaro se la magia esiste e funziona davvero, se ci sono mondi ultraterreni che possono essere contattati; se (diotipregono) alla fine è tutta un'illusione di una matta chiusa in manicomio. Probabilmente conoscendo il personaggio e la storia di Houdini si potrebbe trarre molto di più da questo racconto, ma per me che so ben poco al di là del suo nome è sembrata una serie sconclusionata di eventi, non sempre rilevanti. Voto: 5/10
 Allora proviamo a tornare su qualcosa con sui sono più a mio agio: Francesco Verso ha da poco pubblicato la prima parte di un suo nuovo romanzo, I camminatori. È una storia di transumanesimo imminente, che parte dalle borgate di Roma e mette le basi per un ampiamento del contesto (è già previsto un secondo volume). C'è da dire che le premesse fantascientifiche su cui si basa la storia sono piuttosto forti: la possibilità di utilizzare nanomacchine per potenziare il corpo umano, al punto di rendere l'alimentazione quasi superflua. Non è mica poco. Ma a partire da questo, Verso costruisce una trama postdatapunk che coinvolge personaggi di ogni risma, una piccola rivoluzione che parte da una comune che vive negando i postulati della società capitalista. La storia è ricca di speculazione e spunti di riflessione, ed è in ultima analisi positivista: si potrebbe definire per questo Francesco Verso il Neal Stephenson de noantri, non in senso dispregiativo ma per come la dimensione speculativa sul futuro è calato nel contesto dei borghi che conosciamo. Qua e là si sarebbe potuto asciugare un po' di infodump, ma lo stesso si può dire appunto di Stephenson, e nessuno ha avuto shock anafilattici a leggere Seveneves, che io sappia. Un'ottima base per la seconda parte, che ritengo possa svilupparsi in direzioni ancora più interessanti. Voto: 7/10
Allora proviamo a tornare su qualcosa con sui sono più a mio agio: Francesco Verso ha da poco pubblicato la prima parte di un suo nuovo romanzo, I camminatori. È una storia di transumanesimo imminente, che parte dalle borgate di Roma e mette le basi per un ampiamento del contesto (è già previsto un secondo volume). C'è da dire che le premesse fantascientifiche su cui si basa la storia sono piuttosto forti: la possibilità di utilizzare nanomacchine per potenziare il corpo umano, al punto di rendere l'alimentazione quasi superflua. Non è mica poco. Ma a partire da questo, Verso costruisce una trama postdatapunk che coinvolge personaggi di ogni risma, una piccola rivoluzione che parte da una comune che vive negando i postulati della società capitalista. La storia è ricca di speculazione e spunti di riflessione, ed è in ultima analisi positivista: si potrebbe definire per questo Francesco Verso il Neal Stephenson de noantri, non in senso dispregiativo ma per come la dimensione speculativa sul futuro è calato nel contesto dei borghi che conosciamo. Qua e là si sarebbe potuto asciugare un po' di infodump, ma lo stesso si può dire appunto di Stephenson, e nessuno ha avuto shock anafilattici a leggere Seveneves, che io sappia. Un'ottima base per la seconda parte, che ritengo possa svilupparsi in direzioni ancora più interessanti. Voto: 7/10
 Rimaniamo nell'ambito della fantascienza, ma qualcosa di più insolito.
The Only Harmless Great Thing
è poco più che un racconto, dell'autrice pressoché sconosciuta Brooke Bolander. Ma è una storia ricca di fascino e di implicazioni, di quelle che riescono a suscitare molto grazie a quello che non dicono. La si potrebbe definire un'ucronia, e il punto di divergenza storico è che gli elefanti sono creature intelligenti e pensanti, cosa che in effetti sono davvero, ma in questo caso hanno la capacità di comunicare anche con gli umani, attraverso il linguaggio dei segni della proboscide. La pratica è talmente diffusa che esistono corsi di elefantico nei licei, ed esistono mediatori culturali e ambasciatori tra gli umani e le Matriarche. La storia si svolge in due epoche, tra gli inizi del novecento, quando gli elefanti sono schiavizzati e usati nel lavoro in miniera, e l'epoca attuale, dove una ricercatrice cerca di stabilire un accordo con gli elefanti dopo che decenni di schiavismo hanno compromesso i rapporti tra le due specie. Tre le protagoniste c'è Topsy, il famoso elefante che fu elettrificato sulla pubblica piazza da Edison per dimostrare la pericolosità della corrente alternata di Tesla. Qui però la storia di Topsy è diversa, e si lega a quella di una ragazza malata e anch'essa schiava di una vita di cui non può disporre. Come dicevo il racconto è pieno di suggestioni, soprattutto perché concede sprazzi nella cultura degli elefanti, tramandata attraverso le canzoni delle Madri. Forse la parte nel presente è fin troppo abbozzata, riesce appena a mostrare qualche immagine del mondo contemporaneo ma non fornisce un vero e proprio contributo, tant'è che della ricercatrice stessa si sa molto poco. La fine arriva un po' all'improvviso, e anche se si capisce cosa voglia dire, forse qualche pagina in più per rimarcare le idee avrebbe reso il tutto più equilibrato. Comunque un ottimo lavoro, una storia che parla di valori e sentimenti universali, indipendenti dalla specie. Voto: 8/10
Rimaniamo nell'ambito della fantascienza, ma qualcosa di più insolito.
The Only Harmless Great Thing
è poco più che un racconto, dell'autrice pressoché sconosciuta Brooke Bolander. Ma è una storia ricca di fascino e di implicazioni, di quelle che riescono a suscitare molto grazie a quello che non dicono. La si potrebbe definire un'ucronia, e il punto di divergenza storico è che gli elefanti sono creature intelligenti e pensanti, cosa che in effetti sono davvero, ma in questo caso hanno la capacità di comunicare anche con gli umani, attraverso il linguaggio dei segni della proboscide. La pratica è talmente diffusa che esistono corsi di elefantico nei licei, ed esistono mediatori culturali e ambasciatori tra gli umani e le Matriarche. La storia si svolge in due epoche, tra gli inizi del novecento, quando gli elefanti sono schiavizzati e usati nel lavoro in miniera, e l'epoca attuale, dove una ricercatrice cerca di stabilire un accordo con gli elefanti dopo che decenni di schiavismo hanno compromesso i rapporti tra le due specie. Tre le protagoniste c'è Topsy, il famoso elefante che fu elettrificato sulla pubblica piazza da Edison per dimostrare la pericolosità della corrente alternata di Tesla. Qui però la storia di Topsy è diversa, e si lega a quella di una ragazza malata e anch'essa schiava di una vita di cui non può disporre. Come dicevo il racconto è pieno di suggestioni, soprattutto perché concede sprazzi nella cultura degli elefanti, tramandata attraverso le canzoni delle Madri. Forse la parte nel presente è fin troppo abbozzata, riesce appena a mostrare qualche immagine del mondo contemporaneo ma non fornisce un vero e proprio contributo, tant'è che della ricercatrice stessa si sa molto poco. La fine arriva un po' all'improvviso, e anche se si capisce cosa voglia dire, forse qualche pagina in più per rimarcare le idee avrebbe reso il tutto più equilibrato. Comunque un ottimo lavoro, una storia che parla di valori e sentimenti universali, indipendenti dalla specie. Voto: 8/10
 Rimaniamo sulla forma breve, che è ciò di cui si occupa per definizione la casa editrice Racconti Edizioni, che tenevo d'occhio da tempo ma non avevo ancora provato prima. Il primo esperimento l'ho fatto con Il vizio di smettere, raccolta di Michele Orti Manara. Si tratta di testi brevi, in media una decina di pagine ma anche meno, stile moderno e accattivante, di quelli che non usano i dialogue tag. Ogni racconto in sostanza presenta un personaggio, che è una persona comune, in una situazione comune, con tante piccole ossessioni (vizi?) come quelle che abbiamo tutti. Per lo più giovani, cresciuti in provincia, con qualche difficoltà a trovare una collocazione nella società secondo le aspettative degli altri. Sono ritratti interessanti, con qualche frase degna di essere citata, però per la maggior parte sono solo ritratti, nel senso che non ci sono vere e proprie storie dietro. Ci viene presentato il protagonita, la sua sitauzione e qualche aneddoto, passato o presente: la morte del fratello, l'incidente in bicicletta, l'incontro con una ragazza, la conversazione col padre... cose del genere. Il protagonista viene delineato bene, capiamo subito di che persona si tratta e cosa lo condiziona, ma poi il racconto finisce, e tutto è come prima. Un ritratto, appunto. C'è una notabile eccezione, il racconto più lungo della raccolta, Una vita in venti minuti, dove invece avviene un sensibile sviluppo dei due personaggi principali, il famoso presentatori televisivo e sua figlia con cui da tempo ha interrotto i rapporti. Questo peraltro è un racconto che potremmo inquadrare come weird, visto che parte dalla premesse di un uomo che ha dei fili che gli partono dalle braccia e lo collegano al cielo. In definitiva, la raccolta merita, però in alcune occasioni lascia un po' insoddisfatti, perché viene da pensare cosa avrebbe potuto essere se questi personaggi, così vivi e così vicini, avessero davvero fatto qualcosa o cercato di cambiare, magari opponendosi proprio a quei vizi (ossessioni?). Voto: 6.5/10
Rimaniamo sulla forma breve, che è ciò di cui si occupa per definizione la casa editrice Racconti Edizioni, che tenevo d'occhio da tempo ma non avevo ancora provato prima. Il primo esperimento l'ho fatto con Il vizio di smettere, raccolta di Michele Orti Manara. Si tratta di testi brevi, in media una decina di pagine ma anche meno, stile moderno e accattivante, di quelli che non usano i dialogue tag. Ogni racconto in sostanza presenta un personaggio, che è una persona comune, in una situazione comune, con tante piccole ossessioni (vizi?) come quelle che abbiamo tutti. Per lo più giovani, cresciuti in provincia, con qualche difficoltà a trovare una collocazione nella società secondo le aspettative degli altri. Sono ritratti interessanti, con qualche frase degna di essere citata, però per la maggior parte sono solo ritratti, nel senso che non ci sono vere e proprie storie dietro. Ci viene presentato il protagonita, la sua sitauzione e qualche aneddoto, passato o presente: la morte del fratello, l'incidente in bicicletta, l'incontro con una ragazza, la conversazione col padre... cose del genere. Il protagonista viene delineato bene, capiamo subito di che persona si tratta e cosa lo condiziona, ma poi il racconto finisce, e tutto è come prima. Un ritratto, appunto. C'è una notabile eccezione, il racconto più lungo della raccolta, Una vita in venti minuti, dove invece avviene un sensibile sviluppo dei due personaggi principali, il famoso presentatori televisivo e sua figlia con cui da tempo ha interrotto i rapporti. Questo peraltro è un racconto che potremmo inquadrare come weird, visto che parte dalla premesse di un uomo che ha dei fili che gli partono dalle braccia e lo collegano al cielo. In definitiva, la raccolta merita, però in alcune occasioni lascia un po' insoddisfatti, perché viene da pensare cosa avrebbe potuto essere se questi personaggi, così vivi e così vicini, avessero davvero fatto qualcosa o cercato di cambiare, magari opponendosi proprio a quei vizi (ossessioni?). Voto: 6.5/10
 Infine, forse perché mi ero trovato bene con questo assaggino di weird, sono passato a Chuck Palahniuk, con un romanzo che mi ero lasciato indietro da qualche anno:
Damned
, la storia di Madison Spencer, tredicenne figlia di star del cinema finita all'infarno per aver fumato marijuana (così almeno crede lei). Si tratta sicuramente di una delle storie più assurde di Palahniuk, proprio per come l'inferno viene descritto tra location, organizzazione e attività che vi si svolgono. Non che l'idea dell'inferno come "azienda" sia nuova, ma il tocco di Palahniuk è sempre efficace. Si capisce presto che Madison sa meno di quello che dice, e infatti nel corso del libro assistiamo a diverse rivelazioni, su di lei, sul mondo che ha lasciato e su quello in cui si trova ora. Forse però proprio qui sta il problema, perché verso la fine Madison pare cambiare prospettiva troppo bruscamente e questo suo cambiamento è giustificato in una maniera un po' cheap, forse non un deus ex machina, ma comunque un jolly che si potrebbe usare in qualunque situazione per spiegare qualunque cosa poco credibile (un po' come la mia retcon, per fare un esempio). Si ha quasi l'impressione che verso la fine del libro Palahniuk dovesse portare Madison a un qualche tipo di scontro e allora abbia aggiunto questa sua origin story, con cui peraltro lei fa i conti molto in fretta visto che torna subito dopo a lavorare come aveva fatto fino al giorno prima. La storia si conclude con un to be continued e infatti poco tempo dopo è uscito Doomed. Sicuramente prima o poi lo leggerò, perché vabbè è Palahniuk e si legge sempre volentieri, ma la parte finale di Damned non mi ha invogliato così tanto a voler conoscere l'evoluzione della storia. Voto: 7/10
Infine, forse perché mi ero trovato bene con questo assaggino di weird, sono passato a Chuck Palahniuk, con un romanzo che mi ero lasciato indietro da qualche anno:
Damned
, la storia di Madison Spencer, tredicenne figlia di star del cinema finita all'infarno per aver fumato marijuana (così almeno crede lei). Si tratta sicuramente di una delle storie più assurde di Palahniuk, proprio per come l'inferno viene descritto tra location, organizzazione e attività che vi si svolgono. Non che l'idea dell'inferno come "azienda" sia nuova, ma il tocco di Palahniuk è sempre efficace. Si capisce presto che Madison sa meno di quello che dice, e infatti nel corso del libro assistiamo a diverse rivelazioni, su di lei, sul mondo che ha lasciato e su quello in cui si trova ora. Forse però proprio qui sta il problema, perché verso la fine Madison pare cambiare prospettiva troppo bruscamente e questo suo cambiamento è giustificato in una maniera un po' cheap, forse non un deus ex machina, ma comunque un jolly che si potrebbe usare in qualunque situazione per spiegare qualunque cosa poco credibile (un po' come la mia retcon, per fare un esempio). Si ha quasi l'impressione che verso la fine del libro Palahniuk dovesse portare Madison a un qualche tipo di scontro e allora abbia aggiunto questa sua origin story, con cui peraltro lei fa i conti molto in fretta visto che torna subito dopo a lavorare come aveva fatto fino al giorno prima. La storia si conclude con un to be continued e infatti poco tempo dopo è uscito Doomed. Sicuramente prima o poi lo leggerò, perché vabbè è Palahniuk e si legge sempre volentieri, ma la parte finale di Damned non mi ha invogliato così tanto a voler conoscere l'evoluzione della storia. Voto: 7/10
 Cominciamo non benissimo con
Houdini - passione oscura,
che già come titolo non è così accattivante (l'originale è meglio) e poi la copertina lo fa sembrare un po' un erotosadochicklit. Questo romanzetto di Lisa Mannetti racconta in parte la storia di Houdini attraverso il punto di vista di una delle sue assistenti. Il nucleo principale della storia ruota intorno alla morte di Houdinni, avvenuta a quanto pare per mano dei circoli di occultismo che lui si adoperava a smascherare. Ma c'è anche tempo per flashback e flashforward, nella vita della protagonista, in cui vediamo quando e come la presenza di Houdini ha fatto la differenza. Il tutto però è estremamente confuso. Ora, io non avrò il QI di Moriarty ma riesco a seguire trame complesse e non lineari. Qui però mi sembra che ci sia solo miscuglio e contraddizione: non si capisce bene quando si racconta il passato, quando il presente; non è chiaro se la magia esiste e funziona davvero, se ci sono mondi ultraterreni che possono essere contattati; se (diotipregono) alla fine è tutta un'illusione di una matta chiusa in manicomio. Probabilmente conoscendo il personaggio e la storia di Houdini si potrebbe trarre molto di più da questo racconto, ma per me che so ben poco al di là del suo nome è sembrata una serie sconclusionata di eventi, non sempre rilevanti. Voto: 5/10
Cominciamo non benissimo con
Houdini - passione oscura,
che già come titolo non è così accattivante (l'originale è meglio) e poi la copertina lo fa sembrare un po' un erotosadochicklit. Questo romanzetto di Lisa Mannetti racconta in parte la storia di Houdini attraverso il punto di vista di una delle sue assistenti. Il nucleo principale della storia ruota intorno alla morte di Houdinni, avvenuta a quanto pare per mano dei circoli di occultismo che lui si adoperava a smascherare. Ma c'è anche tempo per flashback e flashforward, nella vita della protagonista, in cui vediamo quando e come la presenza di Houdini ha fatto la differenza. Il tutto però è estremamente confuso. Ora, io non avrò il QI di Moriarty ma riesco a seguire trame complesse e non lineari. Qui però mi sembra che ci sia solo miscuglio e contraddizione: non si capisce bene quando si racconta il passato, quando il presente; non è chiaro se la magia esiste e funziona davvero, se ci sono mondi ultraterreni che possono essere contattati; se (diotipregono) alla fine è tutta un'illusione di una matta chiusa in manicomio. Probabilmente conoscendo il personaggio e la storia di Houdini si potrebbe trarre molto di più da questo racconto, ma per me che so ben poco al di là del suo nome è sembrata una serie sconclusionata di eventi, non sempre rilevanti. Voto: 5/10 Allora proviamo a tornare su qualcosa con sui sono più a mio agio: Francesco Verso ha da poco pubblicato la prima parte di un suo nuovo romanzo, I camminatori. È una storia di transumanesimo imminente, che parte dalle borgate di Roma e mette le basi per un ampiamento del contesto (è già previsto un secondo volume). C'è da dire che le premesse fantascientifiche su cui si basa la storia sono piuttosto forti: la possibilità di utilizzare nanomacchine per potenziare il corpo umano, al punto di rendere l'alimentazione quasi superflua. Non è mica poco. Ma a partire da questo, Verso costruisce una trama postdatapunk che coinvolge personaggi di ogni risma, una piccola rivoluzione che parte da una comune che vive negando i postulati della società capitalista. La storia è ricca di speculazione e spunti di riflessione, ed è in ultima analisi positivista: si potrebbe definire per questo Francesco Verso il Neal Stephenson de noantri, non in senso dispregiativo ma per come la dimensione speculativa sul futuro è calato nel contesto dei borghi che conosciamo. Qua e là si sarebbe potuto asciugare un po' di infodump, ma lo stesso si può dire appunto di Stephenson, e nessuno ha avuto shock anafilattici a leggere Seveneves, che io sappia. Un'ottima base per la seconda parte, che ritengo possa svilupparsi in direzioni ancora più interessanti. Voto: 7/10
Allora proviamo a tornare su qualcosa con sui sono più a mio agio: Francesco Verso ha da poco pubblicato la prima parte di un suo nuovo romanzo, I camminatori. È una storia di transumanesimo imminente, che parte dalle borgate di Roma e mette le basi per un ampiamento del contesto (è già previsto un secondo volume). C'è da dire che le premesse fantascientifiche su cui si basa la storia sono piuttosto forti: la possibilità di utilizzare nanomacchine per potenziare il corpo umano, al punto di rendere l'alimentazione quasi superflua. Non è mica poco. Ma a partire da questo, Verso costruisce una trama postdatapunk che coinvolge personaggi di ogni risma, una piccola rivoluzione che parte da una comune che vive negando i postulati della società capitalista. La storia è ricca di speculazione e spunti di riflessione, ed è in ultima analisi positivista: si potrebbe definire per questo Francesco Verso il Neal Stephenson de noantri, non in senso dispregiativo ma per come la dimensione speculativa sul futuro è calato nel contesto dei borghi che conosciamo. Qua e là si sarebbe potuto asciugare un po' di infodump, ma lo stesso si può dire appunto di Stephenson, e nessuno ha avuto shock anafilattici a leggere Seveneves, che io sappia. Un'ottima base per la seconda parte, che ritengo possa svilupparsi in direzioni ancora più interessanti. Voto: 7/10 Rimaniamo nell'ambito della fantascienza, ma qualcosa di più insolito.
The Only Harmless Great Thing
è poco più che un racconto, dell'autrice pressoché sconosciuta Brooke Bolander. Ma è una storia ricca di fascino e di implicazioni, di quelle che riescono a suscitare molto grazie a quello che non dicono. La si potrebbe definire un'ucronia, e il punto di divergenza storico è che gli elefanti sono creature intelligenti e pensanti, cosa che in effetti sono davvero, ma in questo caso hanno la capacità di comunicare anche con gli umani, attraverso il linguaggio dei segni della proboscide. La pratica è talmente diffusa che esistono corsi di elefantico nei licei, ed esistono mediatori culturali e ambasciatori tra gli umani e le Matriarche. La storia si svolge in due epoche, tra gli inizi del novecento, quando gli elefanti sono schiavizzati e usati nel lavoro in miniera, e l'epoca attuale, dove una ricercatrice cerca di stabilire un accordo con gli elefanti dopo che decenni di schiavismo hanno compromesso i rapporti tra le due specie. Tre le protagoniste c'è Topsy, il famoso elefante che fu elettrificato sulla pubblica piazza da Edison per dimostrare la pericolosità della corrente alternata di Tesla. Qui però la storia di Topsy è diversa, e si lega a quella di una ragazza malata e anch'essa schiava di una vita di cui non può disporre. Come dicevo il racconto è pieno di suggestioni, soprattutto perché concede sprazzi nella cultura degli elefanti, tramandata attraverso le canzoni delle Madri. Forse la parte nel presente è fin troppo abbozzata, riesce appena a mostrare qualche immagine del mondo contemporaneo ma non fornisce un vero e proprio contributo, tant'è che della ricercatrice stessa si sa molto poco. La fine arriva un po' all'improvviso, e anche se si capisce cosa voglia dire, forse qualche pagina in più per rimarcare le idee avrebbe reso il tutto più equilibrato. Comunque un ottimo lavoro, una storia che parla di valori e sentimenti universali, indipendenti dalla specie. Voto: 8/10
Rimaniamo nell'ambito della fantascienza, ma qualcosa di più insolito.
The Only Harmless Great Thing
è poco più che un racconto, dell'autrice pressoché sconosciuta Brooke Bolander. Ma è una storia ricca di fascino e di implicazioni, di quelle che riescono a suscitare molto grazie a quello che non dicono. La si potrebbe definire un'ucronia, e il punto di divergenza storico è che gli elefanti sono creature intelligenti e pensanti, cosa che in effetti sono davvero, ma in questo caso hanno la capacità di comunicare anche con gli umani, attraverso il linguaggio dei segni della proboscide. La pratica è talmente diffusa che esistono corsi di elefantico nei licei, ed esistono mediatori culturali e ambasciatori tra gli umani e le Matriarche. La storia si svolge in due epoche, tra gli inizi del novecento, quando gli elefanti sono schiavizzati e usati nel lavoro in miniera, e l'epoca attuale, dove una ricercatrice cerca di stabilire un accordo con gli elefanti dopo che decenni di schiavismo hanno compromesso i rapporti tra le due specie. Tre le protagoniste c'è Topsy, il famoso elefante che fu elettrificato sulla pubblica piazza da Edison per dimostrare la pericolosità della corrente alternata di Tesla. Qui però la storia di Topsy è diversa, e si lega a quella di una ragazza malata e anch'essa schiava di una vita di cui non può disporre. Come dicevo il racconto è pieno di suggestioni, soprattutto perché concede sprazzi nella cultura degli elefanti, tramandata attraverso le canzoni delle Madri. Forse la parte nel presente è fin troppo abbozzata, riesce appena a mostrare qualche immagine del mondo contemporaneo ma non fornisce un vero e proprio contributo, tant'è che della ricercatrice stessa si sa molto poco. La fine arriva un po' all'improvviso, e anche se si capisce cosa voglia dire, forse qualche pagina in più per rimarcare le idee avrebbe reso il tutto più equilibrato. Comunque un ottimo lavoro, una storia che parla di valori e sentimenti universali, indipendenti dalla specie. Voto: 8/10 Rimaniamo sulla forma breve, che è ciò di cui si occupa per definizione la casa editrice Racconti Edizioni, che tenevo d'occhio da tempo ma non avevo ancora provato prima. Il primo esperimento l'ho fatto con Il vizio di smettere, raccolta di Michele Orti Manara. Si tratta di testi brevi, in media una decina di pagine ma anche meno, stile moderno e accattivante, di quelli che non usano i dialogue tag. Ogni racconto in sostanza presenta un personaggio, che è una persona comune, in una situazione comune, con tante piccole ossessioni (vizi?) come quelle che abbiamo tutti. Per lo più giovani, cresciuti in provincia, con qualche difficoltà a trovare una collocazione nella società secondo le aspettative degli altri. Sono ritratti interessanti, con qualche frase degna di essere citata, però per la maggior parte sono solo ritratti, nel senso che non ci sono vere e proprie storie dietro. Ci viene presentato il protagonita, la sua sitauzione e qualche aneddoto, passato o presente: la morte del fratello, l'incidente in bicicletta, l'incontro con una ragazza, la conversazione col padre... cose del genere. Il protagonista viene delineato bene, capiamo subito di che persona si tratta e cosa lo condiziona, ma poi il racconto finisce, e tutto è come prima. Un ritratto, appunto. C'è una notabile eccezione, il racconto più lungo della raccolta, Una vita in venti minuti, dove invece avviene un sensibile sviluppo dei due personaggi principali, il famoso presentatori televisivo e sua figlia con cui da tempo ha interrotto i rapporti. Questo peraltro è un racconto che potremmo inquadrare come weird, visto che parte dalla premesse di un uomo che ha dei fili che gli partono dalle braccia e lo collegano al cielo. In definitiva, la raccolta merita, però in alcune occasioni lascia un po' insoddisfatti, perché viene da pensare cosa avrebbe potuto essere se questi personaggi, così vivi e così vicini, avessero davvero fatto qualcosa o cercato di cambiare, magari opponendosi proprio a quei vizi (ossessioni?). Voto: 6.5/10
Rimaniamo sulla forma breve, che è ciò di cui si occupa per definizione la casa editrice Racconti Edizioni, che tenevo d'occhio da tempo ma non avevo ancora provato prima. Il primo esperimento l'ho fatto con Il vizio di smettere, raccolta di Michele Orti Manara. Si tratta di testi brevi, in media una decina di pagine ma anche meno, stile moderno e accattivante, di quelli che non usano i dialogue tag. Ogni racconto in sostanza presenta un personaggio, che è una persona comune, in una situazione comune, con tante piccole ossessioni (vizi?) come quelle che abbiamo tutti. Per lo più giovani, cresciuti in provincia, con qualche difficoltà a trovare una collocazione nella società secondo le aspettative degli altri. Sono ritratti interessanti, con qualche frase degna di essere citata, però per la maggior parte sono solo ritratti, nel senso che non ci sono vere e proprie storie dietro. Ci viene presentato il protagonita, la sua sitauzione e qualche aneddoto, passato o presente: la morte del fratello, l'incidente in bicicletta, l'incontro con una ragazza, la conversazione col padre... cose del genere. Il protagonista viene delineato bene, capiamo subito di che persona si tratta e cosa lo condiziona, ma poi il racconto finisce, e tutto è come prima. Un ritratto, appunto. C'è una notabile eccezione, il racconto più lungo della raccolta, Una vita in venti minuti, dove invece avviene un sensibile sviluppo dei due personaggi principali, il famoso presentatori televisivo e sua figlia con cui da tempo ha interrotto i rapporti. Questo peraltro è un racconto che potremmo inquadrare come weird, visto che parte dalla premesse di un uomo che ha dei fili che gli partono dalle braccia e lo collegano al cielo. In definitiva, la raccolta merita, però in alcune occasioni lascia un po' insoddisfatti, perché viene da pensare cosa avrebbe potuto essere se questi personaggi, così vivi e così vicini, avessero davvero fatto qualcosa o cercato di cambiare, magari opponendosi proprio a quei vizi (ossessioni?). Voto: 6.5/10 Infine, forse perché mi ero trovato bene con questo assaggino di weird, sono passato a Chuck Palahniuk, con un romanzo che mi ero lasciato indietro da qualche anno:
Damned
, la storia di Madison Spencer, tredicenne figlia di star del cinema finita all'infarno per aver fumato marijuana (così almeno crede lei). Si tratta sicuramente di una delle storie più assurde di Palahniuk, proprio per come l'inferno viene descritto tra location, organizzazione e attività che vi si svolgono. Non che l'idea dell'inferno come "azienda" sia nuova, ma il tocco di Palahniuk è sempre efficace. Si capisce presto che Madison sa meno di quello che dice, e infatti nel corso del libro assistiamo a diverse rivelazioni, su di lei, sul mondo che ha lasciato e su quello in cui si trova ora. Forse però proprio qui sta il problema, perché verso la fine Madison pare cambiare prospettiva troppo bruscamente e questo suo cambiamento è giustificato in una maniera un po' cheap, forse non un deus ex machina, ma comunque un jolly che si potrebbe usare in qualunque situazione per spiegare qualunque cosa poco credibile (un po' come la mia retcon, per fare un esempio). Si ha quasi l'impressione che verso la fine del libro Palahniuk dovesse portare Madison a un qualche tipo di scontro e allora abbia aggiunto questa sua origin story, con cui peraltro lei fa i conti molto in fretta visto che torna subito dopo a lavorare come aveva fatto fino al giorno prima. La storia si conclude con un to be continued e infatti poco tempo dopo è uscito Doomed. Sicuramente prima o poi lo leggerò, perché vabbè è Palahniuk e si legge sempre volentieri, ma la parte finale di Damned non mi ha invogliato così tanto a voler conoscere l'evoluzione della storia. Voto: 7/10
Infine, forse perché mi ero trovato bene con questo assaggino di weird, sono passato a Chuck Palahniuk, con un romanzo che mi ero lasciato indietro da qualche anno:
Damned
, la storia di Madison Spencer, tredicenne figlia di star del cinema finita all'infarno per aver fumato marijuana (così almeno crede lei). Si tratta sicuramente di una delle storie più assurde di Palahniuk, proprio per come l'inferno viene descritto tra location, organizzazione e attività che vi si svolgono. Non che l'idea dell'inferno come "azienda" sia nuova, ma il tocco di Palahniuk è sempre efficace. Si capisce presto che Madison sa meno di quello che dice, e infatti nel corso del libro assistiamo a diverse rivelazioni, su di lei, sul mondo che ha lasciato e su quello in cui si trova ora. Forse però proprio qui sta il problema, perché verso la fine Madison pare cambiare prospettiva troppo bruscamente e questo suo cambiamento è giustificato in una maniera un po' cheap, forse non un deus ex machina, ma comunque un jolly che si potrebbe usare in qualunque situazione per spiegare qualunque cosa poco credibile (un po' come la mia retcon, per fare un esempio). Si ha quasi l'impressione che verso la fine del libro Palahniuk dovesse portare Madison a un qualche tipo di scontro e allora abbia aggiunto questa sua origin story, con cui peraltro lei fa i conti molto in fretta visto che torna subito dopo a lavorare come aveva fatto fino al giorno prima. La storia si conclude con un to be continued e infatti poco tempo dopo è uscito Doomed. Sicuramente prima o poi lo leggerò, perché vabbè è Palahniuk e si legge sempre volentieri, ma la parte finale di Damned non mi ha invogliato così tanto a voler conoscere l'evoluzione della storia. Voto: 7/10
Published on September 21, 2018 01:27
September 18, 2018
Coppi Night 16/09/2018 - The Signal
C'è stato un certo iato nelle Coppi Night, perché si sa l'estate e le ferie e gli eventi e gli impegni e vabbè. Ma ora può darsi si riesca a riprendere una certa regolarità, e questa settimana ho messo su una selezione frettolosa di film tra cui l'ha spuntata questo The Signal.
 Nonostante la criptica descrizione di Netflix, lo avevo identificato subito come un film sulle
Nonostante la criptica descrizione di Netflix, lo avevo identificato subito come un film sulle
abduction, e già lì la mia curiosità e il mio incoffessabile timore per questo tema sono state stuzzicate. Conosciamo tre ragazzi, in viaggio per accompagnare l'amica/fidanzata nel suo trasloco. Il protagonista cammina con le stampelle e i due maschietti sono pure dei programmatori in competizione con un terzo misterioso hacker che li ha messi nei casini. Scoprono di passare vicino al punto in cui lo hanno localizzato ("vicino" per come lo intendono negli USA, sono giusto un 300 km di detour) e decidono di andarlo a smascherare.
C'è giusto il tempo di sospettare che il resto del film diventi un found footage (grazie a dio non è così), che succede quello che doveva succedere e il nostro protagonista si risveglia in sedia a rotelle, in mezzo a gente imbottita in tute di contenimento e Laurence Fishburne che gli fa domande strane. Il mistero comunque dura poco, visto che gli viene subito rivelato che sono entrati in contatto con qualche creatura aliena, ed è per questo che adesso sono lì dentro, sottoposti a esami di vario tipo.
Questa è probabilmente la parte più interessante del film, con la partita mentale tra il protagonista e i suoi carcerieri. Anche se alcuni momenti sembrano un po' forzati, la tensione rimane alta e il conflitto funziona. Poi a un certo punto il ragazzo riesce a scappare, insieme alla sua fidanzata ancora in coma, e qui si inizia a perdere il filo. Vedere gli agenti dell'Area 51 (ops, mi è scappato, ma scommetto che l'effetto sorpresa è migliore di quello ottenuto nel fim) al di fuori del loro ambiente asettico sminuisce la loro figura. È chiaro fin da subito che c'è qualcos'altro di nascosto, ma si fa presto a immaginare di che si tratta, e dopo lo standoff finale si arriva alla rivelazione che tutti a quel punto si aspettavano. Con un sottofondo dubstep del tutto fuori luogo, che sembra alterare il registro tenuto dal film fino a quel momento, come a dire "ehilà, abbiamo scherzato, dai!".
Peccato perché la prima parte era interessante, e a livello tecnico il film è ben realizzato. Fotografia, regia ed effetti speciali sono di livello elevato per una produzione di questo tipo, e avrebbero potuto dare forza a un film capace di dare un messaggio. Sembra invece che gli autori abbiano concentrato tutti i loro sforzi in continui plot twist, che poi non twistano più di tanto, dimenticandosi di dare consistenza alla storia nel suo complesso proprio quando ne aveva più bisogno. Apprezzabile il tentativo, ma poco convincente il risultato.
 Nonostante la criptica descrizione di Netflix, lo avevo identificato subito come un film sulle
Nonostante la criptica descrizione di Netflix, lo avevo identificato subito come un film sulle abduction, e già lì la mia curiosità e il mio incoffessabile timore per questo tema sono state stuzzicate. Conosciamo tre ragazzi, in viaggio per accompagnare l'amica/fidanzata nel suo trasloco. Il protagonista cammina con le stampelle e i due maschietti sono pure dei programmatori in competizione con un terzo misterioso hacker che li ha messi nei casini. Scoprono di passare vicino al punto in cui lo hanno localizzato ("vicino" per come lo intendono negli USA, sono giusto un 300 km di detour) e decidono di andarlo a smascherare.
C'è giusto il tempo di sospettare che il resto del film diventi un found footage (grazie a dio non è così), che succede quello che doveva succedere e il nostro protagonista si risveglia in sedia a rotelle, in mezzo a gente imbottita in tute di contenimento e Laurence Fishburne che gli fa domande strane. Il mistero comunque dura poco, visto che gli viene subito rivelato che sono entrati in contatto con qualche creatura aliena, ed è per questo che adesso sono lì dentro, sottoposti a esami di vario tipo.
Questa è probabilmente la parte più interessante del film, con la partita mentale tra il protagonista e i suoi carcerieri. Anche se alcuni momenti sembrano un po' forzati, la tensione rimane alta e il conflitto funziona. Poi a un certo punto il ragazzo riesce a scappare, insieme alla sua fidanzata ancora in coma, e qui si inizia a perdere il filo. Vedere gli agenti dell'Area 51 (ops, mi è scappato, ma scommetto che l'effetto sorpresa è migliore di quello ottenuto nel fim) al di fuori del loro ambiente asettico sminuisce la loro figura. È chiaro fin da subito che c'è qualcos'altro di nascosto, ma si fa presto a immaginare di che si tratta, e dopo lo standoff finale si arriva alla rivelazione che tutti a quel punto si aspettavano. Con un sottofondo dubstep del tutto fuori luogo, che sembra alterare il registro tenuto dal film fino a quel momento, come a dire "ehilà, abbiamo scherzato, dai!".
Peccato perché la prima parte era interessante, e a livello tecnico il film è ben realizzato. Fotografia, regia ed effetti speciali sono di livello elevato per una produzione di questo tipo, e avrebbero potuto dare forza a un film capace di dare un messaggio. Sembra invece che gli autori abbiano concentrato tutti i loro sforzi in continui plot twist, che poi non twistano più di tanto, dimenticandosi di dare consistenza alla storia nel suo complesso proprio quando ne aveva più bisogno. Apprezzabile il tentativo, ma poco convincente il risultato.
Published on September 18, 2018 03:33
September 11, 2018
Netiquette please
Mi è capitato spesso negli ultimi mesi di leggere annunci di "disintossicazione social", del tipo:
Gli ambienti social nel corso degli anni sono diventati sempre meno sereni, luoghi virtuali dove persone reali si polarizzano sulle loro posizioni e sono pronti prima di tutto a distruggere la fazione opposta, incapaci di ascoltare qualunque obiezione. Mi riferisco a Facebook in particolare, ma anche tutto ciò che gli ruota intorno e non propriamente definibile come social network, dalla sezione commenti di Youtube (paradossalmente è molto più civile quella di Pornhub) ai siti di recensioni (libri, film, ristoranti), dai giornali online ai vari aggregatori di notizie, vere o false che siano.
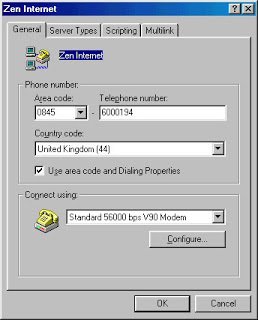 Ci sono fondati sospetti che questa informe massa di menti immerse nella loro confirmation bubble sia alla base dell'affermazione dei movimenti populisti un po' ovunque nel mondo. Ma non voglio farne un discorso politico. Quella politica è solo una conseguenza di un fenomeno più ampio.
Ci sono fondati sospetti che questa informe massa di menti immerse nella loro confirmation bubble sia alla base dell'affermazione dei movimenti populisti un po' ovunque nel mondo. Ma non voglio farne un discorso politico. Quella politica è solo una conseguenza di un fenomeno più ampio.
Quello che molti si chiedono è come siamo arrivati a questo punto. Gli stessi guru della Rete, che fino a dieci anni fa sostenevano che Internet sarebbe stata la salvezza dei popoli, stanno facendo marcia indietro di fronte all'evidenza dei fatti. Cosa è successo che nemmeno loro avevano previsto?
Provo a dare una mia interpretazione, che chiaramente non si vuole sostituire alle analisi di chi studia questo settore da decenni, ma che trovo empiricamente applicabile a molti di questi casi.
Il problema è la netiquette. Vale a dire, l'assenza di netiquette.
La netiquette è talmente assente che probabilmente la maggior parte degli attuali utilizzatori di internet non sa nemmeno cosa sia. Senza stare a fare l'Aranzulla della situazione, la netiquette comprende tutte quelle norme di buona condotta, e per certi versi anche educazione, che si dovrebbe assumere quando ci si relaziona online con gli altri.
Quando internet ha iniziato a diffondersi tra il popolino, la netiquette era una cosa terribilmente seria. Si parla di fine anni 90 - primi 2000. All'epoca avevo tredici-quattordici anni e mi affacciavo timidamente sui canali chat come C6 e, i gruppi MSN, i blog su splinder e i forum forumfree. La netiquette era sempre ben evidente e la pena per la violazione era semplice e immediata, senza appello.
Se usavi terminologia inappropriata, venivi bannato.
Se insultavi qualcuno, venivi bannato.
Se scrivevi in caps lock, venivi bannato.
Se metti link non richiesti a siti esterni, venivi bannato.
Se inserivi immagini troppo pesanti, venivi bannato.
Se aggiungevi troppe emoticon ai tuoi messaggi, venivi bannato.
Se facevi una domanda senza prima cercare che qualcuno non avesse già fatto quella stessa domanda... venivi bannato.
Si faceva presto a imparare. Di certo c'era chi esagerava con la rigorosità, e in molti casi usava la scusa della netiquette per applicare un becero nonnismo verso le reclute che si riversavano ingenue e speranzose nel mondo virtuale. Ma da un altro punto di vista, la netiquette insegnava a essere prudenti.
 A quei tempi connettersi a internet era una cosa occasionale, un paio d'ore al giorno se andava bene. E con un model dial-up 56k ogni minuto di connessione era prezioso (tant'è che costava come un minuto di telefonata urbana). Per questo, tante di queste norme di comportamento derivavano dalla necessità di preservare l'integrità della connessione per tutti. Niente link farlocchi, niente allegati pesanti, niente ridondanza. La Rete era un mondo pericoloso, perché era territorio inesplorato. Se sbagliavi a cliccare ti si attaccavano alla linea e telefonavano in Bangladesh; se scaricavi su Napster un file senza prima aver controllato le fonti, ti ritrovavi al posto della canzone una compilation di rutti e avevi buttato una nottata intera di connessione; se seguivi i suggerimenti delle persone sbagliate su come ripulire il pc ti trovavi con l'hard disk formattato.
A quei tempi connettersi a internet era una cosa occasionale, un paio d'ore al giorno se andava bene. E con un model dial-up 56k ogni minuto di connessione era prezioso (tant'è che costava come un minuto di telefonata urbana). Per questo, tante di queste norme di comportamento derivavano dalla necessità di preservare l'integrità della connessione per tutti. Niente link farlocchi, niente allegati pesanti, niente ridondanza. La Rete era un mondo pericoloso, perché era territorio inesplorato. Se sbagliavi a cliccare ti si attaccavano alla linea e telefonavano in Bangladesh; se scaricavi su Napster un file senza prima aver controllato le fonti, ti ritrovavi al posto della canzone una compilation di rutti e avevi buttato una nottata intera di connessione; se seguivi i suggerimenti delle persone sbagliate su come ripulire il pc ti trovavi con l'hard disk formattato.
Io non sono un nativo digitale. Sono nato in un mondo per lo più analogico e ho assistito allo shift verso il digitale. Per certi versi, ne ho fatto parte. La mia impressione è che chi come me ha vissuto quel periodo, su internet si muove con più dimestichezza, e ancora oggi si destreggia meglio tra fake news e phishing, profili falsi e siti fallati.
Al contrario, chi è approdato in Rete senza quegli anni di gavetta, ne subisce tutti gli effetti peggiori. Da una parte quei nativi digitali che con internet sono nati e a tre anni già maneggiavano l'ipad, che danno per scontata la possibilità di avere sempre a disposizione banda larga per qualsiasi necessità, anche la più effimera; dall'altra tutte quelle fasce che il computer non lo hanno mai usato, ma quando si sono ritrovate con il cellulare già connesso, allora è facile. Tutti questi si sono riversati su internet, e in particolare sui social network, senza sapere niente della netiquette. E infatti si comportano senza la minima cognizione di dove sono e cosa fanno, come se fossero parte del pubblico in una trasmissione tv:
Scrivono tutto maiuscolo.
Insultano.
Spammano.
Abusano di emoticon (evolute in emoji/sticker/gif).
Ripetono in continuazione cose dette da altri immediatamente prima.
Ed è un passo breve dalla constatazione che milioni di persone utilizzano un mezzo che non comprendono, all'idea che su questa loro ignoranza si possa capitalizzare. Succedeva già con la televisione, è successo col telefono, prima ancora con la posta: le catene di Sant'Antonio sono nate così, no?
Non voglio impostarlo come uno scontro generazionale. Ci sono tanti miei coetanei che hanno scoperto internet come quella gente lì, e ci sono tanti baby boomers che invece erano attivi già a quell'epoca, e magari erano tra quelli che la netiquette la amministravano. Semplicemente, in linea di massima io e la mia generazione ci siamo trovati al momento giusto con le possibilità di inaugurare questo mondo, e ci siamo entrati in punta di piedi, quando ancora era nuovo e pieno di cose da scoprire. Prima che diventasse nazionalpopolare e ci aprissero la spa, il casino e il buffet 24/7.
Sono convinto che il ritorno della netiquette potrebbe giovare al clima attuale, ma credo anche che ormai sia troppo tardi. I buoi sono scappati e costruire la staccionata ora non li farà rientrare. C'è anche chi sostiene che è proprio questo il momento in cui è importante non mollare, mantenere la propria presenza e costanza, fino a quando queste dinamiche non si risolveranno da sole con la maturazione di una classe di utenti più consapevole.
Ma io non sono così fiducioso. Devo ammettere anzi di aver pensato anch'io ad allontanarmi dagli ambienti social, ma per ora ho deciso di resiste. È comunque vero che da un anno a questa parte ho ridotto notevolmente la mia presenza su questi canali, perché bastano pochi minuti di interazione per sentire la pressione di quel blob di risentimento rigurgitato da foto profilo con la cornice a cuoricino. Probabilmente continuerò a starmene un po' in disparte, a osservare poco e partecipare meno, in attesa che cambi il tempo
cari amici, il clima qui sopra si sta facendo sempre più astioso e non riesco a sopportarlo, per cui disattivo temporaneamente il mio account, ci rivediamo forse tra sei mesi, chi vuole può contattarmi qui e qui.
Gli ambienti social nel corso degli anni sono diventati sempre meno sereni, luoghi virtuali dove persone reali si polarizzano sulle loro posizioni e sono pronti prima di tutto a distruggere la fazione opposta, incapaci di ascoltare qualunque obiezione. Mi riferisco a Facebook in particolare, ma anche tutto ciò che gli ruota intorno e non propriamente definibile come social network, dalla sezione commenti di Youtube (paradossalmente è molto più civile quella di Pornhub) ai siti di recensioni (libri, film, ristoranti), dai giornali online ai vari aggregatori di notizie, vere o false che siano.
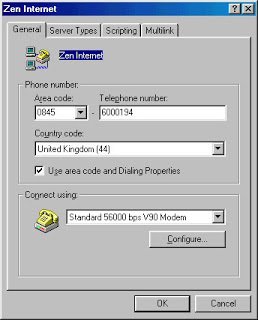 Ci sono fondati sospetti che questa informe massa di menti immerse nella loro confirmation bubble sia alla base dell'affermazione dei movimenti populisti un po' ovunque nel mondo. Ma non voglio farne un discorso politico. Quella politica è solo una conseguenza di un fenomeno più ampio.
Ci sono fondati sospetti che questa informe massa di menti immerse nella loro confirmation bubble sia alla base dell'affermazione dei movimenti populisti un po' ovunque nel mondo. Ma non voglio farne un discorso politico. Quella politica è solo una conseguenza di un fenomeno più ampio.Quello che molti si chiedono è come siamo arrivati a questo punto. Gli stessi guru della Rete, che fino a dieci anni fa sostenevano che Internet sarebbe stata la salvezza dei popoli, stanno facendo marcia indietro di fronte all'evidenza dei fatti. Cosa è successo che nemmeno loro avevano previsto?
Provo a dare una mia interpretazione, che chiaramente non si vuole sostituire alle analisi di chi studia questo settore da decenni, ma che trovo empiricamente applicabile a molti di questi casi.
Il problema è la netiquette. Vale a dire, l'assenza di netiquette.
La netiquette è talmente assente che probabilmente la maggior parte degli attuali utilizzatori di internet non sa nemmeno cosa sia. Senza stare a fare l'Aranzulla della situazione, la netiquette comprende tutte quelle norme di buona condotta, e per certi versi anche educazione, che si dovrebbe assumere quando ci si relaziona online con gli altri.
Quando internet ha iniziato a diffondersi tra il popolino, la netiquette era una cosa terribilmente seria. Si parla di fine anni 90 - primi 2000. All'epoca avevo tredici-quattordici anni e mi affacciavo timidamente sui canali chat come C6 e, i gruppi MSN, i blog su splinder e i forum forumfree. La netiquette era sempre ben evidente e la pena per la violazione era semplice e immediata, senza appello.
Se usavi terminologia inappropriata, venivi bannato.
Se insultavi qualcuno, venivi bannato.
Se scrivevi in caps lock, venivi bannato.
Se metti link non richiesti a siti esterni, venivi bannato.
Se inserivi immagini troppo pesanti, venivi bannato.
Se aggiungevi troppe emoticon ai tuoi messaggi, venivi bannato.
Se facevi una domanda senza prima cercare che qualcuno non avesse già fatto quella stessa domanda... venivi bannato.
Si faceva presto a imparare. Di certo c'era chi esagerava con la rigorosità, e in molti casi usava la scusa della netiquette per applicare un becero nonnismo verso le reclute che si riversavano ingenue e speranzose nel mondo virtuale. Ma da un altro punto di vista, la netiquette insegnava a essere prudenti.
 A quei tempi connettersi a internet era una cosa occasionale, un paio d'ore al giorno se andava bene. E con un model dial-up 56k ogni minuto di connessione era prezioso (tant'è che costava come un minuto di telefonata urbana). Per questo, tante di queste norme di comportamento derivavano dalla necessità di preservare l'integrità della connessione per tutti. Niente link farlocchi, niente allegati pesanti, niente ridondanza. La Rete era un mondo pericoloso, perché era territorio inesplorato. Se sbagliavi a cliccare ti si attaccavano alla linea e telefonavano in Bangladesh; se scaricavi su Napster un file senza prima aver controllato le fonti, ti ritrovavi al posto della canzone una compilation di rutti e avevi buttato una nottata intera di connessione; se seguivi i suggerimenti delle persone sbagliate su come ripulire il pc ti trovavi con l'hard disk formattato.
A quei tempi connettersi a internet era una cosa occasionale, un paio d'ore al giorno se andava bene. E con un model dial-up 56k ogni minuto di connessione era prezioso (tant'è che costava come un minuto di telefonata urbana). Per questo, tante di queste norme di comportamento derivavano dalla necessità di preservare l'integrità della connessione per tutti. Niente link farlocchi, niente allegati pesanti, niente ridondanza. La Rete era un mondo pericoloso, perché era territorio inesplorato. Se sbagliavi a cliccare ti si attaccavano alla linea e telefonavano in Bangladesh; se scaricavi su Napster un file senza prima aver controllato le fonti, ti ritrovavi al posto della canzone una compilation di rutti e avevi buttato una nottata intera di connessione; se seguivi i suggerimenti delle persone sbagliate su come ripulire il pc ti trovavi con l'hard disk formattato.Io non sono un nativo digitale. Sono nato in un mondo per lo più analogico e ho assistito allo shift verso il digitale. Per certi versi, ne ho fatto parte. La mia impressione è che chi come me ha vissuto quel periodo, su internet si muove con più dimestichezza, e ancora oggi si destreggia meglio tra fake news e phishing, profili falsi e siti fallati.
Al contrario, chi è approdato in Rete senza quegli anni di gavetta, ne subisce tutti gli effetti peggiori. Da una parte quei nativi digitali che con internet sono nati e a tre anni già maneggiavano l'ipad, che danno per scontata la possibilità di avere sempre a disposizione banda larga per qualsiasi necessità, anche la più effimera; dall'altra tutte quelle fasce che il computer non lo hanno mai usato, ma quando si sono ritrovate con il cellulare già connesso, allora è facile. Tutti questi si sono riversati su internet, e in particolare sui social network, senza sapere niente della netiquette. E infatti si comportano senza la minima cognizione di dove sono e cosa fanno, come se fossero parte del pubblico in una trasmissione tv:
Scrivono tutto maiuscolo.
Insultano.
Spammano.
Abusano di emoticon (evolute in emoji/sticker/gif).
Ripetono in continuazione cose dette da altri immediatamente prima.
Ed è un passo breve dalla constatazione che milioni di persone utilizzano un mezzo che non comprendono, all'idea che su questa loro ignoranza si possa capitalizzare. Succedeva già con la televisione, è successo col telefono, prima ancora con la posta: le catene di Sant'Antonio sono nate così, no?
Non voglio impostarlo come uno scontro generazionale. Ci sono tanti miei coetanei che hanno scoperto internet come quella gente lì, e ci sono tanti baby boomers che invece erano attivi già a quell'epoca, e magari erano tra quelli che la netiquette la amministravano. Semplicemente, in linea di massima io e la mia generazione ci siamo trovati al momento giusto con le possibilità di inaugurare questo mondo, e ci siamo entrati in punta di piedi, quando ancora era nuovo e pieno di cose da scoprire. Prima che diventasse nazionalpopolare e ci aprissero la spa, il casino e il buffet 24/7.
Sono convinto che il ritorno della netiquette potrebbe giovare al clima attuale, ma credo anche che ormai sia troppo tardi. I buoi sono scappati e costruire la staccionata ora non li farà rientrare. C'è anche chi sostiene che è proprio questo il momento in cui è importante non mollare, mantenere la propria presenza e costanza, fino a quando queste dinamiche non si risolveranno da sole con la maturazione di una classe di utenti più consapevole.
Ma io non sono così fiducioso. Devo ammettere anzi di aver pensato anch'io ad allontanarmi dagli ambienti social, ma per ora ho deciso di resiste. È comunque vero che da un anno a questa parte ho ridotto notevolmente la mia presenza su questi canali, perché bastano pochi minuti di interazione per sentire la pressione di quel blob di risentimento rigurgitato da foto profilo con la cornice a cuoricino. Probabilmente continuerò a starmene un po' in disparte, a osservare poco e partecipare meno, in attesa che cambi il tempo
Published on September 11, 2018 07:34
September 3, 2018
Dennis White, il primo sporifero
 Ormai due anni fa segnalavo come l'Infinity Burial Project, l'idea che sta all'origine del mio racconto Spore, si era evoluto in una vera e propria azienda, la
Coeio
, che si sarebbe dedicata alla produzione e commercializzazione delle infinity suits. Naturalmente questo comportava anche trovare qualcuno che volesse utilizzarle. E hanno trovato Dennis White.
Ormai due anni fa segnalavo come l'Infinity Burial Project, l'idea che sta all'origine del mio racconto Spore, si era evoluto in una vera e propria azienda, la
Coeio
, che si sarebbe dedicata alla produzione e commercializzazione delle infinity suits. Naturalmente questo comportava anche trovare qualcuno che volesse utilizzarle. E hanno trovato Dennis White.Dennis White era un sessantaquattrenne del Massachussets affetto da una grave malattia degenerativa incurabile, la demenza frontotemporale. Dopo aver scoperto le Inifinity Burial Suit, ha contattato la Coeio per offrirsi come soggetto test. Sul sito è presente un video che documenta la fase di progettazione della tuta e l'impatto che questa scelta ha avuto su Dennis e la sua famiglia, lo ripubblico qui.
Quando ho scritto la prima versione di Spore (pubblicato nel 2013 nella raccolta omonima, non più disponibile), dovevo trovare un punto di origine per la mia storia, e ho pensato a tale Robert Kerrigan. Nella scena iniziale lo mostro con la sua famiglia, dopo una cena, consumato dalla malattia a parlare con suo figlio del futuro in cui lui non ci sarà.
È esattamente quello che si vede in questo video. Dennis White assomiglia a come mi ero immaginato Robert Kerrigan per molti versi. Anche l'aspetto fisico, quello di un uomo anziano ma sicuro di sé nonostante la decadenza del corpo, si avvicina molto a quello che avevo in mente. E il rapporto con la famiglia, il modo in cui tutti sono coinvolti nella scelta di cui lui è fermamente convinto, mi sembra del tutto affine a quello che ho descritto.
Quando ho rimesso mano a Spore in occasione della sua ripubblicazione all'interno de Il lettore universale , non avevo ancora scoperto la storia di Dennis. Forse se l'avessi trovato prima, avrei potuto pensare di cambiare nome al mio personaggio e chiamarlo come lui. Ma forse sarebbe stato poco rispettoso nei confronti di un uomo coraggioso e lungimirante.
Talmente lungimirante che mi ha battuto sul tempo. Il mio racconto inizia con Robert Kerrigan nel 2019, anno in cui avevo ipotizzato avrebbe potuto iniziare la diffusione del decompikit micotico. Dennis invece è morto nel settembre del 2016.
Grazie a lui il processo di sporizzazione del pianeta ha guadagnato un paio di anni sulla tabella di marcia.
Published on September 03, 2018 23:10
August 21, 2018
Cosa manca a Disincanto per essere come Futurama
La settimana scorsa è apparsa su Netflix la prima stagione di
Disincanto
(Disenchantment), la nuova serie ideata e prodotto da Matt Groening, che per eventuali neanderthal lettori di questo post che non riconoscessero il nome, è l'ideatore dei Simpson e soprattutto di Futurama (anche se c'è da dire che poi il team di autori di quest'ulimo è stato guidato per lo più da David X. Cohen, ma questo è un altro discorso).
 Dato che sono il fan italiano numero uno di Futurama (nessuno mi ha ancora smentito), l'uscita di questa serie mi ha da un lato eccitato, nella speranza di trovare in Disincanto qualcosa dello splendore di Futurama, dall'altro mi ha preoccupato, nel timore di trovare in Disincanto qualcosa dello splendore di Futurama. In ogni caso, fin da quando è stata annunciata sapevo che l'avrei vista, per capire se avevo ben riposto le mie speranze e i miei timori. Dopo aver visto i dieci episodi della prima serie, sono pronto a tracciare un breve riepilogo e un confronto con la mia serie animata preferita. Seguiranno moderati spoiler, ma non su punti particolari della trama quanto soprattutto su temi, personaggi, archi narrativi. Anche se non avete visto la serie potete leggere senza troppi rischi.
Dato che sono il fan italiano numero uno di Futurama (nessuno mi ha ancora smentito), l'uscita di questa serie mi ha da un lato eccitato, nella speranza di trovare in Disincanto qualcosa dello splendore di Futurama, dall'altro mi ha preoccupato, nel timore di trovare in Disincanto qualcosa dello splendore di Futurama. In ogni caso, fin da quando è stata annunciata sapevo che l'avrei vista, per capire se avevo ben riposto le mie speranze e i miei timori. Dopo aver visto i dieci episodi della prima serie, sono pronto a tracciare un breve riepilogo e un confronto con la mia serie animata preferita. Seguiranno moderati spoiler, ma non su punti particolari della trama quanto soprattutto su temi, personaggi, archi narrativi. Anche se non avete visto la serie potete leggere senza troppi rischi.
Partiamo subito sgombrando il terreno: Disincanto non è riuscito come Futurama. Anche considerando solo la prima stagione, che pure in Futurama era immatura, sono tanti i punti in cui questa nuova serie non eguaglia la precedente. Ammetto di affrontare la questione con un certo confirmation bias, perché sotto sotto voglio che Futurama rimanga migliore, ma credo ci siano dati oggettivi che si possono portare a conferma della mia tesi. Provo a elencarli.
La protagonista. Giusto per contestualizzare, Disincanto è la storia di Bean (diminuitivo di Tiabeanie), giovane principessa del regno di Dreamland. Bean è la classica principessa che non vive bene il suo ruolo, ribelle, tomboy, preferisce passare il suo tempo a sbronzarsi in taverna piuttosto che al castello. La sua vita le va stretta e questo è il punto principale che rende difficile empatizzare con lei. Sicuro, siamo abituati a personaggi del genere (da Fantaghirò a tutti i più recenti film Disney), e l'archetipo del nobile insofferente per la sua posizione può funzionare. In questo caso però, Bean appare per lo più come la bimba viziata che crede tutto le sia dovuto, anche una vita entusiasmante e avventurosa. Infatti nessuno di chi le sta intorno è particolarmente malvagio, oppressivo o violento verso di lei. Anzi, quasi tutti le mostrano comprensione e continuano a perdonare le sue scappatelle. Suo padre Re Zog, per quanto burbero e anaffettivo, le vuole bene e in fondo si trova in una posizione ben peggiore della sua; il "personale" di corte, dalle guardie alla domestica, al ministro, sono sempre a sua disposizione per ascolto e incarichi; perfino la sua matrigna, che per tradizione dovrebbe essere cattiva, è viscida solo in senso letterale (in quanto di specie umano-anfibia), ma in realtà è condiscendente e addirittura dispensa consigli. Quindi, che ha da lamentarsi Bean, quando ha tutte le possibilità di fare e ottenere ciò che vuole? Facendo un confronto con Futurama, a differenza di Fry che è tonto ma buono e si trova spesso in situazioni spiacevoli non per colpa sua, questa principessa sembra ricercare le proprie sciagure per combattere la noia. Anche il suo alcolismo, se pure non viene rappresentato come un problema serio ma solo una forma di evasione, non contribuisce a farla risultare simpatica. E se è sempre vero che un protagonsita non deve essere necessariamente simpatico, è comunque importante che lo spettatore sia interessato ai suoi problemi e tifi per lui nei conflitti. Purtroppo non è così.I personaggi principali. Oltre alla protagonista, c'è qualche problema anche con gli altri comprimari. Del trio principale, forse solo Elfo ha personalità e uno sviluppo narrativo ben definito e condivisibile. Il suo interesse romantico ber Bean forse è un po' forzato, ma si può accettare. Il demonietto Luci invece non ha un ruolo altrettanto chiaro: inviato come dono da stregoni sconosciuti, dovrebbe essere il demone personale di Bean e portarla sulla strada del male, ma nella maggior parte dei casi si rivela essere la voce della ragione. È sicuramente il più intelligente e pratico del gruppo, oltre ad avere una serie di poteri che possono tornare comodi molto spesso. Credo che il paragone con Bender sia scontato: il personaggio "negativo" che non fa mistero della sua cattiveria e ostenta i suoi vizi. Con la differenza che mentre Bendere, coerentemente con questa caratterizzazione, spesso causa problemi agli altri e se stesso, Luci invece li risolve. Poi abbiamo il già citato Re Zog, che dovrebbe essere in qualche modo un antagonista ma a ben vedere è un povero diavolo: ha perso l'unico amore della sua vita (la madre di Bean), è stato costretto a un matrimonio politico per terminare una guerra e in fin dei conti nemmeno avrebbe dovuto diventare re. Insomma, va bene sovvertire gli archetipi, ma qui sono proprio le funzioni narrative che non combaciano perfettamente e rendono la storia squilibrata.Il sense of wonder. Dov'è? Da una serie fantasy ci si aspetta un buon livello di worldbuiling, tante invenzioni e ambientazioni e idee che ispirino meraviglia. Invece tutto Disenchantment si appoggia fin troppo su cliché e topoi del fantasy epico più commerciale, dalle creature mitologiche alle quest, dalla magia alle mappe. Certamente tutto è reinterpretato in chiave parodistica, come già faceva Futurama per i cliché della fantascienza, ma non c'è davvero un'invenzione che sia una. Il sangue di elfo come elisir di vita? Già visto. Il villaggio degli elfi come catena di montaggo di dolciumi? Praticamente uguale ai nettuniani di Futurama che lavorano nella fabbrica di babbo natale, anche nell'aspetto. Il gigante buono? Il cacciatore di demoni? I barbari invasori? Check. Check. Check. L'unica idea che ho trovato minimamente originale è la nazione di umani-anfibi, dove vengono fori anche alcune simpatiche trovate nell'ambientazione. Ma lo sforzo è proprio ai minimi.Animazione e musica. Non sono un super esperto, ma mi pare che scarseggi qualcosa a livello di animazione, soprattutto nelle scene d'azione. Ovvio, in questo senso lo stile di Groening non brilla né ne I Simpson né in Futurama, eppure mi è sembrato che non ci sia stato nessun miglioramento nonostante i decenni di innovazione tecnologica. La sovrapposizione tra 2D e 3D c'era già in Futurama (e all'epoca era davvero innovativa), per il resto niente da notare. E la colonna sonora, in generae, non sembra accompagnare né sottolineare in maniera adeguata ciò che avviene. L'esempio più lampante è la sequenza della rissa nella taverna del primo episodio: una scena che dovrebbe essere caotica e concitata risulta del tutto piatta, senza tensione.L'umorismo. Alla fine dei conti ho riso poco. Questo può essere un mio problema, perché chiaramente ognuno è più sensibile a un certo tipo di umorismo, e per me quello scientifico/assurdo di Futurama è il più efficace. Però in generale mi sembra che non si va oltre le situazioni da sitcom, con poche gag visive (che sono quelle che a posteriori rendono di più) e tante battute prevedibili. Apprezzo però che si faccia poco affidamento sulle battute basate sulla cultura pop, quindi riferimenti all'attualità, dalla politica allo spettacolo. Questo è quello che ha rovinato I Simpson ed è bene starne lontani quanto possibile. In definitiva, Disincanto per me è un prodotto non del tutto riuscito. Tutto sommato gradevole, ma che non lascia un segno. C'è da dire che la storia vista in questa prima stagione è incompleta, e anzi finisce con vari cliffhanger (sono già in produzione i dieci episodi della stagione due, poi si vedrà). Può darsi quindi che nel prosieguo della storia alcuni punti della trama diano maggior spessore ai personaggi, ad esempio la missione di Luci. Allo stato attuale però, ci troviamo di fronte a qualcosa di incompleto.
In definitiva, Disincanto per me è un prodotto non del tutto riuscito. Tutto sommato gradevole, ma che non lascia un segno. C'è da dire che la storia vista in questa prima stagione è incompleta, e anzi finisce con vari cliffhanger (sono già in produzione i dieci episodi della stagione due, poi si vedrà). Può darsi quindi che nel prosieguo della storia alcuni punti della trama diano maggior spessore ai personaggi, ad esempio la missione di Luci. Allo stato attuale però, ci troviamo di fronte a qualcosa di incompleto.
Non sono sicuro se seguirò la seconda stagione o se Disincanto finirà tra le serie che ho smesso di vedere. Credo che guarderò almeno i primi episodi per scoprire come hanno risolto i cliffhanger, in particolare quello di Elfo e Luci (di Bean ho già detto che mi importa poco?), e se la risoluzione mi sembrerà inadeguata, potrei mollare. Nel complesso comunque non mi sento di scoraggiare la visione, ma di certo tenere le aspettative basse.
In alternativa, c'è sempre la possiblità di recuperare Futurama.
 Dato che sono il fan italiano numero uno di Futurama (nessuno mi ha ancora smentito), l'uscita di questa serie mi ha da un lato eccitato, nella speranza di trovare in Disincanto qualcosa dello splendore di Futurama, dall'altro mi ha preoccupato, nel timore di trovare in Disincanto qualcosa dello splendore di Futurama. In ogni caso, fin da quando è stata annunciata sapevo che l'avrei vista, per capire se avevo ben riposto le mie speranze e i miei timori. Dopo aver visto i dieci episodi della prima serie, sono pronto a tracciare un breve riepilogo e un confronto con la mia serie animata preferita. Seguiranno moderati spoiler, ma non su punti particolari della trama quanto soprattutto su temi, personaggi, archi narrativi. Anche se non avete visto la serie potete leggere senza troppi rischi.
Dato che sono il fan italiano numero uno di Futurama (nessuno mi ha ancora smentito), l'uscita di questa serie mi ha da un lato eccitato, nella speranza di trovare in Disincanto qualcosa dello splendore di Futurama, dall'altro mi ha preoccupato, nel timore di trovare in Disincanto qualcosa dello splendore di Futurama. In ogni caso, fin da quando è stata annunciata sapevo che l'avrei vista, per capire se avevo ben riposto le mie speranze e i miei timori. Dopo aver visto i dieci episodi della prima serie, sono pronto a tracciare un breve riepilogo e un confronto con la mia serie animata preferita. Seguiranno moderati spoiler, ma non su punti particolari della trama quanto soprattutto su temi, personaggi, archi narrativi. Anche se non avete visto la serie potete leggere senza troppi rischi.Partiamo subito sgombrando il terreno: Disincanto non è riuscito come Futurama. Anche considerando solo la prima stagione, che pure in Futurama era immatura, sono tanti i punti in cui questa nuova serie non eguaglia la precedente. Ammetto di affrontare la questione con un certo confirmation bias, perché sotto sotto voglio che Futurama rimanga migliore, ma credo ci siano dati oggettivi che si possono portare a conferma della mia tesi. Provo a elencarli.
La protagonista. Giusto per contestualizzare, Disincanto è la storia di Bean (diminuitivo di Tiabeanie), giovane principessa del regno di Dreamland. Bean è la classica principessa che non vive bene il suo ruolo, ribelle, tomboy, preferisce passare il suo tempo a sbronzarsi in taverna piuttosto che al castello. La sua vita le va stretta e questo è il punto principale che rende difficile empatizzare con lei. Sicuro, siamo abituati a personaggi del genere (da Fantaghirò a tutti i più recenti film Disney), e l'archetipo del nobile insofferente per la sua posizione può funzionare. In questo caso però, Bean appare per lo più come la bimba viziata che crede tutto le sia dovuto, anche una vita entusiasmante e avventurosa. Infatti nessuno di chi le sta intorno è particolarmente malvagio, oppressivo o violento verso di lei. Anzi, quasi tutti le mostrano comprensione e continuano a perdonare le sue scappatelle. Suo padre Re Zog, per quanto burbero e anaffettivo, le vuole bene e in fondo si trova in una posizione ben peggiore della sua; il "personale" di corte, dalle guardie alla domestica, al ministro, sono sempre a sua disposizione per ascolto e incarichi; perfino la sua matrigna, che per tradizione dovrebbe essere cattiva, è viscida solo in senso letterale (in quanto di specie umano-anfibia), ma in realtà è condiscendente e addirittura dispensa consigli. Quindi, che ha da lamentarsi Bean, quando ha tutte le possibilità di fare e ottenere ciò che vuole? Facendo un confronto con Futurama, a differenza di Fry che è tonto ma buono e si trova spesso in situazioni spiacevoli non per colpa sua, questa principessa sembra ricercare le proprie sciagure per combattere la noia. Anche il suo alcolismo, se pure non viene rappresentato come un problema serio ma solo una forma di evasione, non contribuisce a farla risultare simpatica. E se è sempre vero che un protagonsita non deve essere necessariamente simpatico, è comunque importante che lo spettatore sia interessato ai suoi problemi e tifi per lui nei conflitti. Purtroppo non è così.I personaggi principali. Oltre alla protagonista, c'è qualche problema anche con gli altri comprimari. Del trio principale, forse solo Elfo ha personalità e uno sviluppo narrativo ben definito e condivisibile. Il suo interesse romantico ber Bean forse è un po' forzato, ma si può accettare. Il demonietto Luci invece non ha un ruolo altrettanto chiaro: inviato come dono da stregoni sconosciuti, dovrebbe essere il demone personale di Bean e portarla sulla strada del male, ma nella maggior parte dei casi si rivela essere la voce della ragione. È sicuramente il più intelligente e pratico del gruppo, oltre ad avere una serie di poteri che possono tornare comodi molto spesso. Credo che il paragone con Bender sia scontato: il personaggio "negativo" che non fa mistero della sua cattiveria e ostenta i suoi vizi. Con la differenza che mentre Bendere, coerentemente con questa caratterizzazione, spesso causa problemi agli altri e se stesso, Luci invece li risolve. Poi abbiamo il già citato Re Zog, che dovrebbe essere in qualche modo un antagonista ma a ben vedere è un povero diavolo: ha perso l'unico amore della sua vita (la madre di Bean), è stato costretto a un matrimonio politico per terminare una guerra e in fin dei conti nemmeno avrebbe dovuto diventare re. Insomma, va bene sovvertire gli archetipi, ma qui sono proprio le funzioni narrative che non combaciano perfettamente e rendono la storia squilibrata.Il sense of wonder. Dov'è? Da una serie fantasy ci si aspetta un buon livello di worldbuiling, tante invenzioni e ambientazioni e idee che ispirino meraviglia. Invece tutto Disenchantment si appoggia fin troppo su cliché e topoi del fantasy epico più commerciale, dalle creature mitologiche alle quest, dalla magia alle mappe. Certamente tutto è reinterpretato in chiave parodistica, come già faceva Futurama per i cliché della fantascienza, ma non c'è davvero un'invenzione che sia una. Il sangue di elfo come elisir di vita? Già visto. Il villaggio degli elfi come catena di montaggo di dolciumi? Praticamente uguale ai nettuniani di Futurama che lavorano nella fabbrica di babbo natale, anche nell'aspetto. Il gigante buono? Il cacciatore di demoni? I barbari invasori? Check. Check. Check. L'unica idea che ho trovato minimamente originale è la nazione di umani-anfibi, dove vengono fori anche alcune simpatiche trovate nell'ambientazione. Ma lo sforzo è proprio ai minimi.Animazione e musica. Non sono un super esperto, ma mi pare che scarseggi qualcosa a livello di animazione, soprattutto nelle scene d'azione. Ovvio, in questo senso lo stile di Groening non brilla né ne I Simpson né in Futurama, eppure mi è sembrato che non ci sia stato nessun miglioramento nonostante i decenni di innovazione tecnologica. La sovrapposizione tra 2D e 3D c'era già in Futurama (e all'epoca era davvero innovativa), per il resto niente da notare. E la colonna sonora, in generae, non sembra accompagnare né sottolineare in maniera adeguata ciò che avviene. L'esempio più lampante è la sequenza della rissa nella taverna del primo episodio: una scena che dovrebbe essere caotica e concitata risulta del tutto piatta, senza tensione.L'umorismo. Alla fine dei conti ho riso poco. Questo può essere un mio problema, perché chiaramente ognuno è più sensibile a un certo tipo di umorismo, e per me quello scientifico/assurdo di Futurama è il più efficace. Però in generale mi sembra che non si va oltre le situazioni da sitcom, con poche gag visive (che sono quelle che a posteriori rendono di più) e tante battute prevedibili. Apprezzo però che si faccia poco affidamento sulle battute basate sulla cultura pop, quindi riferimenti all'attualità, dalla politica allo spettacolo. Questo è quello che ha rovinato I Simpson ed è bene starne lontani quanto possibile.
 In definitiva, Disincanto per me è un prodotto non del tutto riuscito. Tutto sommato gradevole, ma che non lascia un segno. C'è da dire che la storia vista in questa prima stagione è incompleta, e anzi finisce con vari cliffhanger (sono già in produzione i dieci episodi della stagione due, poi si vedrà). Può darsi quindi che nel prosieguo della storia alcuni punti della trama diano maggior spessore ai personaggi, ad esempio la missione di Luci. Allo stato attuale però, ci troviamo di fronte a qualcosa di incompleto.
In definitiva, Disincanto per me è un prodotto non del tutto riuscito. Tutto sommato gradevole, ma che non lascia un segno. C'è da dire che la storia vista in questa prima stagione è incompleta, e anzi finisce con vari cliffhanger (sono già in produzione i dieci episodi della stagione due, poi si vedrà). Può darsi quindi che nel prosieguo della storia alcuni punti della trama diano maggior spessore ai personaggi, ad esempio la missione di Luci. Allo stato attuale però, ci troviamo di fronte a qualcosa di incompleto.Non sono sicuro se seguirò la seconda stagione o se Disincanto finirà tra le serie che ho smesso di vedere. Credo che guarderò almeno i primi episodi per scoprire come hanno risolto i cliffhanger, in particolare quello di Elfo e Luci (di Bean ho già detto che mi importa poco?), e se la risoluzione mi sembrerà inadeguata, potrei mollare. Nel complesso comunque non mi sento di scoraggiare la visione, ma di certo tenere le aspettative basse.
In alternativa, c'è sempre la possiblità di recuperare Futurama.
Published on August 21, 2018 01:34
August 14, 2018
Rapporto letture - Luglio 2018
A luglio siamo tornati a una media regolare di letture, anche se in generale le pagine consumate sono meno del solito per via del caldo che spezza la voglia di leggere, almeno a me.
 Il primo libro che ho letto è The Separation di Christopher Priest. Un romanzo che stavolta non si colloca nel macrocontesto del Dream Archipelago ma è una storia a sé, ambientata all'epoca della Seconda Guerra Mondiale. È la storia di due gemelli londinesi, Jack e Joe Sawyer, che partecipano come canottieri alle Olimpiadi di Berlino del 1936 e in seguito sono coinvolti nella guerra, uno come pilota della RAF e l'altro come autista di ambulanze per la Croce Rossa. Ma la storia non procede in modo lineare. Ci sono infatti linee temporali diverse che si sovrappongono (una è quella che conosciamo, nell'altra l'Inghilterra ha fatto un accordo di pace con la Germania nel 1941), e come accade spesso in molti lavori di Priest, si gioca con sosia e doppleganger, non solo per i due gemelli ma anche per altri personaggi centrali della storia, come Rudolf Hess e Winston Churchill. La storia viene raccontata due volte, prima da parte del pilota e poi dell'autista, ma si tratta di storie in universi differenti, che però si toccano e si intrecciano, pur rimanendo separati. Alla fine della lettura però mi sono sentito in qualche modo insoddisfatto: non tanto perché la vicenda non segue un percorso chiaro (cosa che ho già imparato ad apprezzare in Priest), quanto perché sembri che manchi una vera chiusura. Tutto il racconto dei fratelli è inserito in una cornice narrativa dove uno scrittore di romanzi storici dell'altro universo (quello in cui UK e Germania hanno siglato la pace) che trova il diario del pilota che racconta la storia del nostro universo. A metà del libro troviamo ancora lo scrittore, ma poi il romanzo si conclude con il diario dell'autista, tratto in parte da archivi di musei oggi inesistenti, e non si sa più nulla dello scrittore. Ho avuto addirittura il sospetto che il mio ebook fosse difettoso e mancassero dei capitoli, il che non può essere una buona sensazione. Probabilmente se fossi stato più esperto del periodo della WWII avrei potuto cogliere molti più dettagli, ad esempio a proposito di Hess e del suo piano di pace con gli inglesi non approvato da Hitler, ma la storia di per sé mi è parsa incompleta al di là dei livelli di interpretazione allegorica. Pertanto per la prima volta devo dire che un romanzo di Christopher Priest mi è "soltanto piaciuto". Voto: 6/10
Il primo libro che ho letto è The Separation di Christopher Priest. Un romanzo che stavolta non si colloca nel macrocontesto del Dream Archipelago ma è una storia a sé, ambientata all'epoca della Seconda Guerra Mondiale. È la storia di due gemelli londinesi, Jack e Joe Sawyer, che partecipano come canottieri alle Olimpiadi di Berlino del 1936 e in seguito sono coinvolti nella guerra, uno come pilota della RAF e l'altro come autista di ambulanze per la Croce Rossa. Ma la storia non procede in modo lineare. Ci sono infatti linee temporali diverse che si sovrappongono (una è quella che conosciamo, nell'altra l'Inghilterra ha fatto un accordo di pace con la Germania nel 1941), e come accade spesso in molti lavori di Priest, si gioca con sosia e doppleganger, non solo per i due gemelli ma anche per altri personaggi centrali della storia, come Rudolf Hess e Winston Churchill. La storia viene raccontata due volte, prima da parte del pilota e poi dell'autista, ma si tratta di storie in universi differenti, che però si toccano e si intrecciano, pur rimanendo separati. Alla fine della lettura però mi sono sentito in qualche modo insoddisfatto: non tanto perché la vicenda non segue un percorso chiaro (cosa che ho già imparato ad apprezzare in Priest), quanto perché sembri che manchi una vera chiusura. Tutto il racconto dei fratelli è inserito in una cornice narrativa dove uno scrittore di romanzi storici dell'altro universo (quello in cui UK e Germania hanno siglato la pace) che trova il diario del pilota che racconta la storia del nostro universo. A metà del libro troviamo ancora lo scrittore, ma poi il romanzo si conclude con il diario dell'autista, tratto in parte da archivi di musei oggi inesistenti, e non si sa più nulla dello scrittore. Ho avuto addirittura il sospetto che il mio ebook fosse difettoso e mancassero dei capitoli, il che non può essere una buona sensazione. Probabilmente se fossi stato più esperto del periodo della WWII avrei potuto cogliere molti più dettagli, ad esempio a proposito di Hess e del suo piano di pace con gli inglesi non approvato da Hitler, ma la storia di per sé mi è parsa incompleta al di là dei livelli di interpretazione allegorica. Pertanto per la prima volta devo dire che un romanzo di Christopher Priest mi è "soltanto piaciuto". Voto: 6/10
 Cambiamo decisamente genere, contesto e prodotto, passando a una raccolta di racconti di un giovane autore italiano. Lorenzo Crescentini si è sentito nominare diverse volte negli ultimi anni nell'ambiente della sf italiana, appunto per i suoi racconti pubblicati e per il coinvolgimento in vari progetti (è ad esempio il curatore di
Dinosauria
). Animali è un'antologia che include racconti di genere diverso, da fantascienza a weird e horror. Si tratta probabilmente di racconti scritti in momenti diversi della carriera dell'autore perché si può rilevare qualche differenza nella maturità della scrittura tra una storia e l'altra. Per la maggior parte si tratta di racconti "plot heavy" in cui un'idea principale viene sviluppata fino alle sue conseguenze più estreme. Per la verità non ci sono spunti di originalità straordinaria, e forse per questo i lavori più validi sono quelli in cui oltre allo sviluppo dell'idea in sé si assiste anche a un'evoluzione dei personaggi. Tra i lavori migliori si possono includere Un'introduzione alla meccanica delle cronofaglie (l'idea di fondo mi ha ricordato la Terra spezzettata in segmenti temporali de L'occhio del tempo di Clarke e Baxter), I corridori (che avevo già letto su un numero di Robot), La cosa che non è sua madre (qualche affinità con Babadook), L'arca (dove ho trovato alcune affinità con la serie della Torre Nera di King o anche con Paradox di Massimo Spiga). Altri mi sono sembrati meno riusciti, ad esempio tutta la serie di Impresa Nuova Vita dove il tentativo di storie leggere dal tratto umoristico non ha funzionato del tutto. Una cosa interessante è notare come alcune storie sono tra loro collegate, a volte anche solo grazie a una singola frase che le colloca in un unico universo narrativo. Sono piccoli easter egg che danno un diverso senso di proporzioni e possono far pensare a un futuro fix-up di alcune storie, come forse già in parte è L'arca. In generale comunque la qualità è buona, ma c'è margine di miglioramento, soprattutto se si insiste nella direzione delle storie orientate ai personaggi, che sono quelle che riescono a coinvolgere e rimanere di più. Voto: 7/10
Cambiamo decisamente genere, contesto e prodotto, passando a una raccolta di racconti di un giovane autore italiano. Lorenzo Crescentini si è sentito nominare diverse volte negli ultimi anni nell'ambiente della sf italiana, appunto per i suoi racconti pubblicati e per il coinvolgimento in vari progetti (è ad esempio il curatore di
Dinosauria
). Animali è un'antologia che include racconti di genere diverso, da fantascienza a weird e horror. Si tratta probabilmente di racconti scritti in momenti diversi della carriera dell'autore perché si può rilevare qualche differenza nella maturità della scrittura tra una storia e l'altra. Per la maggior parte si tratta di racconti "plot heavy" in cui un'idea principale viene sviluppata fino alle sue conseguenze più estreme. Per la verità non ci sono spunti di originalità straordinaria, e forse per questo i lavori più validi sono quelli in cui oltre allo sviluppo dell'idea in sé si assiste anche a un'evoluzione dei personaggi. Tra i lavori migliori si possono includere Un'introduzione alla meccanica delle cronofaglie (l'idea di fondo mi ha ricordato la Terra spezzettata in segmenti temporali de L'occhio del tempo di Clarke e Baxter), I corridori (che avevo già letto su un numero di Robot), La cosa che non è sua madre (qualche affinità con Babadook), L'arca (dove ho trovato alcune affinità con la serie della Torre Nera di King o anche con Paradox di Massimo Spiga). Altri mi sono sembrati meno riusciti, ad esempio tutta la serie di Impresa Nuova Vita dove il tentativo di storie leggere dal tratto umoristico non ha funzionato del tutto. Una cosa interessante è notare come alcune storie sono tra loro collegate, a volte anche solo grazie a una singola frase che le colloca in un unico universo narrativo. Sono piccoli easter egg che danno un diverso senso di proporzioni e possono far pensare a un futuro fix-up di alcune storie, come forse già in parte è L'arca. In generale comunque la qualità è buona, ma c'è margine di miglioramento, soprattutto se si insiste nella direzione delle storie orientate ai personaggi, che sono quelle che riescono a coinvolgere e rimanere di più. Voto: 7/10
 Infine ho letto un libro di quelli che quando li hai finiti ti chiedi come hai fatto a non averli letti prima: Nova di Samuel Delany. Non mi era capitato per le mani prima della ripubblicazione di Urania di qualche mese fa (insieme a Einsetin Perduto che avevo già letto tempo fa come
Una favolosa tenebra informe
). Nova è un romanzo scritto negli anni 60, la lingua, la storia e i personaggi sono talmente vivi e coinvolgenti che il peso dei decenni non si sente affatto, a differenza di tanti altri romanzi di sf di quell'epoca. La vicenda potrà anche non essere scientificamente rigorosa o completamente coerente (in un paio di occasioni mi sono chiesto perché succedesse una certa cosa), ma lo sviluppo è talmente efficace che ci si passa sopra. In cima a tutto, c'è anche una gustosa trama laterale sulla funzione e il valore del romanzo come forma d'arte, affidata a uno dei personaggi principali e che va poi a chiudere in modo inaspettato l'intero libro. L'universo e i personaggi di questo romanzo sono indimenticabili, ed è un peccato che la loro storia si limiti a queste poche pagine, ma d'altra parte è proprio quello il senso di un romanzo, come appunto ci viene spiegato. Credo che letto in lingua originale sarebbe stato anche meglio, perché la lingua e i dialetti presenti hanno un ruolo centrale e probabilmente non erano facili da trasporre, comunque anche questa traduzione riesce a mantenere una certa "letterarietà". Delany è un autore giustamente considerato tra i più talentuosi della fantascienza e questo libro ne è ulteriore dimostrazione. Voto: 9/10
Infine ho letto un libro di quelli che quando li hai finiti ti chiedi come hai fatto a non averli letti prima: Nova di Samuel Delany. Non mi era capitato per le mani prima della ripubblicazione di Urania di qualche mese fa (insieme a Einsetin Perduto che avevo già letto tempo fa come
Una favolosa tenebra informe
). Nova è un romanzo scritto negli anni 60, la lingua, la storia e i personaggi sono talmente vivi e coinvolgenti che il peso dei decenni non si sente affatto, a differenza di tanti altri romanzi di sf di quell'epoca. La vicenda potrà anche non essere scientificamente rigorosa o completamente coerente (in un paio di occasioni mi sono chiesto perché succedesse una certa cosa), ma lo sviluppo è talmente efficace che ci si passa sopra. In cima a tutto, c'è anche una gustosa trama laterale sulla funzione e il valore del romanzo come forma d'arte, affidata a uno dei personaggi principali e che va poi a chiudere in modo inaspettato l'intero libro. L'universo e i personaggi di questo romanzo sono indimenticabili, ed è un peccato che la loro storia si limiti a queste poche pagine, ma d'altra parte è proprio quello il senso di un romanzo, come appunto ci viene spiegato. Credo che letto in lingua originale sarebbe stato anche meglio, perché la lingua e i dialetti presenti hanno un ruolo centrale e probabilmente non erano facili da trasporre, comunque anche questa traduzione riesce a mantenere una certa "letterarietà". Delany è un autore giustamente considerato tra i più talentuosi della fantascienza e questo libro ne è ulteriore dimostrazione. Voto: 9/10
 Il primo libro che ho letto è The Separation di Christopher Priest. Un romanzo che stavolta non si colloca nel macrocontesto del Dream Archipelago ma è una storia a sé, ambientata all'epoca della Seconda Guerra Mondiale. È la storia di due gemelli londinesi, Jack e Joe Sawyer, che partecipano come canottieri alle Olimpiadi di Berlino del 1936 e in seguito sono coinvolti nella guerra, uno come pilota della RAF e l'altro come autista di ambulanze per la Croce Rossa. Ma la storia non procede in modo lineare. Ci sono infatti linee temporali diverse che si sovrappongono (una è quella che conosciamo, nell'altra l'Inghilterra ha fatto un accordo di pace con la Germania nel 1941), e come accade spesso in molti lavori di Priest, si gioca con sosia e doppleganger, non solo per i due gemelli ma anche per altri personaggi centrali della storia, come Rudolf Hess e Winston Churchill. La storia viene raccontata due volte, prima da parte del pilota e poi dell'autista, ma si tratta di storie in universi differenti, che però si toccano e si intrecciano, pur rimanendo separati. Alla fine della lettura però mi sono sentito in qualche modo insoddisfatto: non tanto perché la vicenda non segue un percorso chiaro (cosa che ho già imparato ad apprezzare in Priest), quanto perché sembri che manchi una vera chiusura. Tutto il racconto dei fratelli è inserito in una cornice narrativa dove uno scrittore di romanzi storici dell'altro universo (quello in cui UK e Germania hanno siglato la pace) che trova il diario del pilota che racconta la storia del nostro universo. A metà del libro troviamo ancora lo scrittore, ma poi il romanzo si conclude con il diario dell'autista, tratto in parte da archivi di musei oggi inesistenti, e non si sa più nulla dello scrittore. Ho avuto addirittura il sospetto che il mio ebook fosse difettoso e mancassero dei capitoli, il che non può essere una buona sensazione. Probabilmente se fossi stato più esperto del periodo della WWII avrei potuto cogliere molti più dettagli, ad esempio a proposito di Hess e del suo piano di pace con gli inglesi non approvato da Hitler, ma la storia di per sé mi è parsa incompleta al di là dei livelli di interpretazione allegorica. Pertanto per la prima volta devo dire che un romanzo di Christopher Priest mi è "soltanto piaciuto". Voto: 6/10
Il primo libro che ho letto è The Separation di Christopher Priest. Un romanzo che stavolta non si colloca nel macrocontesto del Dream Archipelago ma è una storia a sé, ambientata all'epoca della Seconda Guerra Mondiale. È la storia di due gemelli londinesi, Jack e Joe Sawyer, che partecipano come canottieri alle Olimpiadi di Berlino del 1936 e in seguito sono coinvolti nella guerra, uno come pilota della RAF e l'altro come autista di ambulanze per la Croce Rossa. Ma la storia non procede in modo lineare. Ci sono infatti linee temporali diverse che si sovrappongono (una è quella che conosciamo, nell'altra l'Inghilterra ha fatto un accordo di pace con la Germania nel 1941), e come accade spesso in molti lavori di Priest, si gioca con sosia e doppleganger, non solo per i due gemelli ma anche per altri personaggi centrali della storia, come Rudolf Hess e Winston Churchill. La storia viene raccontata due volte, prima da parte del pilota e poi dell'autista, ma si tratta di storie in universi differenti, che però si toccano e si intrecciano, pur rimanendo separati. Alla fine della lettura però mi sono sentito in qualche modo insoddisfatto: non tanto perché la vicenda non segue un percorso chiaro (cosa che ho già imparato ad apprezzare in Priest), quanto perché sembri che manchi una vera chiusura. Tutto il racconto dei fratelli è inserito in una cornice narrativa dove uno scrittore di romanzi storici dell'altro universo (quello in cui UK e Germania hanno siglato la pace) che trova il diario del pilota che racconta la storia del nostro universo. A metà del libro troviamo ancora lo scrittore, ma poi il romanzo si conclude con il diario dell'autista, tratto in parte da archivi di musei oggi inesistenti, e non si sa più nulla dello scrittore. Ho avuto addirittura il sospetto che il mio ebook fosse difettoso e mancassero dei capitoli, il che non può essere una buona sensazione. Probabilmente se fossi stato più esperto del periodo della WWII avrei potuto cogliere molti più dettagli, ad esempio a proposito di Hess e del suo piano di pace con gli inglesi non approvato da Hitler, ma la storia di per sé mi è parsa incompleta al di là dei livelli di interpretazione allegorica. Pertanto per la prima volta devo dire che un romanzo di Christopher Priest mi è "soltanto piaciuto". Voto: 6/10
 Cambiamo decisamente genere, contesto e prodotto, passando a una raccolta di racconti di un giovane autore italiano. Lorenzo Crescentini si è sentito nominare diverse volte negli ultimi anni nell'ambiente della sf italiana, appunto per i suoi racconti pubblicati e per il coinvolgimento in vari progetti (è ad esempio il curatore di
Dinosauria
). Animali è un'antologia che include racconti di genere diverso, da fantascienza a weird e horror. Si tratta probabilmente di racconti scritti in momenti diversi della carriera dell'autore perché si può rilevare qualche differenza nella maturità della scrittura tra una storia e l'altra. Per la maggior parte si tratta di racconti "plot heavy" in cui un'idea principale viene sviluppata fino alle sue conseguenze più estreme. Per la verità non ci sono spunti di originalità straordinaria, e forse per questo i lavori più validi sono quelli in cui oltre allo sviluppo dell'idea in sé si assiste anche a un'evoluzione dei personaggi. Tra i lavori migliori si possono includere Un'introduzione alla meccanica delle cronofaglie (l'idea di fondo mi ha ricordato la Terra spezzettata in segmenti temporali de L'occhio del tempo di Clarke e Baxter), I corridori (che avevo già letto su un numero di Robot), La cosa che non è sua madre (qualche affinità con Babadook), L'arca (dove ho trovato alcune affinità con la serie della Torre Nera di King o anche con Paradox di Massimo Spiga). Altri mi sono sembrati meno riusciti, ad esempio tutta la serie di Impresa Nuova Vita dove il tentativo di storie leggere dal tratto umoristico non ha funzionato del tutto. Una cosa interessante è notare come alcune storie sono tra loro collegate, a volte anche solo grazie a una singola frase che le colloca in un unico universo narrativo. Sono piccoli easter egg che danno un diverso senso di proporzioni e possono far pensare a un futuro fix-up di alcune storie, come forse già in parte è L'arca. In generale comunque la qualità è buona, ma c'è margine di miglioramento, soprattutto se si insiste nella direzione delle storie orientate ai personaggi, che sono quelle che riescono a coinvolgere e rimanere di più. Voto: 7/10
Cambiamo decisamente genere, contesto e prodotto, passando a una raccolta di racconti di un giovane autore italiano. Lorenzo Crescentini si è sentito nominare diverse volte negli ultimi anni nell'ambiente della sf italiana, appunto per i suoi racconti pubblicati e per il coinvolgimento in vari progetti (è ad esempio il curatore di
Dinosauria
). Animali è un'antologia che include racconti di genere diverso, da fantascienza a weird e horror. Si tratta probabilmente di racconti scritti in momenti diversi della carriera dell'autore perché si può rilevare qualche differenza nella maturità della scrittura tra una storia e l'altra. Per la maggior parte si tratta di racconti "plot heavy" in cui un'idea principale viene sviluppata fino alle sue conseguenze più estreme. Per la verità non ci sono spunti di originalità straordinaria, e forse per questo i lavori più validi sono quelli in cui oltre allo sviluppo dell'idea in sé si assiste anche a un'evoluzione dei personaggi. Tra i lavori migliori si possono includere Un'introduzione alla meccanica delle cronofaglie (l'idea di fondo mi ha ricordato la Terra spezzettata in segmenti temporali de L'occhio del tempo di Clarke e Baxter), I corridori (che avevo già letto su un numero di Robot), La cosa che non è sua madre (qualche affinità con Babadook), L'arca (dove ho trovato alcune affinità con la serie della Torre Nera di King o anche con Paradox di Massimo Spiga). Altri mi sono sembrati meno riusciti, ad esempio tutta la serie di Impresa Nuova Vita dove il tentativo di storie leggere dal tratto umoristico non ha funzionato del tutto. Una cosa interessante è notare come alcune storie sono tra loro collegate, a volte anche solo grazie a una singola frase che le colloca in un unico universo narrativo. Sono piccoli easter egg che danno un diverso senso di proporzioni e possono far pensare a un futuro fix-up di alcune storie, come forse già in parte è L'arca. In generale comunque la qualità è buona, ma c'è margine di miglioramento, soprattutto se si insiste nella direzione delle storie orientate ai personaggi, che sono quelle che riescono a coinvolgere e rimanere di più. Voto: 7/10
 Infine ho letto un libro di quelli che quando li hai finiti ti chiedi come hai fatto a non averli letti prima: Nova di Samuel Delany. Non mi era capitato per le mani prima della ripubblicazione di Urania di qualche mese fa (insieme a Einsetin Perduto che avevo già letto tempo fa come
Una favolosa tenebra informe
). Nova è un romanzo scritto negli anni 60, la lingua, la storia e i personaggi sono talmente vivi e coinvolgenti che il peso dei decenni non si sente affatto, a differenza di tanti altri romanzi di sf di quell'epoca. La vicenda potrà anche non essere scientificamente rigorosa o completamente coerente (in un paio di occasioni mi sono chiesto perché succedesse una certa cosa), ma lo sviluppo è talmente efficace che ci si passa sopra. In cima a tutto, c'è anche una gustosa trama laterale sulla funzione e il valore del romanzo come forma d'arte, affidata a uno dei personaggi principali e che va poi a chiudere in modo inaspettato l'intero libro. L'universo e i personaggi di questo romanzo sono indimenticabili, ed è un peccato che la loro storia si limiti a queste poche pagine, ma d'altra parte è proprio quello il senso di un romanzo, come appunto ci viene spiegato. Credo che letto in lingua originale sarebbe stato anche meglio, perché la lingua e i dialetti presenti hanno un ruolo centrale e probabilmente non erano facili da trasporre, comunque anche questa traduzione riesce a mantenere una certa "letterarietà". Delany è un autore giustamente considerato tra i più talentuosi della fantascienza e questo libro ne è ulteriore dimostrazione. Voto: 9/10
Infine ho letto un libro di quelli che quando li hai finiti ti chiedi come hai fatto a non averli letti prima: Nova di Samuel Delany. Non mi era capitato per le mani prima della ripubblicazione di Urania di qualche mese fa (insieme a Einsetin Perduto che avevo già letto tempo fa come
Una favolosa tenebra informe
). Nova è un romanzo scritto negli anni 60, la lingua, la storia e i personaggi sono talmente vivi e coinvolgenti che il peso dei decenni non si sente affatto, a differenza di tanti altri romanzi di sf di quell'epoca. La vicenda potrà anche non essere scientificamente rigorosa o completamente coerente (in un paio di occasioni mi sono chiesto perché succedesse una certa cosa), ma lo sviluppo è talmente efficace che ci si passa sopra. In cima a tutto, c'è anche una gustosa trama laterale sulla funzione e il valore del romanzo come forma d'arte, affidata a uno dei personaggi principali e che va poi a chiudere in modo inaspettato l'intero libro. L'universo e i personaggi di questo romanzo sono indimenticabili, ed è un peccato che la loro storia si limiti a queste poche pagine, ma d'altra parte è proprio quello il senso di un romanzo, come appunto ci viene spiegato. Credo che letto in lingua originale sarebbe stato anche meglio, perché la lingua e i dialetti presenti hanno un ruolo centrale e probabilmente non erano facili da trasporre, comunque anche questa traduzione riesce a mantenere una certa "letterarietà". Delany è un autore giustamente considerato tra i più talentuosi della fantascienza e questo libro ne è ulteriore dimostrazione. Voto: 9/10
Published on August 14, 2018 08:11
August 8, 2018
Coppi Night 05/08/2018 - Regression
Le Coppi Night stanno subendo una battuta d'arresto, un po' per la stagione estiva che scoraggia cinque-sei persone a chiudersi per due ore in una stanza di otto metri quadri, un po' per questioni di disponibilità degli spazi. Anche quella del post attuale non è una Coppi Night vera e propria ma solo un film che mi sono visto a casa mia di domenica sera. Mi pare però il caso di approfittare per farne due parole, soprattutto per mettere in guardia l'ignaro lettore che potrebbe aver voglia di vedere questo film.
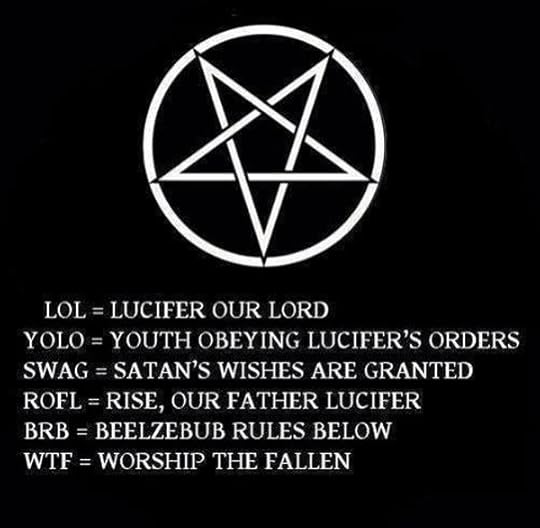 Come già ho avuto modo di dichiarare in altri post, non ho una considerazione rigida dello spoiler. Una storia (film/libro/quelchetipare) che può essere di fatto rovinata da uno spoiler ha probabilmente poco valore di per sé. A maggior ragione, una brutta storia necessita di essere spoilerata affinché si possa capire perché non merita il tempo che richiederebbe la sua fruizione. Quindi nel seguito del post, come ho già fatto con altri libri o film palesemente brutti, andrò libero con gli spoiler. Ma credetemi, vi sto facendo un favore.
Come già ho avuto modo di dichiarare in altri post, non ho una considerazione rigida dello spoiler. Una storia (film/libro/quelchetipare) che può essere di fatto rovinata da uno spoiler ha probabilmente poco valore di per sé. A maggior ragione, una brutta storia necessita di essere spoilerata affinché si possa capire perché non merita il tempo che richiederebbe la sua fruizione. Quindi nel seguito del post, come ho già fatto con altri libri o film palesemente brutti, andrò libero con gli spoiler. Ma credetemi, vi sto facendo un favore.
Regression parte come un'indagine su una violenza sessuale del detective protagnista (Ethan Hawke). È il padre della vittima (una Emma Watson che dovrebbe avere diciassette anni) a confessare e autoincriminarsi delle violenze. Dietro tutto questo però sembra esserci una rete di satanisti, che all'epoca andavano molto di moda. Per recuperare i ricordi che il padre e altri coinvolti nelle vicende (tra cui un collega poliziotto) sembrano non poter afferrare, viene assunto uno psichiatra che applica l'ipnosi regressiva: emergono così questi particolari truci e malefici. Il detective inizia a sospettare di tutti, ha incubi sulla setta satanica, e si aspetta di diventare la prossima vittima dei satanisti. Nel frattempo il suo rapporto con la ragazzina si approfondisce e attraversa anche qualche barriera deontologica. Salvo che poi si scopre che le cose non tornano, non c'è nessun satanista, e la Watson si è inventata tutto per far andare il padre in galera perché odia lui e tutta la sua famiglia. La regressione ipnotica è una puttanata che ha solo suggestionato la gente che ha confessato quello che il detective voleva che dicessero, i ricordi finti si sono autoalimentati e pure lui si è illuso di essere perseguitato quando nessuno se lo cagava. Wow, bel plot twist, a pensarci è un ribaltamento notevole, la vittima che diventa l'unico vero cattivo, gente innocente finita in carcere per accuse orribili solo per un suo capriccio e una tecnica investigativa viziata... però, no. Questa storia non regge. Perché nella prima scena del film, il padre va alla polizia e confessa. Dice testualmente "sì, sono stato io, però non me lo ricordo". E in quel momento, nell'ufficio ci sono solo lui, il detective e il superiore della polizia. Nessuno psichiatra, nessuna regressione o suggestione. Tutta l'indagine parte da lì, dal padre che per quanto ex alcolista, attuale fanatico religioso, e da sempre individuo fragile, non ha motivo di dire di aver violentato sua figlia se non l'ha fatto. In seguito si può credere che la falsa pista della regressione e le notizie sui giornali abbiano influenzato tutti, ma in quel preciso momento non esiste niente di tutto questo. Eppure tutta l'indagine parte da lì! Manca anche un'altra parte importante, tanto che ho pensato che qualche scena sia stata tagliata. Verso la fine c'è un confronto tra il detective e lo psichiatra: il primo accusa l'altro che le sue tecniche hanno portato a un'indagine falsata, il secondo ribatte che la sua è una scienza e non può sbagliare. E finisce lì. Non sappiamo se lo psichiatra stesse volutamente manipolando le sedute, se fosse troppo ansioso di dimostrare le sue capacità o banalmente inesperto. Quello che è il nucleo centrale della storia (tanto che gli dà il titolo) rimane irrisolto.
A tutto ciò si aggiunge il fatto che il film è di una lentezza estenuante, e totalmente piatto sotto tutti i punti di vista: regia anonima, recitazione (di tutti) senza guizzi, fotografia smorta, colonna sonora non pervenuta. Sembra davvero un film messo insieme senza che nessuno ne avesse davvero voglia. La tesina dell'esame di maturità che vabbè la devi fare per forza allora prendi degli stralci di wikipedia e gli cambi giusto la punteggiatura. Non c'è un attimo di tensione, niente che catturi l'attenzione. Persino il sogno erotico con Emma Watson nuda (che so farebbe la felicità di tanti fanboy) non suscita niente di quel che dovrebbe.
I veri satanisti avrebbero tutto il diritto di prendere le distanze da questo film che li dipinge come gente prevedibile, caricaturalmente cattiva (orge, omicidi, cannibalismo), e in fin dei conti soprattutto noiosa.
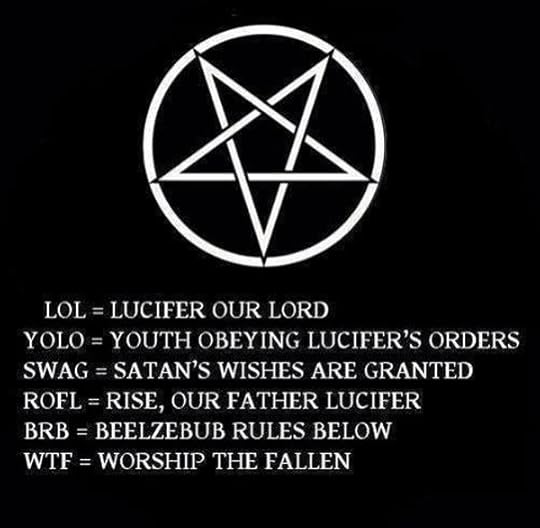 Come già ho avuto modo di dichiarare in altri post, non ho una considerazione rigida dello spoiler. Una storia (film/libro/quelchetipare) che può essere di fatto rovinata da uno spoiler ha probabilmente poco valore di per sé. A maggior ragione, una brutta storia necessita di essere spoilerata affinché si possa capire perché non merita il tempo che richiederebbe la sua fruizione. Quindi nel seguito del post, come ho già fatto con altri libri o film palesemente brutti, andrò libero con gli spoiler. Ma credetemi, vi sto facendo un favore.
Come già ho avuto modo di dichiarare in altri post, non ho una considerazione rigida dello spoiler. Una storia (film/libro/quelchetipare) che può essere di fatto rovinata da uno spoiler ha probabilmente poco valore di per sé. A maggior ragione, una brutta storia necessita di essere spoilerata affinché si possa capire perché non merita il tempo che richiederebbe la sua fruizione. Quindi nel seguito del post, come ho già fatto con altri libri o film palesemente brutti, andrò libero con gli spoiler. Ma credetemi, vi sto facendo un favore.Regression parte come un'indagine su una violenza sessuale del detective protagnista (Ethan Hawke). È il padre della vittima (una Emma Watson che dovrebbe avere diciassette anni) a confessare e autoincriminarsi delle violenze. Dietro tutto questo però sembra esserci una rete di satanisti, che all'epoca andavano molto di moda. Per recuperare i ricordi che il padre e altri coinvolti nelle vicende (tra cui un collega poliziotto) sembrano non poter afferrare, viene assunto uno psichiatra che applica l'ipnosi regressiva: emergono così questi particolari truci e malefici. Il detective inizia a sospettare di tutti, ha incubi sulla setta satanica, e si aspetta di diventare la prossima vittima dei satanisti. Nel frattempo il suo rapporto con la ragazzina si approfondisce e attraversa anche qualche barriera deontologica. Salvo che poi si scopre che le cose non tornano, non c'è nessun satanista, e la Watson si è inventata tutto per far andare il padre in galera perché odia lui e tutta la sua famiglia. La regressione ipnotica è una puttanata che ha solo suggestionato la gente che ha confessato quello che il detective voleva che dicessero, i ricordi finti si sono autoalimentati e pure lui si è illuso di essere perseguitato quando nessuno se lo cagava. Wow, bel plot twist, a pensarci è un ribaltamento notevole, la vittima che diventa l'unico vero cattivo, gente innocente finita in carcere per accuse orribili solo per un suo capriccio e una tecnica investigativa viziata... però, no. Questa storia non regge. Perché nella prima scena del film, il padre va alla polizia e confessa. Dice testualmente "sì, sono stato io, però non me lo ricordo". E in quel momento, nell'ufficio ci sono solo lui, il detective e il superiore della polizia. Nessuno psichiatra, nessuna regressione o suggestione. Tutta l'indagine parte da lì, dal padre che per quanto ex alcolista, attuale fanatico religioso, e da sempre individuo fragile, non ha motivo di dire di aver violentato sua figlia se non l'ha fatto. In seguito si può credere che la falsa pista della regressione e le notizie sui giornali abbiano influenzato tutti, ma in quel preciso momento non esiste niente di tutto questo. Eppure tutta l'indagine parte da lì! Manca anche un'altra parte importante, tanto che ho pensato che qualche scena sia stata tagliata. Verso la fine c'è un confronto tra il detective e lo psichiatra: il primo accusa l'altro che le sue tecniche hanno portato a un'indagine falsata, il secondo ribatte che la sua è una scienza e non può sbagliare. E finisce lì. Non sappiamo se lo psichiatra stesse volutamente manipolando le sedute, se fosse troppo ansioso di dimostrare le sue capacità o banalmente inesperto. Quello che è il nucleo centrale della storia (tanto che gli dà il titolo) rimane irrisolto.
A tutto ciò si aggiunge il fatto che il film è di una lentezza estenuante, e totalmente piatto sotto tutti i punti di vista: regia anonima, recitazione (di tutti) senza guizzi, fotografia smorta, colonna sonora non pervenuta. Sembra davvero un film messo insieme senza che nessuno ne avesse davvero voglia. La tesina dell'esame di maturità che vabbè la devi fare per forza allora prendi degli stralci di wikipedia e gli cambi giusto la punteggiatura. Non c'è un attimo di tensione, niente che catturi l'attenzione. Persino il sogno erotico con Emma Watson nuda (che so farebbe la felicità di tanti fanboy) non suscita niente di quel che dovrebbe.
I veri satanisti avrebbero tutto il diritto di prendere le distanze da questo film che li dipinge come gente prevedibile, caricaturalmente cattiva (orge, omicidi, cannibalismo), e in fin dei conti soprattutto noiosa.
Published on August 08, 2018 09:20
July 29, 2018
Rivedere i film da adulti
Non vorrei che il titolo di questo post fosse letto con l'enfasi sbagliata: non si parla di "film da adulti", di quelli che danno dalle 22 in poi su Cielo, ma di film di qualsiasi genere, rivisti in età adulta.
Tutti abbiamo dei film che da bambini/ragazzini abbiamo visto e rivisto fino a imparare le battute a memoria. O almeno, tutti quelli fino alla mia generazione. Non so le leve da 2000 in poi come se la passano in questo senso, per dire, non so nemmeno se capiscono le citazioni dei Simpson che per me fanno parte del patrimonio culturale dell'umanità, ma questo è un altro discorso. Partiamo dall'assunto che esistono dei film che conosciamo alla perfezione, immagine per immagine, parola per parola, nota per nota. Quelli che quando avevamo otto, dieci, dodici anni continuavamo a riavvolgere e rivedere fino a smagnetizzare il nastro delle VHS. Il punto è: li conosciamo davvero, quei film?
Mi è capitato in tempi recenti di rivedere alcuni di questi film iconici della mia infanzia. E nonostante, appunto, conoscessi perfettamente il loro svolgimento mentre mi si presentava davanti, riguardandoli li ho capiti in modo del tutto diverso. Mi si sono presentati una serie di temi e significati che forse proprio in ragione della mia giovinezza non avevo colto. Facciamo un esempio pratico con tre di questi, sono film della metà degli anni 90 che hanno avuto un buon successo e sono ormai considerati dei cult: Jurassic Park, Jumanji, Independence Day.
Con Jurassic Park forse è più facile. Quando sei un ragazzino vedi i mostri, vedi gli inseguimenti e i raptor furbi come gatti. Questo è tutto quanto ti serve a farti contento, ed è ragione sufficiente a premere replay over and over. Ma rivisto adesso, con gli occhi di un adulto, noti che i dinosauri non sono il centro tematico della storia. Non sono nemmeno il vero nemico. Certo bisogna essere piuttosto superficiali per non capirlo, visto che ci sono una serie di battute che rendono la cosa piuttosto esplicita, durante il primo pranzo degli ospiti al parco, quando tutti gli invitati di Hammond si oppongono al suo progetto. Il tema è quello dell'illusione del controllo, di come sia facile credere di avere un potere sul mondo (animali, persone, eventi naturali) che invece può sgretolarsi in pochi istanti. La mancanza di controllo si manifesta da subito, quando durante il giro inaugurale i dinosauri non si mostrano ai visitatori, e in seguito la tempesta peggiora la situazione. Abbiamo poi il sabotatore interno all'azienda, un altro esempio di sottovalutazione, soprattutto per via della sua indispensabilità nella gestione del parco. Poi naturalmente i dinosauri, che non sono pericolosi in quanto "mostri", ma solo perché sono creature imprevedibili, di cui non sappiamo anticipare il comportamento nel mondo in cui si trovano. E poi si scopre che, ops!, anche il sistema di controllo sulla loro riproduzione non funziona. Nella seconda conversazione durante un pasto tra la dottoressa Sattler e John Hammond, il concetto viene ribadito, e si arriva alla conclusione che il controllo si può ottenere solo come illusione: era possibile forse al circo delle pulci, che era di per sé un'illusione, ma altrimenti non c'è modo di ottenerlo. Sarebbe semplicistico limitare la lezione di Jurassic Park a un monito contro i rischi della scienza. Certo, anche questo rientra nel tema, ma il film non è una parabola luddista. È l'arroganza umana, in termini più generici, a essere sotto accusa, perché tutti, protagonisti e anatagonisti, ne soffrono e tutti devono confrontarsi con essa, uscendone in modo tragico o vittorioso.
Passiamo a Jumanji . Ne ho parlato tempo fa quando è stato visto durante una Coppi Night, quindi posso rimandare anche a quel post per riprendere la mia interpretazione adulta della storia. Riassumendo, quella che si configura come un'avventura fantasy anche in questo caso con mostri e inseguimenti, funziona a un altro livello come metafora del rapporto tra genitori e figli. Lo vediamo fin da subito: il giovane Alan Parrish subisce la disciplina ferrea del padre e da questa cerca di sfuggire... salvo poi rimanere intrappolato nel gioco. Dall'altra parte, i due ragazzini degli anni 90 che riscoprono Jumanji sono orfani, ed entrambi elaborano il lutto convincendosi di aver avuto genitori terribili. Quando poi Alan torna nella civiltà, si accorgerà di usare con il piccolo Peter le stesse odiose parole che suo padre rivolgeva a lui. Ed è emblematico il fatto che il cacciatore della giungla che esce dal gioco per uccidere Alan è interpretato dallo stesso attore di suo padre (cosa che all'epoca non avevo notato).
Il caso di Independece Day è più complesso. Perché è un disaster movie dei più classici, quello che ha consacrato Roland Emmerich tra i registi più fracassoni del secolo, e una di quelle storie in cui il big american dream salva il mondo, perché chi altri può farlo? Pare difficile trovare un senso remoto in un film del genere, che è fatto apposta per spegnere il cervello e godere della distruzioni di quei cazzo di alieni tentacolati, tornatene a casa vostra EARTH FIRST!!! Eppure, a ben guardare, anche qui c'è un tema meno evidente, e lo si nota seguendo con più attenzione il background dei protagonisti. Il presidente (Bill Pullman), il pilota (Will Smith) e lo scienziato (Jeff Goldblum, anche qui) sono tutti dei falliti: sicuramente sono capaci, appassionati, ma non vengono presi sul serio. Lo scienziato viene considerato un paranoico, fissato per la tutela dell'ambiente, è stato mollato dalla moglie e non se ne fa una ragione; il pilota vorrebbe avanare di carriera per diventare astronauta ma viene continuamente scartato, e si è invischiato in una relazione con una stripper single-mother che non lo aiuterà; il presidente è accusato di inesperienza, non è al corrente degli affari della sua Nazione (non sa niente dell'Area 51) e viene continuamente scavalcato nelle decisioni dai suoi sottoposti: lo si vede bene nelle prime scene, in cui sono i suoi segretari a decidere come affrontare la minaccia, contraddicendolo apertamente. Anche l'ubriacone reduce del Vietnam che racconta di essere stato rapito si rivela alla fine come l'eroe determinante per la sopravvivenza dell'umanità. Ecco il tema nascosto, dietro gli abbagli dei laser ed esplosioni: la storia fatta dai numeri due, quelli che sono messi da parte perché reputati inadatti al loro ruolo. Certo questo non basta a fare di Independence Day un'opera di utilità sociale, ma contribuisce quanto meno a rendere la storia più avvincente.
Di seguito a questa riflessione, mi pare di vedere che questo secondo livello di interpretazione è quello che spesso manca nei sequel. Non ho visto il recente Jumanji quindi non parlo di quello, ma tutti i sequel di Jurassic Park (incluso il terribile Jurassic World , e non ho avuto ancora la forza di vedere Fallen Kingdom) e pure Independence Day Resurgence sembrano capaci di cogliere solo l'aspetto superficiale di queste storie, e non aggiungere nessun approfondimento, che poi non deve necessariamente essere lo stesso ma anche un tema diverso capace di dare più profondità alla storia e allo sviluppo dei personaggi. Invece no, come afferma il sempre profetico professor Ian Malcolm: "Siete saliti sulle spalle di altri per raggiungere questo risultato, e ora lo avete impacchettato e volete venderlo."
Conclusa la parentesi old man yells at people, vi invito a riprendere i film della vostra infanzia, quelli che siete convinti di conoscere alla perfezione, e rivederlo adesso, a distanza magari di vent'anni dall'ultima volta. Magari siete convinti di sapere tutto quello che contiene, ma come è successo a me potreste scoprire qualcosa, e apprezzarlo ancora di più. Ma occhio, non garantisco che sia una formula universale: può darsi anche che il vostro film preferito da bambini sia solo un film per bambini, e rivederlo distrugga i vostri dolci ricordi: i film di merda li sapevano fare allora come oggi. Procedete solo a vostro rischio, consapevoli di poter avere l'infanzia distrutta.
Tutti abbiamo dei film che da bambini/ragazzini abbiamo visto e rivisto fino a imparare le battute a memoria. O almeno, tutti quelli fino alla mia generazione. Non so le leve da 2000 in poi come se la passano in questo senso, per dire, non so nemmeno se capiscono le citazioni dei Simpson che per me fanno parte del patrimonio culturale dell'umanità, ma questo è un altro discorso. Partiamo dall'assunto che esistono dei film che conosciamo alla perfezione, immagine per immagine, parola per parola, nota per nota. Quelli che quando avevamo otto, dieci, dodici anni continuavamo a riavvolgere e rivedere fino a smagnetizzare il nastro delle VHS. Il punto è: li conosciamo davvero, quei film?
Mi è capitato in tempi recenti di rivedere alcuni di questi film iconici della mia infanzia. E nonostante, appunto, conoscessi perfettamente il loro svolgimento mentre mi si presentava davanti, riguardandoli li ho capiti in modo del tutto diverso. Mi si sono presentati una serie di temi e significati che forse proprio in ragione della mia giovinezza non avevo colto. Facciamo un esempio pratico con tre di questi, sono film della metà degli anni 90 che hanno avuto un buon successo e sono ormai considerati dei cult: Jurassic Park, Jumanji, Independence Day.
Con Jurassic Park forse è più facile. Quando sei un ragazzino vedi i mostri, vedi gli inseguimenti e i raptor furbi come gatti. Questo è tutto quanto ti serve a farti contento, ed è ragione sufficiente a premere replay over and over. Ma rivisto adesso, con gli occhi di un adulto, noti che i dinosauri non sono il centro tematico della storia. Non sono nemmeno il vero nemico. Certo bisogna essere piuttosto superficiali per non capirlo, visto che ci sono una serie di battute che rendono la cosa piuttosto esplicita, durante il primo pranzo degli ospiti al parco, quando tutti gli invitati di Hammond si oppongono al suo progetto. Il tema è quello dell'illusione del controllo, di come sia facile credere di avere un potere sul mondo (animali, persone, eventi naturali) che invece può sgretolarsi in pochi istanti. La mancanza di controllo si manifesta da subito, quando durante il giro inaugurale i dinosauri non si mostrano ai visitatori, e in seguito la tempesta peggiora la situazione. Abbiamo poi il sabotatore interno all'azienda, un altro esempio di sottovalutazione, soprattutto per via della sua indispensabilità nella gestione del parco. Poi naturalmente i dinosauri, che non sono pericolosi in quanto "mostri", ma solo perché sono creature imprevedibili, di cui non sappiamo anticipare il comportamento nel mondo in cui si trovano. E poi si scopre che, ops!, anche il sistema di controllo sulla loro riproduzione non funziona. Nella seconda conversazione durante un pasto tra la dottoressa Sattler e John Hammond, il concetto viene ribadito, e si arriva alla conclusione che il controllo si può ottenere solo come illusione: era possibile forse al circo delle pulci, che era di per sé un'illusione, ma altrimenti non c'è modo di ottenerlo. Sarebbe semplicistico limitare la lezione di Jurassic Park a un monito contro i rischi della scienza. Certo, anche questo rientra nel tema, ma il film non è una parabola luddista. È l'arroganza umana, in termini più generici, a essere sotto accusa, perché tutti, protagonisti e anatagonisti, ne soffrono e tutti devono confrontarsi con essa, uscendone in modo tragico o vittorioso.
Passiamo a Jumanji . Ne ho parlato tempo fa quando è stato visto durante una Coppi Night, quindi posso rimandare anche a quel post per riprendere la mia interpretazione adulta della storia. Riassumendo, quella che si configura come un'avventura fantasy anche in questo caso con mostri e inseguimenti, funziona a un altro livello come metafora del rapporto tra genitori e figli. Lo vediamo fin da subito: il giovane Alan Parrish subisce la disciplina ferrea del padre e da questa cerca di sfuggire... salvo poi rimanere intrappolato nel gioco. Dall'altra parte, i due ragazzini degli anni 90 che riscoprono Jumanji sono orfani, ed entrambi elaborano il lutto convincendosi di aver avuto genitori terribili. Quando poi Alan torna nella civiltà, si accorgerà di usare con il piccolo Peter le stesse odiose parole che suo padre rivolgeva a lui. Ed è emblematico il fatto che il cacciatore della giungla che esce dal gioco per uccidere Alan è interpretato dallo stesso attore di suo padre (cosa che all'epoca non avevo notato).
Il caso di Independece Day è più complesso. Perché è un disaster movie dei più classici, quello che ha consacrato Roland Emmerich tra i registi più fracassoni del secolo, e una di quelle storie in cui il big american dream salva il mondo, perché chi altri può farlo? Pare difficile trovare un senso remoto in un film del genere, che è fatto apposta per spegnere il cervello e godere della distruzioni di quei cazzo di alieni tentacolati, tornatene a casa vostra EARTH FIRST!!! Eppure, a ben guardare, anche qui c'è un tema meno evidente, e lo si nota seguendo con più attenzione il background dei protagonisti. Il presidente (Bill Pullman), il pilota (Will Smith) e lo scienziato (Jeff Goldblum, anche qui) sono tutti dei falliti: sicuramente sono capaci, appassionati, ma non vengono presi sul serio. Lo scienziato viene considerato un paranoico, fissato per la tutela dell'ambiente, è stato mollato dalla moglie e non se ne fa una ragione; il pilota vorrebbe avanare di carriera per diventare astronauta ma viene continuamente scartato, e si è invischiato in una relazione con una stripper single-mother che non lo aiuterà; il presidente è accusato di inesperienza, non è al corrente degli affari della sua Nazione (non sa niente dell'Area 51) e viene continuamente scavalcato nelle decisioni dai suoi sottoposti: lo si vede bene nelle prime scene, in cui sono i suoi segretari a decidere come affrontare la minaccia, contraddicendolo apertamente. Anche l'ubriacone reduce del Vietnam che racconta di essere stato rapito si rivela alla fine come l'eroe determinante per la sopravvivenza dell'umanità. Ecco il tema nascosto, dietro gli abbagli dei laser ed esplosioni: la storia fatta dai numeri due, quelli che sono messi da parte perché reputati inadatti al loro ruolo. Certo questo non basta a fare di Independence Day un'opera di utilità sociale, ma contribuisce quanto meno a rendere la storia più avvincente.
Di seguito a questa riflessione, mi pare di vedere che questo secondo livello di interpretazione è quello che spesso manca nei sequel. Non ho visto il recente Jumanji quindi non parlo di quello, ma tutti i sequel di Jurassic Park (incluso il terribile Jurassic World , e non ho avuto ancora la forza di vedere Fallen Kingdom) e pure Independence Day Resurgence sembrano capaci di cogliere solo l'aspetto superficiale di queste storie, e non aggiungere nessun approfondimento, che poi non deve necessariamente essere lo stesso ma anche un tema diverso capace di dare più profondità alla storia e allo sviluppo dei personaggi. Invece no, come afferma il sempre profetico professor Ian Malcolm: "Siete saliti sulle spalle di altri per raggiungere questo risultato, e ora lo avete impacchettato e volete venderlo."
Conclusa la parentesi old man yells at people, vi invito a riprendere i film della vostra infanzia, quelli che siete convinti di conoscere alla perfezione, e rivederlo adesso, a distanza magari di vent'anni dall'ultima volta. Magari siete convinti di sapere tutto quello che contiene, ma come è successo a me potreste scoprire qualcosa, e apprezzarlo ancora di più. Ma occhio, non garantisco che sia una formula universale: può darsi anche che il vostro film preferito da bambini sia solo un film per bambini, e rivederlo distrugga i vostri dolci ricordi: i film di merda li sapevano fare allora come oggi. Procedete solo a vostro rischio, consapevoli di poter avere l'infanzia distrutta.
Published on July 29, 2018 23:30
July 23, 2018
L'arco narrativo del Dodicesimo Dottore
Stanno uscendo in questi giorni i primi teaser e promo dell'undicesima stagione del NuWho, che vedrà il Dottore interpretato per la prima volta in più di cinquant'anni da una donna, ragione per cui molti associano il nuovo cacciavite sonico a un vibratore. Ma prima di buttarsi su questo soft reboot (nuovo Dottore, nuovi companion, nuovo Tardis, nuovo cacciavite, nuovo showrunner, nuovi autori, nuovo compositore...) potrebbe essere il caso di riguardare in prospettiva alle ultime stagioni, quelle del Dodicesimo Dottore di Peter Capaldi, e provare a capire cosa ha rappresentato nella storia della serie e del personaggio. È passato tempo a sufficienza dalla sua struggente rigenerazione da poter affrontare l'argomento senza lucciconi.
 Disclaimer: Peter Capaldi è il mio Dottore preferito. E lo dico quando sono arrivato con pazienza a metà del periodo del Sesto Dottore di Colin Baker, e posso essere ragionevolmente sicuro che né il Settimo Sylvester McCoy né l'Ottavo Paul McGann potranno fare miracoli. Di conseguenza la mia analisi potrebbe essere in parte viziata da questa adorazione, ma prometto che cercherò di limitare le considerazion da fanboy.
Disclaimer: Peter Capaldi è il mio Dottore preferito. E lo dico quando sono arrivato con pazienza a metà del periodo del Sesto Dottore di Colin Baker, e posso essere ragionevolmente sicuro che né il Settimo Sylvester McCoy né l'Ottavo Paul McGann potranno fare miracoli. Di conseguenza la mia analisi potrebbe essere in parte viziata da questa adorazione, ma prometto che cercherò di limitare le considerazion da fanboy.
Come abbiamo visto tempo fa, tutto il percorso dell'Undicesimo Dottore di Matt Smith è inscrivibile in un unico ampio arco narrativo, arrovellato su se stesso, presentato in ordine non cronologico e più volte retconizzato... ma comunque presente. Riesaminando invece il Dodicesimo Dottore, ci si accorge invece che una storia unitaria che abbraccia tutte le tre stagioni non esiste. Ci sono dei temi ricorrenti che sono risolti nel season finale (la Terra Promessa nella stagione otto, l'Ibrido nella stavione nove, la Cella con Missy nella stagione dieci), ma non c'è un unico plot che poi riannodi insieme tutti i fili. Quindi, di arco narrativo non si può parlare
A meno che non prendiamo in considerazione l'arco di trasformazione del Dottore stesso. Perché il Dodicesimo Dottore è forse quello più tormentato, più cupo ma anche più determinato, quello che si evolve maggiormente nel suo percorso. Proviamo a ripassare questo percorso.
Il Dodicesimo è il primo Dottore che sa cosa è successo a Gallifrey durante la Time War. In seguito agli eventi di The Day of the Doctor, Dodici "nasce" con la consapevolezza di aver salvato ma al tempo stesso perso per sempre il suo popolo. Non è un peso da poco, perché fin dall'inizio abbiamo seri dubbi sul fatto che questa incarnazione del Dottore sia "buono" nel senso classico. Tutti i Dottori hanno le loro ombre, ma quella di Dodici sembra più scura e meno timida delle altre. Tutta l'ottava stagione porta avanti questo tema, il tentativo del Dottore di capire se è davvero un buono: lo chiede a Clara, esplicitamente: "Am i a good man?" e lei non gli sa rispondere (forse ancora un po' turbata dalla trasformazione del piacione Undicesimo in questo vecchio zio scorbutico). Nel suo primo episodio, Capaldi potrebbe aver ucciso il suo nemico buttandolo nel vuoto (non ci è dato di saperlo, ma io propendo per questa ipotesi); nell'episodio successivo, un Dalek lo riconosce come suo simile per l'odio che porta dentro di sé; in seguito il Dottore dimostra più volte la sua scarsa considerazione per i piccoli umani che chiedono il suo aiuto, e arriva quasi a farsi ammazzare da Clara che sopporta la sua indifferenza. È solo nel finale della stagione che di fronte all'esercito di cyberman e al ritorno del Master nella sua versione femminile, arriva alla realizzazione di non essere né buono né cattivo, ma solo un qualunque idiota che commette errori.
 Nella nona stagione ritroviamo il Dottore in crisi. Forse per la sua rottura con Clara (presto riparata per esigenze di produzione, ma probabilmente nelle intenzioni iniziali avrebbe dovuto uscire di scena dopo lo speciale di natale), il nuovo scontro con Missy e l'incontro con il giovane Davros, pare che si sia rassegnato al suo declino e stia solo aspettando la fine. Una sorta di crisi di mezza età con tanto di chitarra elettrica, capelli in disordine e occhiali da sole. Il suo cinismo inizialmente continua a esondare, ma quando si accorge a più riprese di come il suo intervento influenza la vita delle persone, raggiunge un altro momento di epifania. È allora che capisce anche la ragioen per cui porta il viso del pompeano che ha salvato tanto tempo prima, quando la sua faccia era quella di David Tennant: "I am the Doctor, and i save people". Questa sua determinazione a voler salvare l'insalvabile lo porterà al limite estremo, fino a tentare di impedire la morte (meritata) di Clara. Anche il ritrovamento di Gallifrey e il confronto con i Time Lord passerà in secondo piano rispetto a questo.
Nella nona stagione ritroviamo il Dottore in crisi. Forse per la sua rottura con Clara (presto riparata per esigenze di produzione, ma probabilmente nelle intenzioni iniziali avrebbe dovuto uscire di scena dopo lo speciale di natale), il nuovo scontro con Missy e l'incontro con il giovane Davros, pare che si sia rassegnato al suo declino e stia solo aspettando la fine. Una sorta di crisi di mezza età con tanto di chitarra elettrica, capelli in disordine e occhiali da sole. Il suo cinismo inizialmente continua a esondare, ma quando si accorge a più riprese di come il suo intervento influenza la vita delle persone, raggiunge un altro momento di epifania. È allora che capisce anche la ragioen per cui porta il viso del pompeano che ha salvato tanto tempo prima, quando la sua faccia era quella di David Tennant: "I am the Doctor, and i save people". Questa sua determinazione a voler salvare l'insalvabile lo porterà al limite estremo, fino a tentare di impedire la morte (meritata) di Clara. Anche il ritrovamento di Gallifrey e il confronto con i Time Lord passerà in secondo piano rispetto a questo.
Questa nuova attitudine proseguirà anche nella decima stagione, e anzi la sua voglia di fare la cosa giusta si estende anche a Missy, che cercherà di redimere e che costituirà il suo metro di paragone per capire se le sue azioni hanno un peso. Il suo discorso finale ai due Master "Who i am is where i stand; where i stand is where i fall" è la sintesi della consapevolezza che raggiunto, l'idea finale che la sua persona è definita da ciò che decide di difendere, pur senza ricompensa, senza speranza, senza testimoni. E stavolta parla sul serio di morte, perché quando arriva il momento in cui il suo fisico non lo regge più e vorrebbe rigenerarsi, è lui a volerlo impedire. Non per paura di morire, non per vanità o perché pensa di poter ancora fare molto come all'epoca del Decimo, ma per non cambiare: per non dover riniziare da capo il percorso che lo ha portato a emergere da una profonda crisi e a capire di nuovo chi è. Questo Dottore vuole semplicemente morire, perché sente di aver raggiunto un punto di equilibrio con se stesso. Ha la forza di farlo ancora? Ovviamente sì, lo sappiamo, ma è una scelta molto sofferta, tanto che prima di andarsene ha l'accortezza di lasciare al suo successore alcuni preziosi consigli.
Tutto questo arco è a mio avviso ineguagliato da qualsiasi altro Dottore, e fa del Dodicesimo quello con la storia più interessante, perché è un percorso di crescita, di presa di coscienza, di cambiamento, che nessuno aveva dimostrato prima. Secondo un'altra interpretazione che ho letto tempo fa da qualche parte (probabilmente su qualche subreddit), ogni stagione del Dodicesimo Dottore mostra un personaggio che cerca di diventare come il Dottore: nell'ottava stagione è il Dottore stesso, dopo la rigenerazione; nella nona è Clara; nella decima Missy. Come chiave di lettura può funzionare, ma secondo me rimane comunque valido l'intero arco di trasformazione proposto prima.
Con ciò non voglio dire che il periodo del Dodicesimo Dottore sia perfetto. Anzi. Ci sono degli abissi davvero bui, con alcuni degli episodi più brutti della serie moderna (Sleep No More, In the Forest of the Night). L'ottava stagione soprattutto è stata influenzata da un cambio troppo brusco del protagonista: molte delle storie sembravano scritte per il Dottore sornione di Matt Smith, piuttosto che quello ruvido di Capaldi. E nonostante l'eccellente spirito di adattamento dell'attore, le stonature si notano. Inoltre anche le continue incertezze sulla presenza o meno di Jenna Coleman hanno portato a una volatilità del personaggio di Clara, che sembra cambiare negli atteggiamenti e intenzioni da una stagione all'altra.
 È noto che in queste ultime tre stagioni gli ascolti di DW sono calati, non in modo drammatico ma comunque costante. Probabilmente la scelta di un Dottore anziano, incollocabile nelle fanfiction e nei sogni di ship dei fan (Tennant e Smith hanno giovato molto di questa loro piacevolezza estetica), ha allontanato una parte di pubblico giovane che fino a quel momento aveva seguito il Dottore. La scelta di Steven Moffat di prendere Capaldi in questo senso è stata audace, e ha permesso quanto meno di riportare in scena un Dottore maturo, refrattario al romanticismo di cui il personaggio si era ammantato fin dall'epoca di McGann. Mi permetto quindi di suggerire un percorso essenziale degli episodi dell'epoca di Capaldi da vedere per potersi mettere in pari prima dell'arrivo di Jodie Whittaker. Quelle che elenco sono le puntate essenziali per poter seguire questo percorso del Dodicesimo Dottore, scansando il materiale meno funzionale. Tra quelle elencate compare anche qualche puntata mediocre, ma che contiene elementi necessari per poter seguire lo sviluppo del personaggio.
È noto che in queste ultime tre stagioni gli ascolti di DW sono calati, non in modo drammatico ma comunque costante. Probabilmente la scelta di un Dottore anziano, incollocabile nelle fanfiction e nei sogni di ship dei fan (Tennant e Smith hanno giovato molto di questa loro piacevolezza estetica), ha allontanato una parte di pubblico giovane che fino a quel momento aveva seguito il Dottore. La scelta di Steven Moffat di prendere Capaldi in questo senso è stata audace, e ha permesso quanto meno di riportare in scena un Dottore maturo, refrattario al romanticismo di cui il personaggio si era ammantato fin dall'epoca di McGann. Mi permetto quindi di suggerire un percorso essenziale degli episodi dell'epoca di Capaldi da vedere per potersi mettere in pari prima dell'arrivo di Jodie Whittaker. Quelle che elenco sono le puntate essenziali per poter seguire questo percorso del Dodicesimo Dottore, scansando il materiale meno funzionale. Tra quelle elencate compare anche qualche puntata mediocre, ma che contiene elementi necessari per poter seguire lo sviluppo del personaggio.
Stagione 8: Deep Breath, Into the Dalek, Listen, The Caretaker, Kill the Moon, Dark Water/Death in Heaven
Stagione 9: praticamente tutta tranne Sleep No More , essendo interamente composta da episodi doppi tutti significativi
Stagione 10: The Pilot, Thin Ice, Oxygen, Extremis (tecnicamente questo è il primo di un tre-parti, ma le due successive si possono evitare), World Enough and Time/The Doctor Falls, Twice Upon a Time
Forse prima dell'inizio della nuova stagione dedicherò un post anche a una retrospettiva sull'intera era di Moffat a capo della serie, per cercare di capire se al netto delle critiche si possao considerare un periodo positivo o no. Ma non vorrei addentrarmi troppo nei territori del fandom rabbioso, per cui non prometto niente.
 Disclaimer: Peter Capaldi è il mio Dottore preferito. E lo dico quando sono arrivato con pazienza a metà del periodo del Sesto Dottore di Colin Baker, e posso essere ragionevolmente sicuro che né il Settimo Sylvester McCoy né l'Ottavo Paul McGann potranno fare miracoli. Di conseguenza la mia analisi potrebbe essere in parte viziata da questa adorazione, ma prometto che cercherò di limitare le considerazion da fanboy.
Disclaimer: Peter Capaldi è il mio Dottore preferito. E lo dico quando sono arrivato con pazienza a metà del periodo del Sesto Dottore di Colin Baker, e posso essere ragionevolmente sicuro che né il Settimo Sylvester McCoy né l'Ottavo Paul McGann potranno fare miracoli. Di conseguenza la mia analisi potrebbe essere in parte viziata da questa adorazione, ma prometto che cercherò di limitare le considerazion da fanboy.Come abbiamo visto tempo fa, tutto il percorso dell'Undicesimo Dottore di Matt Smith è inscrivibile in un unico ampio arco narrativo, arrovellato su se stesso, presentato in ordine non cronologico e più volte retconizzato... ma comunque presente. Riesaminando invece il Dodicesimo Dottore, ci si accorge invece che una storia unitaria che abbraccia tutte le tre stagioni non esiste. Ci sono dei temi ricorrenti che sono risolti nel season finale (la Terra Promessa nella stagione otto, l'Ibrido nella stavione nove, la Cella con Missy nella stagione dieci), ma non c'è un unico plot che poi riannodi insieme tutti i fili. Quindi, di arco narrativo non si può parlare
A meno che non prendiamo in considerazione l'arco di trasformazione del Dottore stesso. Perché il Dodicesimo Dottore è forse quello più tormentato, più cupo ma anche più determinato, quello che si evolve maggiormente nel suo percorso. Proviamo a ripassare questo percorso.
Il Dodicesimo è il primo Dottore che sa cosa è successo a Gallifrey durante la Time War. In seguito agli eventi di The Day of the Doctor, Dodici "nasce" con la consapevolezza di aver salvato ma al tempo stesso perso per sempre il suo popolo. Non è un peso da poco, perché fin dall'inizio abbiamo seri dubbi sul fatto che questa incarnazione del Dottore sia "buono" nel senso classico. Tutti i Dottori hanno le loro ombre, ma quella di Dodici sembra più scura e meno timida delle altre. Tutta l'ottava stagione porta avanti questo tema, il tentativo del Dottore di capire se è davvero un buono: lo chiede a Clara, esplicitamente: "Am i a good man?" e lei non gli sa rispondere (forse ancora un po' turbata dalla trasformazione del piacione Undicesimo in questo vecchio zio scorbutico). Nel suo primo episodio, Capaldi potrebbe aver ucciso il suo nemico buttandolo nel vuoto (non ci è dato di saperlo, ma io propendo per questa ipotesi); nell'episodio successivo, un Dalek lo riconosce come suo simile per l'odio che porta dentro di sé; in seguito il Dottore dimostra più volte la sua scarsa considerazione per i piccoli umani che chiedono il suo aiuto, e arriva quasi a farsi ammazzare da Clara che sopporta la sua indifferenza. È solo nel finale della stagione che di fronte all'esercito di cyberman e al ritorno del Master nella sua versione femminile, arriva alla realizzazione di non essere né buono né cattivo, ma solo un qualunque idiota che commette errori.
 Nella nona stagione ritroviamo il Dottore in crisi. Forse per la sua rottura con Clara (presto riparata per esigenze di produzione, ma probabilmente nelle intenzioni iniziali avrebbe dovuto uscire di scena dopo lo speciale di natale), il nuovo scontro con Missy e l'incontro con il giovane Davros, pare che si sia rassegnato al suo declino e stia solo aspettando la fine. Una sorta di crisi di mezza età con tanto di chitarra elettrica, capelli in disordine e occhiali da sole. Il suo cinismo inizialmente continua a esondare, ma quando si accorge a più riprese di come il suo intervento influenza la vita delle persone, raggiunge un altro momento di epifania. È allora che capisce anche la ragioen per cui porta il viso del pompeano che ha salvato tanto tempo prima, quando la sua faccia era quella di David Tennant: "I am the Doctor, and i save people". Questa sua determinazione a voler salvare l'insalvabile lo porterà al limite estremo, fino a tentare di impedire la morte (meritata) di Clara. Anche il ritrovamento di Gallifrey e il confronto con i Time Lord passerà in secondo piano rispetto a questo.
Nella nona stagione ritroviamo il Dottore in crisi. Forse per la sua rottura con Clara (presto riparata per esigenze di produzione, ma probabilmente nelle intenzioni iniziali avrebbe dovuto uscire di scena dopo lo speciale di natale), il nuovo scontro con Missy e l'incontro con il giovane Davros, pare che si sia rassegnato al suo declino e stia solo aspettando la fine. Una sorta di crisi di mezza età con tanto di chitarra elettrica, capelli in disordine e occhiali da sole. Il suo cinismo inizialmente continua a esondare, ma quando si accorge a più riprese di come il suo intervento influenza la vita delle persone, raggiunge un altro momento di epifania. È allora che capisce anche la ragioen per cui porta il viso del pompeano che ha salvato tanto tempo prima, quando la sua faccia era quella di David Tennant: "I am the Doctor, and i save people". Questa sua determinazione a voler salvare l'insalvabile lo porterà al limite estremo, fino a tentare di impedire la morte (meritata) di Clara. Anche il ritrovamento di Gallifrey e il confronto con i Time Lord passerà in secondo piano rispetto a questo.Questa nuova attitudine proseguirà anche nella decima stagione, e anzi la sua voglia di fare la cosa giusta si estende anche a Missy, che cercherà di redimere e che costituirà il suo metro di paragone per capire se le sue azioni hanno un peso. Il suo discorso finale ai due Master "Who i am is where i stand; where i stand is where i fall" è la sintesi della consapevolezza che raggiunto, l'idea finale che la sua persona è definita da ciò che decide di difendere, pur senza ricompensa, senza speranza, senza testimoni. E stavolta parla sul serio di morte, perché quando arriva il momento in cui il suo fisico non lo regge più e vorrebbe rigenerarsi, è lui a volerlo impedire. Non per paura di morire, non per vanità o perché pensa di poter ancora fare molto come all'epoca del Decimo, ma per non cambiare: per non dover riniziare da capo il percorso che lo ha portato a emergere da una profonda crisi e a capire di nuovo chi è. Questo Dottore vuole semplicemente morire, perché sente di aver raggiunto un punto di equilibrio con se stesso. Ha la forza di farlo ancora? Ovviamente sì, lo sappiamo, ma è una scelta molto sofferta, tanto che prima di andarsene ha l'accortezza di lasciare al suo successore alcuni preziosi consigli.
Tutto questo arco è a mio avviso ineguagliato da qualsiasi altro Dottore, e fa del Dodicesimo quello con la storia più interessante, perché è un percorso di crescita, di presa di coscienza, di cambiamento, che nessuno aveva dimostrato prima. Secondo un'altra interpretazione che ho letto tempo fa da qualche parte (probabilmente su qualche subreddit), ogni stagione del Dodicesimo Dottore mostra un personaggio che cerca di diventare come il Dottore: nell'ottava stagione è il Dottore stesso, dopo la rigenerazione; nella nona è Clara; nella decima Missy. Come chiave di lettura può funzionare, ma secondo me rimane comunque valido l'intero arco di trasformazione proposto prima.
Con ciò non voglio dire che il periodo del Dodicesimo Dottore sia perfetto. Anzi. Ci sono degli abissi davvero bui, con alcuni degli episodi più brutti della serie moderna (Sleep No More, In the Forest of the Night). L'ottava stagione soprattutto è stata influenzata da un cambio troppo brusco del protagonista: molte delle storie sembravano scritte per il Dottore sornione di Matt Smith, piuttosto che quello ruvido di Capaldi. E nonostante l'eccellente spirito di adattamento dell'attore, le stonature si notano. Inoltre anche le continue incertezze sulla presenza o meno di Jenna Coleman hanno portato a una volatilità del personaggio di Clara, che sembra cambiare negli atteggiamenti e intenzioni da una stagione all'altra.
 È noto che in queste ultime tre stagioni gli ascolti di DW sono calati, non in modo drammatico ma comunque costante. Probabilmente la scelta di un Dottore anziano, incollocabile nelle fanfiction e nei sogni di ship dei fan (Tennant e Smith hanno giovato molto di questa loro piacevolezza estetica), ha allontanato una parte di pubblico giovane che fino a quel momento aveva seguito il Dottore. La scelta di Steven Moffat di prendere Capaldi in questo senso è stata audace, e ha permesso quanto meno di riportare in scena un Dottore maturo, refrattario al romanticismo di cui il personaggio si era ammantato fin dall'epoca di McGann. Mi permetto quindi di suggerire un percorso essenziale degli episodi dell'epoca di Capaldi da vedere per potersi mettere in pari prima dell'arrivo di Jodie Whittaker. Quelle che elenco sono le puntate essenziali per poter seguire questo percorso del Dodicesimo Dottore, scansando il materiale meno funzionale. Tra quelle elencate compare anche qualche puntata mediocre, ma che contiene elementi necessari per poter seguire lo sviluppo del personaggio.
È noto che in queste ultime tre stagioni gli ascolti di DW sono calati, non in modo drammatico ma comunque costante. Probabilmente la scelta di un Dottore anziano, incollocabile nelle fanfiction e nei sogni di ship dei fan (Tennant e Smith hanno giovato molto di questa loro piacevolezza estetica), ha allontanato una parte di pubblico giovane che fino a quel momento aveva seguito il Dottore. La scelta di Steven Moffat di prendere Capaldi in questo senso è stata audace, e ha permesso quanto meno di riportare in scena un Dottore maturo, refrattario al romanticismo di cui il personaggio si era ammantato fin dall'epoca di McGann. Mi permetto quindi di suggerire un percorso essenziale degli episodi dell'epoca di Capaldi da vedere per potersi mettere in pari prima dell'arrivo di Jodie Whittaker. Quelle che elenco sono le puntate essenziali per poter seguire questo percorso del Dodicesimo Dottore, scansando il materiale meno funzionale. Tra quelle elencate compare anche qualche puntata mediocre, ma che contiene elementi necessari per poter seguire lo sviluppo del personaggio.Stagione 8: Deep Breath, Into the Dalek, Listen, The Caretaker, Kill the Moon, Dark Water/Death in Heaven
Stagione 9: praticamente tutta tranne Sleep No More , essendo interamente composta da episodi doppi tutti significativi
Stagione 10: The Pilot, Thin Ice, Oxygen, Extremis (tecnicamente questo è il primo di un tre-parti, ma le due successive si possono evitare), World Enough and Time/The Doctor Falls, Twice Upon a Time
Forse prima dell'inizio della nuova stagione dedicherò un post anche a una retrospettiva sull'intera era di Moffat a capo della serie, per cercare di capire se al netto delle critiche si possao considerare un periodo positivo o no. Ma non vorrei addentrarmi troppo nei territori del fandom rabbioso, per cui non prometto niente.
Published on July 23, 2018 00:30
Unknown to Millions
Il blog di Andrea Viscusi since 2010
Libri, fantascienza, serie tv, Futurama, Doctor Who
Libri, fantascienza, serie tv, Futurama, Doctor Who
- Andrea Viscusi's profile
- 81 followers



