Andrea Viscusi's Blog: Unknown to Millions, page 3
March 4, 2025
Somebody that i used to be
Quando è uscita Somebody That I Used To Know di Gotye (feat. Kimbra) io ero già adulto. Magari non ero proprio “maturo” ma vivevo già per conto mio, avevo un lavoro, una routine e soprattutto ero sopravvissuto alla fine di qualche relazione sentimentale.
Per questo, il testo di Gotye che parla di una relazione che si conclude bruscamente con la totale reciproca e rabbiosa rimozione dai ricordi, l’avevo interpretata per quel che era. Forte delle mie esperienze, i versi della canzone mi erano sembrati subito facili da comprendere e collegare al mio vissuto. I feel you, Gotye.
Questo accadeva, come ci dice la data sul video di youtube, 13 anni e rotti fa.
In questi 13 anni quasi 14, credo di non aver mai visto il video di Somebody That I Used To Know. Non ne sono del tutto sicuro. Potrei averlo anche visto en passant, ma forse mi confondo solo con il fatto di aver memorizzato quella particolare immagine dei due protagonist+ dipinti da tappezzeria. In ogni caso, di certo non avevo assimilato il video (anche perché, di base, sono sempre un fruitore di musica in quanto musica, e i “videoclip” non mi hanno mai attratto particolarmente).
Qualche settimana fa ho recuperato il ritardo di questi 14 anni più che 13. Non ricordo bene per quale catena di collegamenti, ma sono arrivato sul video di Gotye e me lo sono guardato. Poi ho premuto replay e l’ho riguardato. E poi l’ho fatto di nuovo, e ancora, forse per venti volte di seguito. E man mano che assorbivo i dettagli del video, iniziavo a scorrere i commenti sottostanti.
È una cosa che mi piace fare, soprattutto per i video molto vecchi. Vedere le tracce che arrivano da otto dieci dodici anni dal passato. I migliori sono quelli che dopo molti anni sono stati rieditati con un commento a posteriori. E sotto il video di questa canzone, ce ne sono molti, di gente che aveva sentito la canzone nel 2011 e poi l’ha riascoltata nel 2024. Commenti di questo tenore:

Persone che nel 2011 erano ragazzine o anche bambine, e che vedendo il video ridacchivano pensando che c’erano due tizi nudi dipinti che si parlavano addosso. Per poi tornare, dieci anni dopo, con il cuore spezzato, e finalmente capire. Che cosa significa soffrire, perdere, dimenticare. E naturalmente il collegamento più immediato è quello con gli amori, le relazioni, i partner. Ma vale per molte altre cose.
fr tho, i wish i didnt relate but its crazy how much we change
Quella frase antipatica che si sente dire spesso: “non puoi capire se non ci sei passato”, che nella maggior parte dei casi si riferisce all’avere figli, è odiosamente vera. Vorrei che non lo fosse (i wish i didnt relate) ma è davvero così.
A me non è capitato per Somebody That I Used To Know, perché in qualche modo l’ho sempre capita nelle sue intenzioni originali, ma mi chiedo quante cose non ho capito perché non ci sono ancora passato, perché non ho le esperienze, i ricordi e il bagaglio necessario per capire davvero.
Non sono uno che rilegge i libri, perché sono dell’idea che non ci sia tempo nella vita per leggere tutto quello che vorrei. Ma in tempi relativamente recenti ho riletto I Promessi Sposi e Dune e Solaris, e li ho trovati tutti migliori di quanto ricordavo. Forse ero io il problema, perché non ero ancora in grado di recepire. Forse alcune cose non le potrò recepire mai.
Forse ogni tanto dovrei tornare indietro, alle cose che mi hanno segnato, a quelle che ho amato o disprezzato, e provare a capirle di nuovo. Sarebbe anche un modo per rendermi conto di chi ero, e di come sono adesso, di quanto sono cambiato. E concedermi anche un po’ di nostalgia per quel somebody that i used to be.
P.S.: nei commenti sotto il videoclip ne trovate anche tanti che scherzano sul fatto che Gotye dopo questo successo globale (solo su youtube ci sono due miliardi e quattrocento milioni di visualizzazioni) sia sparito del tutto. Anche questa è una bella storia, che quelli come noi che si impegnano in progetti creativi dovrebbero conoscere. Cercatela, se non ne sapete niente.
February 14, 2025
Rapporto letture - Gennaio 2025
Con il passaggio su substack dalla vecchia versione su blogspot, voglio provare (provare!) a riportare i rapporti letture alla naturale base mensile, invece di farli ogni due mesi come l’accidia mi aveva portato a fare negli ultimi anni. Potrei anche fare quel salto di modernità e chiamarli “wrap up”, ma la tradizione ultradecennale dei miei post vale più di un hashtag. Quindi sto.
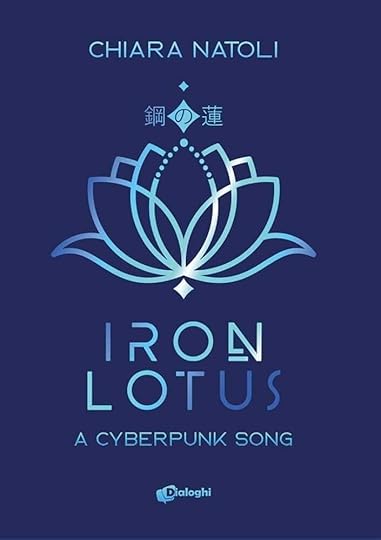
Il primo libro terminato nel 2025 è Iron Lotus - A cyerbpunk song, il romanzo d’esordio di Chiara Natoli. L’autrice mi aveva contattato direttamente qualche mese fa per propormi di leggere il suo libro, e io che sono un ragazzo semplice e se vedo “cyberpunk” mi animo già, ho accettato, soprattutto per la curiosità di vedere un’interpretazione attuale del cyberpunk di un’autrice emergente (non esce tanta roba cyberpunk in Italia, ultimamente [e c’è un motivo]). Purtroppo l’esperienza non è stata troppo soddisfacente, perché Iron Lotus soffre di diversi problemi, sia dal punto di vista della struttura che della scrittura. La componente cyberpunk è per lo più estetica, con topoi e trope risalenti al genere, che però vengono impiegati tal quali, senza nessuna rielaborazione (che nel 2020+ diventa necessaria), un po’ come si stesse giocando con delle action figure. I temi sono quelli del cyberpunk classico, superati da una trentina d’anni, per cui chiunque abbia un minimo di conoscenza del genere (o anche solo abbia visto Johnny Mnemonic e Nirvana) non ci troverà niente di nuovo. E la scrittura è grezza, sporca, frettolosa. Abbondanza di doppiaggese e tante ripetizioni, errori di spelling dei frequenti termini inglesi (e non so il giapponese, sennò chissà) e sviste tipografiche e di punteggiatura. Il libro quindi è del tutto insufficiente, ma si percepisce che c’era la volontà di fare qualcosa da parte dell’autrice, che purtroppo non è stata raccolta e valorizzata dall’editore (anche solo la cura minima del testo avrebbe fatto una certa differenza). Come nel caso del libro di Federico Tamanini letto qualche mese fa, questo è un romanzo che con un buon editing e una buona dose di pazienza dell’autrice avrebbe potuto essere quanto meno discreto. Non rivoluzionario, perché è comunque un prodotto estremamente derivativo, ma comunque godibile, che adesso non è. Voto: 4.5/10
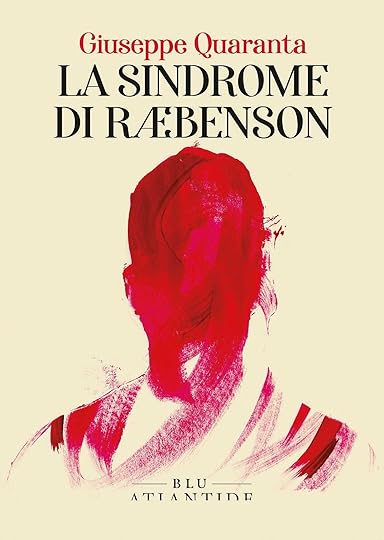
Altro esordio, ma di ben altro spessore, è La sindrome di Raebenson, che ho letto per il primo e ultimo gruppo di lettura che seguirò mai (solo perché coincideva già di base con le mie intenzioni di lettura!), dopo aver già assistito a una presentazione con l’autore Giuseppe Quaranta poco dopo l’uscita. Questo romanzo (pubblicato da Atlantide) si è rivelato piuttosto sorprendente, perché non mi aspettavo di essere così avvinto dalla ricerca di una malattia. La storia è narrata da un giovane psichiatra che racconta la storia di un collega (amico?) che inizia a soffrire di strani sintomi dissociativi, che vengon poi ricondotti a questa curiosa sindrome di Raebenson, di cui si sente parlare negli ambienti accademici ma che non è stata mai studiata e definita. L’interesse nei confronti dei raebensoniani sta nel fatto che, a quanto pare, questa malattia conduca incidentalmente all’immortalità. Ma come, sempre, qual è il prezzo della vita eterna? Il romanzo è costruito come il resoconto della ricerca su questa malattia, quasi come un’indagine senza colpevole, e suscita davvero l’idea di un processo scientifico, una serie di ipotesi e tentativi, per arrivare a una risposta chiara. Il sapore accademico è esaltato dall’abbondanza di lessico tecnico e dalle immagini con didascalie che ricordano proprio un testo di medicina. La scrittura è carica, ottocentesca, e si colloca bene in un’assurda intersezione tra Conan Doyle e Lovecraft, ma senza assassini (a meno che i suicidi non siano considerati tali) e senza orrori cosmici (a meno che la vita eterna non sia l’orrore supremo). Insomma, è un libro che combina in modo innovativo elementi, temi e stili che non credevo si potessero intrecciare così bene, e per questo lo ritengo tra i migliori letti ultimamente. È anche, indubitabilmente, un libro inquadrabile nella speculative fiction. Voto: 9/10
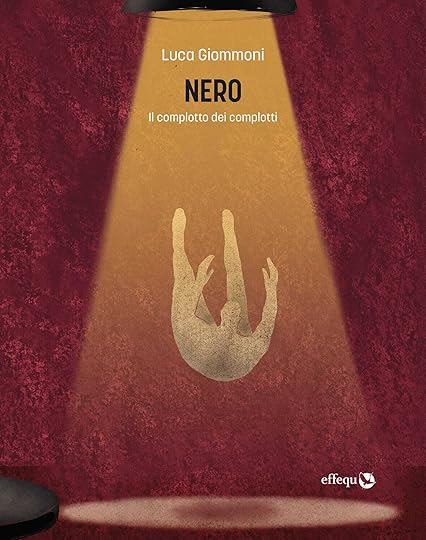
Dalla vita eterna alle code eterne all’ufficio di collocamento, con il romanzo di Luca Giommoni pubblicato a novembre da effequ. Nero è il protagonista eponimo di Nero - Il complotto dei complotti, ed è un fissato dei complotti. In realtà non ci crede davvero, ma è abituato a scorgerli ovunque, perché è quello che faceva sempre sua madre. La madre che è morta di cancro, facendo uscire di testa il padre, che passa le giornate a lanciare un rotolo di cartone nella speranza che si apra un buco nero. Almeno finché anche il padre non sparisce nel nulla. Nero è anche disoccupato, e questo è un utleriore problema che cerca di risolvere con continui colloqui che lo portano sempre in situazioni grottesche, ma niente di più assurdo dell’annuncio medio di ricerca personale che potete trovare su Linkedin. Il tutto si fa più assurdo quando scopre strani macchinari e operatori negli uffici comunali, e inizia a sospettare che ci sia un complotto per impedire alla gente di trovare davvero lavoro. Qui inizia la parte più fantascientifica del libro, che fa un uso disinvolto del viaggio nel tempo per creare vari paradossi di predestinazione che intrecciano la ricerca di lavoro, la famiglia di Nero e il futuro dell’umanità. Nero è un romanzo che si pone da subito come leggero e dissacrante, ma che a tradimento riesce a infliggere delle stoccate che non ti dissanguano, però bruciano parecchio. Troppo drammatico per essere Fantozzi e troppo divertente per essere Kafka, è anche un libro generazionale, che rappresenta bene la condizione di noi vecchi millennial, evitando sia il tono paternalista che quello consolatorio. Voto: 8/10

Concludiamo con l’unico libro straniera della mesata che ero rimasto l’unico a non aver letto. Non serve che vi dica io che cos’è Non lasciarmi e non serve che arrivi io a commentare il Premio Nobel Kazuo Ishiguro. Mi limiterò a dire che avevo forse aspettative un po’ diverse, e che in molti casi la lettura mi ha lasciato freddo. Sicuramente per mia predisposizione avrei gradito un maggior approfondimento delle parti speculative, ma non è tanto questo il problema che ho incontrato, più che altro mi è sembrato che soprattutto nella parte centrale la storia abba perso l’orientamento e si muovesse un po’ a caso con una sequenza di episodi sconnessi. Le relazioni tra i protagonisti sono messe in scena magnificamente, ma ho sofferto la mancanza di un obiettivo, un intenzione sottostante a quello che veniva raccontato. Anche perché il romanzo è volutamente impostato come il racconto diretto della protagonista, che si rivolge direttamente al lettore anche con frasi tipo “ma di questo parleremo dopo, come stavo dicendo” ecc, per cui mi sarei aspettato che verso la fine ci fosse un momento raccordo di questa narrazione diretta in cui la protagonista si posiziona nel presente nel momento in cui scrive rivelando perché. Quindi un po’ di incertezza e un po’ di fastidio che non me lo hanno fatto apprezzare in pieno. Voto: 6.5/10
January 29, 2025
Dune: Prophecy: Exposed
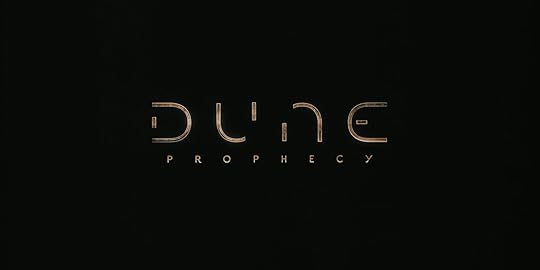
Trascorsa qualche settimana dalla conclusione della prima stagione di Dune: Prophecy, e con l’annuncio di una stagione 2 in arrivo, i tempi sono maturi per le considerazioni generali sulla serie e su cosa rappresenta nell’universo mediatico di Dune, che inizia ad avere le caratteristiche per essere definito un franchise.
Avevo già espresso alcune prime impressioni a metà stagione, e su Reading Wildlife avevo proposto anche un’utile FAQ per chi si approcciasse alla serie, ma adesso voglio fare un discorso a baliset fermi.
Iniziamo dalla domanda più banale: Dune: Prophecy è una bella serie?
La risposta breve è: no.
D:P è una serie “meh”, che oscilla tra il mediocre e il sufficiente. Questo prima e oltre tutte le considerazioni che si possono fare sul suo rapporto con l’opera di riferimento, ma proprio in quanto prodotto seriale di fine 2024. In un’industria dell’intrattenimento satura di proposte, D:P si pone semplicemente come un’altra di quelle serie da vedere doomscrollando per poi dimenticarla la settimana dopo. Nonostante si percepisca il valore produttivo della serie (fotografia, effetti e reparto tecnico sono tutti di buon livello), il risultato finale rimane generico e superficiale, l’ennesimo GameOfThrones-wannabe che porta le stesse dinamiche della serie ammiraglia di HBO del decennio scorso, solo con una patina cosmetica diversa. Il che è anche abbastanza ironico, se si considera che la saga di Martin ha numerosi elementi ripresi proprio da Dune di Herbert. E che probabilmente rimarrà anch’essa incompiuta a un libro dalla fine.
 Risposta secca: che serie tv è?
Risposta secca: che serie tv è?Senza entrare troppo nelle specifictà della trama, il problema di Dune: Prophecy sta soprattutto nella scrittura, intesa sia come struttura delle scene che dei dialoghi. Tutto è estremamente didascalico, ogni punto tematico viene esplicitato nei dialoghi e si perde pertanto ogni livello di sottigliezza che ci si poteva aspettare non solo da una serie di Dune, ma a maggior ragione da una stori che si concentra proprio sulle macchinazione del Bene Gesserit, la cui mission aziendale è, di fatto, complottare nell’ombra. Diventa un po’ anticlimatico quando questi piani nei piani nei piani vengono riferiti per bocca da un personaggio all’altro.
Oltre a questo livello di superficialità, c’è anche un piattume generale nella composizione delle scene, che per lo più hanno questo template: un personaggio sta in una stanza a fare qualcosa, un altro personaggio entra nella stanza, parlano di qualcosa per alcuni minuti, uno dei dei personaggi lascia la stanza. Raramente le sequenze includono azione, intesa non tanto come momenti adrenalinici quanto mostrare quello che i personaggi concretamente fanno al di là di quanto si dicono. Insomma, gira che ti rigira, il problema finisce sempre sullo show don’t tell, che per quanto sia inculcato a forza in generazioni di sceneggiatori, viene per lo più travisato o ignorato quando a decidere cosa mettere in scena sono gli studios.
Infine, rimane anche da decidere quanto è Dune, Dune: Prophecy. E anche qui la risposta è molto poco. Perdendo il suo grande senso di scopo, limitandosi ad appiccicare ai personaggi nomi ed etichette riconoscibili ma senza dare valore a queste etichette (guarda, un Richese! guarda, un Volto Danzante!), il tutto sembra appunto una fanfiction di Dune con attori in cosplay. Cosa che ricorda in buona parte l’operazione di franchisizzazione di Herbert figlio insieme a K.J. Anderson a partire dagli infami “preludi a Dune”. Tutti i personaggi sono collegati, e l’universo diventa estremamente piccolo, perché dovunque vai trovi sempre qualcuno che ha già avuto a che fare con gli altri. Questa storia soffre quindi dello stesso paradosso di Star Wars (anche questo, ironicamente, debitore per moltissimi aspetti a Dune), per il quale nonostante gli eventi si svolgano in una galassia sconfinata, i gradi di separazione massimi tra le persone sono appena un paio.
Sicuramente molti dei problemi sono dovuti anche agli intoppi di produzione, che hanno portato a mettere insieme una serie cambiando due volte showrunner e registi. Il progetto inizialmente era in mano allo stesso Villeneuve, poi è stato riassegnato e alla fine è stato completato quasi per inerzia, subendo molti tagli. Una stagione di sei episodi in effetti non sembra sufficiente a coprire l’arco narrativo che si voleva portare avanti, e questo contribuisce al generale disequilibrio della storia.
 Witches…
Witches…Questo significa che Dune: Prophecy sia terribile e inguardabile? No, il livello è appunto quello medio di molte serie di questo periodo. Da metà in poi, superato lo scoglio degli infodump più grossolani, alcune storylin e sequenze diventano piacevoli. L’ultimo episodio ha un paio di momenti interessanti… galleggianti nello stagno di noia e frustrazione. Di certo non è la serie che farà innamorare un nuovo pubblico di Dune come universo narrativo, perché chi partisse da qui non troverebbe niente di nuovo, unico e caratteristico per cui dovrebbe passare a scoprire il resto del franchise. Ma certamente per gli appassionati e per chi vuole ingannare l’attesa di Dune Messiah di Villeneuve può essere un discreto surrogato.
La profezia è: non ci sarà una terza stagione.
Se vuoi esserci quando la profezia si rivelerà, iscriviti
January 20, 2025
So long and thanks for all the links
A partire dal 2025, Unknown to Millions si trasferisce.
Questo blog rimarrà aperto (server permettendo) come archivio, ma i nuovi post, a partire dal rapporto letture di fine 2024, saranno su substack.
Raggiungetemi lì se volete proseguire la vostra UtM experience per altri dieci anni.
Rapporto letture - Novembre/Dicembre 2024
Con questo post non solo chiudiamo l’anno appena (cioè tre settimane fa) trascorso, ma chiudiamo anche la lunga e calante stagione del precedente blog su blogspot. Unknown to Millions da oggi è su substack, perché la piattaforma blog di google è ormai disabitata da anni, mentre questa sembra invece avere una diffusione ben più ampia. Visto che i post che scrivo sostanzialmente sono gli stessi, why not. Vi potete anche iscrivere così vi arrivano come newsletter. Ho comunque importato tutti i post precedenti, quindi l’archivio di UtM è tutto qui, ma magari i post non sono indicizzati e i link interni rimandano comunque al vecchio blog, quindi vabbuò quello rimane lì, ma ormai in disuso. Vedremo se questa nuova piattaforma durerà altrettanto.
Detto questo, iniziamo, ché ce n’è diversi di cui parlare.
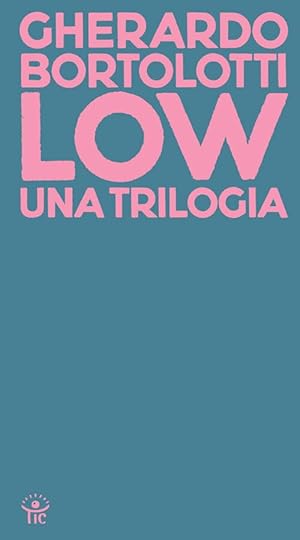
Iniziamo con Low - una trilogia, un… libro di Gherardo Bortolotti pubblicato da Tic Edizioni. Fatico a dare una definizione perché non lo si può considerare un romanzo, è una serie di “testi” divisa in tre parti. La prima è una parte abbastanza generica in cui sono descritte sensazioni, scene, attimi, tutti afferenti a un certo senso di nostalgia, inadeguatezza, straniamento per l’epoca contemporanea. Fortunatamente la cura del testo e la ricchezza delle immagini ci salva dall’effetto pensierini alla Fabio Volo. La seconda parte è una sequenza di similitudini molto interessanti, da cui infatti ho preso spunto anche per un video sul canale. Infine l’ultima racconta di un contatto alieno e delle conseguenze a lungo termine, ma sempre con un questa forma di sequenze scomposte e un grande senso di tragedia cosmica. Un libro che si potrebbe definire sperimentale, ma che comunque trasmette qualcosa. Non esprimo un voto perché è qualcosa che esula dai parametri, ma nonostante lo spaesamento iniziale l’ho apprezzato.

La lettura allegra del momento storico è stata White Power, un saggio di Stefano Tevini pubblicato da Red Star Press che indaga sulla sottocultura della narrativa distopica/postapocalittica del movimento suprematista bianco negli USA. A partire da alcuni testi fondamentali (che Tevini ha letto tutti) si traccia un interessante percorso che spiega anche molti aspetti delle attuali tendenze politiche americane. Non mi dilungo troppo perché abbiamo parlato con Tevini in una puntata del podcast, per cui potete recuperare quella per dettagli sulla scrittura e sugli argomenti trattati. Nonostante la pesantezza del tema, la ritengo una lettura importante per comprendere certi fenomeni che non possiamo ignorare.
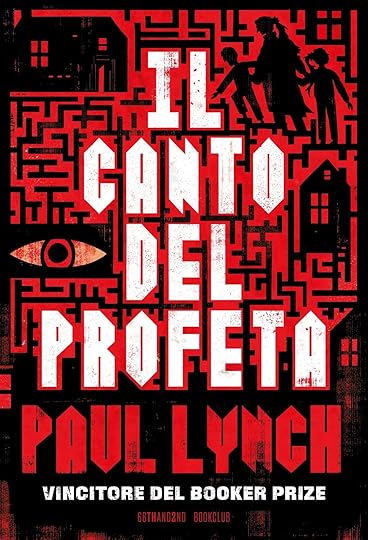
Per rincarare la dose, praticamente in parallelo al precedente ho letto anche Il canto del profeta, romanzo dell’anno scorso di Paul Lynch (portato in italia da 66th2nd) che racconta le vicende di una famiglia inglese che subisce l’oppressione di un prossimo governo autoritario. Non sono ben specificate le circostanze che portano questo regime al potere, ma i dissidenti e potenziali nemici vengono prelevati e la protagonista si trova a dover portare avanti dopo che il marito sindacalista non fa ritorno a casa. La lettura è angosciante e forse nelle prime fasi un po’ ripetitiva, resa meno facile anche da uno stile che è interamente costituito di muri di testo. Quanto a valore come distopia non aggiunge molto a quelle classiche, ma la riesce comunque a trasmettere il senso di impotenza di una situazione del genere. Voto: 6.5/10
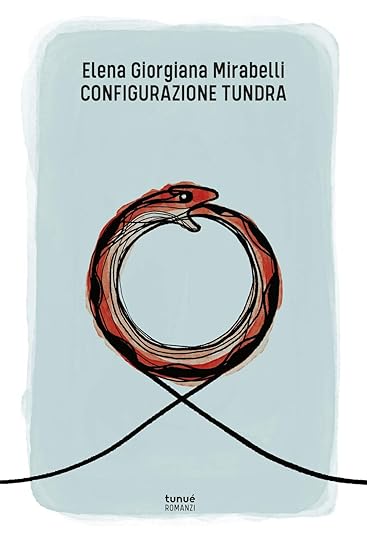
Il romanzo d’esordio di Elena Giorgiana Mirabelli ce l’avevo già da diversi anni ma per una cosa o l’altra non l’avevo ancora letto. Si potrebbe definire Configurazione Tundra pubblicato da Tunué come il primo (a mio conoscenza) romanzo di speculative architecture perché la storia ruota intorno all’esistenza di città perfette autosufficienti e all’architetta che le ha progettate. Ma in realtà questo è un elemento di contesto da cui si parte per una biografia indiretta, ricostruita attraverso gli effetti personali trovati in casa da una nuova inquilina. La narrazione salta continuamente, descrivendo momenti e personaggi diversi, andando a comporre un puzzle di tessere che si incastrano ma sembrano formare immagini differenti. Si percepisce che la parziale incomprensibilità fosse nelle intenzioni dell’autrice, e in questo senso credo che lo si possa inserire nella vaga categoria della narrativa ergodica. Voto: 7/10
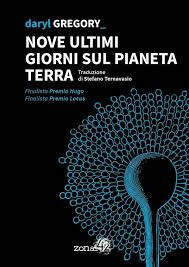
Siccome ero in periodo di recuperi, mi sono andato a prendere anche uno dei primi Nodi di Zona 42 (nel senso che è proprio tra i primi che hanno pubblicato) che ancora non avevo letto. Peraltro Daryl Gregory è uno di quegli autori che ogni volta che lo leggo mi dico “wow questo mi piace proprio devo leggere altro” e poi me ne dimentico, tanto che l’ultimo libro che ho letto è di più di cinque anni fa. Nove ultimi giorni sul pianeta Terra me l’ha confermato, sia per il concept per la forma di scrittura: il racconto di un’invasione “vegetale” con forme di vita arboree che precipitano sulla Terra e iniziano a svilupparsi e colonizzarla, e non si sa bene se sono una minaccia o no. Il tutto raccontato con brevi episodi distanziati di diversi anni nella vita del protagonista, dall’infanzia alla vecchiaia. Una storia che nasconde una lore profondissima ma non si perde a investigare tutti gli angoli, perché quello che conta sono le vite delle persone. Il tipo di fantascienza che preferisco. Devo ricordarmi di Gregory, mannaggia. Voto: 7.5/10
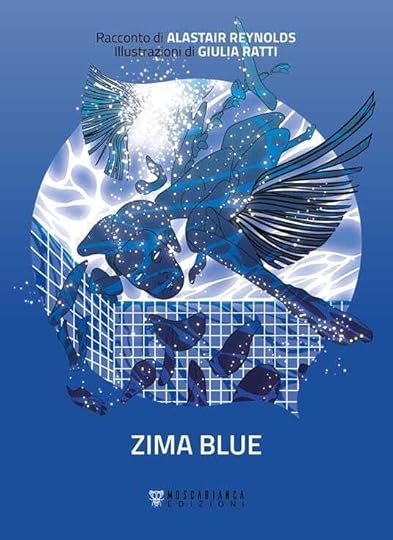
E di quella via, già che ero a leggere novelle, mi sono sciroppato al volo anche Zima Blue, che sicuramente conoscete dalla serie Love Death + Robots di Netflix, ma che qui è stato tradotto per la prima volta da Moscabianca in uno dei volumi illustrati. C’è poco che si può dire sul racconto di Alastair Reynolds senza spoilerarlo o senza che lo sappiate già. Di interessante il racconto rispetto all’episodio ha una conversazione più approfondita di Zima con la giornalista, che si concentra maggiormente sul senso dell’arte, e che è sicuramente importante per comprendere il senso profondo della storia. Voto: 8/10

Avevo approcciato Sinder di Franz Palermo (Acheron books) come detox leggero da letture impegnative (potete vederle tornando verso l’alto), e in buona parte è ciò che ho avuto. La storia di un trentenne mollato dopo dieci anni di relazione che torna al paese e per spassarsela un po’ sei iscrive a un’app di incontri su cui le ragazze sono fin troppo disponibili. Ragazze che in circostanze normali ti risponderebbero “neanche morta” su Sinder invece fanno il primo passo… perché per l’appunto sono morte, anime dannate costrette da un patto infernale a corrompere i giovanotti. Scritto in stile colloquiale e scanzonato, con tanto dialetto e tanti trimoni, non manca però di un livello di profondità nel processo di accettazione della fine di una relazione. Voto: 7/10
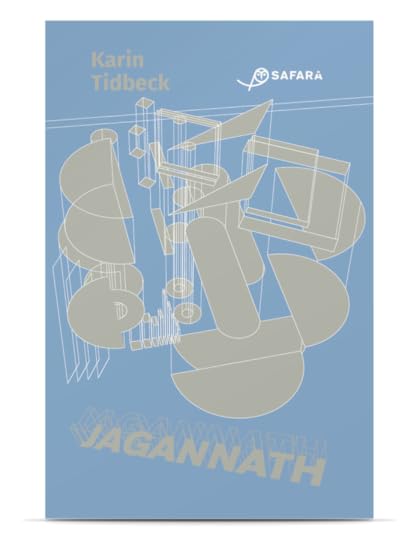
E mo’ che ti posso dire di Jagannath, la raccolta di racconti di Karin Tidbeck pubblicata da Safarà? Veramente difficile da inquadrare, siamo senza dubbio nel campo del new weird, da alcune parti tendende più alla fantascienza e in altre più all’horror, con elementi di folklore e altri di surrealismo. Ma davvero, è difficile descrivere cosa si trova in questi racconti, anche perché alcuni dei temi più ricorrenti sono tra i miei trigger, come gravidanza parto maternità. Me la cavo meglio con il cannibalismo, qui ampiamente rappresentato. Racconti fuori di testa ma che incidono bene nella carne. Voto: 7.5/10

Ho concluso l’anno con il corposo saggio storico/critico sul fantasi di Gloria Bernareggi/Sephira Riva pubblicato da Lumien. Anatomia del fantasy è una guida vasta e per quanto possibile completa (impossibile perseguire la completezza totale), che affronta la letteratura fantasy in un’ottica contemporanea, dichiaratemente intersezionale. Dalla definizione del genere all’elenco delle miriadi di sottogeneri, l’esplorazione di topoi e tematiche, la trattazione è ampia e indubbiamente efficace nel fornire una base solida per poter “leggere e scrivere in modo critico”. Forse le parti sulla scrittura mi sono sembrate un po’ generiche, nel senso che molte nozioni sarebbero state facilmente applicabili o riscontrabili in storie non di genere fantasy, e alcuni dei box di contributi esterni li ho trovati un po’ superficiali. Ma vista l’immensità dell’argomento, direi che si tratta di un volume ben fatto, probabilmente adatto più a chi ha meno familiarità col genere e sta iniziando a esplorarlo.
December 28, 2024
Doctor Who Christmas Special 2024 - Joy to the World
Questo episodio ha un dei what-if più moffatiani di sempre: e se le stanze chiuse nelle camere d'albergo portassero da qualche parte? È sicuramente andata che Moffat a un certo punto si è posto questa domanda e a partire da qui ha costruito la sua storia di natale basata sull'idea del "time hotel". Che di natalizio ha ben poco per la verità, ma a questo siamo abbastanza abituati.

Questa probabile genesi è da una parte la forza dell'episodio, perché fornisce un setting stuzzicante in cui svolgere la vicenda, ma dall'altra ne diventa anche il limite, perché si ha l'idea che quello che succede sia piuttosto accessorio e inconsequenziale rispetto al punto di partenza. Infatti il Dottore si trova per caso in questo hotel (non sapeva nemmeno che fosse un hotel intertemporale) e nota per caso l'uomo con la valigetta sospetta. Certo ci sono tanti altri casi in cui alcune storie sono partite senza particolari giustificazioni, è nella natura stessa di DW, ma stavolta la sensazione è che la storia della valigia avrebbe potuto svolgersi ovunque, e non avesse alcun bisogno del time hotel, che quindi rimane a suo modo inutilizzato, se non per un breve momento di confronto tra due Dottori di epoche diverse.
Un'altra cosa che non funziona benissimo è la presunta companion occasionale dell'episodio, la tizia random che si trova coinvolta nell'avventura ma che, a conti fatti, ha davvero poco da aggiungere e probabilmente non ha capito niente di quello che è successo. Il paradosso è che l'altra tizia random con cui il Dottore si trova a passare un anno ha invece un impatto molto più decisivo su di lui, tanto che si arriva a considerarla "companion material". Il finale strappalacrime è un po' telefonato e nemmeno molto guadagnato, non è chiaro con quali facoltà (a parte la magia del natale) la tipa abbia trovato la capacità di detonare come stella. Sì, anche la cosa che fosse la cometa di Betlemme l'avevo capita subito, è un trucco vecchio e abusato da Arthur Clarke in poi.
Gli episodi di natale in fondo sono sempre abbastanza leggeri (a meno che non siano anche episodi di rigenerazione, come Twice Upon a Time) quindi non c'è molto da lamentarsi, ma forse con le premesse di questa storia si poteva comunque fare di meglio. Voto: 6.5/10
November 10, 2024
Rapporto letture - Settembre/ottobre 2024
Fine estate impegnativa con diverse letture forzate per impegni e un paio di discorsi antipatici che mi tocca fare e porteranno ad argomenti più estesi, altrove da qui.
 In realtà inizio con un recupero, perché mi ero dimenticato nel rapporto letture precedente che ad agosto avevo letto pure
Solaris
. O meglio, riletto, perché io il capolavoro di Stanislaw Lem lo avevo già letto tanti anni fa, forse troppi, non abbastanza per essere in grado di capirlo davvero. Per questo ho pensato che fosse il caso di provare a rileggerlo (nella nuova traduzione pubblicata da Sellerio) per vedere come mi sembrava adesso che sono forse un po' più maturo del diciannovenne (o anche meno) che lo ha letto la prima volta. E vabbè, che vi devo dire. Mica avete bisogno che vi parli io di questo libro, no? Per me è tutto quello che la fantascienza dovrebbe essere, fare e dire. Lem si conferma una delle mie guide spirituali, l'obiettivo che non raggiungerò mai come scrittore. Sono anche in difficoltà a dare un voto perché, davvero, con che diritto assegno un numero a una cosa del genere.
In realtà inizio con un recupero, perché mi ero dimenticato nel rapporto letture precedente che ad agosto avevo letto pure
Solaris
. O meglio, riletto, perché io il capolavoro di Stanislaw Lem lo avevo già letto tanti anni fa, forse troppi, non abbastanza per essere in grado di capirlo davvero. Per questo ho pensato che fosse il caso di provare a rileggerlo (nella nuova traduzione pubblicata da Sellerio) per vedere come mi sembrava adesso che sono forse un po' più maturo del diciannovenne (o anche meno) che lo ha letto la prima volta. E vabbè, che vi devo dire. Mica avete bisogno che vi parli io di questo libro, no? Per me è tutto quello che la fantascienza dovrebbe essere, fare e dire. Lem si conferma una delle mie guide spirituali, l'obiettivo che non raggiungerò mai come scrittore. Sono anche in difficoltà a dare un voto perché, davvero, con che diritto assegno un numero a una cosa del genere.
 Iniziato durante l'estate ma finito a inizio settembre, Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow è una lettura su cui ero partito con una certa diffidenza. Avevo sentito parlare di questo "romanzo sui videogiochi" di Gabrielle Zevin, ambientato tra la fine degli anni 90 e il 2000, e temevo un'operazione notalgia per millennial scoraggiati. Invece si è rivelato meglio costruito di quello che pensavo, con la storia dei due amici game developer che lavorano assieme dai tempi della scuola fino all'età adulta, perdendosi e ritrovandosi, litigando e facendo pace, mentre il mondo attorno a loro cambia. È un libro che rappresenta bene il rapporto tra due persone che collaborano da una vita, e tra i quali scorre anche un filo di romanticismo che però non trova mai soddisfazione. Mi è sembrato che nella parte finale andasse a forzare un po' la situazione, quando uno dei personaggi secondari fa una brutta fine, mi è sembrato un meccanismo artificioso per portare nuovo conflitto tra i protagonisti, ma in generale è trattato tutto molto bene, con un uso intelligente del narratore onniciente (probabilmente ne parlerò sul canale) e il giusto spazio al game design. E soprattutto, niente notalgia per i perduti anni 90. Voto: 8/10
Iniziato durante l'estate ma finito a inizio settembre, Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow è una lettura su cui ero partito con una certa diffidenza. Avevo sentito parlare di questo "romanzo sui videogiochi" di Gabrielle Zevin, ambientato tra la fine degli anni 90 e il 2000, e temevo un'operazione notalgia per millennial scoraggiati. Invece si è rivelato meglio costruito di quello che pensavo, con la storia dei due amici game developer che lavorano assieme dai tempi della scuola fino all'età adulta, perdendosi e ritrovandosi, litigando e facendo pace, mentre il mondo attorno a loro cambia. È un libro che rappresenta bene il rapporto tra due persone che collaborano da una vita, e tra i quali scorre anche un filo di romanticismo che però non trova mai soddisfazione. Mi è sembrato che nella parte finale andasse a forzare un po' la situazione, quando uno dei personaggi secondari fa una brutta fine, mi è sembrato un meccanismo artificioso per portare nuovo conflitto tra i protagonisti, ma in generale è trattato tutto molto bene, con un uso intelligente del narratore onniciente (probabilmente ne parlerò sul canale) e il giusto spazio al game design. E soprattutto, niente notalgia per i perduti anni 90. Voto: 8/10
 Quelli che seguono sono i tre romanzi finalisti del Premio Mondofuturo, la prima edizione di un premio letterario per romanzi di fantascienza organizzato nell'ambito del Trieste Science+Fiction Festival di cui sono stato giurato. Li ho letti tutti nel corso di settembre perché appunto dovevo fornire la mia valutazione in tempo. Devo ammettere che non è andata benissimo, i tre finalisti (selezionati da una commisione interna) mi sono sembrati tutti poco adeguati, di certo non il meglio che si potesse trovare nella fantascienza italiana del 2023 (di questo ho parlato con la giuria durante le riunioni con la giuria, ed è stato preso in considerazione, per cui non sto accoltellando nessuno alle spalle). Iniziamo dal primo, Prigionieri dell'effimero di Nino Martino, a mio avviso il peggiore in assoluto. Il romanzo è ambientato sul pianeta utopico di Sogno III (che però, in un'occasione diventa inspiegabilmente Mango III, wtf!?), occupato da una comunità che potremmo definire di hippy spaziali dediti ai giochi di ruolo (tanto che obbligano tutti gli stranieri in visita a partecipare a una sessione di roleplay perché così possono tracciare la loro personalità). Su questo pianeta perfetto è avvenuta la morte di una scienziata/poetessa, che si sospetta essere un omicidio ma di cui non si riesce a scoprire moventi e colpevoli. Dell'indagine sono incaricati due fratelli, agenti di una qualche forza d'ordine interplanetaria (e figli dei protagonisti di storie precedenti dell'autore) che sono l'esempio più efficace di bamboccioni privilegiati dal nepotismo. I due protagonisti infatti sono degli inetti totali, non hanno una singola qualità o expertise, non arrivano a una sola deduzione logica ma lasciano che sia la loro IA ginoide (che ha accesso a tutte le informazioni del mondo e capacità di calcolo infinite) a mettere insieme i pezzi, mentre il resto viene svolto in videochiamata dai genitori che se ne stanno nella loro villa a prendere il tè. L'unica cosa che sono in grado di fare i fratelli è punzecchiarsi a vicenda (a volte con uno strano innunendo erotico), chiedere alla IA di fare qualcosa al posto loro, osservare i corpi delle donne (umane o robotiche o olografiche non importa) che per qualche ragione hanno sempre queste vesti leggere che scoprono i seni, e guardare dalla finestra della loro astronave a fine capitolo in modo che si possa concludere con uno scorcio di uccelli che volano contro il tramonto. La parte investigativa pertanto è del tutto assente, priva di qualsiasi tensione perché ogni cosa viene risolta offscreen, piena di red herring che non portano da nessuna parte e risolta poi semplicemente con un interrogatorio. Le brillanti deduzioni proposte sono in realtà le informazioni di base che gli investigatori avrebbero dovuto avere sul caso, per dire che non sapere che la vittima fosse una poetessa di fama interplanetaria con un fandom di cultisti dovrebbe stare nei file dell'indagine, no? E invece. Ci sono sicuramente degli spunti fantascientifici che hanno un qualche valore ma non sono niente di diverso da quello che si leggeva nel 1965 e sono accrocchiati dentro una storia che non ne aveva bisogno, quasi per dare ulteriore "profondità" a una storia che non ne ha. Una cosa che mi ha fatto particolarmente incazzare per la sua illogicità è che la tipa che è stata uccisa (una nigeriana nerissima con i denti bianchissimi, cosa che ci viene fatta notare a ogni occasione) era una biologa che seguiva la terraformazione del pianeta, ma al tempo stesso una poetessa "effimera" nel senso che le sue poesie diffuse in rete avevano un codice intrinseco che le faceva sparire dopo un giorno. Ecco, proprio perché lei usava questo codice di autodistruzione, è capace di ricavare che nel codice genetico delle piante di Sogno III è presente un gene che porta all'autodistruzione nel giro di qualche generazione. Cioè capito, è come dire che siccome so come fare un header in html allora se leggo il DNA di un cammello so quali geni compongono la testa. E tutto ciò riguarda solo quella che è la costruzione della storia, ma la scrittura stessa è di un livello infimo. Ripetitiva, farraginosa ma al tempo stesso vuota, e i dialoghi in particolare sono spesso surreali, i personaggi hanno delle interazioni inconsequenziali, parlano tra loro come se metti Siri e Alexa a rispondersi a vicenda. Inoltre il male gaze per questi corpi sinuosi e capezzoli emerge in ogni capitolo e c'è anche una punta di paradigma colonialista con le razze non bianche ritenute "esotiche". Un romanzo veramente brutto sotto tutti i punti di vista, che non rende assolutamente giustizia al livello della fantascienza contamporanea. Voto: 4/10
Quelli che seguono sono i tre romanzi finalisti del Premio Mondofuturo, la prima edizione di un premio letterario per romanzi di fantascienza organizzato nell'ambito del Trieste Science+Fiction Festival di cui sono stato giurato. Li ho letti tutti nel corso di settembre perché appunto dovevo fornire la mia valutazione in tempo. Devo ammettere che non è andata benissimo, i tre finalisti (selezionati da una commisione interna) mi sono sembrati tutti poco adeguati, di certo non il meglio che si potesse trovare nella fantascienza italiana del 2023 (di questo ho parlato con la giuria durante le riunioni con la giuria, ed è stato preso in considerazione, per cui non sto accoltellando nessuno alle spalle). Iniziamo dal primo, Prigionieri dell'effimero di Nino Martino, a mio avviso il peggiore in assoluto. Il romanzo è ambientato sul pianeta utopico di Sogno III (che però, in un'occasione diventa inspiegabilmente Mango III, wtf!?), occupato da una comunità che potremmo definire di hippy spaziali dediti ai giochi di ruolo (tanto che obbligano tutti gli stranieri in visita a partecipare a una sessione di roleplay perché così possono tracciare la loro personalità). Su questo pianeta perfetto è avvenuta la morte di una scienziata/poetessa, che si sospetta essere un omicidio ma di cui non si riesce a scoprire moventi e colpevoli. Dell'indagine sono incaricati due fratelli, agenti di una qualche forza d'ordine interplanetaria (e figli dei protagonisti di storie precedenti dell'autore) che sono l'esempio più efficace di bamboccioni privilegiati dal nepotismo. I due protagonisti infatti sono degli inetti totali, non hanno una singola qualità o expertise, non arrivano a una sola deduzione logica ma lasciano che sia la loro IA ginoide (che ha accesso a tutte le informazioni del mondo e capacità di calcolo infinite) a mettere insieme i pezzi, mentre il resto viene svolto in videochiamata dai genitori che se ne stanno nella loro villa a prendere il tè. L'unica cosa che sono in grado di fare i fratelli è punzecchiarsi a vicenda (a volte con uno strano innunendo erotico), chiedere alla IA di fare qualcosa al posto loro, osservare i corpi delle donne (umane o robotiche o olografiche non importa) che per qualche ragione hanno sempre queste vesti leggere che scoprono i seni, e guardare dalla finestra della loro astronave a fine capitolo in modo che si possa concludere con uno scorcio di uccelli che volano contro il tramonto. La parte investigativa pertanto è del tutto assente, priva di qualsiasi tensione perché ogni cosa viene risolta offscreen, piena di red herring che non portano da nessuna parte e risolta poi semplicemente con un interrogatorio. Le brillanti deduzioni proposte sono in realtà le informazioni di base che gli investigatori avrebbero dovuto avere sul caso, per dire che non sapere che la vittima fosse una poetessa di fama interplanetaria con un fandom di cultisti dovrebbe stare nei file dell'indagine, no? E invece. Ci sono sicuramente degli spunti fantascientifici che hanno un qualche valore ma non sono niente di diverso da quello che si leggeva nel 1965 e sono accrocchiati dentro una storia che non ne aveva bisogno, quasi per dare ulteriore "profondità" a una storia che non ne ha. Una cosa che mi ha fatto particolarmente incazzare per la sua illogicità è che la tipa che è stata uccisa (una nigeriana nerissima con i denti bianchissimi, cosa che ci viene fatta notare a ogni occasione) era una biologa che seguiva la terraformazione del pianeta, ma al tempo stesso una poetessa "effimera" nel senso che le sue poesie diffuse in rete avevano un codice intrinseco che le faceva sparire dopo un giorno. Ecco, proprio perché lei usava questo codice di autodistruzione, è capace di ricavare che nel codice genetico delle piante di Sogno III è presente un gene che porta all'autodistruzione nel giro di qualche generazione. Cioè capito, è come dire che siccome so come fare un header in html allora se leggo il DNA di un cammello so quali geni compongono la testa. E tutto ciò riguarda solo quella che è la costruzione della storia, ma la scrittura stessa è di un livello infimo. Ripetitiva, farraginosa ma al tempo stesso vuota, e i dialoghi in particolare sono spesso surreali, i personaggi hanno delle interazioni inconsequenziali, parlano tra loro come se metti Siri e Alexa a rispondersi a vicenda. Inoltre il male gaze per questi corpi sinuosi e capezzoli emerge in ogni capitolo e c'è anche una punta di paradigma colonialista con le razze non bianche ritenute "esotiche". Un romanzo veramente brutto sotto tutti i punti di vista, che non rende assolutamente giustizia al livello della fantascienza contamporanea. Voto: 4/10
 Secondo libro della tornata era
Il dio elettrico
, del pressoché esordiente Federico Tamanini. Qui la storia inizia da una IA globale che prende il controllo e decreta che la sopravvivenza dell'umanità richiede dei sacrifici, impone quindi a ogni nazione di scegliere una possibile strada per evitare l'estinzione: vita sotterranea, svolta ambientalista, emigrazione su Marte ecc. La premessa, per quanto certo non originale, ha comunque un potenziale, perché conduce a un mondo diviso in zone in cui ognuna pratica una strada diversa sotto il giogo di quest'entità malevola, un po' come se AM di Harlan Ellison per qualche motivo avesse a cuore la continuazione dell'umanità ma non perdesse il suo odio per i creatori. Purtroppo a partire da qui la trama si fa dispersiva, con un tentativo di romanzo corale che però rimane solo fuori fuoco, dato che le vicende di buona parte dei personaggi non hanno nessun impatto sulla storia e si concludono senza una vera risoluzione. Inoltre il finale è un deus ex machina, con l'IA onnipotente che viene battuta perché il suo programmatore aveva già previsto un codice per disattivarla alla bisogna e doveva solo trovare il modo di avvicinarsi, per cui tutte le azioni costruite fino a quel momento appaiono del tutto irrilevanti dato che la soluzione c'era già. Di buono c'è che alcune sequenze di azione sono condotte benino e alcuni personaggi hanno storie personali abbastanza interessanti, ma tutto ciò rimane annacquato nella mediocrità del resto. La scrittura anche qui ha difetti macroscopici, con sezioni di infodump (una in apertura al libro che descrive tutta la situazione, tanto che sembrava il riassunto della stagione precedente di una serie tv. Inoltre ci sono problemi di sintassi, spesso nei dialoghi non si capisce chi parla i soggetti delle frasi balzano da una frase all'altra, e anche le mere convenzioni tipografiche sono ignorate, per esempio nella formattazione dei dialoghi. Una convenzione banale come quella di usare il corsivo per i pensieri inframezzati ai dialoghi qui è ribaltata, con i dialogue tag che decrivono le battute in corsivo, e i pensieri tra virgolette (wtf!?). Roba che basterbbe aver letto due libri negli ultimi trent'anni per aver notato come viene svolta di solito. Naturalmente su questi aspetti la responsabilità va imputata all'editore, perché se decidi di pubblicare un testo che magari ha delle imperfezioni tecniche, ti incarichi di metterlo a posto, e invece qui non è successo. Nel complesso non mi sento di squalificare troppo il libro, perché l'autore è alle prime armi e qualche spunto interessante è presente. Questo è uno dei casi in cui l'intervento di un buon editor avrebbe potuto tirare fuori da un'opera grezza e approssimativa un prodotto quanto meno discreto. Non posso assegnargli la sufficienza ma ho una moderata fiducia nelle possibilità di Tamanini, se avrà la pazienza di mettersi a studiare e lavorare meglio sui suoi testi. Voto: 5/10
Secondo libro della tornata era
Il dio elettrico
, del pressoché esordiente Federico Tamanini. Qui la storia inizia da una IA globale che prende il controllo e decreta che la sopravvivenza dell'umanità richiede dei sacrifici, impone quindi a ogni nazione di scegliere una possibile strada per evitare l'estinzione: vita sotterranea, svolta ambientalista, emigrazione su Marte ecc. La premessa, per quanto certo non originale, ha comunque un potenziale, perché conduce a un mondo diviso in zone in cui ognuna pratica una strada diversa sotto il giogo di quest'entità malevola, un po' come se AM di Harlan Ellison per qualche motivo avesse a cuore la continuazione dell'umanità ma non perdesse il suo odio per i creatori. Purtroppo a partire da qui la trama si fa dispersiva, con un tentativo di romanzo corale che però rimane solo fuori fuoco, dato che le vicende di buona parte dei personaggi non hanno nessun impatto sulla storia e si concludono senza una vera risoluzione. Inoltre il finale è un deus ex machina, con l'IA onnipotente che viene battuta perché il suo programmatore aveva già previsto un codice per disattivarla alla bisogna e doveva solo trovare il modo di avvicinarsi, per cui tutte le azioni costruite fino a quel momento appaiono del tutto irrilevanti dato che la soluzione c'era già. Di buono c'è che alcune sequenze di azione sono condotte benino e alcuni personaggi hanno storie personali abbastanza interessanti, ma tutto ciò rimane annacquato nella mediocrità del resto. La scrittura anche qui ha difetti macroscopici, con sezioni di infodump (una in apertura al libro che descrive tutta la situazione, tanto che sembrava il riassunto della stagione precedente di una serie tv. Inoltre ci sono problemi di sintassi, spesso nei dialoghi non si capisce chi parla i soggetti delle frasi balzano da una frase all'altra, e anche le mere convenzioni tipografiche sono ignorate, per esempio nella formattazione dei dialoghi. Una convenzione banale come quella di usare il corsivo per i pensieri inframezzati ai dialoghi qui è ribaltata, con i dialogue tag che decrivono le battute in corsivo, e i pensieri tra virgolette (wtf!?). Roba che basterbbe aver letto due libri negli ultimi trent'anni per aver notato come viene svolta di solito. Naturalmente su questi aspetti la responsabilità va imputata all'editore, perché se decidi di pubblicare un testo che magari ha delle imperfezioni tecniche, ti incarichi di metterlo a posto, e invece qui non è successo. Nel complesso non mi sento di squalificare troppo il libro, perché l'autore è alle prime armi e qualche spunto interessante è presente. Questo è uno dei casi in cui l'intervento di un buon editor avrebbe potuto tirare fuori da un'opera grezza e approssimativa un prodotto quanto meno discreto. Non posso assegnargli la sufficienza ma ho una moderata fiducia nelle possibilità di Tamanini, se avrà la pazienza di mettersi a studiare e lavorare meglio sui suoi testi. Voto: 5/10
 L'ultimo finalista del premio è considerato uno dei maggiori esponenti della fantascienza italiana, e apaprtiene a quella cerchia di "autori urania" che spesso vengono presi a rappresentaione dell'intera scena fantascientifica. Di Piero Schiavo Campo credo di aver letto un paio di racconti (sulle antologie estive di questi anni) ma Il viaggio della Electra Persei è il primo romanzo. Anche questo si apre con un lungo infodump che è letteralmente il riassunto delle puntate precedenti perché fa riferimento a fatti e nozioni derivanti da Il sigillo del serpente piumato, con cui questo romanzo condivide l'ambientazione in una galassia che sfrutta il paradigma della simulazione, in cui esistono esseri e poteri sovrannaturali che corrispondono agli sviluppatori del nostro universo. In questo la storia si svolge come una space opera classica, con protagonsita un diplomatico che si ritrova coinvolto in traffici loschi e assiste alla distruzione della Terra. Per ripristinare il pianeta natale deve accettare la sfida di uno di questi esseri superuniversali, che sfortunatamente anche qui si conclude con l'intervento di un deus ex machina... indovina? Un'IA superintelligente, anche qui. Ci sono idee interessanti, come gli scacchi infiniti e il pianeta che riproduce l'inferno dantesco, ma anche questi sembrano rimanere al livello di curiosità, non sono mai troppo approfonditi e integrali nella vicenda. La narrazione ogni tot capitoli viene interrotta da parti in cui una voce narrante (quella dell'autore?) illustra alcune nozioni sul multiverso, la probabilità, i viaggi nel tempo ecc. Informazioni interessanti, che però non è chiaro come si inquadrino nella vicenda complessiva, da che punto della storia derivino e sembrano del tutto extradiegetiche, quando ci sarebbe stato modo di farle emergere dalla storia. Nel complesso questo è un romanzo leggibile, la scrittura è precisa e pervasa da un velo d'ironia che la rende piacevole, ma non brilla sicuramente né per innovazione né per stile, sembra un po' di leggere certe cose che scriveva Farmer negli anni 60. Voto: 6/10
L'ultimo finalista del premio è considerato uno dei maggiori esponenti della fantascienza italiana, e apaprtiene a quella cerchia di "autori urania" che spesso vengono presi a rappresentaione dell'intera scena fantascientifica. Di Piero Schiavo Campo credo di aver letto un paio di racconti (sulle antologie estive di questi anni) ma Il viaggio della Electra Persei è il primo romanzo. Anche questo si apre con un lungo infodump che è letteralmente il riassunto delle puntate precedenti perché fa riferimento a fatti e nozioni derivanti da Il sigillo del serpente piumato, con cui questo romanzo condivide l'ambientazione in una galassia che sfrutta il paradigma della simulazione, in cui esistono esseri e poteri sovrannaturali che corrispondono agli sviluppatori del nostro universo. In questo la storia si svolge come una space opera classica, con protagonsita un diplomatico che si ritrova coinvolto in traffici loschi e assiste alla distruzione della Terra. Per ripristinare il pianeta natale deve accettare la sfida di uno di questi esseri superuniversali, che sfortunatamente anche qui si conclude con l'intervento di un deus ex machina... indovina? Un'IA superintelligente, anche qui. Ci sono idee interessanti, come gli scacchi infiniti e il pianeta che riproduce l'inferno dantesco, ma anche questi sembrano rimanere al livello di curiosità, non sono mai troppo approfonditi e integrali nella vicenda. La narrazione ogni tot capitoli viene interrotta da parti in cui una voce narrante (quella dell'autore?) illustra alcune nozioni sul multiverso, la probabilità, i viaggi nel tempo ecc. Informazioni interessanti, che però non è chiaro come si inquadrino nella vicenda complessiva, da che punto della storia derivino e sembrano del tutto extradiegetiche, quando ci sarebbe stato modo di farle emergere dalla storia. Nel complesso questo è un romanzo leggibile, la scrittura è precisa e pervasa da un velo d'ironia che la rende piacevole, ma non brilla sicuramente né per innovazione né per stile, sembra un po' di leggere certe cose che scriveva Farmer negli anni 60. Voto: 6/10
 Chiuso il sottocapitolo del premio, passiamo ad altre letture. Avevo fatto un po' indigestione di fantascienza per cui mi sono dovuto disintossicare e ho pensato di farlo con
Bugifera
, l'ultimo capitolo della saga del Regno di Taglia di Jack Sensolini e Luca Mazza. Se vi ricordate qualche mese fa avevo letto Apocalemme e mi aveva conquistato, e il fatto che a così breve distanza abbia letto il successivo mi sembra rivelatorio. Bugifera chiude l'esalogia (novelle incluse) iniziata con Vilupera qualche anno fa, e riprende dalla fine del precedente, con la guerra infernale che sta per travolgere tutto il Regno. A opporsi alla discesa dei demoni ci sono i Fratelli di Taglia, soldati rinnegati che si incaricano di combattere la guerra che il re aveva cercato di condurre da solo. La storia segue due piani principali, uno con i preparativi alla guerra (che intrecciano molte delle vicende e personaggi incontrati nei volumi precedenti) e l'altro con la processione (Via Trucis) con cui uno dei protagonisti viene torturato per compiere un rito demoniaco che porterà all'evocazione dell Bugifera, la "Fiera del Vespro" che dovrebbe portare il mondo alla rovina totale. Come hanno già dimostrato, gli autori hanno uno stile unico e un'intensità rara nel raccontare le gesta di derelitti e antieroi, che come dicevo per Apocalemme bilancia dramma e farsa in un modo impeccabilel che mi ricorda i migliori spaghetti western. In questo caso devo ammettere che mi è piaciuta di più la parte di processione/rituale, che ha dei momenti di estrema truculenza ma mantiene il tono epico/biblico, mentre la guerra è forse un po' affrettata nelle parti iniziali, ma diventa poi più convincente andando avanti. Nel complesso si respira un'atmosfera quasi nostalgica, si percepisce che quella che stiamo leggendo è la fine di qualcosa (di una saga, di un'era, di un regno, e di tante persone) e questo lo rende a suo modo diverso da tutti i precedenti. Apocalemme rimane il mio preferito ma questo è una più che degna conclusione. Voto: 8/10
Chiuso il sottocapitolo del premio, passiamo ad altre letture. Avevo fatto un po' indigestione di fantascienza per cui mi sono dovuto disintossicare e ho pensato di farlo con
Bugifera
, l'ultimo capitolo della saga del Regno di Taglia di Jack Sensolini e Luca Mazza. Se vi ricordate qualche mese fa avevo letto Apocalemme e mi aveva conquistato, e il fatto che a così breve distanza abbia letto il successivo mi sembra rivelatorio. Bugifera chiude l'esalogia (novelle incluse) iniziata con Vilupera qualche anno fa, e riprende dalla fine del precedente, con la guerra infernale che sta per travolgere tutto il Regno. A opporsi alla discesa dei demoni ci sono i Fratelli di Taglia, soldati rinnegati che si incaricano di combattere la guerra che il re aveva cercato di condurre da solo. La storia segue due piani principali, uno con i preparativi alla guerra (che intrecciano molte delle vicende e personaggi incontrati nei volumi precedenti) e l'altro con la processione (Via Trucis) con cui uno dei protagonisti viene torturato per compiere un rito demoniaco che porterà all'evocazione dell Bugifera, la "Fiera del Vespro" che dovrebbe portare il mondo alla rovina totale. Come hanno già dimostrato, gli autori hanno uno stile unico e un'intensità rara nel raccontare le gesta di derelitti e antieroi, che come dicevo per Apocalemme bilancia dramma e farsa in un modo impeccabilel che mi ricorda i migliori spaghetti western. In questo caso devo ammettere che mi è piaciuta di più la parte di processione/rituale, che ha dei momenti di estrema truculenza ma mantiene il tono epico/biblico, mentre la guerra è forse un po' affrettata nelle parti iniziali, ma diventa poi più convincente andando avanti. Nel complesso si respira un'atmosfera quasi nostalgica, si percepisce che quella che stiamo leggendo è la fine di qualcosa (di una saga, di un'era, di un regno, e di tante persone) e questo lo rende a suo modo diverso da tutti i precedenti. Apocalemme rimane il mio preferito ma questo è una più che degna conclusione. Voto: 8/10
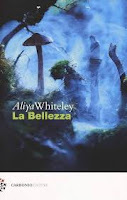 La bellezza è un libro che mi era stato segnalto fin dall'uscita perché parla di funghi che contaminano e ibridano gli umani, e l'ho finalmente letto (in preparazione del podcast sui funghi) e posso dire che sì, ha molti tratti in comune col mio Spore (che però è uscito prima, ecco). In questo romanzo Aliya Whiteley racconta di un mondo in cui le donne sono scomparse, e una piccola comunità di soli uomini viene visitata da donne-fungo che diventano compagne e amanti, perché si sa, gli uomini scoperebbero qualsiasi cosa con una parvenza di mammelle. Il romanzo si inserisce nel filone new weird, con tanti discorsi su questa "bellezza" che visita l'uomo e come la comunità viene cambiata dall'incontro, non necessariamente positivo visto il potere seduttivo quasi soprannaturale di questi funghi le cui intenzioni non sono ben chiare (e come potrebbero esserlo, sono funghi). Un buon romanzo, a mio avviso un po' preveidbile, ma forse perché sono abituato a questo tipo di storie e forse anche perché l'avevo già scritta prima io. Voto: 7.5/10
La bellezza è un libro che mi era stato segnalto fin dall'uscita perché parla di funghi che contaminano e ibridano gli umani, e l'ho finalmente letto (in preparazione del podcast sui funghi) e posso dire che sì, ha molti tratti in comune col mio Spore (che però è uscito prima, ecco). In questo romanzo Aliya Whiteley racconta di un mondo in cui le donne sono scomparse, e una piccola comunità di soli uomini viene visitata da donne-fungo che diventano compagne e amanti, perché si sa, gli uomini scoperebbero qualsiasi cosa con una parvenza di mammelle. Il romanzo si inserisce nel filone new weird, con tanti discorsi su questa "bellezza" che visita l'uomo e come la comunità viene cambiata dall'incontro, non necessariamente positivo visto il potere seduttivo quasi soprannaturale di questi funghi le cui intenzioni non sono ben chiare (e come potrebbero esserlo, sono funghi). Un buon romanzo, a mio avviso un po' preveidbile, ma forse perché sono abituato a questo tipo di storie e forse anche perché l'avevo già scritta prima io. Voto: 7.5/10
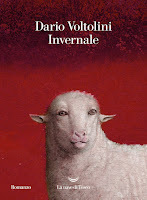 Infine mi sono letto un quasi Premio Strega, ci credete?
Invernale
è stato finalista all'ultima edizione e ho dovuto leggerlo per presentare Dario Voltolini a Pistoia. In realtà non sapevo bene cosa aspettarmi e forse se l'avessi saputo non avrei accettato. Non perché il libro non sia valido, ma perché tocca temi a cui sono fin troppo sensibile. È la storia della malattia del padre dell'autore, scritta in occasione del quarantesimo anniversario della morte dell'autore. Questo è un argomento che non riesco ad affrontare con lucidità (vi ricordate
La strada
?) ma al di là della mia sensibilità posso dire che il libro (che non so se si può classificare come romanzo, è quasi una cronaca, non è costruito come una storia) è scritto con grande maestria e colpisce dove deve. È una lettura che per chi ha vissuto un'esperienza del genere può essere traumatica o terapeutica. Non so se consigliravelo, decidete voi. Non posso dare un voto in casi come questo.
Infine mi sono letto un quasi Premio Strega, ci credete?
Invernale
è stato finalista all'ultima edizione e ho dovuto leggerlo per presentare Dario Voltolini a Pistoia. In realtà non sapevo bene cosa aspettarmi e forse se l'avessi saputo non avrei accettato. Non perché il libro non sia valido, ma perché tocca temi a cui sono fin troppo sensibile. È la storia della malattia del padre dell'autore, scritta in occasione del quarantesimo anniversario della morte dell'autore. Questo è un argomento che non riesco ad affrontare con lucidità (vi ricordate
La strada
?) ma al di là della mia sensibilità posso dire che il libro (che non so se si può classificare come romanzo, è quasi una cronaca, non è costruito come una storia) è scritto con grande maestria e colpisce dove deve. È una lettura che per chi ha vissuto un'esperienza del genere può essere traumatica o terapeutica. Non so se consigliravelo, decidete voi. Non posso dare un voto in casi come questo.November 5, 2024
Fantascienza - Storia delle storie del futuro
Dopo quindici anni di carriera è strano poter dire che sta uscendo di nuovo il "mio primo libro". Perché Fantascienza - Storia delle storie del futuro è in effetti una prima volta per me, perché è la mia prima pubblicazione non di narrativa. Ed è anche la prima volta che non scrivo da solo ma in coppia con Angela Bernardoni, con cui immagino sappiate già, collaboro già da diversi anni per articoli, podcast e riviste.

Di fatto FSSF (come lo chiameremo d'ora in poi) è nata proprio come evoluzione di una serie di episodi di Reading Wildlife in cui abbiamo ripercorso la storia della fantascienza. L'esigenza nasce dal fatto che, ci siamo accorte, là fuori non c'è tanto materiale disponibile e facilmente fruibile per chi volesse farsi una rapida e sommaria cultura di fantascienza letteraria. Ovvio che ci sono saggi, articoli e wiki, ma sono fonti dispersive e spesso troppo vaghe o troppo specifiche, e per chi non ha familiarità e interesse già maturato rispetto al genere è facile lasciarsi sopraffare e mollare tutto. Soprattutto per lettori giovani e volenterosi, ma poco pazienti.
FSSF non è un testo per specialisti, ma piuttosto un "Fantascienza for dummies" che abbiamo voluto dedicare a chi ha interesse a scoprire questo genere ma non l'ha mai fatto, o per chi è rimasto al 1984 o per chi non è ancora sicura che la fantascienza le piaccia o no. Abbiamo tracciato un percorso storico/critico che procede in ordine cronologico, dalla proto-protofantascienza fino al solarpunk, parlando di movimenti, tendenze, correnti, topoi, autori, autrici, titoli, premi. E anche problemi, limiti, dubbi, perché ci sono anche quelli, da sempre, ed è bene che siano espressi.
Quello che vogliamo fare è rendere la fantascienza accessibile anche a chi non la frequnta quotidianamente, come facciamo noi da tanto tempo, e non si rende conto che da fuori è difficile capire di cosa stiamo parlando. Anche per questo la pubblicazione con Armillaria, casa editrice non di genere, che si dedica alla saggistica di temi vari, serve a portare questa materia al di fuori del solito giro.
Fantascienza - Storia delle storie del futuro sarà disponibile in libreria dal 28 novembre, ma è già preordinabile sul sito dell'editore.
October 20, 2024
Rapporto letture - Luglio/agosto 2024
Sono talmente in ritardo con questi rapporti che potrei farli diventare trimestrali. Ma questa estate, e in particolare il periodo a cavallo tra agosto e settembre, è stata particolarmente faticosa e stressante, quindi anche se ho letto abbastanza non ho avuto moltissimo tempo da dedicare a un post di commenti approfonditi e il poco tempo che avevo per il blog l'ho dedicato ai commenti su Futurama che capirete bene hanno la priorità. Comunque è stata un'estate non solo di letture per "piacere" ma anche per ricerca, per scopi che vi saranno presto chiariti.
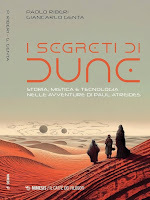 Visto che quest'anno non avevo consumato abbastana Dune (chissà come farò il prossimo) uno dei libri consumati in questi mesi è stato
I segreti di Dune
, un saggio di Paolo Riberi e Giancarlo Genta che approfondisce molti aspetti della costruzione e della lore del romanzo di Frank Herbert (principalmente il primo, ma con accenni anche al resto della serie originale). Vengono esaminati aspetti come le ispirazini storiche e letterarie, la visione religione e filosofica, la politica e la tecnologia. Molti dei riferimenti citati li conoscevo o li avevo comunque sentiti, ma ce ne sono stati alcuni che mi sono suonati del tutto nuovi e anche molto interessanti. In particolare tutta la questione del legame con l'islam e in particolare per alcune specifiche correnti, che non avevo mai approfondito. Ovviamente si tratta di un saggio per appassionati e addetti ai lavori, e il fan occasionale probabilmente faticherebbe ad assimilarlo, ma visto che a Shai Hulud piacendo rientro nella prima categoria, l'ho trovato affascinante e illuminante.
Visto che quest'anno non avevo consumato abbastana Dune (chissà come farò il prossimo) uno dei libri consumati in questi mesi è stato
I segreti di Dune
, un saggio di Paolo Riberi e Giancarlo Genta che approfondisce molti aspetti della costruzione e della lore del romanzo di Frank Herbert (principalmente il primo, ma con accenni anche al resto della serie originale). Vengono esaminati aspetti come le ispirazini storiche e letterarie, la visione religione e filosofica, la politica e la tecnologia. Molti dei riferimenti citati li conoscevo o li avevo comunque sentiti, ma ce ne sono stati alcuni che mi sono suonati del tutto nuovi e anche molto interessanti. In particolare tutta la questione del legame con l'islam e in particolare per alcune specifiche correnti, che non avevo mai approfondito. Ovviamente si tratta di un saggio per appassionati e addetti ai lavori, e il fan occasionale probabilmente faticherebbe ad assimilarlo, ma visto che a Shai Hulud piacendo rientro nella prima categoria, l'ho trovato affascinante e illuminante.
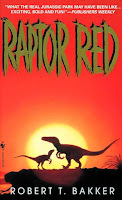
Per rimanere nello stereotipo della mia personalità dichiarata, dopo Dune passiamo ai dinosauri. Mi sono infatti deciso a leggere un piccolo cult dei dinomaniaci, il romanzo scritto dal paleontologo Robert Bakker con protagonista un'utahraptor. Raptor Red è stato un piccolo fenomeno all'epoca, certo non un successo mondiale (anche se comunque si è difeso benissimo) ma insomma un libro di cui si è parlato molto negli ambienti della paleontologia e affini. La storia della raptor rimasta sola, che deve lottare per sopravvivere nell'inospitale Utah di 120 milioni di anni per poi ricostruirsi una famiglia, è costruita proprio come uno di quei documentari "narrativi" più avvincenti, solo con gli animali del mesozoico. Raptor Red è la protagonsita ma i capitoli spesso si dedicano ad altre creature sue coeve, illustrandone la biologia e il comportamento, per quanto ne possiamo dedurre. Bakker specula forte, e si lascia andare a ipotesi libere sull'ecologia dell'ambiente che descrive, raccontando un habitat di cui sappiamo molto poco. Tuttavia il suo racconto è al passo coi (suoi) tempi e descrive comunque un mondo vitale, variegato, interconnesso, che riesce a dare forma e dignità a un'epoca spesso ridotta a caricatura. Detto questo, il romanzo è obiettivamente scritto male, con una quantità di ridicole onomatopee che sfiorano il futurismo, e una prosa in generale goffa. Un libro da non considerare per il suo valore letterario, piuttosto come la sceneggiatura di un documentario che non potremo mai girare. Voto: 7/10
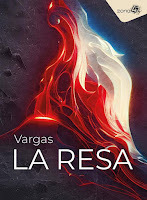 Torniamo poi a qualcuno che scrive per davvero, con il "primo romanzo fantasy" pubblicato da Zona 42, ovvero La resa di Vargas. La storia è quella di due figure archetipiche, Eroe e Necromante (quest'ulimo è un po' il classico Signore Oscuro), che da sempre sono contrapposte nella battaglia tra bene e male e hanno dato origine a ogni mito e leggenda della storia, ma a un certo punto decidono di deporre le armi e abbandonare la loro guerra millenaria, lasciando l'umanità libera di decidere il proprio destino invece di continuare a usarla per combattersi. Durante questa resa, i due continuano a frequentarsi, e mentre il Necromante è immortale e immutabile, l'Eroe è invece un semplice umano che si reincarna ogni volta in individui diversi. Li conosciamo quindi in un paesino della provincia italiana, con l'Eroe che al solito cerca di mantenere un basso profilo ma pur vivendo nel corpo di una bambina si trova a scatenare di nuovo una guerra per i suoi ideali di libertà. La storia poi si ripete anche dall'altra parte del mondo, con l'Eroe inconsapevole che mette su un team di supereroi e si ritrova coinvolta nelle rivolte della popolazione afroamericana contro i soprusi della polizia. Il libro è volutamente ironico e grottesco, e il Necromante spicca come personaggio mostruosamente adorabile, perché i cattivi sono pronti a smembrare il prossimo sono sempre più simpatici. La prima parte è indubbiamente la più spassosa, perché l'impressione è quella di un Good Omens ambientato al paesello, con una surreale sovrapposizione tra scontri epici e vita di provincia. La seconda parte cambia un po' di tono e forse è meno fresca, perché vira troppo nel supereroistico, e sembra invece un Kikc-Ass coi mostri di carne. Nonostante la mole è comunque una lettura veloce e divertente, ma non per questo superficiale, proprio una di quelle che fa ridere ma fa anche riflettere. Voto: 7.5/10
Torniamo poi a qualcuno che scrive per davvero, con il "primo romanzo fantasy" pubblicato da Zona 42, ovvero La resa di Vargas. La storia è quella di due figure archetipiche, Eroe e Necromante (quest'ulimo è un po' il classico Signore Oscuro), che da sempre sono contrapposte nella battaglia tra bene e male e hanno dato origine a ogni mito e leggenda della storia, ma a un certo punto decidono di deporre le armi e abbandonare la loro guerra millenaria, lasciando l'umanità libera di decidere il proprio destino invece di continuare a usarla per combattersi. Durante questa resa, i due continuano a frequentarsi, e mentre il Necromante è immortale e immutabile, l'Eroe è invece un semplice umano che si reincarna ogni volta in individui diversi. Li conosciamo quindi in un paesino della provincia italiana, con l'Eroe che al solito cerca di mantenere un basso profilo ma pur vivendo nel corpo di una bambina si trova a scatenare di nuovo una guerra per i suoi ideali di libertà. La storia poi si ripete anche dall'altra parte del mondo, con l'Eroe inconsapevole che mette su un team di supereroi e si ritrova coinvolta nelle rivolte della popolazione afroamericana contro i soprusi della polizia. Il libro è volutamente ironico e grottesco, e il Necromante spicca come personaggio mostruosamente adorabile, perché i cattivi sono pronti a smembrare il prossimo sono sempre più simpatici. La prima parte è indubbiamente la più spassosa, perché l'impressione è quella di un Good Omens ambientato al paesello, con una surreale sovrapposizione tra scontri epici e vita di provincia. La seconda parte cambia un po' di tono e forse è meno fresca, perché vira troppo nel supereroistico, e sembra invece un Kikc-Ass coi mostri di carne. Nonostante la mole è comunque una lettura veloce e divertente, ma non per questo superficiale, proprio una di quelle che fa ridere ma fa anche riflettere. Voto: 7.5/10
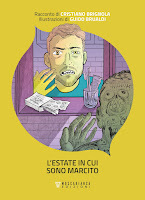 Dai necromanti ai non-morti veri e propri, con un bel racconto di zombie: Cristiano Brignola si inventa gli zombie incel in
L'estate in cui sono marcito
. I morti viventi li abbiamo visti in tutte le salse e fluidi corporei, come allegoria di tante cose brutte (consumismo, razzismo, nichilismo) ma questa è la prima volta in cui sono usati come rappresentazione di una incapacità di accettare il rifiuto e gestire i sentimenti. Il protagonista infatti è stato lasciato dalla ragazza e continua a fissare la sue foto con il nuovo fidanzato, e gradualmente si accorge che sta marcendo. Il suo ragionamento è collegare le due cose, ovvero che il disfacimento del corpo deriva dall'ingiusto trattamento che ha subito il suo cuore spezzato, e potremmo inzialmente empatizzare con lui se non fosse che poi si lascia trascinare in un gorgo di malvagità quando entra in contatto con gli altri ragazzi dal cuore spezzato che attribuiscono alle donne che li hanno lasciati o non li hanno mai voluti la colpa della loro decomposizione. Il gruppo sviluppa presto dinamiche tipiche di queste sottoculture rancorose, con un suo lessico e azioni dimostrative e violente che fanno porre diversi dubbi anche al protagonista. Una novella forte, che prende un tema abusato ma lo interpreta in un modo nuovo e attualissimo. Voto: 8/10
Dai necromanti ai non-morti veri e propri, con un bel racconto di zombie: Cristiano Brignola si inventa gli zombie incel in
L'estate in cui sono marcito
. I morti viventi li abbiamo visti in tutte le salse e fluidi corporei, come allegoria di tante cose brutte (consumismo, razzismo, nichilismo) ma questa è la prima volta in cui sono usati come rappresentazione di una incapacità di accettare il rifiuto e gestire i sentimenti. Il protagonista infatti è stato lasciato dalla ragazza e continua a fissare la sue foto con il nuovo fidanzato, e gradualmente si accorge che sta marcendo. Il suo ragionamento è collegare le due cose, ovvero che il disfacimento del corpo deriva dall'ingiusto trattamento che ha subito il suo cuore spezzato, e potremmo inzialmente empatizzare con lui se non fosse che poi si lascia trascinare in un gorgo di malvagità quando entra in contatto con gli altri ragazzi dal cuore spezzato che attribuiscono alle donne che li hanno lasciati o non li hanno mai voluti la colpa della loro decomposizione. Il gruppo sviluppa presto dinamiche tipiche di queste sottoculture rancorose, con un suo lessico e azioni dimostrative e violente che fanno porre diversi dubbi anche al protagonista. Una novella forte, che prende un tema abusato ma lo interpreta in un modo nuovo e attualissimo. Voto: 8/10
 Visto che come forse sapete questa è stata un'estate anche di scrittura e di studio, tra i testi consumati ce ne sono anche alcuni "da consultazione", come Scrivere fantascienza di Robert Silverberg, che raccoglie articoli e interventi di uno dei massimi autori della fantascienza americana, e forse l'unico dei grandi maestri dell'età classica della scifi ancora in vita. Silverberg si presenta subito come molto critico nei confronti dell'ambiente della fantascienza in cui è cresciuto, anche se ne ha fatto parte fin dall'inizio ne ha visto molti dei limiti e ne parla senza timore. È interessante vedere come il mondo editoriale degli USA in quegli anni fosse totalmente diverso da quello che ci aspettiamo noi oggi, ma nonostante questo molte dinamiche di amichettismo e gatekeeping sono riconscibilissime. Molto curiosi (e in certi casi struggenti) anche i coccodrili che Sturgeon, in quanto ultimo sopravvissuto della cerchia, ha scritto per la dipartita dei vari colleghi nel corso degli anni. Mi ha fatto piacere soprattutto scoprire gli aneddoti su Harlan Ellison, con cui a quanto pare ha avuto un rapporto molto stretto. Un testo per appassionati e connaisseur, ma di grande valore.
Visto che come forse sapete questa è stata un'estate anche di scrittura e di studio, tra i testi consumati ce ne sono anche alcuni "da consultazione", come Scrivere fantascienza di Robert Silverberg, che raccoglie articoli e interventi di uno dei massimi autori della fantascienza americana, e forse l'unico dei grandi maestri dell'età classica della scifi ancora in vita. Silverberg si presenta subito come molto critico nei confronti dell'ambiente della fantascienza in cui è cresciuto, anche se ne ha fatto parte fin dall'inizio ne ha visto molti dei limiti e ne parla senza timore. È interessante vedere come il mondo editoriale degli USA in quegli anni fosse totalmente diverso da quello che ci aspettiamo noi oggi, ma nonostante questo molte dinamiche di amichettismo e gatekeeping sono riconscibilissime. Molto curiosi (e in certi casi struggenti) anche i coccodrili che Sturgeon, in quanto ultimo sopravvissuto della cerchia, ha scritto per la dipartita dei vari colleghi nel corso degli anni. Mi ha fatto piacere soprattutto scoprire gli aneddoti su Harlan Ellison, con cui a quanto pare ha avuto un rapporto molto stretto. Un testo per appassionati e connaisseur, ma di grande valore.
 E infine sempre per la parte formativa dell'estate 2024, ho finalmente letto un libro che avevo in libreria da anni e anni, un saggio di Roberto Paura (direttore dell'Italian Institute for the Future) che come dichiara il sottotitolo fa da "introduzione alla speculative fiction" e incidentalmente porta il miglior titolo possibile:
Il cielo sopra il porto
. Paura declina questa introduzione in una serie di temi ricorrenti nella fantascienza ma non solo, perché tocca anche il werid e il fantasy, con una lunga trattazione dedicata anche a Tolkien e Lewis. L'approccio forse non dà un quadro completo ma dà molti spunti interessanti, mettendo in relazione testi e argomenti che non sempre vengono correlati, proprio per la tendenza a considerare i generi e le epoche come comparti stagni che non comunicano tra loro. Mi verrebbe da dire che forse come "introduzione" non sarebbe ottimale, perché qualcuno che non abbia già una certa familiarità con questi testi e generi forse non avrebbe un punto di riferimento da cui partire, tuttavia come approfondimento su temi specifici è sicuramente molto efficace.
E infine sempre per la parte formativa dell'estate 2024, ho finalmente letto un libro che avevo in libreria da anni e anni, un saggio di Roberto Paura (direttore dell'Italian Institute for the Future) che come dichiara il sottotitolo fa da "introduzione alla speculative fiction" e incidentalmente porta il miglior titolo possibile:
Il cielo sopra il porto
. Paura declina questa introduzione in una serie di temi ricorrenti nella fantascienza ma non solo, perché tocca anche il werid e il fantasy, con una lunga trattazione dedicata anche a Tolkien e Lewis. L'approccio forse non dà un quadro completo ma dà molti spunti interessanti, mettendo in relazione testi e argomenti che non sempre vengono correlati, proprio per la tendenza a considerare i generi e le epoche come comparti stagni che non comunicano tra loro. Mi verrebbe da dire che forse come "introduzione" non sarebbe ottimale, perché qualcuno che non abbia già una certa familiarità con questi testi e generi forse non avrebbe un punto di riferimento da cui partire, tuttavia come approfondimento su temi specifici è sicuramente molto efficace.October 7, 2024
Futurama 9x10 - Otherwise / Realtà alternative
E così ci siamo di nuovo. Siamo al quinto finale di Futurama. Ricordiamo infatti che quando Hulu ha commissionato i nuovi episodi, ne sono stati prodotti venti, che hanno composto i due blocchi da 10 della stagione 8 e 9. Per questo l'ultimo episodio della stagione 8 non era inteso come possibile finale della serie, ma questo invece sì, perché non c'era nessuna certezza che ce ne sarebbero stati altri. Poi le cose sono andate bene, e tra un blocco e l'altro Hulu ha richiesto altri 20 episodi, ma ormai Otherwise era già stato preparato, e quindi avrebbe potuto essere il finale finale (di nuovo) dell'intera serie.

Si era già speculato sul titolo (orribilmente trasposto in italiano) e la sua affinità con Meanwhile, e infatti il collegamento con il precedente finale è diretto. Fry infatti subisce l'influsso del multiverso e recupera i ricordi della realtà alternativa in cui lui e Leela hanno vissuto insieme fino alla vecchiaia in un universo fermo nel tempo. Da qui inizia l'ossessione per scoprire che cosa è successo, e la minaccia di una nave fantasma che sembra essere il relitto della Planet Express che ha subito danni fatali all'inizio della puntata.
Devo dire che l'inizio con la dismissione dell'astronave mi stava quasi facendo commuovere, perché davvero la PE è quanto mai rappresentativa di tutto quello che succede in Futurama, e vederla abbattuta e persa per sempre era davvero un peccato (probabilmente mi ha risvegliao ricordi traumatici di Battlestar Galactica). Da lì si entra poi nella parte della storia in cui Fry subisce i dejà vu, fino alla battaglia finale a bordo della nuova Planet Express.
La puntata è sicuramente valida, e riesce a tenere bene il ritmo pur cambiando continuamente situazione. Forse però il dramma di Fry rimane anche troppo tangenziale al procedere della storia, e non viene mai sviluppato a fondo il modo in cui perscepisce una storia dimenticata, tutto quello che succede sono dei flash dai quali si ritrova privo di sensi. Inoltre, anche se la conclusione è a suo modo romantica (ed è una scelta perfetta che a sposare Fry e Leela sia proprio Zapp), il fatto di resettare di nuovo la coppia nel momento in cui riesce a raggiungere la sua unione definitiva è un po' on the nose, e anzi proprio perché sappiamo che per qualche ragione questa cosa non avverrà mai nel canone della serie, appena si vede accadere capiamo che quello che sta succedendo in qualche modo non è "reale" e sarà riscritto. E infatt il plot twist dell'universo alternativo (abbastanza intuitbile dal titolo) ripristina la situazione di partenza. Insomma un altro uso del reset button nel rapporto Fry/Leela che credevamo di esserci lasciati indietro dopo il quarto film.
C'è anche da dire che nel 2024 questa pressione per il matrimonio comincia a diventare anacronistica. Dopo tutto Fry e Leela stanno insieme come coppia stabile da anni, convivono e condividono tutto: è davvero importante che siano ufficialmente sposati, a questo punto? Forse si potrebbe trovare qualche obiettivo nuovo, meno burocratico e più concreto, per dare forza alla loro relazione.
Insomma, se da una parte l'episodio di per sé funziona, inteso come finale di stagione e potenzialmente di serie rimane più debole, e già rispetto al finale della stagione 8 a mio avviso risulta inferiore, sia dal punto di vista del sense of wonder che della forza emotiva. Fortunatamente sappiamo che, almeno nel nostro universo, avremo altri 20 episodi di Futurama, quindi possiamo rimandare le preoccupazioni al prossimo finale di serie ever. Voto: 7/10
Unknown to Millions
Libri, fantascienza, serie tv, Futurama, Doctor Who
- Andrea Viscusi's profile
- 81 followers



