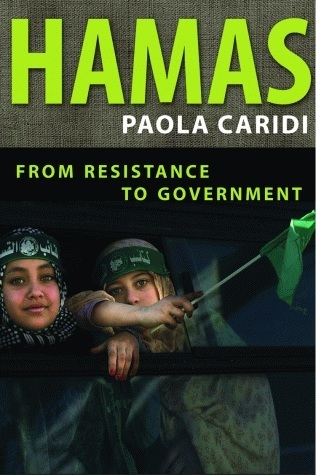Paola Caridi's Blog, page 89
October 4, 2012
Prove tecniche di diplomazia islamista
E così, alla fine, la tanto attesa fiammata sulla frontiera turco-siriana c’è stata. Colpi di mortaio da parte siriana, cinque turchi uccisi, in massima parte bambini (quattro). Quasi immediata la reazione turca, con un raid al territorio siriano che nella notte di ieri ha rotto una impasse che durava da settimane. Se non da mesi.
Ora tocca alla NATO decidere se gli scontri di frontiera tra Siria e Turchia si inquadrano nel famoso articolo cinque del Trattato dell’Atlantico del Nord, e se dunque uno degli stati membri (Ankara) debba essere difeso da tutti gli altri. L’Europa, insomma, deciderà di intervenire contro Bashar al Assad? Lo si vedrà. L’aspetto più interessante della questione – paradossalmente – non è però la ‘fiammata’ militare, quanto i tanti fatti politici che l’hanno preceduta. Eventi, segnali, riposizionamenti….
Tutto è ruotato attorno al congresso dell’AKP di fine settembre, e all’exploit di Recep Tayyep Erdogan. Un congresso di partito divenuto, visti gli ospiti intervenuti, non solo un ritratto di quello che succede nei nuovi equilibri in campo islamista dopo il Secondo Risveglio Arabo. Ma anche un vero e proprio evento di politica regionale. Anzitutto, perché la frattura Egitto-Turchia degli ultimi anni di Hosni Mubarak è stata definitivamente sanata. La presenza di Mohammed Morsy al congresso dell’AKP come l’ospite eccellente, e gli stessi contenuti del suo discorso, hanno rappresentato il clou di un evento curato – a quanto sembra – con una precisa regia politica.
E allora, cerchiamo di comprendere meglio i dettagli. Il neo-presidente egiziano Morsy si presenta al congresso dell’AKP dopo una sostanziale investitura internazionale, e cioè dopo il discorso di fronte all’Assemblea generale dell’ONU a New York, sempre a settembre. Il duo Erdogan-Morsy fa inoltre comprendere che su questioni di impatto regionale fortissimo – come la guerra civile siriana – Egitto e Turchia non vogliono lasciare il palcoscenico agli occidentali. Non si deve ripetere, insomma, un intervento sul tipo di quello in Libia, in cui la presenza occidentale era propedeutica a una futura influenza europea e americana sulla questione energetica. Il singolare quartetto che si occupa del caso siriano (assieme a Turchia ed Egitto, Iran e Arabia Saudita) la dice infatti lunga sui nuovi equilibri regionali, e anche sul cambio di passo nelle dinamiche tra potenze mediorientali e occidentali.
Morsy, dunque, ha confermato che l’Egitto non può accettare quello che il regime siriano sta facendo in questi anni. E, scendendo più a sud, ha detto che il confine di Rafah, tra Gaza ed Egitto, è aperto. Un’affermazione che cozza con quanto succede tra Gaza ed Egitto, e fra Hamas e le autorità del Cairo, sui tunnel in cui passa il contrabbando, unica via commerciale aperta. L’Egitto ha chiuso alcune decine di tunnel, ha chiuso il valico di Rafah, ma non ha ancora messo mano alla zona di libero scambio, come richiesto dalle autorità di Hamas di Gaza, e anche dal numero due del movimento islamista, Moussa Abu Marzouq, che in questi ultimi giorni ha parlato molto.
La parte del discorso di Morsy relativa a Gaza è piuttosto da mettere in relazione alla presenza di un altro ospite al congresso dell’AKP. Khaled Meshaal, ancora numero uno di Hamas, è stato accolto con calore, dai delegati al congresso, e ha avuto a disposizione un podio importante, all’indomani delle indiscrezioni che parlano della sua volontà di non ricandidarsi a capo del bureau politico del movimento islamista. Un podio usato da Meshaal almeno per due motivi: affermare Hamas come parte del più vasto movimento islamista della regione, e – nel confronto tra Turchia e Siria – scegliere definitivamente la Turchia. Il sistema islamista alla Erdogan è stato indicato da Meshaal, nella sostanza, come un modello per Hamas.
A Damasco, la presenza di Meshaal sul podio del congresso dell’AKP non poteva che suscitare una reazione violenta. Come violento è stato l’attacco della tv di stato siriana contro il numero uno dell’ufficio politico di Hamas, per oltre un decennio ospite gradito del regime degli Assad. L’emittente di Damasco ha accusato Meshaal di ingratitudine, visto che la Siria lo aveva accolto nel 1999 quando – ha detto – “nessuno voleva neanche stringergli la mano”. E l’attacco è andato anche oltre, colpendo nel vulnus dei rapporti tra Egitto e Gaza, proprio sulla questione dei tunnel. Meshaal ha girato lo sguardo dall’altra parte, ha detto la tv di stato siriana.
Lo strappo tra Siria e Hamas, dunque, si è consumato. Di per sé, questa non sarebbe una notizia, visto che la presenza di Moussa Abu Marzouq al Cairo è un più che implicito riconoscimento del ruolo dell’Egitto (con presidenza islamista) negli affari palestinesi. È invece uno strappo importante, se il punto di osservazione non è il Cairo, bensì Ankara. La Turchia di Erdogan non può attaccare la Siria (e criticare l’Iran) senza doversi giustificare per il fatto di essere, oggettivamente, sullo stesso fronte di Israele, dove i tamburi di guerra percossi da Netanyahu in direzione di Teheran sono sempre più forti. Avendo ottenuto, invece, l’appoggio incondizionato di Hamas, la Turchia di Erdogan si difende da accuse di questo tipo, e – allo stesso tempo – aiuta anche l’Egitto nel rapporto con l’islam politico palestinese.
Prove tecniche di diplomazia regionale, insomma. E questo è solo l’inizio.
Su Hamas, invece, si concentrano da due giorni attacchi molto duri, che coinvolgono il regime a Gaza. Sul Daily Star Lebanon compare un’inchiesta sulla corruzione a Gaza: un’accusa che ho sentito anch’io, all’inizio dell’estate. Secondo la vox populi, il regime è un sistema di potere che si avvicina sempre di più a quello di Fatah. La differenza, dice sempre la strada a Gaza, è che quelli di Fatah si arricchivano in quanto individui, e quelli di Hamas rafforzano il proprio partito e il proprio potere. Altra accusa, ricorrente, è quella di caricare di tasse la popolazione. Il secondo attacco è quello di Human Rights Watch, che in un rapporto di oltre quaranta pagine dal titolo emblematico (Abusive System) ha accusato il regime di Hamas a Gaza di violazioni pesanti come tortura e arresti arbitrari. Il regime, però, incassa un punto, con l’apertura di una rappresentanza del Qatar dentro Gaza.
Per la playlist, un evergreen. Will we still love me tomorrow, ma cantata da Norah Jones.
La foto è del sultano ottomano Mehmed II, in mostra al museo islamico di Doha
October 1, 2012
Barça della discordia
C’è una fede, a Gerusalemme, del tutto prosaica. Una fede che nulla ha a che vedere con religioni, templi e riti. Chiamarla fede, a dire il vero, è una iperbole fastidiosa che usano, non solo in Italia, i calcio-dipendenti. A Gerusalemme, invece, è uno dei modi per dimenticare conflitto, umiliazioni, e quel disagio impercettibile che segna la vita quotidiana. È la fede (calcistica) nei miti degli ultimi anni: fuori l’Italia, dentro la Spagna. Perché anche a Gerusalemme – e nel Medio Oriente tutto – i miti sono poi gli stessi. FC Barcelona e Real Madrid dividono gli animi, creano bande contrapposte, ma la faglia non è la solita. Non è tra israeliani e palestinesi. E’ tra tifosi del Barça e fan del Real.
Gli esempi sono evidenti, anche soltanto a percorrere le strade di Gerusalemme. Gli scudetti delle due regine del calcio spagnolo sono appiccicate sui bus del trasporto urbano, che a Gerusalemme (città unita?) segue due sistemi diversi. Israeliano e palestinese, appunto. Ebbene, è facile, consueto, addirittura frequente trovare le bandierine sugli autobus, e disegnare un diagramma del tifo pro-Barça o pro-Real che non segue la Linea Verde. Semmai quello del cuore palpitante del fan.
Stesso dicasi per le visioni delle partite, veri e propri happening, a est e a ovest. Stesso dicasi per i piccoli sogni del tifoso, che vorrebbe solo una cosa, a est o a ovest: partire, e andarsene a vedere una partita direttamente in Spagna, allo stadio. Stesso dicasi per la fidelizzazione dei tifosi attraversi i gadget, magliette e scarpe in testa, diffuse – vere o taroccate che siano – nei parchi di Tel Aviv e nei campi profughi di Gaza.
Dimenticatevi di Inter, Roma e Juve. Il tifo, in Medio Oriente, è monopolizzato dalle spagnole. Ed è, nel caso di Gerusalemme, un tifo trasversale che attraversa le comunità presenti nella Città Tre Volte Santa. Sino a che, però, la politica non torna sovrana. Allora, in quel preciso momento, il miracolo compiuto dal tifo, il miracolo delle comunità che si concedono un attimo di respiro e – seppur separate – gioiscono nello stesso istante e per lo stesso gol, si sgonfia e ridiventa ciò che è e ciò che deve essere: un divertissement. La politica è altro, il conflitto pure.
La notizia è di questi giorni. Il Barcelona ha invitato Gilad Shalit, liberato poco meno di un anno fa nello scambio di prigionieri tra Israele e Hamas, ad assistere al derby spagnolo, Barça vs Real. Appuntamento il prossimo 7 ottobre. Un semplice invito, di quelli in cui la politica (mediorientale) non c’entra nulla? Nessuno di noi è così ingenuo da crederlo. Quando frequentavo l’archivio di Stato e quello del ministero degli esteri, a Roma, incappai in documenti della fine degli anni Quaranta in cui si parlava di calcio, e non per mera passione. È che l’allora sottosegretario alla presidenza del Consiglio del governo De Gasperi, Giulio Andreotti, se ne andò ad assistere a una partita di calcio a Madrid, in pieno franchismo. La diplomazia, allora come oggi, si fa anche in tribuna.
I palestinesi, dunque, hanno reagito decisamente piccati, all’invito a Shalit. Anche perché, nelle settimane e nei mesi in cui si è dispiegato lo sciopero della fame di migliaia di detenuti palestinesi nelle carceri israeliane, uno dei casi arrivato sulle colonne dei giornali europei è stato proprio quello di un calciatore. Mahmoud al Sarsak, 25 anni, giocatore della nazionale palestinese, rimasto per tre anni nelle carceri israeliane in detenzione preventiva, senza accuse e senza processo. Liberato lo scorso luglio dopo tre mesi di digiuno, Sarsak aveva ricevuto anche il sostegno a distanza di calciatore e della stessa FIFA, con una dichiarazione molto critica nei confronti degli israeliani da parte di Joseph Blatter.
Delusi i palestinesi, che l’anno scorso avevano invece visto i dirigenti del Barcelona ricevere Mahmoud Abbas e regalare le magliette ai suoi nipoti. A loro volta evidentemente imbarazzati per lo scivolone i dirigenti del Barça, che si sono affrettati a invitare al derby spagnolo del prossimo 7 ottobre anche i palestinesi. Il responsabile del calcio palestinese, il vecchio Jibril Rajoub, l’ambasciatore dell’ANP in Spagna, e – appunto – Sarsak. Il quale però non si è unito a Rajoub e all’ambasciatore, che hanno accettato il biglietto per la partita. Sarsak ha rifiutato l’invito, con la seguente spiegazione: condividere con Shalit lo stesso spalto significherebbe “normalizzazione”. “Sport e politica si mescolano, in questa storia”, ha detto Sarsak. Come dargli torto…
Intanto, i club dei tifosi palestinesi di Gaza hanno scritto una lettera ai loro beniamini, raccontando che il conflitto non risparmia il calcio. Che uno stadio a Gaza è stato distrutto durante l’Operazione Piombo Fuso, che alcuni calciatori sono stati uccisi e altri arrestati dagli israeliani. Il calcio è un gioco che giocano tutti, nelle pieghe del conflitto. I bambini – soprattutto quelli di Gaza, che dalla Striscia non possono uscire per andare in Spagna a vedere i loro miti, vogliono tutti essere Messi. Sino a che, però, non si trovano a essere coinvolti, travolti, schiacciati da altri giochi. Che, spesso, passano sulla loro testa, e sulle loro magliette.
Nella foto di Omar Chatriwala (sotto licenza Creative Commons), un bambino palestinese del campo profughi di Jerash indossa una maglietta del FC Barcelona. Non è il solo, né da parte palestinese né da parte israeliana.
Per la playlist, Mark Knopfler, che è sempre un bel sentire. Redbud Tree.
September 27, 2012
Meglio la strada delle caste
Il palcoscenico più importante è un altro. È molto lontano, al di là di un oceano. Alle Nazioni Unite, dove alcuni dei (grandi) cambiamenti in corso nella regione araba e mediorientale sono già evidenti. In un certo qual modo simboleggiati anche dal discorso di Mohammed Morsy dal podio dell’Assemblea Generale dell’Onu. Morsy ha parlato come il primo presidente democraticamente eletto dell’Egitto in transizione, mentre a casa si discute dei primi articoli della costituzione. E Mahmoud Abbas parla oggi, senza però avere l’impatto che ebbe – inatteso – un anno fa.
Il mondo arabo, però, è fatto per fortuna ancora di altri palcoscenici. Magari tra le case del Cairo. E per vedere che faccia hanno gli altri protagonisti di questa storia, guardatevi con attenzione questo video, girato in una Cairo normale e quotidiana. È il video di un brano rap egiziano. Niente di che, come sperimentazione. Se si vuole, un rap normale (normale? che vuol dire?…).
Asfalt, Ana Satreen. Una summa di quello che pensano molti ragazzi normali del Cairo. Molto più interessanti e vivaci delle discussioni in corso in Italia, anche nella mia categoria. Meglio la strada, delle varie caste.
Thanks, Zeinobia.
September 25, 2012
De blogger disputandum
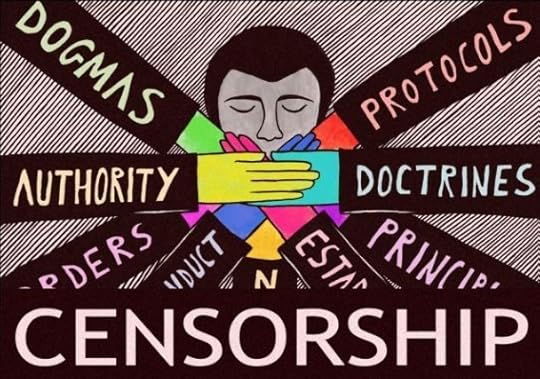
E così, il blogger è diventato una professione. E se non una professione, almeno un ruolo sociale riconosciuto. Uno di quei ruoli che fanno tanto glam. Oppure no? Oppure, ancora una volta, la discussione culturale italiana si contraddistingue per la sua evanescenza? Per la sua straordinaria abilità di nascondersi dietro una parola, senza riconoscerne il peso?
Ri-leggersi non fa bene, anche se ogni tanto aumenta l’autostima. Comunque, ho peccato, e sono andata a ri-leggermi i pensierini sull’oggetto (virtuale) blog che mi aveva chiesto di scrivere – era circa il 2008 – il mio caro, carissimo amico Pino Bruno. È l’amico più esperto di web che io abbia, uno dei giornalisti italiani che conoscono meglio le origini, l’evoluzione e le possibilità del mondo virtuale. Il suo di blog – il futuro non è più quello di una volta - è una di quelle letture quotidiane ineludibili, se ci si vuol capire qualcosa. Allegro, ridanciano, mai spocchioso, alcune volte didascalico, altre per addetti ai lavori. Lo capisco anch’io, il suo blog, e questo vuol dire che non è poi così difficile.
Comunque, qualche anno fa Pino Bruno mi chiese di scrivere non più di una paginetta su una parola del web. Pino Bruno stava costruendo un libro prezioso, Dolce Stil Web. Le parole al tempo di internet (Sperling & Kupfer 2009). Un bignami per entrare nel mondo virtuale senza sentirsi del tutto sguarniti. Il tema a piacere, e io scelsi il blog, perché – in fondo – mi aveva un po’ cambiato la vita. Lo avevo aperto da poco, invisiblearabs, ancora con blogspot perché ero veramente analfabeta, e non era ancora venuto il momento di spostarmi su wordpress. E poi anche la lunghezza dei post era diversa: frasi brevi, pensieri in libertà, qualche citazione, sollecitazione, rimando da una parte all’altra del Mediterraneo…
Il blog lo avevo aperto perché, da qualche anno, seguivo altri blog, quelli dei ragazzi arabi, che cercavano di dire al mondo che stava succedendo molto, sotto la polvere degli stereotipi. Il mondo, però, leggeva altri blog, quelli statunitensi, e pensava che i diari virtuali fossero tutti la stessa cosa. Che i blogger arabi appartenessero alla stessa generazione dei blogger statunitensi, che facessero parte della stessa classe sociale, che percepissero – magari – soldi per produrre ciò che mettevano in rete. Erano invece diversi, perché a seconda della latitudine e delle spinte culturali i blog e i blogger cambiano.
Mi cito:
i blog, nel mondo arabo, sono in tutto e per tutto diari, anche se sono e-diari. Riescono, cioè, a lasciare socchiusa, per il lettore, la porta verso sentimenti, desideri, rabbie e riflessioni. E a far intravedere i semi di quello che in futuro succederà.
Quanto a me, dopo tanta frequentazione di blog, un blog l’ho aperto anch’io ovviamente. Ma non ho scimmiottato i giovani blogger arabi, e il mio diario virtuale l’ho concepito in maniera molto diversa. Vuoi per l’età, che non dà più quella spavalderia e quell’innocenza capace di far mostrare la propria stanza dei giochi. Vuoi perché, nonostante sia un’emigrante, rimango italiana ed europea. Anche questo modo di fare blog, però, ha una sua dignità. E contiene dentro di sé il grande, primo significato dei blog: la loro incredibile democraticità, che consente di dire senza dover per forza essere ricchi. Un po’ e-tazebao, un po’ e-diari, un po’ e-samiszdat. E-parole.
I blog, dunque, sono democratici. I blog sono liberi. I blog sono appassionati, in genere, perché hanno solamente le griglie individuali, alle quali non si sommano altre griglie. I blog fanno parte di un tessuto e-sociale. I blog non sono colonne di piombo virtuale fatti solo per essere visibili, e dire “io c’ero”. Non sono editoriali su schermo. Non soggiacciono alle stesse regole di un giornale, anche se a prima vista – per i non esperti – un giornale online sembra in tutto e per tutto un giornale.
I blogger, a loro volta, diventano blogger quando decidono di avere una frequentazione continua con un’agorà come quella telematica. Di avere un obiettivo che dura nel tempo e rende il proprio diario virtuale un oggetto durevole, anche se a prima vista etereo. Un oggetto con una sua fisionomia, indipendenza, unicità. Sono questi – a mio parere – i tre requisiti che rendono un blog un oggetto riconoscibile della Rete, persino – a suo modo – una fonte. E se dura, se è riconoscibile, è perché sa usare il linguaggio della rete, la lingua della rete, le regole della rete. L’interazione della rete, che non vuol dire – semplicemente – la serie di commenti sotto l’editoriale, ma vuol dire un chiacchiericcio continuo che comincia sul blog, continua su FB, fa una sosta e si sposta su twitter, per poi farsi privato con la messaggistica uno-a-uno. Scritta o in video che sia.
Conclusione, (quasi) scontata, in giorni in cui la discussione (italiana) in rete si concentra – con l’uscita di Huffington Post Italia – su questa strana nuova figura che appare all’orizzonte, quasi fosse la riproposizione dei guru di qualche anno fa. Non basta un PC, una ADSL, e una e-pagina e-patinata per fare un blogger. Sono d’accordo, d’accordissimo con Gennaro Carotenuto, un altro che la Rete la conosce, la conosce molto meglio di me…
Per la playlist non cambio brano, stasera, nel tepore di una fine estate che non vuole lasciare il passo. Come away with me è troppo bella. Norah Jones.
L’immagine è un poster sulla libertà di internet, e ricorda il primo cybermartire, Zouhair Yahyaoui. Il giorno della sua morte, il 13 marzo, è diventata la giornata della libertà della Rete.
September 24, 2012
Khaled Meshaal fa un passo indietro?
La storia va avanti da molti mesi. Dalla primavera, almeno. E non si è ancora risolta, a giudicare dalle indiscrezioni indubbiamente importanti uscite negli scorsi giorni. Hamas non ha ancora scelto il capo dell’ufficio politico, l’organismo che ha un ruolo – per così dire – esecutivo nella struttura del movimento islamista palestinese. Non c’è ancora, insomma, il successore a Khaled Meshaal.
Fin qui, non ci sarebbe niente di nuovo, rispetto a quanto già si sapeva. Dopo le rivoluzioni arabe del 2011, l’abbandono della sede di Damasco da parte del politburo di Hamas, e il rafforzamento del ruolo dell’ala di Gaza all’interno del movimento, la questione del capo del politburo è diventata ancor più centrale. E controversa. Il capo del braccio esecutivo del vertice di Hamas deve rappresentare, ora, equilibri diversi, rispetto a quando – a metà degli anni Novanta – Meshaal diventò il numero uno, dopo l’arresto di Moussa Abu Marzouq. La diaspora, allora, era non solo portavoce delle ali del movimento dentro Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme est. Rappresentava – la diaspora – un potere e un consenso di per sé.
Ora i tempi sono cambiati, e così – in parte – i pesi interni alla struttura di Hamas. In Cisgiordania, gli arresti da parte degli israeliani e delle forze di sicurezza dell’ANP hanno messo a dura prova, ormai da anni, la base dei militanti, così come il vertice. I deputati eletti in Cisgiordania, i dirigenti che nel 2005-6 erano usciti del tutto dalla clandestinità a Ramallah, a Hebron, a Nablus, a Jenin fanno spesso dentro e fuori dalle carceri. Israeliane o palestinesi. Gaza, dal 2007, ha assunto un ruolo che prima non aveva, nonostante il consenso si concentrasse da sempre nei campi profughi della Striscia. E Gaza vuole contare, perché è l’unico pezzo di terra di cui Hamas ha il controllo.
Conclusione: la notizia è che Khaled Meshaal non si vuole ricandidare al ruolo di numero uno del politburo. Le indiscrezioni erano già uscite, ma maannews ha poi dato la conferma, per bocca di uno dei dirigenti più noti di Gaza, Salah el Bardawil.
A dire il vero, si era parlato di un nuovo ruolo per Meshaal, come guida suprema di una sezione palestinese della Fratellanza Musulmana, del tutto staccata da qualsiasi altra organizzazione nazionale. Soprattutto da quella giordana, a cui era stata da sempre legata l’Ikhwan-capitolo palestinese. Le indiscrezioni di questi giorni, però, dicono che la decisione sul nuovo capo del politburo si sta avvicinando.
Se Meshaal, dunque, si è autoescluso dalla corsa alla ‘segreteria’ di Hamas, chi sono allora i veri candidati? Anzitutto, e questa è la vera novità nella storia di Hamas, c’è un candidato forte che esce da Gaza. Ismail Haniyeh, il premier del governo de facto che controlla la Striscia dal giugno del 2007. Anche se, a una sua vittoria, ostano questioni logistiche di non poco peso. Osta, insomma, il fatto che Haniyeh sia a Gaza City, e che quindi non abbia la stessa libertà di manovra che ha avuto Meshaal, fuori dai confini della Palestina. Osta il fatto che Haniyeh può essere un facile bersaglio, per gli israeliani, che più volte in questi anni hanno minacciato di colpire – con gli omicidi mirati – non solo i militanti e i miliziani, ma anche il vertice strettamente politico del movimento islamista. Osta il fatto, inoltre, che lo stesso valico di Rafah, al confine con l’Egitto, sia soggetto alle decisioni del Cairo: chiuso da settimane, è stato riaperto due giorni solo ed esclusivamente per far passare proprio il premier Haniyeh, di ritorno da un incontro con il capo dell’esecutivo egiziano, Qandil. Un capo del politburo di stanza a Gaza, insomma, sarebbe ostaggio – nei suoi stessi movimenti – delle decisioni politiche prese appena al di là degli stretti confini della Striscia. In Israele e in Egitto.
Haniyeh, però, sembra voler dare un’impressione diversa, rispetto a prima. Per esempio, non è andato a Teheran (dove invece, di recente, è andato Mahmoud a-Zahhar) per il vertice dei paesi non-allineati, nonostante fosse stato invitato. Non voleva urtare la sensibilità di Mahmoud Abbas, che è andato come presidente dell’ANP. E forse, ma è un’ipotesi, voleva far capire che Gaza non è più legata a stretto filo con il regime iraniano.
La candidatura di Moussa Abu Marzouq, però, è quella che guadagna punti. Non solo perché è stato il numero del politburo praticamente sin dall’inizio. Khaled Meshaal era il suo vice, sino a che non venne arrestato, e messo in carcere negli Stati Uniti per quasi un anno. Abu Marzouq è considerato lo stratega, ma per mantenere questo ruolo non c’è bisogno di diventare di nuovo il numero uno. Anzi. Le ragioni per un suo ritorno a capo dell’ufficio politico possono semmai essere altre. Il fatto è che Abu Marzouq è sempre stato l’unico, al vertice, ad aver mantenuto un buon numero di buoni contatti. Con Gaza, anzitutto, terra da cui proviene. Contatti che Meshaal non ha. Abu Marzouq è stato anche quello che ha mantenuto sempre aperto un legame con i paesi arabi, che ha continuato a frequentare per anni, facendo la spola – per esempio – tra Damasco e Cairo per tutti i negoziati importanti sul tavolo dell’intelligence egiziana. Anche quando al potere c’era Hosni Mubarak, e il capo dei servizi Omar Suleyman era vivo e faceva il bello e il cattivo tempo nelle trattative interpalestinesi.
Abu Marzouq, insomma, ha mantenuto quei rapporti che si sono rivelati importanti dopo la primavera del 2011, quando Hamas ha deciso di spostare, armi e bagagli, i suoi uffici politici e i suoi dirigenti da Damasco in altre capitali arabe. Cairo in testa. Così, da mesi, Abu Marzouq è in Egitto. E l’Egitto, dopo la vittoria di Mohammed Morsy, diventa fondamentale per lo sdoganamento di Hamas.
Non che sia una cosa semplice. Morsy è troppo pragmatico, e con lui la Fratellanza Musulmana di cui è un tipico rappresentante, perché un rapporto migliore con il movimento islamista palestinese possa, sic et simpliciter, dare il via a una poderosa spinta per sdoganare Hamas. Lo si è visto in queste ultime settimane: i problemi di sicurezza del Sinai (che c’erano anche prima, durante il ‘regno’ di Mubarak), la questione dei tunnel del contrabbando nell’area del confine di Rafah, la posizione prudente e ambigua della presidenza egiziana sul conflitto israelo-palestinese…
Certo, qualche posizione Hamas l’ha guadagnata, soprattutto all’interno degli equilibri palestinesi. La presenza al Cairo, nei giorni recenti di Khaled Meshaal e di Ismail Haniyeh, impegnati in colloqui ad altissimo livello con le autorità egiziane, significa che Hamas sta guadagnando dal cambio al vertice al Cairo. Ne è riprova la reazione piccata del presidente dell’ANP Mahmoud Abbas, che ha detto pubblicamente di non aver gradito questi inviti e queste presenze al Cairo, perché l’Egitto deve interloquire solo con l’Autorità Nazionale Palestinese. E la conferma arriva dallo stesso Abu Marzouq, in una lunghissima intervista concessa a un giornale, Al Sharq al Aswat, mai tenero con l’islam politico. Abu Marzouq attacca Abbas, e nel contempo dice quello che tutti sapevano. Che l’Egitto mediatore, quello dei tempi di Mubarak, era uno degli attori, e non invece il soggetto neutrale che avrebbe dovuto sanare il conflitto interpalestinese:
What angered Abbas is that Egypt is now serious regarding the issue of neutrality toward the Palestinian parties and their files. The talk that Egypt is the same distance from all Palestinian factions is not new in Egyptian foreign policy and this was said over many years. Former President Hosni Mubarak and later [Intelligence chief] Omar Suleiman would always repeat this; however Abbas was not angered by this then because this talk was not in line with the reality on the ground. At that time, Egypt was 100 percent biased toward the Palestinian National Authority and used to deal with Hamas as a fait accompli. However Abbas is now, during the presidency of Mohamed Mursi, witnessing a new form of seriousness regarding Egypt’s neutrality toward the Palestine cause and its files. This is something that strongly angered him, although he has no right to be angered by this.
Nel dire le cose che dice, Abu Marzouq sembra anche uscire allo scoperto. E assumere un ruolo che fino ad ora aveva lasciato a Meshaal. È lui che parla per Hamas, quasi da pari a pari con Abu Mazen. Il cambiamento è in corso?
Un po’ di autopromozione. L’immagine è la copertina del mio libro su Hamas, pubblicato negli Stati Uniti da Seven Stories Press, nel marzo di quest’anno.
Per la playlist, Norah Jones, Come away with me.
September 21, 2012
In esilio ci sta bene un coniglio
Anziché nell’apolidia, il trucco consiste nell’avere molte case, ma nel trovarsi, per ciascuna di esse, contemporaneamente dentro e fuori, coniugare intimità e occhio esterno, coinvolgimento e distacco: un trucco che le persone sedentarie difficilmente possono imparare. L’esilio offre l’opportunità di imparare tale trucco: tecnicamente, un esilio significa essere in un posto ma non farvi parte. L’illimitatezza risultante da tale condizione (e che è anzi l’essenza stessa di tale condizione) rivela come le verità locali siano fatte e disfatte dagli uomini, e come la lingua madre sia un ininterrotto flusso di comunicazioni tra generazioni e un tesoro di messaggi sempre più ricco di quanti ne vengono letti e perennemente in attesa di essere riscoperto. […]
Creare (e dunque anche scoprire) significa sempre infrangere una regola; seguire una regola è pura e semplice routine, non un atto di creazione. Per l’esiliato, infrangere le regole non è una questione di libera scelta, ma una circostanza inevadibile. Gli esiliati non conoscono a sufficienza le regole invalse nel paese ospitante, né le trattano con rispetto sufficiente a far apparire sinceri i loro sforzi di osservarle e conformarvisi.
Zygmunt Bauman, Modernità Liquida, Laterza 2002, pp.245-246.
Vale per tutti gli esiliati, quelli all’interno dei propri paesi, coloro che non riescono a omologarsi del tutto, gli emigranti che lasciavano i propri materassi e i poveri corredi a Palermo, al Monte dei Pegni ora restaurato all’interno di Palazzo Branciforte. Un memento che ha un sapore tutto dickensiano. Ho riletto queste frasi Bauman mentre rileggevo, parallelamente, Cent’Anni di Solitudine, ambientato in un luogo – Macondo – che è composto sin dalle sue origini di auto-esiliati che vanno a trovare condizioni migliori. Una città, Macondo, che continua a essere crocevia anche quando si trasforma in un posto pieno di case, di abitudini consolidate, di unioni. La contaminazione e l’accoglienza, a Macondo, non vengono mai meno, perché questa è la forza della città. Dell’archetipo della città.
Vale per i fatti di questi ultimi giorni, segnati – al contrario – dallo sguardo verso l’Altro che si fa più torvo, forse – paradossalmente – più in Occidente che sulla riva sud del Mediterraneo. E invece la contaminazione è vincente. Nella città. E anche in cucina, ovviamente. E allora, per alleggerire riflessioni che rimandano a Edward Said e a Mahmoud Darwish, così come alle lunghe gallerie di legno di Palazzo Branciforte, ecco la ricetta del coniglio allo zafferano. Un piatto che rimanda alla tipica cucina contadina romana (quella di mia madre), condito con quel tanto di profumi in più che non guastano. Per creare, appunto, bisogna sempre infrangere una regola. E gli esiliati, che di regole ne hanno viste molte, seguite in modo più o meno farisaico, sono bravissimi a infrangerle…
Il coniglio deve essere di campagna, a chilometro zero o poco più. Piccolino, insomma. Fatevelo tagliare a pezzi grandi. Marinatelo per un po’ di tempo (basta anche un’ora) con del vino bianco, un po’ di olio, e tutte le erbe aromatiche e spezie che vi trovate nelle vicinanze. Rosmarino, pepe, aglio, e il mio amato origano non ci stanno per niente male.
Fate rosolare il coniglio per bene, così che faccia quel po’ di crosta, in olio e cipolla. E magari aggiungete un po’ di vino, che farete sfumare. Mettete molte carote e molto sedano, tagliati grossolanamente. Se serve, aggiungete un po’ d’acqua, e fate cuocere. A metà cottura, mettete lo zafferano che avrete fatto sciogliere in un po’ di acqua calda, e i pinoli. A fine cottura, le olive nere, quelle al forno. Non cuocetele, le olive, se non per pochissimi minuti, altrimenti il gusto diventa amaro.
Buon appetito, in onore dei grandi e dei piccoli esiliati.
E per la playlist, The Tracks of My Tears, che molti ricordano nella colonna sonora del Grande Freddo, in una particolare versione di Smockey Robinson assieme ad Annie Lennox.
September 19, 2012
La resa dei conti
A quanto pare, soffiare sul fuoco si sta rivelando il gioco di società che fa più scalpore e notizia in Occidente. Il nostro apporto culturale più in voga sembra sia, insomma, sparare le nostre cartucce sul profeta Mohammed, con quell’insano gusto della superiorità culturale-religiosa-razziale che ha portato – per esempio sul suolo europeo – vergogna e lutti… Così, dopo il video islamofobo prodotto negli Stati Uniti (a proposito di film e Hollywood, vedetevi un documentario ormai classico, Reel Bad Arabs. How Hollywood vilifies a people…), ora tocca alle vignette francesi di Charlie Hebdo. Siamo liberi, per fortuna, e dunque non possiamo far niente contro video e vignette. Se oltre a essere liberi, pensassimo anche alle sensibilità altrui così come curiamo le nostre, forse faremmo un passo avanti.
I video e le vignette, comunque, sono uno strumento politico considerato prezioso da molte parti. Dagli islamofobi di casa nostra, per far vedere quanto poca libertà, democrazia e modernità ci sia dalla parte degli arabi musulmani. E soprattutto per confermare le loro tesi: la democrazia non è possibile, per gli arabi di fede musulmana. Allo stesso tempo, l’islamofobia occidentale è anche un formidabile strumento all’interno della galassia islamista, dove la resa dei conti tra riformatori (Fratelli Musulmani) e letteralisti (genericamente detto, i salafiti) si sta avvicinando a passi veloci.
Quello che segue è un articolo che ho scritto per Affari Internazionali. E’ solo una sintesi, questa abbozzata per lo IAI, di un ragionamento che dovrebbe essere molto più approfondito, con tanto di nomi, cognomi, partiti, correnti, etc.
Buona lettura, da accompagnare con uno dei tanti brani vintage che stanno accompagnando questo mio rientro in Italia. Hey Joe, Jimi Hendrix, a 42 anni dalla sua morte. Hey Joe, where you goin’ with that gun of your hand…
CHI PARLA PER L’ISLAM POLITICO. CHI PARLA PER L’ISLAM
Chi parlerà a nome dell’islam, e non solo dell’islam politico, in quei paesi arabi attraversati dalle rivolte e dalle rivoluzioni del 2011 che nei giorni recenti sono stati il palcoscenico dell’ultima fiammata di violenza di strada? Chi si ergerà a “tutore” del messaggio di fede così come della sua traduzione politica, in una fase in cui l’onda dell’islamismo largamente inteso si sta mostrando con forza?
Può sembrare fuorviante, parlare di una battaglia tutta interna al fronte islamista, proprio negli stessi giorni in cui lo scontro visibile è stato tra una parte dell’islam politico – il salafismo genericamente inteso – e, in termini altrettanto generici, gli Stati Uniti. Eppure il nodo è proprio questo. Chi si assumerà l’onere e il diritto di difendere la fede, e dunque – per certi versi – l’identità nei paesi arabi nel pieno della transizione democratica. Chi sarà il guardiano?
A confermare il profondo scontro in corso all’interno della galassia islamista è uno degli intellettuali musulmani di punta (se non il più importante) in Europa. È stato, infatti, Tariq Ramadan, in una intervista televisiva a Democracy Now!, a spiegare la battaglia politica reale che sottende alle manifestazioni contro le ambasciate non solo americane, ma anche quelle di paesi occidentali.
La sfida più importante nel mondo musulmano di oggi, e nei paesi a maggioranza musulmana della regione araba, è – dice Ramadan – quella della “credibilità religiosa”. La Fratellanza Musulmana, spiega meglio, sta subendo la pressione salafita, in Libia, in Egitto, nello Yemen: una pressione per decidere chi avrà in mano lo scettro della credibilità, da spendere nel consenso interno e nella gestione del potere. Lo scontro tra i “letteralisti”, i salafiti genericamente intesi, da una parte, e dall’altra gli islamisti o riformisti “è qualcosa che dovremo affrontare” perché riguarda lo stesso “futuro di questi paesi”.
Se l’analisi è verosimile – e a mio parere lo è -, la questione del rapporto tra i paesi arabi in transizione e la controparte occidentale viene sminuita a favore della dimensione interna. Il confronto tra loro e noi, tra la loro transizione e il nostro ruolo è solo strumentale. Così si spiega la posizione a tratti ambigua, e comunque indebolita, dei partiti espressione del riformismo, e dunque della Fratellanza Musulmana, nella crisi derivata dal video islamofobo prodotto dai settori più oltranzisti della diaspora egiziano-copta negli Stati Uniti. I salafiti, insomma, sono stati i primi a scendere in piazza, facendo scoppiare la crisi, e hanno poi mostrato diverse facce, da quella tutto sommato meno pericolosa in Egitto, e la deriva violenta del salafismo tunisino, già espressa negli attacchi alle libertà individuali degli scorsi mesi.
I partiti legati alla Fratellanza Musulmana, al potere sia a Tunisi sia al Cairo, si sono trovati a fronteggiare la pressione salafita, cercando di non ricoprire lo stesso ruolo che i regimi precedenti avevano rivestito. A non sembrare, dunque, appiattiti sulle posizioni occidentali, sacrificando la loro identità – nazionale prima ancora che islamista – sull’altare delle buone relazioni con gli Stati Uniti in primis, e anche con l’Europa. Questa è la ragione per la quale, soprattutto nei primi due giorni di manifestazioni di fronte alle ambasciate americane, le forze dell’ordine in Tunisia e in Egitto non hanno avuto il mandato di reprimere duramente. Un po’ per lasciare aperto il canale di sfogo, un po’ per non farsi erodere il consenso popolare alla destra della galassia islamista.
Il risultato è stato quello che sappiamo. Una reazione confusa, alla quale i due governi hanno cercato di rimediare nei giorni successivi. Soprattutto con le dichiarazioni del presidente egiziano, Mohammed Morsi, che ha mostrato ancora una volta una capacità politica per molti versi inattesa.
Da questo quadro, Yemen e ancor di più Libia sono messe ai margini. Non perché siano meno rilevanti, soprattutto dopo l’attacco, forse preparato in anticipo, al consolato americano a Benghazi e la morte di un ambasciatore come Chris Stevens, che nel Secondo Risveglio arabo ci aveva creduto. Yemen e Libia, però, sembrano fuori da questo confronto binario tra salafiti e Fratelli Musulmani. Vuoi perché le dinamiche nazionali fanno storia a sé. Vuoi perché in entrambi i casi il ruolo del jihadismo qaedista è una variabile che non sembra essere presente né in Egitto né in Tunisia, dove l’influenza è invece tutta quella wahhabita. Un’influenza che fa emergere la forte presenza del Golfo, e soprattutto dell’Arabia Saudita, con l’obiettivo di sminuire le istanze del Secondo Risveglio arabo favorendo la presenza salafita.
Il nuovo capitolo aperto dalla crisi di The Innocence of Muslims fa presagire una resa dei conti tra le due componenti più importanti della galassia islamista. Una resa dei conti tra riformisti e letteralisti che fa parte di una parte della storia ideologica e culturale araba che ormai ha oltre un secolo, e che ora si gioca sul parterre della politica e della gestione del potere. La differenza, rispetto al prima, non è soltanto il fatto che i Fratelli Musulmani abbiano conquistato il consenso bastante per governare. Ma che i salafiti, a differenza degli anni e dei mesi precedenti alla stagione rivoluzionaria del 2011, abbiano deciso di entrare nel gioco parlamentare. E di sfidare i riformisti anche su un terreno, come quello della partecipazione politica, che veniva considerato inusuale, lontano dagli stessi fondamenti del pensiero salafita.
La foto è ancora una volta di mosaaberizing
September 15, 2012
Rabbia, numeri e il gusto dell’iperbole
Guardate questa foto. Osservatela bene. Come sempre succede, le immagini possono essere interpretate a seconda del punto in cui si concentra l’attenzione. Vi elenco quello che io vedo. Ragazzi che pregano. Vi posso dire che pregano in una strada del Cairo, fotografati da mosaaberizing, uno dei ragazzi che per tutta l’epopea di Tahrir, tra gennaio e febbraio 2011, è stato in piazza a vivere e descrivere la rivoluzione egiziana. Ragazzi che, a giudicare da come vestono, potrebbero essere ultras di una delle squadre di calcio del Cairo, e/o ragazzi a cui è stata data poca speranza di un futuro decente. Marginali? Forse, ma non è detto. Pregano in una sosta della battaglia ingaggiata con la polizia egiziana nelle proteste di questi ultimi giorni per il video anti-islamico. Lanciano sassi contro i poliziotti che difendono l’ambasciata americana in Egitto.
Poche certezze, anzi, molta confusione, nella lettura di questa bellissima foto. C’è però un elemento che è incontrovertibile. Sono un pugno di ragazzi, sono pochi. E di numeri, oggi, voglio parlare.
A dire il vero, non sono la sola. Ieri Mark LeVine, antropologo e musicologo che scrive anche sul sito di Al Jazeera, studioso molto interessante, aveva messo un link sulla sua pagina Facebook: il link a una foto di Joe Bradford. Nella foto non c’erano ragazzi musulmani, ma quegli stessi ragazzi c’erano in forma di numeri. In un grafico molto semplice, erano riportati alcuni dei principali paesi a maggioranza musulmana, la popolazione di ciascuno, e in una colonna a parte il numero di partecipanti alle proteste di questi giorni. I dati della popolazione dei singoli paesi erano quelli della Banca Mondiale. Il numero dei dimostranti ricavato dai lanci di agenzia. Fatta la tara sull’evoluzione delle proteste, sui numeri mancanti di alcuni paesi, il grafico regge. A protestare, in questi giorni, saranno state 10mila, forse ventimila persone? Vogliamo esagerare, e stimarne cinquantamila? Joe Bradford parla di 9mila dimostranti in giro per il mondo. Io credo che ce ne siano stati di più, tra le centinaia a Sydney di stamattina e le poche migliaia del Cairo, sino ai numeri più consistenti di Khartoum, di San’a, di Tunisi. E se anche fossero stati centomila, un totale di centomila in tutti i paesi a maggioranza musulmana, dove – nel complesso – vivono un miliardo e duecento milioni di fedeli nell’islam, possiamo veramente – come giornalisti – dipingere quello che sta succedendo in questi giorni come una vera e propria insurrezione, una rivolta, un’orda furiosa? Possiamo avere l’ardire di chiamare quello che sta succedendo come “la rabbia islamica”, come “furia islamica globalizzata” (La Padania), il “venerdì della rabbia islamista” (Avvenire), “Comanda Al Qaeda. Rivolta contro l’Occidente nel nome di Allah” (Libero), “Islam, rivolta anti-Occidente” (Il Messaggero), “i giorni dell’ira contro l’America” (Repubblica)? Ho scelto solo i titoli più eclatanti, e la lista della semplificazione, e soprattutto dell’iperbole, non si conclude nei pochi esempi che ho fatto.
Bastano e avanzano questi esempi, però, per chiederci tutti per quale motivo ci sia bisogno di mistificare in questo modo la realtà, ingigantirla a tal punto da far credere – ai lettori – che sia imminente un’invasione. E che tutti i musulmani, tutto il miliardo e duecento milioni, ce l’abbiano con noi, che siamo buoni e non abbiamo fatto nulla. Che siamo tolleranti, propaghiamo il verbo dei diritti in giro per il mondo, e soprattutto non bruciamo le ambasciate. Magari talvolta mandiamo truppe armate non solo di equipaggiamento militare, ma anche di buoni propositi. Questa, però, pensiamo sia tutta un’altra storia…
Le foto di mosaaberizing non ritraggono solo ragazzi che pregano. Ritraggono ragazzi che tirano sassi e molotov, incendiano blindati, indossano pantaloni simili a chi, l’anno scorso, mise in ginocchio Roma e incendiò i blindati delle nostre forze dell’ordine. Non rappresentavano tutta Roma, tutta l’Italia, tutta l’opposizione, tutto il disagio. Erano pochi, anche allora, a Roma, a prendere in ostaggio una grande manifestazione indetta per altri scopi. E anche allora, a Roma, i giornali fecero poca distinzione, tra chi aveva messo a ferro e fuoco l’area attorno a San Giovanni e chi – pacificamente – avrebbe voluto dimostrare il dissenso.
Allora, forse, il problema non è il modo in cui noi giornalisti rappresentiamo un mondo che pensiamo diverso, lontano e antagonista al nostro. Il problema non è il modo in cui noi giornalisti presumiamo di rappresentare il mondo arabo, il più grande mondo musulmano, le sensibilità religiose, i profeti, le fedi considerate di serie A e di serie B. Il problema è come rappresentiamo la realtà. Qualunque essa sia. È realtà? È iperbole? È una parola disconnessa dalla realtà e dagli eventi?
Un’ultima domanda, che condivido con Issandr al Amrani: perché la ‘rabbia’ non è scattata per episodi più esecrabili, dal punto di vista dell’immaginario musulmano, come la copia del Corano bruciata in Afghanistan da un soldato americano? È una rabbia, come dice arabist, “fabbricata” da un network internazionale di attivismo islamista? Il tempo non è ininfluente, in tutta questa triste storia: non solo per l’11 settembre, non solo per altri anniversari importanti nella storia recente del Medio Oriente come il trentennale del massacro di Sabra e Shatila. Il tempo è il tempo della campagna elettorale americana che dovrebbe – anche – scegliere tra due approcci in politica estera (non c’è una distanza siderale tra i due approcci, ma quella che c’è basta per stravolgere in un modo o in altro la regione mediorientale). Il tempo è anche il tempo dell’assemblea generale delle Nazioni Unite, che a ogni settembre si dovrebbe occupare di molte cose, e non di un immaginario e pompato scontro di civiltà ad usum delfini. Il tempo è il tempo del braccio di ferro tra l’amministrazione Obama in scadenza e il premier israeliano Bibi Netanyahu su un possibile raid preventivo israeliano sui siti nucleari iraniani, e sui rischi di un conflitto da
Ce n’è insomma abbastanza di carne al fuoco perché la rabbia di qualche migliaio di dimostranti – salafiti, ultras, islamisti, emarginati – possa essere confinata là dove deve essere confinata.
September 14, 2012
“Ma perché ce l’hanno con noi?”
È sempre e solo una la domanda che rimbalza, soprattutto in Italia. La stessa, che ci si sintonizzi su un canale di allnews, oppure che si entri in un negozio e – visto il mio mestiere – si cominci a chiacchierare su quello che sta succedendo a Benghazi, al Cairo, a Khartoum, a San’a, a Tripoli del Libano, a Tunisi. Sempre e solo una: ‘ma allora, ora che succederà con le Primavere arabe?’. E poi, a corollario: ‘Ma perché ce l’hanno con noi (occidentali)?’
Domande legittime, soprattutto quando vengono dalla strada, dai negozi, dal pubblico. Per rispondere, però dovremmo concentrarci meno sul bersaglio, sul ‘noi’, e più sui luoghi della protesta e sui protagonisti degli assalti alle sedi diplomatiche e a agli edifici considerati occidentali (come la scuola americana a Tunisi).
Cominciamo dai luoghi della protesta. Terribilmente scontato che le manifestazioni anti-americane si siano svolte a San’a e Khartoum. In Yemen, perché la presenza qaedista è evidente, tanto quanto è evidente la presenza americana che ha colpito, in questi anni, molti uomini e cellule considerati parte della rete del terrorismo legato a Bin Laden e ad Ayman al Zawahri. In Sudan perché il braccio di ferro tra le amministrazioni americane che si sono succedute e il regime di Khartoum non si è mai concluso. Più complessi, invece, gli altri luoghi delle manifestazioni di protesta. A cominciare da Tripoli del Libano. Tripoli è la città in cui, alcuni anni fa, si dispiegò la battaglia per Nahr al Bared, il campo profughi in cui si era impiantato un gruppo jihadista. Per sconfiggerlo, l’esercito libanese usò tanta forza da distruggere, in sostanza, buona parte di Nahr al Bared. È verosimile, dunque, che Tripoli non sia per nulla pacificata. Anzi.
C’è poi Tunisi, dove la presenza salafita ha già mostrato la sua faccia violenta, prima che contro gli americani, contro gli stessi tunisini. Cosa significa? Che i salafiti vogliono far vedere che ci sono, che sono una forza, e che contano? Può darsi. Così come può darsi che vogliano farsi vedere al Cairo, visto che sono stati i primi a scendere in piazza contro il video anti-islamico prodotto negli Stati Uniti.
In entrambi i casi, sono proprio le Primavere arabe a rimetterci, dalle proteste di questi giorni. Non sono certo i protagonisti delle rivolte/rivoluzioni arabe a essere scesi in piazza per The Innocence of the Muslims. Ma la lettura superficiale degli eventi di questi giorni, qui da noi, ha già bollato loro – i protagonisti delle rivolte/rivoluzioni ancora in corso – come i facinorosi che distruggono le ambasciate.
Facile, dunque, che con un tratto di penna si leghi il Secondo Risveglio arabo al pericolo di un nuovo 1979. E cioè che le rivoluzioni arabe seguano lo stesso percorso della rivoluzione in Iran, prima multiforme, poi khomeinista. Prima plurale, e poi simboleggiata dalla presa degli ostaggi americani.
Non è così. La storia non si ripete. Il khomeinismo non è l’islam politico arabo-sunnita. Il khomeinismo non è la Fratellanza Musulmana.
Ci sono, però, i salafiti. I salafiti che hanno preso voti e consenso in Egitto e in Tunisia. Vale la pena ricordare che i salafiti sono stati foraggiati per decenni, in Egitto ma non solo, all’ombra delle dittature con cui avevamo ottimi rapporti. E che i salafiti propagandano un tipo di messaggio molto vicino al wahabismo saudita, per nulla riformatore, e molto lontano dall’impianto ideologico della Fratellanza Musulmana. Sono loro, i salafiti, tra i protagonisti da seguire, soprattutto a Tunisi, che ancora una volta sembra essere il primo laboratorio di questa terza fase delle rivoluzioni. Prima la rivolta, poi le elezioni, poi il braccio di ferro per il potere (nella foto, presa dall’account twitter di Nawaat, si vedono appunto manifestanti salafiti tunisini).
Dunque? Dunque ci sono molti ingredienti, nel cocktail perverso che in queste ore ha dato fuoco alle polveri, e alle ambasciate americane e occidentali. Molti ingredienti, ma nessuno di questi può essere appaiato così facilmente alle richieste portate in piazza nei primi mesi del 2011, che parlavano di democrazia, inclusione, diritti.
C’è invece un ingrediente che va studiato per bene, in tutta la sua complessità, ed è l’antiamericanismo. Ma di quello mi occupo domani. Per oggi può bastare.
September 13, 2012
Postille sull’ultima fiammata di violenza
I titoli sui giornali, sui media online, sono altisonanti. Assalto alle ambasciate americane. D’altro canto, i primi numeri di questa nuova fiammata di antiamericanismo che si diffonde in Medio Oriente e Nord Africa non spingono all’ottimismo. Quattro morti a Benghazi, quattro morti americani all’interno del consolato della seconda città libica: un ambasciatore, Chris Stevens, morto per asfissia. Due morti yemeniti a Sana’a, nell’assalto all’ambasciata USA. E al Cairo, attorno e nei dintorni della più grande ambasciata americana del mondo, le manifestazioni non si fermano, anche se sono cambiati i protagonisti delle dimostrazioni: fuori i salafiti, che erano scesi in piazza nei primi due giorni, dentro gli ultras e – diciamo così, con un termine sicuramente troppo generico – un pezzo di marginalità del Cairo, uniti nel chiedere al governo islamista risposte ad alcune importanti richieste sociali della rivoluzione.
La prima reazione, la più immediata, è quella di bollare tutto come la sagra della stupidità, il teatro dell’idiozia. Idioti (e in malafede) coloro che hanno girato il video anti-islamico con il chiaro intento di provocare, accendere la miccia sotto una paglia ben secca, e tirare la volata (di nuovo) a chi sostiene che lo scontro di civiltà è una certezza. Idioti i sostenitori beceri dell’antiamericanismo, anacronistici, passatisti, magari anche utili strumenti nelle mani di chi vuole minimizzare il Secondo Risveglio arabo.
Detto tutto questo, però, occorre andare oltre. Hani Shukrallah – uno degli opinionisti egiziani più interessanti – lo fa, in un articolo che vale la pena leggere perché mette assieme la campagna elettorale di Obama, gli amanti dello scontro di civiltà, i militari egiziani. Shukrallah, laico, ricorda che gli attacchi più pesanti contro i copti (sulla diaspora copta negli USA e sulle sue frange estremiste che la pensano come chi ha prodotto il video, ho scritto una postilla, giù in fondo) sono stati quelli dei militari egiziani non solo nel famoso massacro di Maspero dell’ottobre 2011, ma nell’enfasi con la quale la tv di Stato controllata dal Consiglio militare supremo ha rinfocolato la xenofobia e il rinserrare i ranghi da parte dei musulmani.
Il secondo consiglio di lettura è da una prospettiva più americano-centrica: quella di Shadi Hamid su Foreign Policy, che spiega bene perché proprio ora – in Occidente – non bisogna abbandonare il Secondo Risveglio arabo, e rifuggire dagli stereotipi. Don’t give up the Arab Spring…
Entrambi gli analisti, Shukrallah e Hamid, ci pongono giustamente la domanda del cui prodest. Perché il video proprio ora. Perché gli attacchi alle ambasciate americane proprio ora. Perché a perderci, dal video e dagli assalti, sono sia Barack Hussein Obama sia le rivolte/rivoluzioni arabe. Perché a tentare di guadagnarci, dopo aver ‘subito’ l’epopea delle rivoluzioni arabe, è tutta quella fascia retriva che va dai settori cristiano-evangelici che hanno sostenuto il peggio del conservatorismo americano, sino alla destra europea razzista.
Oltre le ambasciate, oltre l’antiamericanismo più becero, ci sono – insomma – altre vittime, stavolta tutte politiche. Ed è chiaro che il primo bersaglio – quale tempismo! – è un presidente che ha perso molto smalto, rispetto a quattro anni fa. Barack Hussein Obama, presidente in scadenza, nel mezzo di una campagna per la rielezione difficile. Per il pubblico mediorientale, nel 2009, Obama fu il presidente americano che aveva deciso di rompere l’equazione islam=terrorismo. Basta con le teorie folli dello scontro di civiltà, alle quali si era abbeverata la destra non solo americana, ma anche quella europea. Era ora di ricostruire ponti e fiducia.
A quattro anni di distanza, l’immagine di Obama nel mondo arabo è offuscata. Soprattutto per la sua politica nei riguardi del conflitto israelo-palestinese, con uno spostamento sempre più marcato a favore del governo di Bibi Netanyahu, a prescindere dal braccio di ferro sull’Iran di queste ultime settimane. Obama deve fronteggiare, all’interno, Mitt Romney, che non brilla nei sondaggi. E che invece potrebbe guadagnare da una fiammata di violenza lontana dalle rive dell’Atlantico, eppure così simbolica. L’assalto alle ambasciate americane, proprio nell’undicesimo anniversario dell’11 settembre, sembra a dir poco tempista. Chi, più dei repubblicani, può guadagnare dall’America sbeffeggiata e dolorosamente attaccata in terra araba, là dove Obama voleva segnare la discontinuità rispetto al suo predecessore Bush? A giudicare da come si stanno muovendo sui social network le frange della destra americana più islamofobe, il clima non si rasserenerà presto, nonostante i tentativi di Hillary Clinton di smorzare i toni.
Dall’altro capo di questo scontro a distanza, c’è la galassia islamista. Che, però, è talmente composita che guardarla come un tutt’uno, omogeneo e compatto, è ancora una volta fuorviante. La tentazione, da parte di Washington, di raffreddare le posizioni verso gli islamisti è già evidente, con la dichiarazione di Barack Obama sull’Egitto, non un alleato né un nemico. Dichiarazione ambigua, confusa, ma in un elemento molto chiara: e se si fosse andati troppo lontani nel rapporto con l’islam politico arabo vittorioso al Cairo, sembrano dire nell’amministrazione democratica? E se fossimo stati troppo Realpolitiker? Dal canto loro, i Fratelli Musulmani egiziani – a parer mio – si sarebbero evitati molto volentieri una crisi come questa, nei confronti di Washington. Una crisi che vuol dire anche riaprire vasi di Pandora, come la giustizia sociale in Egitto. I due argomenti – l’antiamericanismo e la giustizia sociale – possono sembrare molto distanti l’uno dall’altro, ma il tipo di dimostranti che in questi giorni si sono alternati attorno all’ambasciata americana dice invece molto. Dice che i salafiti, dopo due giorni di proteste pacifiche, hanno lasciato il posto a chi, negli ultimi mesi, ha chiesto al potere egiziano ciò che era il cuore della domanda sociale di Tahrir: dignità e lavoro.
L’ultima vittima di questa ennesima fiammata, e non certo la meno importante, è però l’immagine di un mondo arabo che nel 2011 si era riscattato agli occhi miopi e socchiusi di noi occidentali. L’arabo non aveva più la faccia torva del terrorista, ma quella sorridente di un ragazzo-eroe. Meglio ancora, di una ragazza coraggiosa. Ora, di nuovo, a campeggiare sui nostri giornali è il branco. Anche se il branco, a ben guardare, non è riuscito stavolta a raccogliere in piazza le folle che, alcuni anni fa, urlavano contro le vignette danesi. Meglio non abbandonarle le rivolte arabe, proprio ora, per sacrificarle ancora una volta sull’altare degli stereotipi.
Una postilla sul video che ha scatenato l’ennesima fiammata di antiamericanismo, però, bisogna farla. Sam Bacile, dice l’AP, potrebbe non essere un israeliano-americano, bensì un membro della diaspora copta egiziana di stanza negli Stati Uniti, o meglio, di quel settore della diaspora copta per il quale il problema degli egiziani di fede cristiana non è la dittatura né la mancanza di democrazia e di diritti, bensì l’islam. E’ verosimile, non c’è che dire. Non sono l’unica, per esempio, a essere inondata di email da parte di associazioni di egiziani copti della che vivono negli USA, le cui posizioni sono non molto dissimili da quelle di alcuni settori cristiano-evangelici che hanno sostenuto non solo Bush jr., ma la destra americana più retriva. E’ quel pezzo di diaspora egiziana che Ala al Aswani ha descritto egregiamente in Chicago. E’ quel pezzo di diaspora egiziana che non ha per nulla aiutato i copti in patria. Anzi. Ha semmai sostenuto una visione del ruolo dei copti come setta, e non come parte della popolazione, confinando i cristiani egiziani nel ghetto di una minoranza. Al contrario, i copti che hanno partecipato a Tahrir, e i musulmani che li hanno sostenuti, hanno sempre parlato di diritti per tutti, a prescindere dal credo, perché solo in questo modo ognuno e tutti, copti, donne, laici, islamisti, liberal, gay, giovani, vecchi sarebbero stati protetti.
La didascalia della foto di Ashraf Khalil, su twitter: “quando si piò dire che si tratta di una manifestazione egiziana? Quando arrivano gli ambulanti!”
Per il brano della playlist mi è venuto in soccorso FB. Footsteps, dei Pearljam. Altra America.