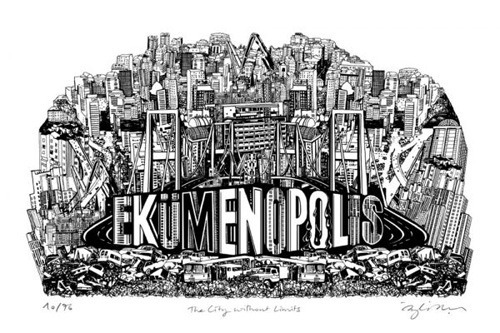Wu Ming 4's Blog, page 112
August 10, 2013
Quale razza? Genere, classe e colore in «Timira» e «L’ottava vibrazione»

[Il 12 agosto 2012 veniva inaugurato ad Affile (RM) il Vespasiano di Sangue in memoria di Rodolfo Graziani, macellaio d'Italia. Nonostante le polemiche, le maledizioni abissine e la revoca dei fondi regionali, il monumento è ancora lì e non più tardi del 29 giugno scorso, ha visto riunirsi a convegno un centinaio di fascisti, con il solito corredo di saluti romani. Per non dimenticare questa vergogna, nei prossimi giorni pubblicheremo qui su Giap due articoli sulla memoria del colonialismo italiano.
Cominciamo con il nuovo numero di Studi Culturali (n°2, Anno X), rivista pubblicata dalla casa editrice Il Mulino . In copertina, la notissima foto di Mario Balotelli in versione Hulk, e all'interno una "tavola rotonda" a cura di Gaia Giuliani intitolata: La sottile linea bianca. Intersezioni di razza, genere e classe nell'Italia postcoloniale. Obiettivo di questa sezione "è raccogliere suggestioni provenienti da un numero ampio e interconnesso di discipline al fine di indagare le dimensioni sia discorsive sia materiali dell'immaginario razzista italiano". Qui di seguito riportiamo l'intervento di Sonia Sabelli - su Timira e L'ottava vibrazione - preceduto dalla "didascalia" scritta da Daniele Salerno per commentare l'immagine di copertina. Buona lettura.]
L’incredibile Hulk “azzurro”. Così molti giornali italiani e stranieri, riprendendo il titolo di El País, definirono Mario Balotelli all’indomani della semifinale dell’Europeo 2012, vinta dall’Italia grazie a una doppietta del calciatore nato nel 1990 a Palermo da genitori ghanesi e cresciuto in una famiglia bresciana.
La definizione si deve alla foto che pubblichiamo in copertina. Balotelli esulta dopo il secondo goal, quello della vittoria, segnato contro la nazionale tedesca: messa la palla in rete, il giocatore si sfila la maglia, lasciandola cadere ai suoi piedi, e tende i muscoli; sul braccio destro è ben visibile il lutto indossato dalla squadra per ricordare Manuele Braj, soldato italiano morto pochi giorni prima in Afghanistan. Le ginocchia sbucano tra i calzettoni azzurri – orlati dal tricolore – e i pantaloncini bianchi con il gagliardetto della nazionale e la scritta Italia.
In quella definizione sta tutto il meaning of Mario, per riprendere il titolo della copertina che Time dedicherà qualche mese dopo a Balotelli: un Hulk, ma azzurro; un italiano, ma nero. Due aggettivi di colore che vanno a mutare un tratto semantico dei sostantivi cui si riferiscono: l’essere verde di Hulk e soprattutto la, storicamente costruita, bianchezza dell’italiano, argomento della tavola rotonda curata da Gaia Giuliani che costituisce il cuore di questo numero di Studi Culturali.
La figura di Balotelli invade lo spazio semantico della bianchezza italiana e lo fa da un luogo discorsivo centrale dell’immaginario nazionale e maschile: il campo di calcio. E non un campo di calcio qualsiasi, ma il rettangolo di gioco dove va in scena il rito sportivo per eccellenza: l’eterna sfida Italia-Germania, che rinnova ogni volta la memoria di uno dei miti (ri)fondativi dell’identità nazionale del secondo dopoguerra, Italia – Germania 4 a 3 (anche quella una semifinale).
Come il protagonista di Autobiografia del rosso, un romanzo di Anne Carson, Balotelli costringe all’aggettivazione, così da modificare sostantivi che non ne includono l’identità e di cui il calciatore, con l’esposizione del suo stesso corpo, mette in crisi i significati: a cominciare proprio da quelli legati al campo semantico dell’italianità. La parola aggettivo, come ci ricorda sempre Carson, è a sua volta un aggettivo: epítheton che in greco significa “apposto”, “aggiunto”, e quindi “importato”, “straniero”, e il cui prefisso – epí – usiamo ancora oggi per formare la parola epidermide. L’incredibile Hulk “azzurro”, dunque. L’italiano nero. E forse, un giorno, molto più semplicemente: l’italiano.
***
Quale razza? Genere, classe e colore in Timira e L’ottava vibrazione
di Sonia Sabelli
In questi ultimi giorni la stampa italiana ha definito la neoministra italocongolese Cécile Kyenge come la prima donna «di colore» (come se dire «nera» fosse un insulto e come se il bianco fosse un non-colore) ad assumere l’incarico di «ministro» (al maschile, come se un ministro non potesse essere una donna e come se la gente nera non avesse un sesso). Non è dunque un caso che l’interessata abbia dovuto ribadire di essere una donna nera e di esserne fiera. Evidentemente, come ci insegnano le femministe e le lesbiche afroamericane, sessismo e razzismo agiscono sempre simultaneamente: sono «sistemi interconnessi di dominio che si rafforzano e si sostengono a vicenda» (hooks 1991, 39). A partire da questa consapevolezza, riprendo qui alcuni degli stimoli offerti dall’intervento di apertura di Gaia Giuliani sull’identificazione tra bianchezza e italianità e sulle intersezioni di genere, classe e colore, per verificare come tali temi siano rappresentati nella letteratura italiana contemporanea. Il mio intervento si concentra in particolare su due romanzi, L’ottava vibrazione di Carlo Lucarelli (2008) e Timira. Romanzo meticcio di Wu
Ming 2 e Antar Mohamed (2012), che testimoniano il recente interesse mostrato da alcuni scrittori molto noti per la storia coloniale italiana.
Nella postfazione, Lucarelli presenta il suo bestseller come «un romanzo
storico ambientato in Eritrea attorno alla battaglia di Adua» (1896). Passata alla storia come una «disfatta» – secondo la prospettiva colonialista incarnata dal narratore del romanzo è «la più grande sconfitta mai subita da un esercito coloniale europeo» (Lucarelli 2008, 441) – Adua si configura piuttosto, agli occhi del popolo etiope e dei movimenti panafricani, come quella «vittoria africana» (vedi Haile Gerima, Adwa. An African Victory, documentario, Etiopia, 1999) che ha messo in questione «la “supremazia bianca” dei discorsi europei e il progetto di intensificazione dello sfruttamento dell’Africa» (Derobertis 2010, 16). Il romanzo di Lucarelli, però, col suo sguardo esotista, saturo di stereotipi razzializzanti che riecheggiano la letteratura e la fotografia di epoca coloniale, non opera quel rovesciamento dei punti di vista che ci si aspetterebbe da un romanzo contemporaneo, confermando quanto la prospettiva postcoloniale non sia una questione cronologica ma di consapevolezza critica. Timira, invece, fin dal sottotitolo, si propone esplicitamente di attraversare la linea del colore, mescolando memoria, documenti d’archivio e invenzione narrativa: nella quarta di copertina si spiega che il romanzo è stato scritto a sei mani da «un cantastorie italiano dal nome cinese [Wu Ming 2], insieme a un’attrice italosomala ottantacinquenne [Isabella Marincola, sorella del partigiano nero Giorgio] e a un esule somalo con quattro lauree e due
cittadinanze [suo figlio Antar Mohamed]» – anche se poi sarà pubblicato dopo la morte di Isabella, che perciò compare solo come protagonista e non come figura autoriale. Un particolare non secondario, se affiancato alla consapevolezza (che emerge negli «interludi») della relazione gerarchica che si instaura necessariamente tra chi detiene il potere di raccontare la propria versione delle storia e chi invece viene raccontata/o, oltre che dei rischi connessi all’interiorizzazione di una mentalità coloniale, sempre in agguato nelle nostre teste di occidentali (Wu Ming 2 e Mohamed 2012, 345).
Qui analizzo in particolare le rappresentazioni della bianchezza e della nerezza che compaiono nei due testi, a partire dalle loro intersezioni con la costruzione del genere e dell’italianità. La costruzione dell’italianità segue percorsi
diametralmente opposti nei due testi, per ovvi motivi di ambientazione storica:
se Timira costituisce un tentativo di decostruire l’identificazione tra colore e nazione nell’Italia dei respingimenti e del pacchetto sicurezza, L’ottava vibrazione si inserisce senza soluzione di continuità in quella tradizione letteraria che narra l’Africa come «il lato oscuro», il «cuore di tenebra» (vedi i versi in epigrafe che spiegano il titolo del romanzo) e che legge il colonialismo come una metafora avventurosa e come uno dei miti fondativi della nazione e della maschilità bianca, oppure, per usare le parole dell’autore, come «il nostro Far West» . Certo, si deve riconoscere a Lucarelli la capacità di evidenziare le continuità, spesso dimenticate, nella storia del colonialismo italiano, dall’età liberale, in cui si svolge il romanzo, all’impero fascista, che si distinguerà per l’aspetto specifico delle politiche sessuali improntate sulle leggi razziali, con la criminalizzazione delle unioni miste e il divieto di riconoscere i figli nati da esse. Inoltre, è significativa la presenza tra i soldati coloniali di un socialista che ammira Andrea Costa (il deputato che nel 1887, durante il dibattito parlamentare sul rifinanziamento della missione coloniale seguito al massacro di Dogali, aveva affermato «né un uomo né un soldo») e dell’anarchico internazionalista Pasolini, che non perde occasione per mettere in evidenza «le contraddizioni del sistema» e si rifiuta di combattere declamando ad alta voce i versi di Ulisse Barbieri: «ma non capite, o branco di cretini, che i patrioti sono gli abissini?» (Lucarelli 2008, 36 e 257). Ma vi sono altri elementi che ripropongono la funzione storica del colonialismo in quanto metafora della costruzione della maschilità italiana come bianca e coloniale. Ad esempio, la descrizione del soldato «insabbiato» Sciortino come un contadino meridionale poco intelligente, che non ha pensieri ma solo sensazioni, e agli occhi dei commilitoni «sembra un abissino» (ivi, 389), riproduce gli stereotipi razzisti sul Mezzogiorno d’Italia come sinonimo di arretratezza e sottosviluppo. Mentre l’insistenza quasi ossessiva sulle varietà regionali dell’italiano che caratterizzano la parlata dei soldati è un segno della mancanza di omogeneità linguistica e culturale di una nazione che ha appena avviato il suo processo di unificazione linguistica e culturale; in questo contesto, si inserisce la percezione della Colonia Eritrea come il luogo in cui i soldati e i funzionari coloniali che popolano il romanzo di Lucarelli possono realizzare il sogno di coprirsi di gloria e soddisfare il desiderio di provare emozioni forti, diventando degli eroi. Se è vero che queste rappresentazioni corrispondono alla necessità di costruire una memoria del colonialismo italiano, è anche vero che quella di Lucarelli – come ha affermato Paolo Jedlowski – è «una memoria che non prende posizione» oppure – come ha precisato Giulietta Stefani – «questa posizione è a tratti ambivalente», proprio per la mancanza di una problematizzazione, evidente soprattutto nelle rappresentazioni stereotipate dei personaggi, sia colonizzati che colonizzatori, e delle relazioni tra i due gruppi.
Ritengo invece che siano proprio le relazioni tra i due gruppi, e in particolare le rappresentazioni del colore, del genere e della sessualità, i nodi cruciali su cui si gioca la possibilità di rilevare in questi testi una prospettiva postcoloniale, che contribuisca a decostruire gli stereotipi razzisti, sessisti e disumanizzanti, oppure a rinforzarli.
In un documentario che significativamente si intitola Quale razza (A.Amadei, video-intervista con Isabella Marincola, Motoproduzioni, 2008 ) Isabella Marincola incalza così il suo intervistatore: «Io sono un’italiana, con la pelle scura. ti va bene a te? O sei anche tu un razzista? [...] mi ricordo che qualcuno mi ha detto: “sei la vergogna della razza!” Allora mi sono chiesta: “quale razza?”». Gli stessi interrogativi ritornano in Timira, quando la protagonista reagisce agli insulti razzisti decidendo di dedicarsi «con grande entusiasmo» a questa particolare abilità, essere «la vergogna della razza», che ha il potere di disorientare i suoi interlocutori (Wu Ming 2 e Mohamed 2012, 279-80). Figlia di una donna somala e di un soldato coloniale che decide di allevare lei e il fratello in Italia, perché convinto che «il figlio meticcio, quando educato da italiano, possa aspirare
alle stesse conquiste di un italiano intero» (ivi, 50), da bambina Isabella è convinta di avere la pelle nera per via del sole di Mogadiscio (ivi, 103). Da adulta, invece, reagisce al razzismo identitario che la considera automaticamente una straniera, una «profuga in patria» (ivi, 181), perché non coincide con la norma somatica bianca, rivendicando la possibilità di identificare nerezza, meticciato e italianità.
Isabella si autodefinisce infatti come «un’italiana dalla pelle scura» (ivi, 395), ma sa bene che per la mentalità comune questo è ancora un ossimoro: «se sei italiano e hai la pelle scura, sei una contraddizione vivente. Devi dimostrare che sei davvero italiano, devi essere più italiano degli altri» (ivi, 449). Paradossalmente, lo stesso trattamento le viene riservato sia dall’amica albanese Merushe – di fronte alla quale deve ribadire di essere italiana nonostante la propria nerezza (ivi, 120) – sia in Somalia, dove la chiamano «gaal», infedele, e dove suo figlio si rifiuta di frequentare la scuola italiana perché vorrebbe dire che si vergogna di essere somalo (ivi, 425). L’unica soluzione che le permetta di sfuggire alla logica nazionalista, identitaria e razzializzante in cui si trova intrappolata suo malgrado, è quella di riaffermare una duplice appartenenza: «la mia patria era l’Italia, mentre la Somalia era la mia matria» (ivi, 282), conclude Isabella citando implicitamente Igiaba Scego: «Eravamo dei dismatriati, qualcuno – forse per sempre – aveva tagliato il cordone ombelicale che ci legava alla nostra matria, alla Somalia» (Scego 2005, 11).
In entrambi i romanzi, l’affermazione della bianchezza come sinonimo di
italianità è complementare alla svalutazione della nerezza, considerata come
la quintessenza dell’alterità. Nell’Ottava vibrazione, in particolare, l’avanzare
dell’esercito del Negus ad Adua, anticipato dal rombo assordante dei tamburi e da un «puzzo aspro e feroce» che è l’«odore di altra gente, di altri soldati», è descritto come «un’onda nera», una «marea che cresce, un flusso inarrestabile, che arriva di corsa, urlando» (Lucarelli 2008, 425-426), quasi a riprodurre le immagini minacciose e inquietanti di «orde» ed «esodi biblici» spesso associate alle migrazioni contemporanee. In perfetta continuità con l’immaginario coloniale, i soggetti colonizzati sono rappresentati sempre come esseri inferiori e animaleschi: c’è un ascaro con la «faccia da cavallo» (ivi, 16, 19), il piccolo Berè squittisce «come un topo» (ivi, 69), un altro bambino è «nero e irsuto proprio come una scimmietta» (ivi, 242) e Sabà si aggrappa al suo soldato «come una scimmia» (ivi, 138), fino all’estremo di Aicha che, dall’inizio alla fine del romanzo, è apostrofata soltanto come «la cagna nera» (ivi, 11, 12, 14, 80, 194, 446). secondo il narratore «Aicha è un animale, è una iena, un gatto nero, che filtra il mondo attorno soltanto con i sensi» (ivi, 233) e come un animale non possiede nemmeno la capacità di parlare: «Aicha non ha parola, non ha pensieri, solo sensazioni, come una iena o un gatto nero» (ivi, 235). Più in generale, le rappresentazioni delle donne nere oscillano tra le due figure femminili tipiche dell’immaginario coloniale – Aicha, la prostituta «nuda, sporca e nera» (ivi, 13), dalla «sensualità selvaggia e rovente» (ivi, 87), che esiste solo per soddisfare i desideri sessuali dei maschi italiani, e Sabà, la madama dolce e servizievole, che è un gradino più in alto nella gerarchia razzializzante perché «non è una selvaggia, è
una donna, è la madama di un ufficiale italiano» (ivi, 71), e infatti parla l’italiano e si prende cura del soldato Branciamore come se fosse sua moglie, anche se «lui ce l’ha già una moglie, in Italia» (ivi, 137). Comunque, entrambe le figure sono sempre posizionate in una relazione di inferiorità gerarchica con l’apparente candore, peraltro solo esteriore, delle donne bianche e italiane, come nel caso di Cristina (ivi, 86-87 e 96-97), la moglie del cavalier Leo Fumagalli, «bello e ricco e troppo preso dal sogno di fare un giardino della Colonia italiana d’Eritrea» (ivi, 24). Le donne nere rimangono dunque imprigionate nei soliti stereotipi razzisti, sessisti e disumanizzanti: «le negrette [...] con le poppe di fuori [...] la Venere nera, la Circe
d’Africa [...] vado in Colonia e me le trombo tutte» (ivi, 35); mentre gli uomini neri sono rappresentati come «i negroni [...] che hanno fatto a pezzi gli inglesi [...] così cattivi, ma così cattivi, che si limano i denti a punta per mordere [...] vi tagliano l’uccello [...] ve lo schiaffano nel culo [...] un’orda di negri disumani» (ivi, 35-36), e dunque come una minaccia costante per la virilità bianca e italiana, che deve proteggersi dal rischio di una castrazione non solo simbolica (ivi, 118). Le uniche figure maschili che trasgrediscono la rappresentazione esclusivamente eteronormativa della sessualità – la coppia omosessuale composta dai due zaptiè (carabinieri indigeni) Ahmed e Gabrè, che in realtà sono spie del Negus, e il maggiore Flaminio, l’ufficiale «effeminato» che si eccita alla vista del sangue giovane – rimangono piuttosto marginali e appaiono come delle mere eccezioni che servono a riconfermare la regola e la superiorità di una maschilità bianca, italiana ed eterosessuale.
Decisamente più complesse appaiono le rappresentazioni del genere, della classe e del colore in Timira, non solo in virtù del più dilatato arco temporale in cui si sviluppa il romanzo ma soprattutto grazie alla moltiplicazione delle voci e dei punti di vista, che offrono a chi legge la possibilità di una seria presa di distanza critica e non un mero rispecchiamento della prospettiva colonialista.
La lettera con cui il maresciallo Marincola annuncia al fratello la decisione di far allevare in Italia i figli «meticci» ci restituisce immediatamente l’assurdità di un razzismo paternalista che serve a confermare il potere civilizzatore del colonizzatore bianco. Inoltre, la reazione del suo superiore ribadisce subito il nesso già rilevato sopra tra affermazione del potere coloniale e conferma della maschilità bianca ed eterosessuale: «per quanto lo riguardava una sola cosa era fondamentale: che lo sfogo della nostra maschile esuberanza non facesse venire meno la virilità, la spina dorsale e il prestigio, senza il quale centinaia di migliaia di individui non resterebbero sottomessi a poche migliaia» (Wu Ming 2 e Mohamed 2012, 51).
Nel racconto delle suore missionarie che la accompagnano in Italia, Isabella è
descritta, secondo il cliché colonialista, come una «bimba selvaggia» dal «musetto d’ambra» (ivi, 64-67), mentre agli occhi di Flora Virdis, la moglie del padre, appare come «l’immagine del peccato di suo marito» (ivi, 68) ed è «stupida come una scimmia» (ivi, 91). Per il figlio Antar, che si prende cura di lei quando ritorna in Italia da «profuga nel suo paese», questa donna indipendente e appassionata rappresenta una presenza scomoda e ingombrante, che arriva a mettere in crisi anche il suo rapporto di coppia; mentre per lo scrittore Wu Ming 2 è una fonte inesauribile di storie da raccontare. La stessa protagonista, a tratti, interiorizza lo sguardo razzializzante che fa della nerezza un disvalore, simbolo di bruttezza e animalità (ivi, 94), tanto da convincersi di essere sterile, secondo la peggiore propaganda fascista «che descriveva muli e mulatti come una razza bastarda di ibridi infecondi» (ivi, 307). Poi però ci regala pagine esilaranti, quando riesce a ironizzare sugli atteggiamenti sessisti, razzisti ed esotizzanti degli italiani: sul datore di lavoro che identifica la sua pelle nera con «promesse di sesso facile, selvaggio e caldo come una notte equatoriale» (ivi, 128) e sull’ossessione degli italiani per «il culo delle donne somale» (ivi, 295); su coloro che negli anni Trenta la vezzeggiano «come una bertuccia ammaestrata» perché vedono in lei «l’icona dell’avventura coloniale» o sul commerciante che la sceglie per reclamizzare degli occhiali con la montatura d’avorio «perché il bianco risalta bene sulla pelle nera o perché l’avorio, gli elefanti, l’Africa, la venere nera…» (ivi, 169); su coloro che ridono della sua eleganza perché ai loro occhi evoca «l’immagine di una scimmia con gli occhiali» (ivi, 170) o su chi si stupisce della sua cultura «perché una morettina così ben istruita, capace di tradurre dal greco e dal latino, non poteva discendere da una stirpe di cammellieri e bingobongo» (ivi, 205); ma anche su chi dà per scontato che lei e il fratello Giorgio debbano avere l’antifascismo nel sangue, perché «figli della colonia», mentre durante il ventennio Isabella è impegnata su un altro fronte, a combattere la sua «resistenza da camera contro un duce in gonnella» (ivi, 187-188). La matrigna è infatti colei che vorrebbe confinarla nei ruoli di «mignotta» o «servetta» (ivi, 206) che sono stati storicamente attribuiti alle donne nere e immigrate, quegli stessi ruoli che le verranno offerti quando intraprenderà la carriera cinematografica, interpretando proprio una schiava. Quando si trasferisce in Somalia, Isabella si rende conto che «l’alternativa secca tra madre e puttana non conosce confini» (ivi, 355) mentre, quando ritorna in Italia, si trova costretta a lavorare come assistente domestica per un’anziana signora che, paradossalmente, si chiama Itala (ivi, 211). A partire dal rifiuto di omologarsi alla norma che ammette le donne nere e immigrate nel mercato del lavoro solo come «colf» e «badanti» (unica alternativa: lo sfruttamento nel mercato della prostituzione), tutta la vita di Isabella Marincola potrebbe essere letta allora come una strategia di resistenza contro sessismo e razzismo, come un rifiuto a lasciarsi imprigionare nei ruoli imposti dalle linee di genere, classe e colore.
Certo, non si può fare a meno di rilevare che Isabella Marincola era una donna anziana mentre i due autori di Timira – che si propongono di disseppellire lo scrigno di storie intrecciate tra Europa e Africa di cui lei è portatrice – sono giovani e maschi (vedi Randall 2012). Inoltre, la riflessione conclusiva che propone la condizione di profuga come una metafora del presente italiano, in cui saremmo tutte e tutti profughi in quanto cittadini di uno stato che non c’è (Wu Ming 2 e Mohamed 2012, 458-465), risulta piuttosto forzata, proprio perché rischia di cancellare le differenze e le gerarchie di potere inscritte sulle linee di genere, classe e colore. Ma, nel complesso, il risultato di quest’esperimento di scrittura collettiva (ivi, 344-346) è un’efficace contronarrazione, che funziona come un potente antidoto contro il persistere della mentalità razzista e sessista, contribuendo attivamente all’affermazione di una consapevolezza postcoloniale nella letteratura italiana contemporanea. Per questo credo che Timira debba essere letto anche alla luce dell’emergere, negli ultimi venti anni, delle scritture migranti e postcoloniali nella letteratura italiana: da Nassera Chora e Geneviève Makaping, fino a Gabriella Ghermandi e Cristina Ali Farah, solo per menzionarne alcune, le opere di autori e autrici afroitaliane e originarie dalle ex colonie sono infatti i luoghi culturali chiave in cui oggi si costruisce una memoria critica del passato coloniale italiano e si decostruisce l’idea che la bianchezza sia «il colore legittimo» nell’Italia contemporanea. La presa di parola dei soggetti che sono stati razzializzati è infatti una strategia di resistenza contro il persistere di quegli stereotipi razzisti e sessisti che storicamente sono serviti a giustificare il colonialismo e che oggi invece sono funzionali a gestire i flussi migratori in tempo di crisi: influenzano la percezione della violenza maschile contro le donne e i discorsi pubblici sull’immigrazione (, stratificano il mercato italiano del lavoro secondo le linee del genere, della classe e del colore (vedi Curcio e Mellino 2012) e riproducono disuguaglianze sociali che limitano l’accesso ai diritti di cittadinanza. Sono queste le soggettività che ci ricordano quanto sia necessario e urgente «parlare di razza» nell’Italia contemporanea, interrogarsi sui diversi significati che questa costruzione culturale assume e sugli effetti che produce, illuminando anche i nessi con la costruzione del genere e dell’identità nazionale.
***
Qualche link per approfondire:
WM1 recensisce L’ottava vibrazione su Nandropausa
Paolo Jedlowski, La memoria pubblica e i media: il caso del passato coloniale italiano.
Giulietta Stefani, Eroi e antieroi coloniali. Uomini italiani in Africa da Flaiano a Lucarelli.
The post Quale razza? Genere, classe e colore in «Timira» e «L’ottava vibrazione» appeared first on Giap.

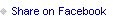






August 3, 2013
Sentiero Luminoso Bologna – Milano. Primo aggiornamento.
 [Il primo giugno scorso, Wu Ming 2 ha presentato al Festival della Viandanza di Monteriggioni il progetto del Sentiero Luminoso da Bologna a Milano. Per l'occasione, ha scritto anche un articolo che rilancia e sintetizza molte nostre riflessioni sul tempo, l'utopia e il cammino. Il pezzo è stato pubblicato su L'Unità del 31 maggio. Lo riportiamo qui sotto. A seguire: aggiornamenti, proposte e notizie sul Sentiero Luminoso. Buona Lettura.]
[Il primo giugno scorso, Wu Ming 2 ha presentato al Festival della Viandanza di Monteriggioni il progetto del Sentiero Luminoso da Bologna a Milano. Per l'occasione, ha scritto anche un articolo che rilancia e sintetizza molte nostre riflessioni sul tempo, l'utopia e il cammino. Il pezzo è stato pubblicato su L'Unità del 31 maggio. Lo riportiamo qui sotto. A seguire: aggiornamenti, proposte e notizie sul Sentiero Luminoso. Buona Lettura.]
Movimento lento.
di Wu Ming 2
Se inserite in un motore di ricerca la parola “lentezza”, il risultato è una lista di siti che propongono di vivere, viaggiare, lavorare, mangiare fuori tempo rispetto ai ritmi incalzanti della quotidianità. Dietro questa comune rivendicazione, però, si nascondono e spesso si mescolano due visioni del tutto differenti. Da una parte, quella di chi vuole ritardare l’arrivo del futuro e quindi considera la lentezza come una sorta di macchina del tempo, capace di riportare in vita gli aspetti più sani di un passato ormai perduto. Dall’altra, quella di chi ritiene che nessun cambiamento reale, e dunque nessun futuro vivibile, possa prodursi senza una rottura del tempo.
Credo che l’approccio più utile e fecondo al tema della lentezza, consista nel sottolineare questa seconda prospettiva, evitando di farsi contagiare dalla prima. I bei tempi andati in cui la vita seguiva un altro ritmo erano infatti tempi di schiavitù, di mortalità infantile, di piccole città stato sempre in lotta tra loro, di donne confinate in casa, di lavoratori senza diritti. In poche parole: erano bei tempi, forse, soltanto per un pugno di privilegiati che se li potevano permettere.
Se l’apologia del passato suona reazionaria e stucchevole, non sempre le cose vanno meglio con l’evocazione del futuro. Il più delle volte finiamo per raccontarcelo come una semplice proiezione del presente, dritta davanti a noi a distanza di tempo, ovvero come un presente invecchiato, che di conseguenza non scalda il cuore a nessuno.
Le continue, frenetiche innovazioni tecnologiche ci danno l’impressione di un mondo che cambia a ritmi velocissimi, anche se spesso quelle innovazioni non sono altro che obsolescenza programmata, merci pensate per diventare vecchie prima di consumarsi, così da alimentare un paradossale “consumo senza consumo”. Il classico cambiamento che non cambia nulla e anzi riproduce il sistema di cui è figlio, il solito tran tran. In questo senso la frenesia è davvero il contrario dell’utopia. Perché chi si lascia incalzare dal presente è incapace di pensare il futuro, se non come “presente invecchiato”, presente spruzzato di morte. La lentezza invece dovrebbe essere soprattutto questo: darsi il tempo di desiderare un altro tempo, un altro stato di cose, diverso da quello presente. Si potrebbe dire che essa è necessaria come impulso utopico, ma non è sufficiente come programma. Anzi, spesso è proprio nel passaggio della lentezza da impulso a programma, da stimolo per pensare un mondo nuovo a chiave di volta per costruirlo, che nasce la confusione tra i due approcci di cui sopra.
Il capitalismo si è imposto come sistema produttivo imponendo sulla vita un unico tempo: quello del lavoro. La diffusione degli orologi ha sancito questa distruzione della crono-diversità: il tempo del pasto diventa la pausa-pranzo di un’ora, il tempo di una pisciata in fabbrica viene quantificato, il tempo libero è dalle-alle.
Non contento, nella sua fase più tardiva il capitalismo si è mangiato anche lo spazio: ormai siamo tutti dentro la globalizzazione, in cerca appunto di spazi alternativi, liberati, utopici. Ma non basta liberare lo spazio, se il tempo rimane schiavo. Occorre creare una doppia discontinuità: nel tempo e nello spazio. Non a caso, uno dei movimenti alternativi più interessanti degli ultimi vent’anni – i NoTav della Val di Susa – proprio su questa doppia articolazione hanno costruito il loro successo. Radicamento sul territorio, presidi, marce, luoghi simbolici (cioè un altro spazio) insieme al rifiuto delle scadenze imposte dai cantieri, con vent’anni di mobilitazione ad libitum, pazienza, racconto, critica, riscoperta della Storia (cioè un altro tempo).
E’ chiaro che l’importanza di queste due variabili dipende dal fatto che la nostra stessa vita si svolge nello spazio-tempo e sarebbe impensabile all’infuori di esso. Tuttavia, c’è una particolare attività nella quale queste due dimensioni della nostra esistenza sono coinvolte in maniera molto evidente: il movimento. Attraversare un certo spazio in un certo tempo. Per questo credo che il movimento lento – camminare, pedalare – sia l’esperienza che più di ogni altra può trasmetterci l’impulso utopico a desiderare un altro futuro. Abbiamo bisogno di prendere coscienza della nostra frenesia e di quello che essa ci fa perdere e ci occulta. Ma per farlo dovremmo riuscire a guardarci da fuori, e questo non è affatto facile, se rimaniamo immersi nel byt, la parola che in russo indica la quotidianità. Se vogliamo immaginare un beat diverso – un altro ritmo e un altro tempo – dobbiamo prenderci una pausa dal byt. Camminare può essere questa pausa. Soprattutto: camminare attraverso spazi che ormai sono pensati per altri tempi, per altre velocità. Andare a piedi da Bologna a Firenze, il “collo di bottiglia” d’Italia, dove si concentrano due autostrade, tre statali, quattro linee ferroviarie. Costruire un sentiero da Bologna a Milano – come stiamo cercando di fare sul nostro blog – per imparare a leggere il paesaggio di quella Grande Pianura che ormai consideriamo tabula rasa, buona giusto come piedistallo per capannoni, outlet in forma di villaggio, villette a schiera e infrastrutture. Perché camminare, – immergersi nel territorio senza la mediazione di un finestrino, liberi di guardarsi intorno, privi di ostacoli da evitare al volo, – ci consente soprattutto di rallentare e approfondire lo sguardo. Di capire che il futuro è davanti a noi, ma non lo si raggiunge correndo in linea retta. Occorre scartare, deviare, scoprire passaggi sghembi e segreti, come un viandante che cerca il suo sentiero, perché sa che esiste, magari nascosto, e per questo in tanti lo chiamano utopia.
***
Il Festival della Viandanza è stato una grande occasione di incontro e di confronto sul progetto del Sentiero Luminoso. Ne sono nati suggerimenti, proposte, consigli di viaggio che sommati ai commenti raccolti su Giap e alle mail piovute in queste settimane, formano già un tesoro prezioso.
Massimo Montanari della Compagnia dei Cammini mi ha proposto di partire da Bologna con una squadra di asini – nel senso stretto di Equus Asinus – e di raggiungere con la medesima l’elegante Piazza Duomo. Alberto Conte di Itineraria mi ha spalancato il mondo delle tecnologie GPS e di strumenti come MapSlow e Land. Roberta Ferraris mi ha messo a disposizione gli articoli di Airone e NoLimits (1997) sul suo viaggio a piedi da Milano a Bologna (e poi Roma, insieme a Riccardo Carnovalini). Valentina Scaglia mi ha indicato luoghi imprevisti dove attraversare il Po e scampoli di antiche foreste in mezzo ai campi di mais.
Nel frattempo, per vie telematiche, il solito Simone Franchino mi ha messo in contatto con i NoTav di pianura, mentre Matteo Toller preparava un tumblelog dedicato al progetto e che aprirà le porte a settembre. Andrea Mainardi si è offerto di farmi da guida tra i cippi partigiani nella zona di Correggio, Francesco di Spazi Indecisi ha cominciato a segnalarmi edifici abbandonati e archeologie industriali. Claudio Madella (aka Clettox) mi ha segnalato la lotta per il Pagiannunz di Abbiategrasso, Paolo Menzani di Transitum Padii mi ha promesso percorsi alternativi tra Parma e Piacenza e poi oltre il Grande Fiume…
Tutto questo per dire che:
1) L’elaborazione del percorso richiederà più tempo del previsto e la partenza è fissata per la tarda primavera del 2014.
2) Come suggerito da Vecio Baeordo, ho deciso di delimitare lo spazio all’interno del quale individuare il Sentiero Luminoso, altrimenti la raccolta di info e suggerimenti diventa ingestibile. Poiché il progetto ha come nucleo fondamentale la coppia di opposti velocità/lentezza e in particolare il tracciato AV tra Bologna e Milano, ho stabilito di considerare due linee guida: 1) Il tragitto del TAV – inteso come fascia, larga 4 km, 2 da una parte e due dall’altra; 2) Il percorso geometricamente più breve tra le due città, ovvero la retta che le congiunge (ma poiché le città non sono punti sul piano, si tratta in realtà di due rette: una che unisce il punto più a Nord della Tangenziale di Milano con il rispettivo punto più a Nord di quella di Bologna, e l’altra che fa lo stesso con i punti più a Sud. Combinando queste tre linee si ottengono i confini del territorio che attraverserò in cammino.
A settembre, sull’apposito tumblelog, forniremo le coordinate precise e gli strumenti per visualizzare il percorso. Al momento, giusto per stimolare ulteriori consigli, diciamo che l’area d’interesse è delimitata a Nord da Nonantola, Novellara, Casalmaggiore, Crema, Melzo e a Sud da Modena, Parma, Piacenza, Somaglia, Rozzano.
Rimane un dubbio: la “fascia” ferroviaria di 4 km è stabilita in maniera arbitraria. L’idea sarebbe quella di considerare un territorio che “sente” la presenza della linea AV, ad esempio come impatto visivo. Non sono però riuscito a trovare valutazioni precise sull’ampiezza di questo tipo di impatto. Anche perché il tracciato AV non è sempre uguale: a volte passa su viadotti alti 12 metri, altre volte è solo “in rilevato” e nel caso del ponte sul Po è sorretto da due torri di 60 metri… Qualcuno ha un criterio da suggerire?
Altra domanda: qualcuno sa dirmi se la diga sul Po che si trova a Isola Serafini – con annessa conca malfunzionante – è transitabile a piedi?
***
Sempre a proposito di storie e di sentieri, ricordiamo che anche quest’anno WM2 accompagnerà un piccolo gruppo di vaindanti lungo la Via degli Dei, da Bologna a Firenze, in collaborazione con la Compagnia dei Cammini. Si parte il 5 settembre e si ritorna il 10. Qui per info e prenotazioni.
The post Sentiero Luminoso Bologna – Milano. Primo aggiornamento. appeared first on Giap.

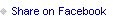






July 30, 2013
We shall overcome! Le Basse Intese contro il referendum di #Bologna

Come le Basse Intese PD – PdL hanno rimosso il referendum di Bologna sulla scuola pubblica. La volontà di 50.000 bolognesi non conta nulla. Disprezzate le 86.000 persone che sono andate a votare. E’ la democrattura, bellezza. Su Internazionale.
The post We shall overcome! Le Basse Intese contro il referendum di #Bologna appeared first on Giap.

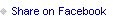






July 25, 2013
#PointLenana, raffica estiva di recensioni e commenti

Alla fine arrivammo al rifugio della stazione meteo. Il mio umore era all’insegna del chi-me-l’ha-fatto-fare, ma in quel momento mi girai e, in fondo al lungo sentiero percorso, vidi la montagna, il massiccio già lontano, azzurro, levitante sul verde degli alberi. Mi resi conto che solo dieci ore prima ero stato lassú, proprio in cima, e il mio umore trasmutò, e quelle dieci ore mi sembrarono niente. Niente. (Foto di Roberto Santachiara, clicca per ingrandire)
E’ come se Point Lenana non fosse uscito a fine aprile ma a metà luglio, tanti sono i lettori che lo stanno scoprendo adesso. Forse c’era bisogno di un po’ di tempo, per molti c’era uno “scoglio” da superare, una comprensibile esitazione: “Un libro che parla di montagna?!” Anche per questo era ed è importante presentarlo in giro per l’Italia. Scarpinare, raccontare, sciogliere le diffidenze.
Altrettanto importante era ed è proseguire il libro con altri mezzi, estendere il suo mondo con un incessante lavoro collettivo in rete (qui su Giap, su Twitter, su Tumblr, su Pinterest…) e con ripetute escursioni a tema. Diversi lettori hanno potuto discutere di Point Lenana mentre “ci mettevano il corpo”, vivendo un’esperienza fisica, fuori dalla loro zona di comfort.
Ebbene, lo sbattimento paga: il libro è accolto sempre meglio, i riscontri positivi si moltiplicano, ogni giorno riceviamo una nuova recensione. Il passaparola si intensifica e tutto fa pensare che stia per raggiungere il tipping point, l’istante in cui si inarcherà e diverrà autosufficiente. Grazie a tutt* per questo momento di impegno e condivisione.
Qui sotto proponiamo alcune recensioni uscite nei giorni scorsi in rete, su quotidiani e su riviste specializzate, oltre all’audio di un’intervista che WM1 ha rilasciato a Radio Onda d’Urto di Brescia. Ricordiamo che il calendario delle presentazioni è qui. Buona lettura e buon ascolto.
Dal blog La Balena Bianca, 21 luglio 2013:
ESEGESI DELL’ALPINISMO E “FUGA” NELLA STORIA
di Fabio Disingrini
Nell’inverno 1943 tre prigionieri di guerra italiani, Felice Benuzzi, Ecce Homo, Giovanni Balletto e Vincenzo Barsotti, evadono dal campo di prigionia inglese di Nanyuki e scalano il monte Kenya issando una bandiera tricolore sulla Punta Lenana salvo riconsegnarsi alle autorità britanniche diciassette giorni dopo. L’ascesa sarà inavvertita in Italia e il testo di Benuzzi che la racconta – Fuga sul Kenya, edito nel 1947 da L’Eroica di Milano – resterà in sostanza giacente fuorché diventare Oltremanica e Oltreoceano un best-seller nella sua traduzione con titolo No picnic on Mount Kenya… Ecce Libro. «Roba da fasci», penserà Wu Ming 1 maneggiando questa strana missiva del suo agente letterario Roberto Santachiara: un volume di Felice Benuzzi, triestino, nel novero di quella «trista retorica giuliana sull’italianità della città irredenta» e quell’impresa di nostrano e «particolare filone, quello di una certa pseudo-storiografia divulgativa che si è data il compito di propinare narrazioni rassicuranti e assolutorie», un «paradigma vittimario» di pronto utilizzo per gli italiani brava gente, «sempre capaci di arrangiarsi e all’occasione di compiere grandi atti di eroismo» (pp. 15-16). Eppure c’è una semiotica altra da definire, una certa metastoria da esumare nei suoi sostrati, un’ucronia congenita nei disegni della New Italian Epic… Ecce Point Lenana.
Il libro è prima un récit d’ascension, una letteratura testimoniale in presa diretta dei due autori sull’orme “benuzziane”, poi un entrelacement di vite declinate nell’epica: dalla Vienna di Freud, Klimt, Trotsky e del fu clochard Adolf Hitler, alla Trieste furente di Wilhelm Oberdank (aka Guglielmo Oberdan), Ruggero Timeus e Scipio Slataper; da Gea della Garisenda e la sua «promessa dell’Africa che è la promessa della fica» (p. 132), alle ebbrezze marziali di D’Annunzio, Carducci e Giovanni Pascoli, «proprio lui, dopo una vita spesa a cantare la natura e la vita dei campi, il fanciullino e l’uccellino, il vecchiettino e il lumicino, il sonnellino e il gelsomino, il rondinino e il biancospino, proprio lui che ha dedicato versi all’uccisione del suo babbino» (p. 135). Gli assolutismi di Franz Ferdinand e le solitudini di Francesco Giuseppe, la Grande Guerra sulle Alpi Orientali, i Ragazzi del ’99, Giuseppe Ungaretti, Fiume, la Grande Proletaria e la vittoria mutilata: «Mi sembra che in questa storia i poeti abbiano tutti un ruolo nefasto» (p. 157) e del resto con la guerra e i nazionalismi gli artisti danno il peggio di sé, è un vero e proprio «complesso militar-poetico» (p. 257) e lo dice anche Slavoj Žižek.
Point Lenana è un’esegesi dell’alpinismo prima, altrimenti e dopo «vent’anni di culto dell’azione elevato a religione civile» (p. 27), di «vitalismo dozzinale» dell’ascesa e strumentalizzazione muscolare alla Rudatis. È la poetica del “bacillo dei sassi” di Benuzzi e del mal di montagna di Giuan, protagonisti di quella fuga alpinistica che sembrava patriottarda anziché sensoriale, ed è lo spettro blues di Emilio Comici, il maestro del sesto grado, rocciatore divelto dal consorzio civile: tre icone di quell’antifascismo latente ed esistenziale, di «un’opposizione al regime passiva ma endemica e inestirpabile» (p. 454) che fra meriti contraddittori e lealtà statuali segnerà l’epilogo del «tragico Arlecchino camuffato da imperatore romano» (p. 165), la fine del suo tempo, il Götterdämmerung degli dei posticci e di ogni finzione mitologica. Che cosa sarà del resto l’andare in montagna se non un apprendistato alla Resistenza (concetto già molto caro a Primo Levi) e una «metonimia del prendere le armi contro i nazifascisti»? (p. 514) Perché Point Lenana è prima il riesame della deriva littoria, della miopia ideologica (allora come oggi) dei partiti di sinistra che disinnescarono gli Arditi del popolo, del do ut des del Balilla Meazza, di Binda, Nuvolari e Primo Carnera, della “direttiva entrista” e dell’“arte di non esser governati tanto”, dell’anacronismo coloniale, delle bombe all’iprite fra negazionisti o relativisti del gas come Indro Montanelli, dell’(ancora una volta attuale?) madamato, del prestigio di razza e della legislazione antisemita, delle rentrées danarose e arriviste del Maresciallo d’Italia e del “Vespasiano di sangue” del Viceré d’Etiopia – al secolo Pietro Badoglio e Rodolfo Graziani – per l’inutile compiacente nomenclatura del ventennio, dello svelto colpo di spugna a spron di amnistie e tribunali compiacenti i fascisti che, cambiato il colore della camicia, potevano tornare utili per un nuovo “governo tecnico” (!).

Così focali in Point Lenana saranno anche il ritratto del duca Amedeo d’Aosta, massimo esponente nel suo Dramma di Eschilo dell’antifascismo apolitico in colonia, e le idiosincrasie del Negus Hailé Selassie, martire austero della demenza fascista e insieme garante di «un governo autoritario con tare ereditate dal sistema feudale e altre importate dal capitalismo» (p. 484). Perché dopo Timira di Wu Ming 2 in Point Lenana c’è ancora tanta, anzi, tantissima Africa: la rivoluzione Mau Mau, il rastafarianesimo, il consumismo indotto dei “client-countries” britannici, l’Eccidio di Mogadiscio e il missionariato di Giuan mentre il calco sinottico e ispirativo di Follow The Fleet, pellicola americana con Fred Astaire e Ginger Rogers, ricorderà invece tante pagine di 54 (Wu Ming) se non per stilemi, almeno nella suggestione filmica.
E alla fine il lettore, lost in foreshadowing da così tante pagine, vorrà avanzare la sua soluzione: se Point Lenana, per stesso lecit autoriale un «oggetto narrativo non identificato» (p. 380) fra saggio e racconto, avrà svelato il caleidoscopio concettuale di quel tricolore dei prisoners of war e se Fuga sul Kenya sarà ormai come «un ipertesto dove ogni parola é diventata “cliccabile”» (p. 493). Se le “due bandiere” di Felice – l’ambasciator romantico che cerca le montagne muovendo per il mondo – e Giuan, afflitto dal male oscuro dell’alpinista, avranno saputo saldare nella loro melanconia la guerra della memoria o se, come lo spleen di Comici, anche questa storia non avrà offerto risposte e si potrà solo continuare a raccontarla.

20 luglio 2013, Point Lenana Tour: WM1 sul Monte Vettore. Clicca per ingrandire.
La Repubblica, 23 luglio 2013:
SE LA NUOVA EPICA RIPARTE DAL KENYA
di Giuseppe Leonelli
Wu Ming è un collettivo impegnato da anni in un processo di rifondazione della narrativa italiana, che persegue «la morte del Vecchio» identificato nei «giochetti tardo-postmoderni» di troppi scrittori contemporanei [A voler essere precisi la "morte del Vecchio" è un'altra cosa, è un mitologema che si trova dentro i romanzi del New Italian Epic, ma pazienza, N.d.R.]. Il romanzo dovrebbe ritrovare uno spirito epico raccontando «imprese storiche o mitiche, eroiche o comunque avventurose». È un programma particolarmente caro a Wu Ming 1, fra i membri più attivi del gruppo, che ora firma, in collaborazione con Roberto Santachiara, l’opera dal titolo Point Lenana (Einaudi, pagg. 596, euro 20).
Il romanzo, se si può definire tale, si apre con l’arrivo al personaggio che dice io, cioè Wu Ming 1, «in una mattina come un’altra del febbraio 2009», d’una busta che contiene un libro, Fuga sul Kenya, scritto da un «tal Felice Benuzzi». Gliel’ha mandata l’amico, in seguito coautore, Ro- berto Santachiara. Il libro, pubblicato nel 1947, racconta un fatto avvenuto in Africa nel 1943, allorché tre italiani – il triestino Felice Benuzzi, il genovese dott. Giovanni Balletto e Vincenzo Barsotti di Camaiore – evadono da un campo di prigionia inglese e scalano il Monte Kenya per piantare sulla vetta la bandiera tricolore, quindi ritornano al campo, suscitando l’ammirazione del nemico.
La breve vicenda, iscritta in tre vite e in un limitato arco temporale, si dilaterà, una volta sottoposta all’attenzione degli autori di Point Lenana, in un’amplissima rete di avvenimenti, alcuni connessi e consequenziali, altri casuali, che, sviluppandosi dal passato al presente e al futuro, riempiranno di sé tutto il corso di un’epoca. Il risultato è un complesso diegetico in cui s’intrecciano vari libri, giustamente definito, dagli autori, «racconto di tanti racconti», la maggior parte dei quali si svolge in Africa, luogo deputato dell’epos contemporaneo, ma anche in Italia e altrove: un libro che «parla di Italia e italianità, di esploratori e squadristi, di poeti e diplomatici, di guide alpine e guerrieri».
L’espediente tecnico che produce e tiene insieme il racconto è un processo di «ibridazione di saggistica e narrativa», di per sé non del tutto originale, perché vi hanno fatto ricorso storici e romanzieri in varie epoche; ma interpretato con senso felice del ritmo ed espresso in una lingua asciutta e intensa, che punta sempre verso la realtà, connotandone con efficacia la sostanza subliminale. Eccoci, dunque, proiettati in un arco temporale che va dal 1910 al 1946, innescato da avvenimenti recentissimi, datati fra il 2009 e il 2010. L’esito di quest’avventura narrativa, rigorosamente sostenuta dai documenti (si veda l’accuratissima sezione bibliografica finale) è un grosso tomo, montato come un film, che si legge, si può dire, in un fiato.
C’è una vaga suggestione ariostesca nella velocità con cui il racconto si muove fra «le donne, i cavallier, l’arme, gli amori», ovvero i fatti e i misfatti del nostro tempo. Intravediamo, in apertura di libro, Wu Ming 1, uomo della bassa ferrarese, mentre emerge dalla prima scalata della sua vita che replica, per amore di conoscenza, quella di Benuzzi e compagni; qualche pagina dopo, retrocediamo nel tempo e siamo a Vienna, a Trieste, tra la guerra e le montagne dei primi venti anni del secolo. Verranno in seguito il mal d’Africa, Graziani, Badoglio e l’Impero, tutti prodromi alla vita di Benuzzi, quindi l’altra guerra, i Mau-Mau e tutto il resto che il lettore scoprirà da sé. Compresi il male di vivere, e quindi le lacrimae rerum, ma anche il misterioso senso dell’armonia che, nello sguardo dei prigionieri della vita, pervade l’epifania delle montagne protese verso le alte costellazioni.

Dalla rivista on line Doppiozero, 21 luglio 2013:
Wu Ming 1, Santachiara. Point Lenana
di Enrico Manera
Visivamente, mi figuro Klaus Kinski e Werner Herzog impegnati sul set di Fitzcarraldo in un corpo a corpo con la natura per dare vita a una narrazione che ha l’andatura molleggiata di un gatto, capace di verticalizzazioni impreviste e improvvise e di carezzare morbidamente come di artigliare a sangue.
Penso questo in uno stato di coscienza tra il sonno e la veglia dopo una intensa giornata di presentazione di libri, oltre quattro ore, piacevolmente impegnativa. Tra questi, in particolare, Point Lenana di Wu Ming 1 e Roberto Santachiara con uno dei due co-autori nella tappa torinese di un vero e proprio tour, impressionante per lunghezza, durata, intensità. Una opportunità per ragionare su diversi nodi che riguardano la narrazione, il suo ruolo pubblico, la sua politicità e il suo potenziale pedagogico.
Il nuovo libro di un membro del collettivo Wu Ming e del loro agente letterario, è un oggetto narrativo non-identificato, un anfibio tra narrativa e saggistica, una non-fiction novel, una inventio ficta. Un (l)ibrido assemblaggio di storie dentro la storia, un itinerario iniziatico tra diversi materiali mitologici, una mappa precisa e in movimento di geografie umane che attraversa vicende di alpinismo e viaggi estremi, di libri di alpinisti e viaggiatori estremi; di Trieste e Istria, Dalmazia; di fascismo e di antifascismo; di colonialismo inglese e italiano; di Kenya, Libia, Etiopia; di razzismo e di post-colonialismo. Di biografie e di tipi umani che quelle vicende hanno attraversato, negoziando e riposizionandosi rispetto ad esse. Tutto questo si stratifica come in una millefoglie a partire dalla vicenda reale di Felice Benuzzi, Giùan Balletto, Enzo Barsotti e della loro impresa. Prigionieri di guerra italiani in un campo inglese in Kenya nel 1943 evasero solo per scalare, senza cibo e in condizioni di fortuna, la Punta Lenana del Monte Kenya. Raggiungono la cima, lasciano tracce del loro passaggio e tornati giù si riconsegnano alle autorità. Per «salvare le loro anime», con un gesto che in Italia viene letto come virile e fulgido esempio di amor di patria o spacconata fascista e che, con gli occhi del resto del mondo è diventato un classico dell’alpinismo e della più nobile fuga into the Wild (cfr. Benuzzi, No picnic on Mount Kenya e la versione italiana Fuga sul Kenya).
Lo strudel, il vortice di cui scriveva Benjamin, è reso ancora più gustoso dalla meta-narrazione: nel 2010 i due coautori hanno ripetuto il viaggio, sono saliti sulla Punta Lenana e raccontano l’esperienza, con il a fatto che uno dei due è un alpinista provetto, l’altro non era mai salito oltre i 1000 metri, mentre qui si parla di 5000 e tre fasce climatiche. Laddove altri lavori del consorzio narrativo bolognese ci fanno vedere il montaggio finito, mostrando il backstage nei titoli di coda, qui il cantiere è aperto e anche il montaggio è trasparente nel testo, con le mail degli autori, le interviste delle tante persone contattate, i documenti di un lavoro di archivio e ricerca di quattro anni di salita al libro.
La montagna, il racconto della quale ha una lunga e consolidata tradizione di genere (in ordine sparso e scriteriato: Petrarca, Goethe, Comici, Motti, Bonatti, Messner, MacFarlane) è per WM1/Santachiara il luogo fisico e simbolico attorno a cui si articola una pratica che sta tra la danza e la disciplina spirituale. Se da un lato può essere malamente inteso (ed è stato fatto dal fascismo) come gesto superomistico e virilizzante, nella sua dimensione più propria è ricerca del vuoto (o del tutto, il suo simmetrico speculare), dell’interiorità e dell’alterità. È la cornice metaforica che nelle parole di Benuzzi significa «meraviglia, umiltà, freschezza di sentimenti». In Primo Levi: «il sapore di essere forti e liberi anche di sbagliare, e padroni del proprio destino»; andare in montagna è «un’impresa matura e responsabile, a cui il fascismo non ci aveva preparati, e che emanava un buon odore asciutto e pulito» .
La montagna è un iper-segno: è luogo post-umano in quanto «mina in noi la compiaciuta convinzione che il mondo sia fatto per l’uomo» (MacFarlane), è simbolo dell’eternità, per via della pietra che significa l’inorganico e dura oltre il tempo (con più cognizione di causa: Caillois, Starobinski, Jesi, Assmann). È legata alla metafora primaria per cui ‘alto’ è associato a situazioni emotive positivamente connotate, fin dal neonatale essere presi in braccio e dallo sguardo infantile che è sempre verso l’alto (Lakoff). In montagna il cervello umano sembra funzionare in altro modo, a partire da una differente ossigenazione che attiva una spinta alla percezione del reale, capace di dare seria dipendenza e creare profonde malinconie oltre che stati estatici, dai quali la ricaduta può essere fatale (il libro racconta anche sottotraccia una storia dei tanti alpinisti suicidi).
Per tutte queste cose andare in montagna per uomini e donne di generazioni diverse diventa anche un’utopia vissuta, il fatto tangibile che un’altra vita è possibile, in solitaria ma più spesso nella comunanza di intenzione: è esperienza della pulsione utopica che spinge a fare cose che sono riflesso del desiderio di vivere altrove.
«Non esiste l’azione concentrata, esiste il campo di concentramento»: Benuzzi è un alpinista triestino che, in cerca di un altro mondo, prima ancora di fuggire dal campo di prigionia, era fuggito dall’Italia per fare il funzionario pubblico nelle colonie dell’Africa Orientale Italiana, non prima di aver sposato un’ebrea tedesca clandestina (Stefania “Marchi”, cioè Marx). Nel 1938, peraltro. Gran parte del libro è narrata grazie alla sua voce e a quella delle figlie, Daniela e Silvia, per un ritratto umano che rifugge il gusto agiografico; da tutte le altre voci e dalla messa in luce del loro contesto emerge una presa di coscienza lucida di cosa sia stato il fascismo per una generazione.
Il sotteso impegno pedagogico-culturale rende Point Lenana un libro particolarmente consigliabile al ventenne di oggi. Il salto tra Trieste e Addis Abeba, via Tripoli, permette di raccontare con precisione e semplicità i crimini di guerra del fascismo giuliano e del colonialismo italiano, i grandi rimossi della nostra storia pubblica grazie alla narrazione assolutoria del «buon italiano» che negli ultimi vent’anni ha contribuito a rendere più ottusa un’opinione pubblica che già prima non scherzava.
Ma il discorso tocca anche lettori più maturi e preparati. «Il prius logico delle leggi antiebraiche è il razzismo in Africa e il prius logico del razzismo in Africa è il razzismo antislavo» sintetizza uno dei due coautori. Il durissimo razzismo del fascismo di confine che prepara le vendette future, l’arroganza dell’Impero e le stragi dimenticate di Libia e di Eritrea, i campi di concentramento italiani, le miserie umane dei campioni di antropologia italica Badoglio e Graziani, le pur buone intenzioni di Amedeo d’Aosta che non possono redimere il marcio del colonialismo, le ricerche ignorate di Del Boca perché moltissimi si bevevano le nostalgie giovanili di Montanelli, le amministrazioni locali nostrane che oggi sperperano denaro per fare monumenti a criminali di guerra, la rozza ignoranza delle nostalgie fasciste e il revisionismo da salotto buono dei quotidiani nazionali. Tutto questo trova posto in Point Lenana, insieme alla Resistenza – che è un andare in montagna – e alle diverse forme che la ribellione esistenziale può assumere, oltre l’andare in montagna. Come trovano posto la ribellione indigena dell’Africa post-coloniale, gli spettri dei Mau Mau che materializzano il terrore del selvaggio cannibale, di fronte a un occidente bianco che si autoassolve e animalizza paternalisticamente un’Africa che non conosce veramente.
Molta storia scorre nelle pagine di un libro in cui, per usare una metafora di Filippo Sottile, la storia è simile a un ascensore di cui si vedono i meccanismi operanti, salendo e scendendo dalla tromba delle scale accompagnati dai ricordi del portiere del palazzo. La voce narrante della storia, solitamente affidata al neutro storiografico del saggio, viene destrutturata dalla pluralità delle storie e dalla dislocazione che le fa esplodere per arborescenza. Fin dagli esordi lo stile Wu Ming è caratterizzato dal montaggio ‘cinematografico’ e dalla decostruzione del mito dell’autore, dalla dimensione collettiva intensamente praticata, dalla tematizzazione di eroi eccentrici, di nodi complessi e di comunità minoritarie e trasversali, dai plot irriducibili a stereotipi maistream e trionfali, dal legame con i movimenti militanti e con un’eterogenea opposizione culturale, dal radicamento in una transmedialità in divenire attraverso la rete, dalla programmatica nuova epicità ragionante.
Scrive Yves Citton che il progetto culturale di Wu Ming, nel suo insieme, «condensa una serie di pratiche, di partiti presi e di teorizzazioni che forniscono un’eccellente piattaforma di riflessione sullo statuto delle storie, dei miti, delle comunità e delle scenarizzazioni ancora da inventare».
La scrittura, al pari del cinema e della musica sempre presenti, è intessuta di valore pubblico e politico, e svolge un ruolo decisivo nella battaglia contro il discorso mediatico dominante, che significa sostanzialmente semplificazione banalizzante, riduzione della complessità, rimozione della scomodità, omologazione stereotipante e reificazione mercantilistica. Il montaggio con cui è prodotta (e la sua esposizione) è un modo per riscattare il ‘mito’ come racconto che salva la significatività e il potenziale comunicativo del racconto, fino a farne uno strumento di mitologia ‘autentica’, cioè non dogmatica e indiscutibile, per comunità in rivolta in cui «singolarità di ogni scrittura e la dimensione comune della moltitudine» (Citton), individuo e comunità, trovino il loro equilibrio.
Nella continuità di paesaggio immaginale tra la linea di ribellione/emancipazione che solca le controculture e le tante vicende di rivolta/rivoluzione della storia si producono «attraverso le gioie del contagio» i «germogli» di «nuovi mondi del possibile preclusi alla ragione contabile» e le ragioni di una ricerca della «felicità» presente. Wu Ming può essere considerato un paradigma di produzione narrativa per la ricostruzione di un immaginario di sinistra: che per Citton non può che essere «un bricolage eteroclito di immagini frammentarie, di metafore dubbiose, di interpretazioni discutibili, di intuizioni vaghe, di sentimenti oscuri, di folli speranze, di racconti senza cornice e di miti interrotti che prendano insieme la consistenza di un immaginario, tenuto insieme [...] dal gioco di risonanze comuni che attraversano la loro eterogeneità per affermare la loro fragilità singolare».
Point Lenana inserisce in questo progetto narrativo anche la comunicazione della storia, su base rigorosamente documentaria, su cui si dovrebbe iniziare a riflettere seriamente, preso atto di una crisi delle Humanities e dello scarso appeal degli studi storici (che poi significa ignoranza mostruosa dei più e degrado della vita pubblica). Ma qui è lo scrivente che parla dopo aver preso un sentiero parallelo, un recensore-lettore che tra l’altro insegna filosofia e storia a gente più giovane e per cui il problema della narrazione è anche rovello di una negoziazione quotidiana.
Gli autori del libro confessano apertamente che il loro campo-base è stato l’amore per i personaggi, le cui tracce sono state disseppellite e restituite a nuova vita.
È un racconto di racconti di uomini che vagarono sui monti. Uomini che in pianura e in città indossavano elmi, cotte di maglia, armature da ufficio, e solo in montagna si sentivano finalmente leggeri, finalmente sé stessi. La montagna era tempo liberato, rubato al dover vivere, conquistato con unghie, denti e piccozza. Quando scendevano – perché prima o poi tocca farlo – la vita li riafferrava, la gravità li tirava giú e tornavano a essere, come scrisse uno di loro che poi si tolse la vita, «i falliti». Lo furono anche nella buona sorte: qualcuno ebbe successo nella professione, girò il mondo, fece piú di una bella figura in società, poté contare su una famiglia che lo amava… Eppure, nulla di tutto ciò rimpiazzava una salita in montagna, una notte in bivacco, uscire dal rifugio e assistere in marcia al sorgere del sole. Tutti i giorni sognavano. Sognavano il cameratismo della cordata o la pace concentrata e acuta dell’ascesa in solitaria. Tutti, senza eccezioni, sognavano il vento che sferza naso e guance mentre lo sguardo si perde dalla vetta, rivivevano l’istante prima della discesa, l’ultimo languore che precede la tristezza, la mancanza, il congedo dal mondo che non conosce il dover vivere.
Ripenso a Kinski e a Herzog, al loro teatro nella giungla. Al felino sornione e a due teste che ruggisce con determinazione o gorgoglia sommessamente, gettando sassi nell’acqua che producono cerchi dall’ampiezza imprevedibile. Ritrovo lo stesso coinvolgimento totalizzante in una comunità di lettori stretta intorno ai loro autori. È chiaro a tutti che scrivere è andare in montagna.

Point Lenana sul Monte Vettore, 2476 mt., vetta più alta delle Marche. Fotografia di Simone Vecchioni, clicca per ingrandire.
Dalla rivista (Meridiani) Montagne, luglio 2013:
TANTI RAMI INTORNO A BENUZZI
di Marco Albino Ferrari
A detta degli stessi autori, Point Lenana è un vero e proprio UNO, cioè un Unidentified Narrative Object o, se preferite, un oggetto narrativo non-identificato. Tant’è che alla fine della lettura non saranno pochi i problemi che vi troverete a risolvere per decidere su quale scaffale inserirlo: tra i romanzi storici? Tra i saggi? Tra i libri di viaggio? Tra i récit d’ascension? Forse finirete per appoggiarlo sul comodino così da riprendere la lettura di quando in quando, ritornando su qualche dettaglio delle innumerevoli e curiose storie che nelle oltre cinquecento pagine si intrecciano. Il filo narrativo, o meglio il “tronco portante” del libro, è la vicenda arcinota di Felice Benuzzi e dei suoi due compagni che durante la guerra fuggono da un campo di prigionia inglese sotto il Monte Kenya e, con attrezzi tecnici ed abbigliamento del tutto inadatti, riescono a dar luce al loro sogno arrivando sulla vertiginosa cima equatoriale. Da quell’avventura nascerà un best-seller internazionale, No Picnic on Mount Kenya (Fuga sul Kenya è il titolo italiano, che ha conosciuto fortuna più contenuta rispetto alla rimaneggiata versione inglese, vedi Montagne n. 58, pag. IX). Dal tronco portante, però, il team degli autori (ibrido pure quello: uno scrittore parte integrante del collettivo Wu Ming e un noto agente letterario) devia, deraglia, sale su rami secondari che invece che assottigliarsi si fanno via via più solidi e diventano vere e proprie storie indipendenti. E’ stato “come navigare in un ipertesto”, dicono gli autori verso la fine del viaggio. “Ogni parola, ogni nome, ogni riferimento en passant è diventato ‘cliccabile’.” Si parte così dagli sforzi di Benuzzi e compagni sulla montagna e si passa all’irredentismo triestino (città di Benuzzi), si transita poi per le evoluzioni di Comici sulle muraglie dolomitiche, si devia sul racconto delle prebende milionarie di una figurina orrenda della nostra storia patria, Pietro Badoglio, e sul suo socio gassatore di negri in Abissinia, Rodolfo Graziani. Che siano sullo sfondo o in primissimo piano, le montagne non mancano mai: così come l’alpinismo, i viaggiatori delle alte quote, il Cai, i libri di scalate, l’amore per i grandi orizzonti. Un libro che consiglio caldamente ai lettori di Montagne: sarà assai facile rimanere sospesi a uno degli infiniti rami che si staccano dal tronco portante.

L’11 luglio scorso WM1 è intervenuto telefonicamente nella trasmissione Flatlandia di Radio Onda d’Urto (Brescia). A intervistarlo c’era Gianbattista (Sancho) Santoni. Ecco la registrazione.
Chiudiamo, per ora, linkando la bella e toccante recensione di una lettrice gardenese, Stefania Demetz, nata e cresciuta nei luoghi in cui Emilio Comici trascorse gli ultimi anni di vita.
The post #PointLenana, raffica estiva di recensioni e commenti appeared first on Giap.

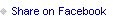






July 23, 2013
«Mitocrazia», di Yves Citton. Prefazione di Wu Ming 1, postfazione di Enrico Manera
[La casa editrice Alegre ha da poco dato alle stampe la traduzione di Mythocratie, importante saggio del filosofo francese Yves Citton. La prefazione è scritta da Wu Ming 1, la postfazione da Enrico Manera. Proponiamo qui entrambi i testi. Il libro è acquistabile sul sito di Alegre con il 15% di sconto e senza spese di spedizione.]
-
L’incontro tra il salmone e gli asparagi sul tavolo del narratologo
di Wu Ming 1
Verso la fine degli anni Zero ci colse il sospetto che in Francia la riflessione «da sinistra» su miti e narrazioni stesse prendendo una brutta piega.
Il libro Storytelling di Christian Salmon, improvvisamente e improvvidamente à la page, stava imponendo un approccio semplicistico e consolatorio al problema. Salmon descriveva un grande e maligno complotto finalizzato a imporre un Nuovo Ordine Narrativo (NON) per mezzo di un’arma di distrazione di massa chiamata – appunto – storytelling. In inglese il vocabolo non designa altro che l’atto basilare e primevo di raccontare storie, ma nella neolingua salmoniana si zavorrava di connotazioni sinistre: raccontare equivaleva tout court a ingannare, abbindolare, irretire, manipolare; le storie erano strumenti del dominio capitalistico in mano a pubblicitari e markettari; lo storytelling era il male.
Leggemmo quel libro prima ancora che fosse tradotto in italiano, lo trovammo decisamente raffazzonato ed esprimemmo il nostro giudizio fuori dai denti. Al fondo, c’era un’incomprensione del rapporto tra esseri umani e storie, ovvero l’idea che i primi possano fare a meno delle seconde. In quell’occasione, ricapitolammo quelle che per noi sono «banalità di base»:
Non c’è mai stata un’età del mondo in cui la comunicazione fosse sganciata dal racconto e dalle mitologie depositate nel linguaggio. La narrazione non occupa un campo specifico (di mero intrattenimento), e non esiste un discorso logico-razionale “puro”. Leibniz sperava che un giorno qualunque disputa si sarebbe potuta risolvere con un calcolo, ma per fortuna quell’alba non è mai sorta. Il positivismo ha sognato che la scienza potesse emanciparsi una volta per tutte dai suoi trascorsi filosofici e letterari, ma i maestri del sospetto – Marx, Nietzsche e Freud – hanno rinvenuto tre cariche esplosive alle fondamenta dell’oggettività scientifica: gli interessi economici, la volontà di potenza e l’inconscio. Quest’ultimo è molto più vasto di quel che si credesse fino a trent’anni fa: non comprende solo istinti e desideri repressi. La scienza cognitiva ha scoperto che il pensiero lavora per lo più in maniera inconscia e che buona parte di questi meccanismi neurali nascosti richiamano strutture narrative. Scheletri di miti e leggende sono tatuati sui nostri cervelli con un inchiostro elettrico. Le storie ci sono indispensabili per capire la realtà, per dare un senso ai fatti, per raccontarci chi siamo. Abbiamo bisogno di scenari e le narrazioni ce li forniscono, spesso con un vantaggio importante rispetto alle cosiddette analisi razionali: le storie ci fanno emozionare e le emozioni, lungi dal contagiarla, sono invece un ingrediente essenziale della ragione. Senza rabbia, passione, tristezza e speranza non saremmo in grado di ponderare la più piccola scelta [...] Non sorprende allora che il potere si sia sempre appoggiato a miti e leggende. E forse, per tutta risposta, basterebbe continuare a fare quel che abbiamo sempre fatto: sgonfiare le favole dei potenti, raccontare altre storie.
Per Salmon, invece, il capitalismo aveva imposto andamenti e schemi narrativi a porzioni di realtà in precedenza esterne alle narrazioni (?), finendo per «inflazionare» e corrompere irreparabilmente l’atto di raccontare. Atto che andava – non si capiva bene come – disertato.

Christian Salmon
L’autore lesse la nostra critica e se ne ebbe a male, ma che potevamo farci? E’ malsano voler piacere a tutti, e mica ce l’avevamo con lui personalmente. In ogni caso, non gli arrecammo nessun danno. Il suo libro, tradotto in varie lingue, continuò ad avere successo. Le geremiadi funzionano sempre.
Quella narrazione capziosa mascherata da critica del narrare capzioso ebbe tale e tanta presa sull’intellighenzia che fra gli scrittori d’Oltralpe si diffuse come un senso di vergogna: «Che senso ha il nostro lavoro se raccontare storie è il modo più banale di fare il gioco del Potere?»
Vergogna non del tutto sincera né priva di pulsione narcisistica. Lo scrittore che si denuda e flagella in pubblico è un cliché dei più retrivi: «Guardatemi, me tapino! Quel che faccio è inutile, anzi, scrivere si ritorce contro di me! Ciò che volevo liberante è cagione di schiavitù! Oh, quanto mi dilania quest’eterogenesi dei fini!».
L’indignazione contro lo storytelling, insomma, fornì ad alcuni nostri colleghi l’ennesima occasione di navigarsi l’ombelico. L’onta esibita e la sfiducia affettata, preincanalate nei varchi di un certo postmodernismo stagionato, diedero luogo a metanarrazioni. Lo scrittore raccontava della propria sfiducia nei confronti del raccontare: «Mi piacerebbe scrivere un romanzo, ma il romanzo è un’arma del potere, e allora scrivo sì un romanzo, ma ogni due pagine mi intrometto per ribadire che il romanzo è un’arma del potere e nemmeno questo sfugge… Anzi, un po’ sfugge, perché proprio grazie a queste mie intromissioni non è davvero un romanzo ma un romanzo che si nega come tale etc. etc.»

Laurent Binet
Tutto questo per inseguire quella che Salmon, vagamente e senza fornire alcun ragguaglio, chiamava «contronarrazione». Si capiva soltanto che doveva tendere allo «sfuocare» lo sguardo del narratore, per «sfumare» la potenza seduttiva delle storie. Tante pagine di sacro furore per concludere che il vino annacquato ubriaca di meno.
Lungi dal fornire al lettore utili strumenti di decodifica e demistificazione, simili estenuanti «aggiunte» finirono per debilitare opere altrimenti potenti. L’esempio più eclatante lo avemmo leggendo HhHH di Laurent Binet, ricostruzione dell’attentato partigiano in cui morì il caporione nazista Reinhard Heydrich (Praga, 4 giugno 1942). Grazie a quel libro che ci accorgemmo dell’influenza perniciosa delle teorie antinarrative di Salmon. Recensendo HhHH, Wu Ming 2 scrisse:
Qui c’è una contraddizione di fondo che finisce per rendere comici gli sforzi di Binet (che infatti non di rado ci scherza su volentieri). Egli è talmente affascinato dalla letteratura, da trasformare sé stesso in personaggio: un personaggio che quando apre bocca, sputa sugli elementi chiave della letteratura stessa. A me ricorda mio figlio quando assaggia gli asparagi e dice: «Buoni. Però un po’ cattivi.» Ma voi mio figlio non lo conoscete, quindi vi faccio un altro esempio. Avete presente il protagonista di In & Out, quando per convincersi di essere macho, si mette ad ascoltare I Will Survive a tutto volume, cercando disperatamente di non sculettare a ritmo di musica? Oppure ancora quei ragazzini che vorrebbero tanto fare un gioco infantile, ma lo rifiutano per dimostrarsi «grandi»? [...] Voialtri siete troppo intelligenti per giocare con noi, giusto? Siete troppo sgamati. E bisogna a tutti costi che ce lo dimostriate, mettendovi in un angolino a fumare Camel, mentre noi ci divertiamo come cretini [...] Ho come l’impressione che in Francia il problema delle «tossine narrative» sia stato posto in maniera sbagliata. Invece di interrogarsi su quali figure retoriche o bias cognitivi portano un narratore a manipolare il suo pubblico e a nascondere la realtà, si è deciso che raccontare storie equivale a spacciare frottole, sempre e comunque, salvo poi rincorrere un’incomprensibile contro-narrazione, come fa Salmon, o inchinarsi di fronte al “potere imponderabile e nefasto” della letteratura, come fa Binet. Ma un conto è criticare i clichés di tanti romanzi storici, un altro è negare che l’invenzione letteraria può essere una forma di indagine della Storia, e non soltanto un ingranaggio pretenzioso e ridicolo per rimodellarla. Mentre Hayden White ha mostrato come le strutture narrative sono uno strumento legittimo dell’analisi storica, Laurent Binet vorrebbe ripulire la letteratura da ogni artificio retorico: e meno male per lui che non ci riesce affatto.
Mitocrazia non partecipa di quest’equivoco. E’ un libro spinoziano fino al midollo, quindi ha tutti gli anticorpi per non ammalarsi d’apocalisse e passioni tristi. Di più: Yves Citton prende – seppure amabilmente – per i fondelli l’approccio di Salmon e dei suoi epigoni (che descrive come produttori di «pastiches dall’esito incerto», quasi sicuramente pensando alle estenuanti elucubrazioni di Binet):
Il grande Impero… si apprestava a lanciare delle incursioni nella terra di Gallia – questa fiera nazione di cittadini druidi e di irriducibili intellettuali – quando ad un tratto un intrepido cavaliere Christian soffiò nel suo olifante… Il suo richiamo alla crociata attirò i prodi al di là di ogni aspettativa…

Yves Citton
Si può dire che Mitocrazia sia stato scritto per «disincagliare» il dibattito, per portarlo oltre le secche nelle quali Christian Salmon l’aveva condotto e abbandonato. Il sottotitolo è una dichiarazione d’intenti in nominalstil: «Storytelling e immaginario di sinistra», e l’enfasi cade sul secondo elemento. Citton non è un Savonarola, non si accontenta di denunciare, di gridare che il capitalismo ci rincretinisce raccontandoci storie seducenti, ma tiene sempre presente la dimensione del «che fare»: come raccontare «da sinistra»? Come si svolge un racconto «di sinistra»? Cosa lo distingue dai racconti «di destra» che sentiamo ogni giorno?
Per rispondere a queste domande, Citton fa alcuni passi indietro nella storia del pensiero filosofico: ricorre all’ariosa catalogazione di affetti e passioni proposta da Spinoza; rilegge con la lente d’ingrandimento il romanzo filosofico di Denis Diderot (il più spinoziano degli illuministi) Jacques il fatalista e il suo padrone; soprattutto, riparte dalle fondamentali riflessioni di Michel Foucault sulle relazioni di potere. A determinare e muovere queste ultime è una costante attività di «scenarizzazione», predisposizione di ruoli all’interno di cornici narrative (frame) che, una volta attivate, permettono di «condurre le condotte» degli esseri umani. Citton tira fuori dalla cassetta svariati concetti-utensili – attrattori, agganci, plot, infrapolitica… – e spiega con dovizia di esempi come funziona la scenarizzazione.
Nel farlo, si guarda bene dal proporre rigide antinomie tra scenarizzazioni «buone» e «cattive»: anche la cornice narrativa più «malintenzionata» può produrre effetti impredicibili, anche la narrazione più malevolmente ideologica (il mito più intenzionalmente «tecnicizzato», direbbe Furio Jesi) può spingere all’attenzione una singola scena, un passaggio, una frase che si aggancia a un ricordo e innesca una reazione inattesa, avviando un percorso emotivo e riflessivo divergente da quello preventivato.
Anche su questa consapevolezza si fonda la proposta – derivata da Jean-Luc Nancy – di «interrompere il mito». Narrazioni egualitarie possono sorgere dal basso per spezzare e deviare l’andamento in apparenza ineluttabile delle narrazioni dominanti, di quelle che in Italia vengono spacciate per «memorie condivise» e sono tanto più artificiose quanto più si presentano come naturali emanazioni della comunità.
Qui la ricognizione di Citton è per forza di cose sommaria, ma non è per nulla «sfuocata», il profilo delle «contronarrazioni» che Citton ha in mente è nitido, gli esempi ispiranti. Fanno capolino – forse un po’… ingigantiti dalla distanza – anche gli autori di questa prefazione, cosa che ci ha fatto tentennare: «Se introduciamo il libro, siamo o non siamo in conflitto d’interessi?» Dopo attento rimuginare, abbiamo deciso che valeva la pena introdurlo. I maligni maligneranno, e allora? Nil novi sub sole.
Noi ci fermiamo qui. La parola a Citton. Altre cose, ben più approfondite sotto l’aspetto filosofico, le scrive Enrico Manera nella postfazione. Prima del congedo, non resta che ringraziare lui (Manera) e Maurizio Vito, per averci, praticamente in simultanea, fatto conoscere Mitocrazia. Da cosa nasce cosa nasce cosa, e adesso – per opera di Alegre – il libro esiste in italiano.
Buona lettura.
***
Mitopoiesi, mitodinamica e mitocrazia. Appunti di lavoro per una nuova sinistra mitocratica
di Enrico Manera
Ho letto Mythocratie poco dopo l’uscita dell’edizione originale francese (2010) grazie alla segnalazione di Andrea Cortellessa – e a lui va un ringraziamento –, in occasione di un mio contributo al dibattito sul mito, su Furio Jesi in particolare, per un numero di alfabeta2.
Tre anni di lavoro di ricerca sulle mitologie, da un punto di vista teorico, storico-storiografico e letterario mi hanno reso particolarmente sensibile alla riflessione politica sul mito, sulla critica della sua presenza ma anche sul suo uso possibile nell’attualità: un impegno in cui, partire dall’interesse per l’opera di Jesi, sono stato felicemente coinvolto su Giap da Wu Ming 1 e in altri ambienti. Da lì inizia la catena di eventi che porta, grazie alle edizioni Alegre, alla pubblicazione del libro che il lettore ha tra le mani.
Al centro del discorso sta il rapporto tra mito e politica, che è fondativo della dimensione del politico stesso e che si rivela sempre più attuale in anni di attività politica mediatizzata, spettacolare e ‘liquida’.
In modo più radicale e profondo rispetto all’impiego propagandistico del mito teorizzato da Georges Sorel agli inizi del ’900 e alla “tecnicizzazione” fascista analizzata da Ernst Cassirer e Károly Kérènyi dal secondo dopoguerra, parlare di mitologia significa qui parlare in termini teorici più ampi di ‘grandi narrazioni’, la crisi delle quali coincide con la condizione post-moderna (Lyotard); significa anche dire ideologia, nei termini di un marxismo critico e post-francofortese che consideri la sovrastruttura come fattore determinante e costituivo del potere e non solo una sua funzione derivata e secondaria.
Significa in termini pratici constatare i risultati desolanti dell’oggi in cui risulta mortificata ogni passione politica che si voglia aliena dalla professione, dalla spettacolarizzazione e dal malaffare; una situazione che richiede nuovi strumenti per la comprensione delle nuove forme mitologiche capace di determinare gli orizzonti di senso del mondo in cui viviamo, aggiornando la cassetta degli attrezzi teorica che è stata inaugurata da Roland Barthes già dai tardi anni cinquanta e portata ai massimi livelli dalla svolta semiotica della cultura degli anni settanta.
Nelle società contemporanee lo spazio pubblico è stato egemonizzato da una civiltà delle immagini di derivazione televisiva, e via via digitali, multimediali e transmediali, capace di mettere in crisi una consolidata tradizione di pensiero critico. In Italia, la cui crisi politica può essere pienamente spiegata da vent’anni di mitologia berlusconiana trionfante (farsesca versione di quella neoliberale) che hanno oscurato nel senso comune oltre cento anni di epos dell’emancipazione legata al movimento operaio e sindacale: la fine delle grandi lotte operaie nel 1980 chiude la stagione di rivendicazioni sociali apertasi nel 1969 e prefigura il trionfo del pensiero economico che, fatto proprio dalla stessa socialdemocrazia, ha comportato la cancellazione dall’immaginario collettivo di decenni di storia delle classi subalterne e la fine della coscienza di classe come visione del mondo capace di mutarlo. Seguono l’esplosione delle televisioni private e il correlato a livello di massa di conformismo, omologazione, edonismo, narcisismo, implosione della critica e assorbimento dell’utopia.
Il resto, con le vicende dei due crolli – del Muro di Berlino e delle Torri Gemelle – è noto al lettore e ci accompagna lungo un piano inclinato alla crisi irreversibile della sinistra istituzionale, superata per modalità e temi da una realtà difficilmente inquadrabile come il Movimento 5 Stelle e disintegratasi dall’interno per scontri di potere e inconciliabilità delle sue anime. Neanche la crisi economica successiva al 2007, che pure ha fatto da moltiplicatore e da acceleratore per situazioni di protesta e rivolta in tutta Europa e nel mondo, in Italia ha fornito ragioni e motivi per una rinascita della sinistra : se realtà militanti e pensanti continuano ad esistere e a proporre alternative, non esiste un soggetto politico che sia in grado di interpretarle o comunque di proporle come forma di governo.
In ogni caso, anche in Europa, è in gioco la questione della legittimazione delle democrazie moderne con i suoi diversi addentellati, che siano la crisi della sinistra o il dominio della destra.
Il problema principale rimane il fatto che se da un lato è necessaria la critica di un modo di comunicare autoritario e ideologico, incantatorio e mitologico quale è la narrazione ‘di destra’, neoconservatrice e neoliberale, continua a mancare una narrazione nuova ed autentica che possa definirsi ‘di sinistra’ e che possa realizzare e attualizzare l’emancipazione e il riscatto per un’ampia comunità di soggetti, all’interno di un progetto di utopia .
Questa rapida sintesi, che trova un corrispettivo visivo in un recente film molto intelligente come Viva la libertà di Roberto Andò, descrive una questione dai vasti contorni e correlata a una bibliografia immensa, in cui rientra il dibattito contemporaneo sul mito, sull’identità e sulla teologia politica. Un discorso in cui è facile perdersi e di cui il libro di Citton appare come una mirabile disamina, capace di condensare agilmente decenni di riflessioni prodotte all’interno della sinistra critica contemporanea.
Si tratta di un modo per rimettere insieme i diversi fili dell’aspetto strategico dell’analisi ma anche per provare a dare delle risposte al più difficile, impegnativo e paralizzante che fare? , in un momento in cui, pur disponendo di strumenti di analisi raffinati, risulta davvero oscuro come uscire dall’ impasse e come ripensare la narrazione in quanto fatto eminentemente politico, in grado di ridefinire scenari futuri e di fornire respiro all’azione collettiva.
Le mitologie ci fanno essere quello che siamo
Dai tempi de La dialettica dell’illuminismo di Adorno-Horkheimer è chiaro come l’errore di ogni illuminismo consista nel credere di potersi disfare del mito; nel non vedere come esso si riproduca in modo proteiforme e nel sottovalutarne l’importanza e il radicamento nell’umano, nel trascurarlo e nel farlo a pezzi, consegnandolo di fatto al pensiero reazionario e populista: la demitizzazione radicale, il sogno razionalistico che accomuna illuminismo e marxismo, risulta impossibile perché la sola razionalità analitica e amministrativa non sembra essere capace di superare le secche del nichilismo e del disincanto, preparando il terreno – e soprattutto le masse – a nuovi imbonitori e a reincantamenti inaspettati, fondamentalisti e dogmatici. Se il mito e la cultura di destra sorgono dentro le stesse logiche sacralizzanti fin dall’età moderna e sono destinati a un sodalizio continuo per la forma del loro linguaggio stereotipante e monumentale, la stessa sinistra nelle sue peggiori manifestazioni storiche, come il Diamat e il culto stalinista, si è trasformata in una dogmatica repressiva o all’altro estremo nel vacuo estetismo che produce le icone di Che Guevara e le grandi kermesse canore del Primo maggio: in ciò si rivela di fatto ‘cultura di destra’ (Jesi).
L’esito più fecondo di un dibattito europeo sul mito, sviluppato in particolare in Germania dai tardi anni sessanta con il coinvolgimento di numerosi studiosi ( su tutti Hans Blumenberg, Manfred Frank, Leszek Kolakowski, Jürgen Habermas ), è che il mito va accolto, decostruito e umanizzato senza misconoscerne significati, immagini e emozioni che, se negati, finiscono per alimentare nostalgie tradizionaliste e neo-identitarie. Il mito politico ritorna nella contemporaneità in forme nuove e inaspettate perché risponde alle spinte disgreganti della globalizzazione, avvertita come fonte di disorientamento e alla crisi delle grandi storie che per secoli hanno garantito la stabilità dell’identità europea. La svolta sociocostruttivista delle scienze sociali ha mostrato che le identità politiche, sociali e culturali si costruiscono attraverso diverse narrazioni mitologiche, serie testuali e immaginali che determinano e consolidano le memorie culturali e le strutture connettive dei gruppi umani determinando «immaginario sociale» (Castoriadis), la rete simbolica in cui si radicano atti individuali e collettivi nella loro relazione con la significatività . Da un lato dunque il mito è forma di dominazione, come lo studio dei totalitarismi e poi la critica delle democrazie post-moderne e populiste hanno messo in luce; dall’altro continua ad apparire come strumento di critica, progresso ed emancipazione, invocato dalla crisi del significato collettivo, poiché del mito si scopre il valore di legittimazione quando questo viene meno, in seguito alla nietzscheiana «morte di Dio».
Su queste premesse si inserisce Citton, che ha un profilo biografico molto interessante: nato nel 1962 a Ginevra, è teorico della letteratura e filosofo politico con un curriculum denso e internazionale, insegna all’università a Grenoble, è redattore della rivista militante Multitudes, nutre interessi contemporanei quali il free-jazz e l’indie-rock . A partire da questa postura esistenziale e da una forte consapevolezza meta-sociologica, lungi da fare il m aître à penser che invita alla rivolta dal salotto buono, sintetizza i risultati più interessanti del recente dibattito francese mettendo al centro del suo discorso la lettura recente di Spinoza, il pensatore classico moderno che per primo ha affermato che ogni potere emana dalla moltitudine e che tutte le società si basano sull’immaginazione politica . U n mito politico è tale non solo per il contenuto della storia che narra, ma per il fatto che questa narrazione è performativa e coagulante, che è condivisa da un gruppo e che fornisce significatività alle condizioni politiche, cioè alle condizioni relative al conflitto per la distribuzione del potere e delle risorse.
A fianco all’asse teorico dell’immanenza e del materialismo antropologico si ritrova quello legato all’opera di Foucault, il classico contemporaneo che ha permesso di riformulare una teoria del potere, oltre e accanto a quelle liberali e marxiste. Com’è noto, nel moderno il potere si esercita in istituzioni disciplinari che hanno un «potere di normalizzazione» e di «naturalizzazione» della realtà, lavora in modo «microfisico» permeando ogni piega della società. Esso si incarna dunque non tanto nei simboli e nei grandi eventi dell’uso pubblico e del monopolio legittimo della violenza (come in Weber) quanto in una miriade reticolare di campi di forze in tensione che coinvolge tutti gli individui all’interno di più meccanismi impersonali, per indicare i quali viene usato il termine «dispositivi». B iopolitica significa la serie di strategie anonime in cui si realizza un potere opaco, esercitato sulla vita delle persone e caratterizzato da controllo dei corpi. Le istituzioni, sorte dall’incrocio di saperi e poteri (igiene fisica e mentale, carceri, manicomi, scuole, università, fabbriche, uffici, mezzi di comunicazione…) organizzano la vita dei cittadini di uno Stato in modo invisibile e diffuso, basato sull’adesione a un sistema di valori e realizzando una struttura reticolare. Foucault analizza le procedure di trasformazione degli uomini in “soggetti”: le strategie di istituzionalizzazione, ovvero le modalità attraverso cui gli individui soggettivano la norma, la riferiscono a se stessi e se ne impossessano, e le forme di soggettivazione, la formazione di uno stile di vita e della personalità etica, che egli intende come le regole che fondano la soggettività.
Sintetizza Citton: «Se l’espressione “pensare il potere” ha un senso, questo è precisamente quello di pensare all’intreccio intricato delle meta-condotte (strategiche) che inducono le nostre condotte». I racconti in cui siamo avviluppati nella nostra esistenza quotidiana avvengono all’interno di una vera e propria «scenarizzazione»: «raccontare una storia a qualcuno non implica solo articolare determinate rappresentazioni d’azione seguendo una specifica successione, ma comporta anche “condurre le condotte” di chi ascolta, a seconda dell’inclinazione conferita alle articolazioni e alle concatenazioni. Mettendo in scena le trame dei personaggi (fittizi) del mio racconto, contribuisco – in maniera più o meno efficace, più o meno incisiva – a scenarizzare il comportamento delle persone (reali) cui rivolgo il mio racconto».
La riflessione sul potere diventa una riflessione sul «potere di scenarizzazione» e si situa all’incrocio tra antropologia, sociologia, narratologia e semiotica: «passare dalla problematica della narrazione a quella della scenarizzazione significa chiedersi in che modo – attraverso quali strutture della comunicazione e con quali effetti possibili – una storia possa coinvolgere un pubblico e orientarne i futuri comportamenti». Nell’analisi di Citton «un racconto costituisce un marchingegno per catturare (…) desideri e (…) convinzioni». Simile a una macchina da guerra o teatrale, lo storytelling è un meccanismo operativo e strategico che, in quanto struttura di integrazione dell’individuo in un sistema culturale ed economico, è essenzialmente donazione di senso. I suoi prodotti, i racconti, orientano desideri e convinzioni – comportamenti, azioni, condotte –, all’interno di una economia degli affetti che è snodo decisivo del potere nelle società del controllo, un potere che prende l’aspetto di un «Nuovo ordine narrativo» realizzato dall’«immenso cumulo di racconti che le società moderne producono».
Attraverso la costruzione linguistica e visiva dell’immaginario sociale l’ideologia dominante si esercita anche quando non mostra contenuti apertamente ideologici. Un’ industria culturale ormai sovrapposta completamente al potere globale nelle sue forme sempre più accessibili e semplificate continua a essere nella società contemporanea uno dei principali fattori di fabbricazione dei “miti” nei quali ai suoi membri è dato di rispecchiarsi. Citton fornisce la formulazione aggiornata e uno sguardo di insieme di un dibattito teorico che troppo spesso si ferma agli anni Ottanta, di estrema utilità tanto allo studioso di mitologie contemporanee quanto al militante di sinistra. Come le mitologie fasciste e nazionaliste sono state il correlato alla spersonalizzazione della massa, il linguaggio dell’intrattenimento e dell’immaginario hollywoodiano, quello televisivo delle soap opera e dei talk show, dei telegiornali della sera e dell’intimità esposta nei social network sono il codice adatto alla dimensione pubblica della società di massa e dello spettacolo nelle sue mutazioni contemporanee.
Uno stesso principio logico-genetico lega lo stato etico e organicista alla retoriche dell’intimità veicolate nella sfera del rotocalco, della pubblicità e oggi del reality show o dell’informazione spettacolare in tempo reale : viene creato uno spazio ideale che illumina le esistenze individuali sollevandole dalla loro percepita banalità e le colloca in un’aura di eccezionalità. La naturalizzazione della realtà diventa iper-realismo nella società dell’immagine, alla cui adesione la realtà stessa viene piegata. Modelli culturali e stili determinati divengono simboli di un sistema di valori e credenze dalla cui adesione dipendono l’inserimento sociale e la realizzazione personale: le esistenze individuali diventano recitazione di ruoli all’interno di un copione scritto e organizzato da un sistema di potere invisibile e dai contorni inafferrabili. Lo storytelling è il potere di oggi, o quantomeno uno dei suoi aspetti cruciali considerato che Citton per primo ci ricorda che il Soft Power non potrà mai sostituire l’Hard Power che lo fonda.
Una ‘mitologia di sinistra’ è possibile?
Il significato inemendabile del mito nella definizione delle memorie culturali e delle identità politiche invoca un suo possibile uso legittimo, differente da quello ‘di destra’ e praticabile nella lotta di sinistra per la definizione degli orizzonti, dei problemi e dei frames di riferimento. Se il discorso mitologico è prassi comunicativa capace di costruire realtà mediante l’immaginario, oltre alla necessaria ‘distruzione’ del mito-violenza, non bisogna abbandonare il mito-utopia, narrazione che è insieme riflessione al servizio di una razionalità cosciente e responsabile.
Ma come fare a non cadere nel gorgo del mito e nella sua ipnosi incantatoria, visto che gli umani sembrano filogeneticamente predisposti alla credulità e alla mancanza di ragionamento? Il ricorso al mito da parte della propaganda politica è per sua stessa natura “reazionario”, se non “fascista”, anche quando le sue finalità sono progressiste. Una volta che si abbia a che fare con soggetti di forte impatto emotigeno, come sono le immagini mitologiche, la razionalità critica rischia di essere messa fuori gioco. « Com’ è possibile indurre gli uomini a comportarsi in un determinato modo – grazie alla forza esercitata da opportune evocazione mitiche –, e successivamente indurli a un atteggiamento critico verso il movente mitico del comportamento ?», si chiedeva Furio Jesi. Dal secondo dopoguerra sulla scia di Mann, di Brecht, di Benjamin, di Adorno la sinistra intellettuale ha sempre avanzato l’idea che il discorso artistico fosse l’unica possibile esperienza mitica “genuina’” capace di parlare alla collettività nel rispetto per l’uomo.
Se già Benjamin sosteneva la «politicizzazione dell’arte» tipica delle avanguardie contro l’«estetizzazione della politica» operata dal fascismo, si può ormai riconoscere un paesaggio intellettuale recente di riflessione mitologico-politica che dall’«ontologia della finzione» di Jean-Luc Nancy in La comunità inoperosa (1983, con importanti considerazioni sul «comunismo letterario») giunge fino al «potere di scenarizzazione» di cui ci parla Citton nel 2010.
La mitopoiesi è una dinamica elementare di costruzione della realtà: miti, luoghi comuni, strutture narrative ricorrenti determinano modalità di comportamento; la narrazione – concatenazione di simboli preesistenti in sequenze temporali, spaziali e causali – fonda, dà luogo e stabilizza la soggettività stessa. Tramite l’inserimento del sé in una narrazione, il racconto mitico si fa parte costitutiva di ogni programma di senso e azione. La storia del proprio vissuto, il racconto interiore, è l’identità stessa, processo di organizzazione narrativa della memoria e di autocostruzione che riguarda tanto il piano individuale quanto quello collettivo. Un modo antropologico di essere di sinistra necessita di uno storytelling adeguato e deve guardare al realismo critico e alla letteratura: questa in particolare è discorsività che articola in sequenze idee e immagini e le ‘raffredda’ e le de-metafisicizza. Il linguaggio creativo produce la mitologia, ne istituisce il tempo segreto senza produrre l’illusione della trascendenza ma rimanendo fedele all’immanenza, come risvolto utopico del tempo della storia. La scrittura (nel termine più ampio di produzione umana di immaginario sull’umano) è la macchina mitologica che genera la miticità esibendo il segno umano della sua produzione, neutralizza l’effetto ipnotico del mito-sostanza senza soffocare l’emozione che l’immagine suscita: il dispositivo linguistico-ideativo genera lo spazio letterario, extra-quotidiano e latore di significatività che illumina l’esistenza e realizza il mito umanizzato.
Dotati di valore pubblico e politico, la scrittura, il cinema e la musica (protagonista della proposta di Citton, che si interessa di culture pop e alternative) svolgono ancora un ruolo fondamentale nella battaglia per la narrazione contro il discorso mitologico neo-metafisico avanzato dall’immagine mediatica dominante.
Per un autore come Jesi, che non ha potuto vivere gli anni Ottanta, nell’elaborazione del proprio immaginario il mito-creativo deve mostrare la sua genesi artificiale grazie al montaggio ironico e parodistico, con un effetto simile allo straniamento che Brecht nel teatro e Benjamin nella critica praticavano sistematicamente in senso emancipativo per disinnescare l’immedesimazione ipnotica o consolatoria. Analogamente, aggiornando il discorso al terzo millennio con le sue specificità legate alla comunicazione, Citton introduce la nozione di «svolta verso Saturno» indicando nella mitocrazia del jazzista afro-americano Sun Ra e nelle pratiche delle arti espressive contemporanee radicali un modo possibile per riscattare il racconto mitico salvandone la significatività e il potenziale comunicativo, fino a farne uno strumento di mitologia ‘autentica’ per comunità in rivolta in cui «singolarità di ogni scrittura e la dimensione comune della moltitudine», individuo e comunità, trovino il loro equilibrio.
La stessa funzione ha la proposta della «mitocrazia del virtuale tizio qualunque», che si ritrova nella parte conclusiva del libro: il tizio che noi siamo, spersi nella moltitudine ma ad essa appartenenti e in essa desideranti, la cui storia «conta di più proprio perché conta di meno» e in ciò acquisisce un forte potere di «contro-scenarizzazione» contro i miti dominanti della crescita illimitata (e della fine del welfare “perché non possiamo più permettercelo”).
Esiste una continuità, da tempo nota e praticata, tra la linea di ribellione/emancipazione che solca le controculture giovanili (che non a caso sono state sterilizzate, inquadrate e commercializzate mentre le giovani generazioni subiscono fin dalla più tenera età una colonizzazione dell’immaginario da parte del Nuovo ordine narrativo) e le tante vicende di rivolta e rivoluzione della storia: in questo modo si producono «attraverso le gioie del contagio» i «germogli» di «nuovi mondi del possibile preclusi alla ragione contabile» e le ragioni di una ricerca della «felicità» presente.
In questo contesto Citton chiama in causa il progetto culturale e politico di Wu Ming, che «condensa una serie di pratiche, di partiti presi e di teorizzazioni che forniscono un’eccellente piattaforma di riflessione sullo statuto delle storie, dei miti, delle comunità e delle scenarizzazioni ancora da inventare».
É il felice esempio di una scrittura narrativa in grado di additare la svolta ‘saturnale’ e di produrre condivisione per diversi motivi: la decostruzione del mito dell’autore, la dimensione collettiva intensamente praticata, la tematizzazione di eroi eccentrici, di nodi storici complessi e comunità minoritarie e trasversali, i plot irriducibili a stereotipi maistream e trionfali, il legame con i movimenti militanti e con un’eterogenea opposizione culturale, il radicamento in una transmedialità in divenire attraverso la rete, la programmatica nuova epicità ragionante.
La nuova sinistra a cui ci invita Citton si vuole dunque mitocratica, non perché ogni altra via è risultata perdente ma perché ogni altra scelta perdente è stata finora il contrario di questo: un progetto «fondato sul principio di partecipazione di tutti e di ognuno alle attività di narrazione e di scenarizzazione», «un cantiere comune per la costruzione di una dimensione comune attraverso delle virtuose collaborazioni tra tizi qualunque» per «aprire varchi nelle nostre immaginazioni». «”Ciò che resta del mito quando questo si interrompe” sono forse le voci delle instabili epopee minoritarie che ci insegnano a vivere in un eterno cantiere (…) sempre aperto ai nuovi concatenamenti che il potere di scenarizzazione saprà inventare».
Il fascino di queste pagine sta nel suggerire non i contenuti ma le forme narrative di un contro-potere che coincidono con la sua realtà performativa in un progetto che ripropone con gli strumenti dell’oggi il ruolo di un’avanguardia politica che voglia riconquistare un’egemonia culturale: «non tanto un sistema di idee, coerente e totalizzante, fermamente ancorato al rigore del concetto e capace di rassicurare gli animi inquieti con la sua pretesa d’avere una risposta per tutto ( un’ideologia), bensì piuttosto un bricolage eteroclito di immagini frammentarie, di metafore dubbiose, di interpretazioni discutibili, di intuizioni vaghe, di sentimenti oscuri, di folli speranze, di racconti senza cornice e di miti interrotti che prendano insieme la consistenza di un immaginario , tenuto insieme, ancor prima che da una coerenza logica, dal gioco di risonanze comuni che attraversano la loro eterogeneità per affermare la loro fragilità singolare».
Da un simile bricolage emergono le risorse comunicative di una sinistra, dai riferimenti teorici post-moderni e post-strutturalisti, che ponga le condizioni cognitive per non cadere in nuove tecnicizzazioni destrorse, mercantilistiche e neoconservatrici dei propri miti: prima fra tutti la capacità di entrare nella sfera del racconto senza mai smettere di riflettere sull’emozione che essi generano.
Il ritorno di narrazioni emancipative e di giustizia sociale coincide con una consapevole mitopoiesi ‘leggera’: una poetica della politica come racconto (metafisicamente) infondato che renda palese ciò che sta dietro le quinte del mito dei vincitori, evidenziando la dimensione umana, collettiva, euristica dei propri e la frattura tra realtà e immaginazione utopica. Un nuovo mythos di resistenza, cambiamento e condivisione, al tempo stesso dichiarazione di sfiducia verso ogni ‘Mito’ e metacritica di sé, antidoto del suo precipitare in idolo per le comunità che in esso si cercano.
The post «Mitocrazia», di Yves Citton. Prefazione di Wu Ming 1, postfazione di Enrico Manera appeared first on Giap.

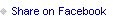






July 15, 2013
Il Partito del Nonsenso
Post estivo “leggero” (si fa per dire) su Internazionale, imbeccato dalle battute su Cecile Kyenge e dalle relative reazioni… con salto indietro di due anni.
The post Il Partito del Nonsenso appeared first on Giap.

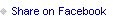






July 8, 2013
#PointLenana | Speciale Middle of the Tour: audio, foto e recensioni

Roberto Santachiara sul massiccio del Kenya, 25 gennaio 2010. Sullo sfondo, la Punta Batian (5199 mt). Foto di Cecilia Perucci. Clicca per ingrandire.
Siamo al giro di boa del tour: 30 presentazioni alle spalle, 30 ad attenderci. Ricordiamo che il calendario è qui. In questo speciale, troverete molte nuove recensioni di Point Lenana e l’audio della presentazione di Pisogne (BS) del 23 giugno scorso.
Delle foto che illustrano il post, due risalgono alla nostra ascesa al Monte Kenya del gennaio 2010; una proviene dall’archivio personale di Peter Barnes, compagno di scalate di Felice Benuzzi nell’Australia degli anni Cinquanta; le altre sono testimonianze delle escursioni e camminate che in questi due mesi e mezzo hanno prolungato i mondi di Point Lenana fuori dalle pagine del libro, tra le rocce dell’arco alpino.
Le escursioni andranno avanti per tutta l’estate (in Val di Susa il 13 luglio, sui Monti Sibillini il 20 luglio, nella Marsica il 21 luglio, in Cadore, in Val Rosandra, in Lessinia, in Trentino…), perché queste sono storie di scarpinate, le abbiamo inseguite e scritte mettendoci il corpo, e bisogna continuare a metterci il corpo, bisogna continuare a scarpinare.
Ricordiamo che esistono un board su Pinterest che “mette in immagini” Point Lenana e, grazie all’opera di alcuni volonterosi lettori, un blog interamente dedicato al libro.
⁂
Ecco l’audio della presentazione a Pisogne (BS), sera del 23 giugno 2013. Per descrivere il contenuto, usiamo le parole di Franco Berteni aka Mr. Mill, organizzatore dell’iniziativa:
“Breve introduzione mia, a seguire Maurizio Vito [ricercatore, italianista] Christian Arnoldi [sociologo, autore del libro Tristi montagne. Guida ai malesseri alpini] e Wu Ming 1.
Poche le domande dal pubblico dopo tutti questi interventi, interessante però sentire cosa risponde WM1: prima sul ruolo che personalità/pensiero/scritti di Gian Piero Motti hanno avuto su Point Lenana e, rispondendo alla domanda successiva, su alcune questioni di ‘traduttologia’ in relazione a Point Lenana.”
⁂
Girolamo De Michele su L’Indice:

Emilio Comici. Secondo De Michele, in Point Lenana la sua figura diviene “emblema del fallimento dell’antropologia fascista”.
Uno dei maggiori storici contemporanei, Robert Darnton, ha spesso tratto spunto per le sue innovative ricerche storiche da qualche evento singolare, bizzarro: un massacro di gatti alla vigilia della Rivoluzione francese, la circolazione di romanzetti osceni nel tardo Settecento, le discrepanze tra le narrazioni della favola di Cappuccetto Rosso. È un metodo che dà i suoi frutti anche in questo oggetto narrativo scritto da Roberto Santachiara e Wu Ming 1, che sono partiti da un curioso avvenimento accaduto durante la seconda guerra mondiale, quando uno scalatore italiano, Felice Benuzzi, rinchiuso in un campo di prigionia in Kenya, evade assieme ad altri compagni, scala il monte Kenya raggiungendo Point Lenana per piantarvi una bandiera italiana, e poi, ridisceso, si riconsegna ai britannici. Fosse stato un atto di propaganda fascista, non ci sarebbe nulla di anomalo. Ma ciò che Benuzzi intendeva fare non era esaltare, ma riscattare la propria italianità dalla vergogna del fascismo e del colonialismo, dalla parte del torto. Perché, allora, proprio con un’ascensione sul Kenya, che Benuzzi narrerà in due libri, italiano (Fuga sul Kenya) e in inglese (No Picnic on Mount Kenya), scritti durante la prigionia? È da questo interrogativo, e da una vecchia copia di Fuga sul Kenya, allora fuori catalogo, che muove le mosse la strana coppia formata da un narratore saltuario, ma esperto scaltore, e da un narratore di professione, ma uomo di pianura del tutto ignaro di montagne – e perciò predisposto all’esperienza della “prima volta” nell’ascendere il Kenya ripercorrendo la via di Benuzzi e dei suoi compagni: perché per capire la montagna bisogna entrarci, nella montagna, bisogna farne esperienza. La montagna, come la vita reale, non si sfoglia. E come la vita reale, la montagna è un oggetto narrabile solo al prezzo di avvolgere le molte storia di cui è intessuta in una corda, e lasciare che dalla corda delle storie pendano i filacci di altre storie, alcune a loro volta narrate, altre lasciate a narratori a venire. Quella che poteva essere una semplice biografia di un triestino che ha attraversato il Novecento diventa così la storia del triestino, e della città in cui nacque e che nel corso della sua vita cambiò quattro bandiere, della terra in cui sorge la montagna che scalò e di quelle limitrofe, dei popoli che l’abitavano da sempre e di quelli che li soggiogarono con ferocia inumana in nome dell’Impero d’Albione o del re e del duce di un impero da operetta, dei fiumi di sangue dei fucilato e delle nubi di gas che sterminarono a migliaia gli indigeni in nome del progresso bianco; e ancora, la storia delle idee che mossero il colonialismo italiano, e di quel coagulo chiamato fascismo che le incarnò nell’esercizio del potere, dei sommersi che perirono nei lager italo-tedeschi in Friuli o nella Jugoslavia o combattendo la dittatura fascio-bruna, e dei salvati che resistettero, o semplicemente scamparono in qualche modo, e ancora…
E la montagna? Ovvero, le montagne? Le montagne sono, in questo libro, ovunque: sono già lì quando arrivano gli uomini, per conquistarne le terre bagnate dalle loro ombre o per scalarle aprendo nuove vie; sono lì a ricordare che c’erano già, e ci saranno anche dopo; sono l’obiettivo, l’oggetto di un’ossessione, o semplicemente lo sfondo. Sono il punto di vista che permette di comprendere e narrare i movimento di quei some insects called ‘human race’: il Novecento e gli orrori che lo hanno attraversato visti dal punto di vista della Montagna e degli uomini che per passione, per mestiere, per prendere la via delle armi contro il nazifascismo, le scalarono e finirono con farne parte. E quindi, anche – ed era inevitabile – la storia degli alpinisti, del modo in cui il loro rapporto con la montagna si è evoluto nel lungo ventesimo secolo: una storia quasi ignota ai più, ma dotata di un altissimo potenziale allegorico. Basterebbe il confronto tra l’alpinismo muscolare, eroico, statutario del maschio virile, ovvero il tentativo di imporre una fascistizzazione dell’alpinismo da parte del Regime, contrapposto all’eleganza quasi ballerina di un Emilio Comici, la cui vita è una delle storie più belle tra questa mille e una. La figura di Comici, che danza tra le pagine di questo libro come il suo corpo faceva tra le vie alpine, diventa emblema del fallimento dell’antropologia fascista, e simbolo di quell’antifascismo esistenziale, categoria mutuata dalla storiografia e ampliata alle minuzie della vita quotidiana per dimostrare il fallimento, prima dell’8 settembre, della fascistizzazione degli italiani. Un fallimento che ha una coda velenosa: la rimozione – o meglio, la forclusione – della causa ha lasciato in circolo gli effetti, le tossine disseminate sotto il mito degli “italiani brava gente”. Al fascismo criminale dei Mussolini, Graziani, Roatta, Badoglio è subentrato un microfascismo che si annida dentro di noi, le cui manifestazioni richiedono anamnesi e antidoti: narrazioni come questa valgono tanto per le une quanto per gli altri.

WM1 sul Pizzo di Gino, cima più alta delle Prealpi Luganesi (2245 mt), 23 giugno 2013. Foto di Camillo Pasquarelli. Grazie ad Andrea Savonitto del rifugio Croce di Campo e all’Associazione Proletari Escursionisti (APE) di Milano.
⁂
Loredana Lipperini recensisce Point Lenana su Lipperatura (a proposito: forza, Ollie!)

Monte Nero / Krn, versante N, con residuato della 1a guerra mondiale. Foto di umberto54, clicca per vedere il set su Panoramio.
Point Lenana di Wu Ming 1 e Roberto Santachiara (Einaudi Stile Libero, pagg.596, euro 20) inizia soffiando nei polmoni del lettore l’aria gelida del Monte Kenya, ma non prosegue raccontando la storia attorno a cui il libro ruota: ovvero, la fuga di tre italiani da un campo di prigionia inglese in Africa, nel 1943, l’ascesa – con mezzi che definire di fortuna è riduttivo – fino a Punta Lenana, la volontaria riconsegna dopo 17 giorni. Quella storia è già in un libro, Fuga sul Monte Kenya, scritto da uno dei protagonisti: Felice Benuzzi, nato a Vienna, cresciuto a Trieste, alpinista, funzionario ad Addis Abeba, infine diplomatico, viaggiatore, scrittore, e soprattutto polo del magnete che attira a sé la storia italiana (e non solo) del Novecento (e non solo). Point Lenana si pone come “altro”, e in quanto “altro” non è incasellabile in alcuna definizione predisposta (libro sulla montagna, saggio, inchiesta, romanzo): si svolge, come l’alpinismo secondo una definizione degli autori, “in un’intersezione”, a scarti, generando narrazione dopo narrazione, tappa dopo tappa, come in un’ascensione che porta dal basso verso l’alto.
Dal basso si parte, infatti: quando Santachiara invia a Wu Ming 1 la copia di Fuga sul Monte Kenya è il 2009, e il ricevente si trovava – come molti – sotto una cappa che “risucchiava le energie buone” lasciando a terra “i vapori nocivi, gli umori più cupi, le inettitudini più resilienti, i rancori più facili da coltivare”. Messo a parte del progetto, lo accoglie con perplessità, sia per l’impresa di Benuzzi, che sulle prime sembra la classica e fascistissima esibizione di muscoli, ma anche per quello che sarà il motore del libro stesso: i due Roberti avrebbero ripercorso la via verso Punta Lenana, uno già esperto di montagne, l’altro uomo di terre basse e scrivania. C’è perplessità anche fra i colleghi e gli amici (fra cui chi scrive, che avrebbe atteso con non poca ansia il messaggio sms che, nel gennaio 2010, annunciava che la cima era stata raggiunta). Ma andare è necessario, per comprendere la “metafora primaria” (“verso su” è bene, “verso giù” è male) che è alla base non solo dell’alpinismo, ma di tutti i nostri pensieri e discorsi.
Se la scalata degli autori è il punto di partenza, la ricostruzione della vita di Benuzzi è il sentiero che tiene insieme altre vicende, piccole e grandi. L’aereo del pediatra di Atlanta che si schianta sul Monte Kenya e che diventa il pretesto per una catena di truffe telematiche. La rivolta dei Mau Mau, di cui una generazione intera conoscerà solo la versione dell’impero (gli assalti ai civili bianchi) e non le migliaia di impiccati o le decine di migliaia torturati e castrati nei campi di concentramento britannici. E poi la comunità slovena, e l’irredentismo, e il mito virile delle colonie, e Gea della Garisenda che canta A Tripoli coperta solo di una bandiera tricolore, e il vecchio Pascoli che incita alla conquista, e Carducci, e D’Annunzio e tutti i poeti che “a contatto col nazionalismo tirano fuori il peggio di sé”, e le fiamme dell’Hotel Balkan. Adolescente, Felice Benuzzi fa le prime ascensioni al Monte Nero di Caporetto mentre la storia gli scorre accanto, e vede i segni di quella da poco trascorsa guardando gli alberi fatti a pezzi dalle artiglierie. Adulto, si incanta alle piroette di Rogers e Astaire in Seguendo la flotta, mentre Rodolfo Graziani erige forche, piaga carni con l’iprite, massacra monaci e cantastorie. Point Lenana segue le curve di ogni sentiero, sale e scende raccontando (anche attraverso interviste a familiari e testimoni) i primi trent’anni di Benuzzi e quelli che che seguiranno la sua liberazione, fino alla morte. Aggira il fulcro “con una manovra a tenaglia”, oscura gli anni del campo inglese e la manciata di giorni dell’avventura indagandone il senso: Felice Benuzzi, Giovanni Balletto ed Enzo Barsotti “andarono su” per sfuggire al tedio e all’abbrutimento della prigionia, per ridare senso al tempo, per ritrovare la fiducia e la capacità di meraviglia. Per Felice funzionò, a quanto sembra: e funziona per il lettore, che infine si meraviglia davvero, e almeno spera di ritrovare fiducia. Di pensare, dal basso, a quel che c’è in alto.

WM1 sale la scarpata che porta alla Grotta dei partigiani, circa 900 mt., tra i borghi di Pizzino e Fraggio in Val Taleggio, Prealpi Orobiche, 6 luglio 2013. Grazie a Enrico, ai Ribelli della Montagna e alla libreria Spazio Terzo Mondo.
⁂
Luca Gianotti sulla newsletter della Compagnia dei cammini:
Regimi, alpinisti e libertà
Per chi non ha mai letto niente dei Wu Ming
Questo libro è scritto da Wu Ming 1, del collettivo di scrittori Wu Ming di Bologna. Insieme a Roberto Santachiara, agente letterario e appassionato di alpinismo e viaggi.
L’idea di Santachiara è stata: scegliere un bravo scrittore che ha il fiuto del segugio, ripercorrere una storia incredibile come quella di Felice Benuzzi che nel 1942 scappò dal campo di prigionia inglese in Africa per scalare con due compagni di cella il Monte Kenya, per poi riconsegnarsi alle autorità britanniche. E raccontarla. Santachiara e Wu Ming 1 hanno scalato come prima cosa il Monte Kenya, per immedesimarsi nel protagonista. Per Wu Ming 1 è stata la prima occasione in vita sua per misurarsi con cose “di montagna”. Poi hanno cominciato a investigare la storia di quest’uomo, che – come la storia di ogni uomo – attraversa periodi storici importanti, incontra protagonisti di quel periodo. La storia di un uomo e la storia di un popolo si intrecciano, in questo libro che Wu Ming 1 definisce un “oggetto letterario non identificato”.
Per chi già conosce i Wu Ming
Wu Ming 1 è di formazione uno storico. E si vede. Questo libro rispetto agli altri libri che ho letto dei Wu Ming (ho letto tutti quelli del collettivo, e come opere soliste solo quelli di Wu Ming 2) l’impronta storiografica è molto più preponderante. È un libro di storia, ma non è un libro di storia. Parla del passato per parlare al presente, come sempre sanno fare i Wu Ming. Nel ripercorrere la vita di Felice Benuzzi, il libro ci racconta i dettagli dell’irredentismo di Trieste, la “fedelissima” che diventa italiana; ci racconta tante storie di alpinisti, soprattutto di Emilio Comici che era quasi-amico di Benuzzi, era il più grande scalatore del periodo ante guerra, ma non era un fanatico fascista, era un rocciatore e basta, e il CAI, fascistissimo, lo emarginò; ci racconta la storia delle guerre coloniali di conquista, in Africa, per costruire l’impero mussoliniano, dei massacri folli di Graziani e Badoglio, e smonta la teoria che noi italiani siamo stati meno terroristi delle altre nazioni, portando le prove storiche dell’uso dei gas chimici in modo massiccio, anche se la comunità internazionale li aveva vietati, l’Italia fu l’unica a usarli sterminando migliaia di innocenti.
In tutto questo, Felice Benuzzi ne esce come un uomo mite, dedito al suo lavoro di funzionario, dedito alla famiglia, una bella famiglia, e alla passione per i viaggi e per la montagna.
Ma il libro ci racconta indirettamente anche l’Italia di oggi, paese che ha perso la memoria. Abbiamo fatto una operazione di rimozione gravissima, e ne stiamo pagando alto lo scotto. Perché la memoria di quegli anni potrebbe insegnarci tanto. Ma abbiamo preferito far finta di niente, non sapere. Non sapere cos’è successo in Etiopia o nelle altre “colonie” del nostro misero Impero. Troppo poco sappiamo del periodo fascista, troppo poco insegniamo ai nostri figli. Da quell’esperienza potremmo far emergere i valori migliori, capire il valore della pace, della condivisione, del senso di comunità. La cultura della non memoria ci porta invece verso il baratro dell’egoismo. Il baratro ce l’abbiamo sotto gli occhi. La memoria storica, e libri come questo, ci aiutano a pensare che un altro modo di vivere non solo è possibile, ma è necessario e urgente.
P.S. Per chi vuole ascoltare Wu Ming 1 presentare il suo libro, e conoscerlo personalmente, noi organizziamo una giornata con Wu Ming 1 al Casale Le Crete, Tagliacozzo (Abruzzo), domenica 21 luglio. Cammineremo insieme il pomeriggio, in una facile camminata aperta a tutti, poi alle 18 presentazione del libro nel teatro degli asini, costruito con le balle di fieno. E per finire piccolo aperitivo. Ecco la pagina web dell’evento e la pagina facebook.

Monte Kenya, 25 gennaio 2010. Wu Ming 1 in cattive condizioni lungo la Sirimon Route, nel tratto che va dall’Old Moses allo Shipton Camp. Foto di Cecilia Perucci.
⁂
Carmen Pellegrino recensisce Point Lenana su Book Detector:
Che i conti con gli scheletri del Novecento italiano – e in parte anche dell’Ottocento – non siano ancora stati fatti è un dato irrefutabile. L’uso pubblico della storia si avvale quasi sempre di una lettura del passato per singoli brandelli, decontestualizzati e presi e lasciati cadere a seconda delle opportunità del momento. Con una regolarità sconcertante, per esempio, riaffiora nel dibattito pubblico la nenia del “fascismo bonario”, della “dittatura all’acqua di rose”, di Mussolini grande statista sostenuto da un vasto consenso popolare. Oppure – e qui siamo al classico – degli “Italiani, brava gente”, rimuovendo con tenacia i molti e efferati crimini di cui tanti italiani – per esempio negli anni che vanno dall’unificazione nazionale alla fine della seconda guerra mondiale – si sono macchiati contro popolazioni ritenute barbare o subumane. Si pensi all’Africa, ai massacri, alle rappresaglie condotte contro “mandrie di negri spinti a tremendi colpi di curbascio come un gregge”, ordinate dal gerarca Rodolfo Graziani. Oppure, se si vuole, ai matrimoni con bambine eritree comprate e godute senza remore; matrimoni di cui i contraenti-acquirenti non si sono mai vergognati, nemmeno nel caso di contraenti dalla mente acuta. Su questi, come su molti altri buchi neri della storia italiana, fa luce il poderoso ultimo libro di Wu Ming 1, scritto in collaborazione con Roberto Santachiara, agente letterario e appassionato di storia e alpinismo. L’occasione intorno alla quale lievita l’imponente corpus documentale che gli autori redigono con metodo da storico orco – l’unico raccomandato agli storici che non siano antiquari, diceva Marc Bloch – è una storia minima, di quelle poco rilevanti sul piano della grande storia, eppure molto nota in certi ambienti, per esempio nel circuito dell’alpinismo. Nel 1943, in piena guerra mondiale, tre prigionieri italiani in Africa – Felice Benuzzi, Giovanni Balletto e Enzo Barsotti – evadono da un campo di prigionia inglese, il Pow di Nanyuki, e s’incamminano verso Punta Lenana, la terza vetta del Monte Kenya, con la precisa intenzione di tentarne la scalata. Restano fuori dal campo per più di due settimane, poi si riconsegnano agli inglesi. Felice Benuzzi narrerà l’impresa in Fuga sul Kenya, tradotto da lui stesso nella versione inglese No Picnic On Mount Kenya, una versione molto diversa da quella italiana che godrà di un notevole successo internazionale. Con un abile uso della tecnica a incastro (entrelacement), la narrazione di Point Lenana viene continuamente sospesa e poi ripresa nei collegamenti fra le varie storie. Si parte dalla Vienna in cui Benuzzi è nato e si giunge alla Trieste in cui è cresciuto; si prosegue per Roma, per l’Africa, poi l’Australia, poi l’Antartide, ricostruendo insieme alla vita dei protagonisti lo stridore di una storia pubblica che ha ben poco di edificante. Così, affiorano le vicende legate al colonialismo (liberale e fascista), l’irredentismo giuliano, le campagne libiche e etiopiche, lo scramble for Africa, ovvero la spartizione del continente fra le potenze europee che si contendono i pezzi migliori. Nella prima parte viene introdotto Benuzzi con il racconto breve della fuga sul Kenya – l’impresa vera e propria non viene raccontata, perché lo ha già fatto Benuzzi nel suo libro. Nella seconda e nella terza parte vengono raccontati i suoi primi trent’anni di vita. Negli interludi compaiono le incursioni nel futuro, che danno la spinta propulsiva alla narrazione. Il periodo etiope-kenyano viene raccontato al passato e al futuro, ovvero il lettore che arriva a leggere la vita di Benuzzi durante la guerra e poi lo segue nella fuga sul Kenya è già avvertito dei suoi trascorsi dal 1946 al 1988. È un procedere, dunque, à rebours, uno scandaglio al contrario del divenire storico. L’oggetto è sempre l’uomo, o meglio gli uomini nel tempo, perché tutto il resto è buon antiquariato. Così, archiviata la temporalità degli eventi, archiviato il superficiale metodo della raccolta di fatti senza una precisa volontà di cercare le grandi correnti nascoste nella vita umana; scovato il falso e l’errore perché – come ben diceva Bloch – dietro la superficie del falso appare la storia profonda, Point Lenana è un perfetto esempio di narrazione composita che supplisce alle mancanze di una storiografia che è sempre più una sottospecie di sotie e sempre meno analisi e comparazione. Sicché, scorrendo le quasi seicento pagine del libro, si ha come la sensazione di essere là dove l’uomo è passato, là dove ha lasciato qualche debole impronta (fosse anche l’orma sopra una vetta che è quasi un miraggio), perché là è la Storia.

Felice Benuzzi e Geoff Goadby sul Mount Barney, Queensland, Australia, 18 settembre 1954. Fotografia di Peter Barnes. Clicca per ingrandire.
⁂
Il compagno Avvocato Laser recensisce Point Lenana sul suo blog:
“Ciao, ti ricordi qual è il punto più alto che abbiamo raggiunto sulle Dolomiti di Brenta due anni fa? Per caso abbiamo fatto una ‘via del camino’?“.
“Boh, sarà stato 2700, non ricordo, dovrei rivedere le mappe. Abbiamo fatto i sentieri Benini e Sosat, non la via del camino“.
Rebus si sbaglia di poco, sull’altezza: il sentiero Benini, scopro in rete, tocca quota 2910 metri. La raggiunsi insieme a due amici più esperti nell’agosto 2011, alla mia prima escursione alpina. Ricordo che arrivai stremato, dopo non meno di 7 ore tra cammino e ferrata (secondo il CAI ne occorrono 4 e mezzo), incapace di muovere anche solo un passo in più.
Non saprei dire come arrivò Felice Benuzzi sulla cima Tosa, ben oltre i 3000 sulle stesse Dolomiti di Brenta, quando la raggiunse nell’estate del 1924, ma immagino che a 14 anni fosse un alpinista ben più capace di me a 31, dal racconto che ne fanno Wu Ming 1 e Roberto Santachiara nel loro Point Lenana.
Chi fosse Felice Benuzzi è proprio l’argomento del libro, che ne percorre le vicende ricomponendo una serie di tracce e documenti, che sono allo stesso tempo collegamenti, link a pagine di Storia più o meno rimossa, e di storie poco note: soprattutto storie di montagne.
Il primo indirizzo, la pagina da cui comincia e che costituisce il vero motore della ricerca e della narrazione, è un altro libro: Fuga sul Kenya (No picnic on Mount Kenya, nella sua edizione – non mera traduzione – inglese), in cui Benuzzi racconta della fuga, sua e di altri due compagni, da un campo di prigionia britannico in Africa Orientale durante la seconda guerra mondiale, con il solo fine di scalare il vicino monte Kenya per poi tornare e riconsegnarsi ai propri carcerieri.
Perché questo libro? Tutta una serie di indizi, dall’argomento – l’impresa eroica di “coloni” italiani in barba ai perfidi albionici, con tanto di tricolore issato sulla punta Lenana – alla casa editrice della prima pubblicazione, al (modesto) uso propagandistico che della vicenda venne fatto in pieno conflitto, “puzzano” di fascismo. Eppure altri elementi stridono con questo comodo pregiudizio, primo fra tutti il successo dell’opera all’estero, specialmente nei paesi anglosassoni, molto maggiore della sua celebrità in Italia. E poi basta sfogliarne le prime pagine per rendersi conto che il libro di Benuzzi ha toni tutt’altro che epici o retorici, è ricco di sensibilità e di pietà.
Il contrasto fra il contesto a cui ci si aspetta che Fuga sul Kenya debba appartenere e l’effettivo carattere del libro è stridente, ed è uno stridore fecondo: le tracce di Felice Benuzzi, nato suddito dell’imperatore d’Austria e Ungheria, trasferito da piccolo nella Trieste prima asburgica e poi italiana, quindi avviato alla carriera di funzionario civile nei territori dell’”impero” italiano in Africa, introducono e intersecano una narrazione suggestiva dell’epoca fascista. Si comincia a Trieste, che con la sua tradizione irredentista e il nazionalismo interessato della grande borghesia, è fin dal Biennio Rosso una vera e propria palestra di quello che sarà il regime e aiuta a capirne origini, sostegno, declino; ma come tutti i territori di confine, al crocevia di popoli e di lingue, di mare e di montagne, la Venezia Giulia riassume in sé le contraddizioni e la complessità che caratterizzano tutto il racconto di WM1 e Santachiara.
Se la vita di Felice Benuzzi è uno dei percorsi, l’altro sentiero che parte dalla fuga sul monte Kenya è quello che conduce in montagna e attraversa tutti i temi raccontati: è un filtro originale e affascinante attraverso cui osservare il fascismo nella sua ascesa (la montagna come simbolo di purezza ed eroismo nella propaganda del regime, la fascistizzazione del CAI epurato da alpinisti ebrei e slavi) e nella sua caduta (le montagne della Resistenza).
La montagna, oltre che cornice narrativa, è la chiave anche stilistica del libro. La stesura di Point Lenana appare un’impresa simile all’ascesa alla Punta Lenana: la sfida a un tema complesso e ricco di sfaccettature, la lunga preparazione, la ricerca degli strumenti necessari, ricordano l’approccio di un alpinista alla parete da scalare. E arrivati in cima, dall’alto, è più facile gettare lo sguardo in basso e ricomporre i pezzi del puzzle. Si può procedere a piacimento, in avanti o indietro nel tempo, cambiando registro e punto di vista, passando dal dialogo al documentario, “montando” la storia come se fosse un film a più voci.
Dopo un veloce passaggio nella Roma che negli anni Trenta si autoproclama capitale di un impero – l’impero più sfigato della storia, sicuramente – il cursus honorum di Benuzzi prosegue in Africa, ed è l’occasione per descrivere l’Italia fascista nella sua compiutezza. Soprattutto, la figura di Benuzzi consente di mettere in luce e cercare di spiegare il legame fra il regime e i cittadini: un rapporto molto più complesso di quanto venga spesso rappresentato (con la tesi del “consenso di massa” quasi incondizionato almeno fino alla guerra), fatto certamente di subordinazione e compromessi, ma allo stesso tempo, in casi tutt’altro che isolati, di gesti individuali di rifiuto, che costituiscono i precedenti necessari per comprendere il sostegno collettivo che avrà successivamente la Resistenza.
Un lavoro di ricerca colossale sostiene la descrizione minuziosa delle atrocità del regime, dalla sua ascesa fino ai suoi ultimi sussulti, attraverso le deportazioni di massa, il genocidio della popolazione libica, lo sterminio di quella etiope, con l’utilizzo delle armi chimiche vietate da ogni convenzione internazionale per la loro crudeltà. Del resto il progetto, documentato, di deportazione di massa della popolazione slovena nei territori slavi occupati durante la guerra, non ha davvero nulla da invidiare ad altre analoghe “soluzioni finali”.
Viene così smontata pezzo per pezzo la narrazione costruita e rinforzata da decenni di rimozione collettiva del “colonialismo dal volto umano” e del “fascismo sostenuto da un consenso di massa fino alla guerra”: una narrazione iniziata praticamente dal giorno stesso della caduta di Mussolini, considerato da troppi l’unico responsabile di tutto ciò che non è possibile “giustificare” in un comodissimo scarica-barile, proseguita dopo la guerra con il reinsediamento del personale fascista nelle questure e nelle prefetture, galvanizzata dall’amnistia concessa da Togliatti fin dal 1946.
["Voglio... amnistiare i fascisti", recitava un post-it appeso da un anonimo trotzkista nel circolo del PRC di Pavia durante la campagna di Bertinotti per le primarie dell'Unione nel 2005].
Contro una memoria ricostruita a uso e consumo delle larghe intese, inquinata dal revisionismo sempre più istituzionale, Point Lenana è una sorprendente boccata di aria pulita: aria di montagna, appunto. Approfittiamone, perché non capita spesso di respirarne.

Cecilia, 25 gennaio 2010. Foto di Roberto Santachiara. Clicca per ingrandire.
⁂
Franco Berteni/Mr. Mill, dopo avere organizzato e introdotto la presentazione di Pisogne ha scritto una lunga e densa recensione di Point Lenana e l’ha messa su Anobii, social network purtroppo agonizzante:
UNA VOLTA IN CIMA TOCCA SEMPRE SCENDERE

Gian Piero Motti
«A te piace dissotterrare le storie, no?» Un affastellarsi di storie, di voci. Un accumulo che mentre procede la lettura prende forma, in cui ogni elemento lascia un segno nell’esperienza di lettura che via andando – pagina dopo pagina – traccia una mappa. Dispiegandosi la mia personale mappa, vi ho trovato più di un invito a seguire un percorso che portava oltre quello che mi trovavo sotto agli occhi, oltre i bordi di una narrazione che, seppur dai tratti poliedrici, è per definizione chiusa, essendo compressa in un “oggetto libro”. Non è facile scrivere di Point Lenana, perché invita il lettore a essere quanto mai attivo e recettivo, per la stratificazione della narrazione, e perché l’accumulo di stimoli si connette con vissuti personali, interessi ed esperienze. Nel mio caso, sono nato e cresciuto fra le montagne, mi sono appassionato negli anni alla letteratura *di montagna*, durante l’infanzia in estate per anni venivo ospitato da parenti – Giugovaz (!) – a Trieste, la mia genealogia famigliare è segnata dall’«salire in montagna». Va aggiunto che ho avuto il piacere di prestarmi come lettore di prova per Point Lenana, così da intrecciare, nei miei giusti tempi, i quadri narrativi contenuti nel libro con questo mio vissuto, tracciando poi su sollecitazione di questa lettura delle narrazioni che nascevano nel libro ma prendevano corpo fuori da questo, eccedendolo: la memoria del colonialismo italiano rintracciata nei luoghi in cui sono cresciuto, i conflitti su questa memoria, l’esperienza resistenziale nella sua complessità di guerra civile, di liberazione e di classe, storie del confine orientale riflesse in oggetti che conservo. It’s been a long strange trip è la frase che apre i “Titoli di coda” di Point Lenana: lo è stato anche per me, e spesso in maniera sorprendente.
«Non mi ero mai interessato di montagna. Roberto si, eccome.» Gli autori di Point Lenana sono uno scrittore cantastorie nato e cresciuto in pianura, un appassionato di montagna che di mestiere fa l’agente letterario. Dall’iniziale condivisione di un’idea, dal dono di un libro, prende origine un movimento che connessione dopo connessione si sviluppa e produce un testo, mediante un processo di ricerca – delle fonti, nell’immedesimazione fisica, delle forme e dei registri narrativi – in cui il lettore è accompagnato attraverso una metanarrazione: sensazioni, considerazioni, riflessioni, sono tutte fuse in un unico io-narrante. Come nella progressione in cordata, a guida alternata e in conserva, Santachiara e Wu Ming 1 si muovono simultaneamente, svolgendo contemporaneamente il ruolo di chi assicura e di chi è assicurato, accettando e condividendo i rischi, mettendo in comune la propria specifica esperienza. Raccontare una storia – quella di Felice Benuzzi e del suo Fuga sul Kenya. 17 giorni di libertà ¬ diventa così il pretesto per moltiplicare i piani narrativi e, di storie, raccontarne molte. L’elenco dei personaggi che compaiono in Point Lenana – il cui racconto di sprazzi delle singole biografia tesse uno sfondo di contestualizzazione storica e sociale – è lungo e vario, e ognuno, in modi differenti, orbita attorno alla vita di Benuzzi, rafforzando la complessità del personaggio e garantendo un sicuro appiglio al lettore, quando mai ne sentisse il bisogno. Ad ogni modo «in questo libro, nessuno e menzionato a casaccio», ogni personaggio è un tassello che trova la sua collocazione nella narrazione e che apporta a questa maggiore ricchezza e, al contempo, ne amplifica la complessità.
«Questa storia è così, ovunque ti giri trovi alpinisti». Point Lenana è un libro che parla di montagne e di alpinisti, lo fa portando questo mondo fuori dalla nicchia in cui in Italia rimangono sovente rinchiusi i libri etichettati come “letteratura di montagna”, cosa che, fra i tanti, è successo anche a Fuga sul Kenya, non favorendone certo la diffusione. Eppure guardare a come è mutato l’andare per montagne, alla «metafora primaria» del «verso su» e del «verso giù», offre uno sguardo obliquo e sghembo sul mutare di un’intera società; interrogare poi il rapporto unico fra alpinismo e scrittura, fra azione e margini dell’azione, scavare nella rappresentazione di quel intramondo in cui l’alpinismo di svolge, scriverne a propria volta, significa occuparsi anche di cosa cazzo voglia dire sentirsi un essere umano. A questo proposito si rintraccia in Point Lenana un filone dark, esistenzialista, nella figura stessa di Felice Benuzzi, ma soprattutto in quella di Emilio Comici: il più grande scalatore italiano della sua epoca, rivoluzionario del VI grado, personaggio controverso, sfuggevole a ogni tentativo di inquadramento, incline a momenti di blues e cadute profonde nel suo spleen. Le pagine a lui dedicate sono quelle che più mi hanno colpito, per desiderio d’autenticità e per intimità, si potrebbe arrivare a dire di femminilità. A proposito va nominato un personaggio che è citato marginalmente nel testo – almeno in proporzione alla sua influenza da me percepita in filigrana in Point Lenana, un’influenza che possiamo dire determinante – ma a cui Point Lenana stesso è dedicato: Gian Piero Motti, alpinista e scrittore torinese, appartenente con altri alpinisti al cosiddetto “Circo volante”, colui che teorizzò il “Nuovo mattino” – portando nell’alpinismo, praticato e scritto, le spinte libertarie dei movimenti protestatari degli anni Sessanta e Settanta – caratterizzandosi sempre per uno sguardo critico sul suo mondo – quello dell’alpinismo – che è parallelamente anche critica sociale. Negli scritti dell’epoca di Motti – raccolti nel volume I falliti ed altri scritti – si trova la stessa sensibilità umana che Wu Ming 1 Santachiara attribuiscono, a mio parere correttamente, a Comici, ma anche al Benuzzi di Non solo sassi contagiato dal relativo bacillo; una sensibilità lontanissima da quella dell’alpinismo eroico con le sue ossessioni da superuomo di derivazione romantica, amplificate poi nella retorica fascista e rimaste intatte in Italia fino alla metà degli anni Settanta. Motti, chiaro e senza lasciare possibilità di fraintendimenti, nel 1974 scriveva: «Sarei felice se su queste pareti potesse evolversi sempre più quella nuova dimensione dell’alpinismo spogliata di eroismo e di gloriuzza da regime, impostata invece su una serena accettazione dei propri limiti, in un’atmosfera gioiosa, con l’intento di trarre, come in un gioco, il massimo piacere possibile da un’attività che finora pareva essere caratterizzata dalla negazione del piacere a vantaggio della sofferenza» (G. Motti, Scandere).
«E Felice: – I shave him every day.» In qualche modo, Motti – Comici – Benuzzi, seppur separati spazialmente e temporalmente, parlavano la stessa lingua, sia per quanto riguarda la concezione dell’alpinismo (certo, non in modo perfettamente sovrapponibile) che più in generale per una certa tensione a un modo di vivere la vita che è risonante fra loro; questa tensione era anche un’inquietudine, quella che spinge ad andare in montagna e trovare lì, nell’azione e nella realizzazione di vie nuove o da ripetere, un riempitivo per le ansie quotidiane, un senso di pienezza che fa sentire vivi. Nella solitudine e nel silenzio della montagna, distaccati dal vociare e dagli eventi mondani, l’azione può diventare feticcio e a volte, come scriveva Motti, “onanismo” o “masturbazione spirituale”, distacco solipsistico, dipendenza. L’azione concentrata, come scrisse Benuzzi, distrae, ma non risolve, l’azione che “realmente guarisce, non esiste”, è illusione, perché all’azione “non bisogna domandarle di più di quello che può dare”; la conclusione di Benuzzi è doppiamente rivoluzionaria quanto lapidaria: fare dell’azione concentrata “un’idolatria è folle”, “esiste il campo di concentramento, ma non l’azione concentrata!”. Questa consapevolezza maturata da Benuzzi nel salire e poi scendere dal Monte Kenya, nel riconsegnarsi al campo e accettare la condizione di prigioniero di guerra, rappresenta il limite all’idea stessa del condurre una vita al di fuori della possibilità – parafrasando Sartre – di decidere cosa fare con ciò che ci è stato fatto. Il rapporto del singolo con il tritacarni della storia, quella dalla esse maiuscola, che consuma le singole esistenze e a cui il gesto individuale di distinzione, se non quando proprio di dissenso, paga pegno, ricadendo sulle spalle di chi lo compie con coraggio e responsabilità, è il costo della libertà. Motti e Comici, al di là del possedere la consapevolezza così ben esposta da Benuzzi, scelsero il suicidio, mascherato o meno che fosse (Se [Comici] fosse sopravvissuto alla depressione senza farsi saltare le cervella…); stesso epilogo lo incontriamo in Point Lenana nelle 118 persone suicide nella Trieste redenta del 1920; in Giuàn Balletto che con Benuzzi aveva raggiunto la Punta Lenana; nelll’alpinista Matthias Zurbriggen di cui Benuzzi scrisse una biografia; in Antonia Pozzi, poetessa alpinista.
«La testa scoperchiata e il cielo dentro.» Point Lenana è un libro che scuote dal torpore, dal tedio, in una parola dall’alienazione, esorcizzando il suicidio che è riparo, senza condanne e senza puntare il dito contro la fragilità umana, rivestendola anzi di un valore politico; la scelta – la consapevolezza delle scelte – e le conseguenze di questa, là fuori dai nostri regni formato cranio, segnano l’intero arco temporale di una vita e, per chi diffida del pensiero sistematico, rendono la vita almeno dignitosa, una buona vita spesa a non dimenticare che “azione è uscire dalla solitudine” (L. Pintor).
⁂
Il giornalista, scrittore e storico dell’alpinismo Enrico Camanni recensisce Point Lenana su dislivelli.eu:

Enrico Camanni
Wu Ming 1, ormai celebre scrittore bolognese, è molto più avvezzo alle suggestioni urbane che al richiamo delle cime. Roberto Santachiara, al contrario, è quel che si dice un “patito di montagna”, nel senso che si diletta e si strugge a salirla, leggerla e raccontarla. L’incontro tra uno scrittore sperimentale e un alpinista appassionato e colto sarebbe già motivo di curiosità, di per sé, se non fosse maturato per di più all’ombra di una storia mitica e strampalata come la scalata del Monte Kenya per piede di Felice Benuzzi e compagni nel 1943, tutti giovani internati in un campo di prigionia africano. La Punta Lenana è stata una fuga-scalata così insensata e allegorica da diventare un romanzo, un film e ora una specie di viaggio di formazione storica e culturale, nel dipanarsi del racconto di Wu Ming e Santachiara che mischiano la biografia di Benuzzi e le autobiografie personali, citazioni letterarie e luoghi autentici, dissertazioni filosofiche e brani di vita vera, a cavallo tra Trieste e l’Africa, e tra la seconda guerra e oggi. Ne esce un racconto senza soluzione di continuità come negli altri libri di Wu Ming, una “scorribanda nel Novecento” che corre liberamente nello spazio e nel tempo attaccandosi a tutte le storie che incontra. Un libro da leggere per imparare, se si vuole (la bibliografia è importante), oppure per il puro piacere di vivere in altri posti e in altre vite.
The post #PointLenana | Speciale Middle of the Tour: audio, foto e recensioni appeared first on Giap.

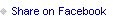






July 6, 2013
Notes for a Musical Intifada

Oday al Khatib
di Dimitri Chimenti (guest blogger)
[Chimenti, oltre che un acuto studioso di cinema e letteratura e uno dei più curiosi indagatori di "oggetti narrativi non-identificati", è autore del documentario Just Play (2012).
Just Play racconta la storia di Al Kamandjâti (Il Violinista), un'associazione culturale che da 10 anni porta le sue scuole di musica in un territorio che dai campi profughi del Libano arriva sino alla Striscia di Gaza. La musica come mezzo di liberazione. "Che senso ha suonare Bizet tra le sbarre di un checkpoint? Perché un’orchestra sfida un esercito? Qual è la posta in gioco?" In questo articolo/racconto per Giap, Dimitri racconta cos'è accaduto a uno dei protagonisti del film.]
-
19 marzo 2013
Sono le 21.51 quando ricevo il messaggio di Jibril su Skype: hanno arrestato Oday. Il capo d’accusa non si conosce e nessuno sa dove è rinchiuso; l’unica notizia certa è che tre giorni fa è partito da Ramallah per fare visita ai genitori nel campo profughi di Al Fawwar, pochi chilometri a sud di Hebron. Da allora più niente.
La prima volta che l’ho sentito cantare, Oday Al Khatib aveva 15 anni ma ne dimostrava non più di 10; oggi è un famoso interprete dei canti di resistenza palestinesi e quando torna al campo viene accolto come una celebrità. Stavolta però è diverso, da qualche giorno tira una brutta aria ad Al Fawwar: i soldati hanno ammazzato un ragazzo durante un raid e ci sono manifestazioni, scontri e arresti in tutto il campo profughi. Oday deve esserci finito in mezzo. Se le cose si mettono bene lo tengono qualche notte per cercare di estorcergli chissà quali informazioni. Se si mettono male sta dentro mesi. Prima o poi i genitori riceveranno una comunicazione, magari tramite un difensore d’ufficio, e a quel punto sapremo dove è tenuto prigioniero.

Oday al Qalandia Checkpoint
21 giugno 2011
Se il soldato dietro il vetro si accorge che il lasciapassare appartiene a un altro, va a finire male. Oday lo sa e canticchia per farsi coraggio. Da piccolo esibirsi a Gerusalemme non era un problema, ma da quando è maggiorenne gli serve un permesso e non c’è verso di ottenerlo. Tutte le sue richieste vengono respinte con le stesse tre parole di motivazione: questioni di sicurezza. Oday non ha precedenti penali, ma è nato e cresciuto in un campo profughi e tanto basta a farne un individuo potenzialmente pericoloso. Se a ciò si somma che i fratelli sono stati tutti in prigione, le sue possibilità di cantare al di là del muro scendono a un quarto di zero. Un divieto inaccettabile per chi gira gli auditori di mezza Europa; e Oday non accetta, a costo di farsi tre mesi di cella. Ci sono molti modi per entrare senza lasciapassare, il più comune dei quali è seguire la rotta dei lavoratori irregolari che ogni giorno raggiungono Gerusalemme attraversando le colline circostanti. Un percorso a piedi lungo chilometri sul quale è facile perdersi, finire in bocca a una pattuglia israeliana o prendersi una pallottola. Negli ultimi tempi poi l’esercito utilizza cani da attacco lungo le frontiere, bestie talmente feroci che per fargli lasciare la presa devi stordirle con una pistola Taser. Ecco perché c’è chi preferisce giocarsela al checkpoint. Il trucco consiste nell’attraversare in gruppo, accucciarsi dietro ai compagni e al momento giusto, quando il soldato nel gabbiotto ha la visuale coperta, sgattaiolare oltre il checkpoint senza farsi vedere. Sembra una barzelletta, invece è proprio così che Oday è passato l’ultima volta. Quest’anno proverà con un permesso rilasciato a un ragazzo di 15 anni. Lui di anni ne ha 20 ma senza barba sembra un ragazzino e soprattutto ai minori di 16 anni non chiedono un documento di identità. Ha imparato a memoria data di nascita e nome del ragazzo e adesso canticchia con le braccia appoggiate al tornello d’acciaio, in attesa che si sblocchi.
26 marzo 2013
C’è voluta una settimana per sapere che è rinchiuso nel Carcere di Ofer , appena fuori Ramallah. Lo hanno preso durante un rastrellamento quindi non si tratta di un arresto mirato e questo potrebbe essere un bene. L’accusa nei suoi confronti è di aver lanciato pietre a una pattuglia di soldati israeliani e questo è di sicuro un male. Se condannato, Oday rischia 10 anni di carcere. La buona notizia è che ha incontrato un avvocato.

Concerto al Qalandia Checkpoint.
22 giugno 2011
I musicisti scendono dal bus con il leggio in una mano e lo strumento nell’altra, si piazzano nell’angolo più lontano del checkpoint su uno sfondo regolare di barre blu. Neanche 5 minuti e l’orchestra è già nella Sesta Sinfonia di Mozart in Fa maggiore. Le regole da seguire sono semplici: non parlare ai soldati e ignorare i loro ordini. I musicisti suonano, le persone in fila ai tornelli si arrestano, c’è chi si avvicina per scattare una foto con il cellulare. Attorno all’orchestra si forma un semicerchio e loro continuano a suonare, riempiono lo spazio, lo trasformano. Anche l’acustica è buona, meglio di molti teatri. Non si è mai visto niente del genere nel checkpoint di Qalandia.
Una soldatessa si affaccia al pertugio del casotto in cemento dentro al quale è rinchiusa. La sua espressione è più di sorpresa che di allarme. Quando l’orchestra passa a Bizet, un primo soldato fa la sua comparsa. Ha la faccia da duro, mitra a tracolla e occhiali da sole. Alzo d’istinto la camera, ritaglio la scena nel display, regolo il fuoco: davanti al soldato, dall’altra parte delle sbarre, Majd Qadi spreme le guance nel trombone. Soffia come un dannato mentre il tizio se ne sta impalato dall’altra parte e osserva, talmente immobile che diventa difficile stabilire chi è dentro e chi è fuori da quelle sbarre.

Dentro – fuori.
Arrivano un secondo e un terzo soldato. Una ragazza sulla ventina e un uomo tarchiato sui quaranta. E’ chiaro che quest’ultimo è il più alto in grado. Non sembra preoccupato, parlotta a mezza bocca con il duro mentre il duro parlotta nel microfono che tiene appeso a una spalla.
L’orchestra conclude, attacca il bis: la Farandole di Bizet. Un pezzo in Re minore che anziché insistere sulla tonica enfatizza le tonalità maggiori della scala e procede forte e aggressivo e si allontana dai languori dei toni minori. Stringo sul primo piano delle dita del comandante che tamburellano a tempo sulla cinghia del mitra mentre le note si spengono e l’uditorio si scatena nell’applauso finale. I ragazzi si guardano in faccia, non riescono a credere che sia successo davvero. Neppure io ci riesco. Ho assistito a una battaglia e pare che stavolta sia stato l’esercito a perderla.
1 aprile 2013
Altri 6 giorni per fissare la data dell’udienza. Oday andrà a processo mercoledì 3 aprile. L’avvocato ha raccolto le testimonianze dei genitori e dei conoscenti. Secondo la sua ricostruzione, Oday doveva incontrare un amico per cena. I due si erano dati appuntamento sulla collina di Al Fawwar. Oday arriva in leggero anticipo e aspetta all’ombra di un mandorlo. Vede corrergli incontro un gruppo di ragazzi, non capisce subito cosa sta succedendo e quando arrivano i soldati non tenta neppure di scappare. Lo accusano di aver tirato dei sassi e lo portano via.
Nel 2010, la percentuale di condanne in processi per lo stesso reato è stata del 99,74% . Su 400 imputati 399 sono stati riconosciuti colpevoli. Tradotto in termini spicci è pressoché impossibile essere assolti da una corte militare israeliana. La cosa peggiore è che a lanciare pietre contro gli occupanti sono soprattutto bambini e adolescenti, particolare che non impedisce all’esercito di metterli in galera. Secondo un recente rapporto dellUNICEF , la maggioranza dei minorenni processati nelle corti militari israeliane è accusata di aver lanciato pietre. Un crimine appositamente sanzionato nella sezione 212 dell’Ordinanza Militare 1651 , secondo la quale
(i) Lanciare un oggetto, compresa una pietra, contro una persona o una proprietà con l’intento di arrecare danno alla persona o alla proprietà comporta una pena massima di 10 anni di detenzione.
Poche righe che da sole spiegano l’alto numero di condanne poiché, interpretando alla lettera il testo, è sufficiente lanciare un sasso a un cartello stradale per finire in carcere. Non ce lo vedo Oday a tirare pietre, l’occupazione ha sempre voluto combatterla con la musica, ma è ingenuo ridurre la questione a formule del tipo pietre/non pietre o violenza/non violenza. Poco importa se procedi con le mani alzate o se invece stringi una pietra, se sei un bambino o un adulto, se scappi o resti fermo. There is a system in place dicono quelli che la sanno lunga, un sistema di controllo politico-giudiziario che sanziona come terroristico qualsiasi atto di opposizione, anche se di carattere meramente simbolico come cantare, scrivere o fare un film ; un sistema che e a ogni atto di resistenza risponde con una forza smisurata, infliggendo punizioni la cui entità varia secondo parametri misteriosi o forse solo casuali ma che in ogni caso portano dei corpi dietro a delle sbarre.
Luglio 2003
Ramzi non si è ancora diplomato al conservatorio di Angers, quando insieme ad alcuni compagni fonda Al Kamandjati (Il Violinista), un’associazione culturale il cui scopo è portare corsi di musica e concerti nelle zone più isolate della Palestina. Quell’estate parte con alcuni giovani musicisti francesi. Al Kamandjati non ha neppure una sede e alloggiano tutti a casa di Ramzi. Attraversano in lungo e in largo la Cisgiordania, raggiungono i luoghi più sperduti suscitando lo stupore degli abitanti che si chiedono cosa ci fa un’orchestra da quelle parti. Arrivano nel campo profughi di Al Fawwar, alle porte di Hebron; ma siamo nel bel mezzo della Seconda Intifada e i soldati chiudono ogni uscita del campo e impongono il coprifuoco. Ramzi e i suoi non hanno scelta: devono fermarsi per la notte e provare a ripartire il giorno dopo. Intanto si fa buon viso a cattivo gioco e il workshop per i bambini del campo viene allungato di un giorno. E’ qui che i destini si incrociano e imboccano traiettorie imprevedibili. Mentre cammina per strada, una banda di ragazzini avvicina Ramzi, lo chiamano zio, gli dicono che un loro amico canta molto bene. Dietro ai ragazzi più grandi se ne nasconde uno minuto con indosso una maglietta arancione che gli sta troppo larga. Il suo nome è Oday e Ramzi lo invita al workshop per cantare una canzone .
- A scuola capitava che organizzassimo dei concorsi di musica o di canto, io vincevo sempre. Il preside era molto soddisfatto e un giorno mi comprò un vestito elegante e andammo a fare un concorso in una scuola dell’Unrwa (Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l’Occupazione, NdR). E vinsi anche quella volta.
A Oday piace l’idea che ci siano degli stranieri ad ascoltarlo e canta un Mawwal (un pezzo per sola voce che si esegue come introduzione a una canzone) che si intitola Rharib (straniero). Ramzi è conquistato dalla sua voce e prima di ripartire gli promette che registreranno un cd insieme.
- Io ero ragazzino, non ero mai uscito dal campo, non ci potevo credere, pensavo che mi prendesse in giro. Per me era come un sogno. Ramzi parlò con i miei genitori, era il gennaio del 2003 e andammo in Francia per un Festival. Per la prima volta ho cantato davanti a un pubblico, ed era un grande pubblico, qualcosa come 1000 persone. Io non sapevo nulla di musica. Da quella volta sono tornato in Francia ogni anno, sempre allo stesso festival. Quest’anno è la dodicesima volta che vado in Francia.

Commemorazione di Maysara Abu Hamdiyeh.
4 aprile 2013
L’udienza è rimandata all’8 aprile. Gli avvocati palestinesi sono in sciopero da ieri, protestano per la morte di Maysara Abu Hamdiyeh , un prigioniero malato di cancro a cui le carceri israeliane passavano solo aspirine e antidolorifici. Oday resta in cella e, a parte l’avvocato, nessuno è riuscito a incontrarlo. Oday è finito nel buco nero delle percentuali statistiche, in quel il 40% di maschi palestinesi, circa il 20% della popolazione totale, che sono o sono stati imprigionati sotto gli ordini militari israeliani. Non c’è famiglia in tutta la Palestina che non abbia almeno un membro in carcere: ragazzi, vecchi, donne, invalidi, malati, contadini, accademici, sindacalisti, fumettari, leader politici, medici e poi fotografi, attivisti, giornalisti, studenti, elettricisti, videomaker, fruttivendoli, tassisti, muratori e cantanti. Non c’è parte politica né categoria sociale che sia risparmiata e nonostante sia vietato dalle convenzioni internazionali, i prigionieri vengono trasferiti e processati fuori dai territori occupati da Israele. Tra le molte possibili, la forma di arresto più odiosa e arbitraria è la «detenzione amministrativa». Vale a dire una detenzione senza imputazione, giustificata sulla base di prove segrete che neppure il tuo avvocato può vedere. Resti in carcere per periodi rinnovabili di sei mesi in sei mesi e poi alla fine un processo oppure nulla e sei libero. Fino alla prossima volta. Si aspetta l’8, in attesa di nuovi risvolti.
18 giugno 2011.
- Hanno voluto educarci alla farina. Ci hanno convinti che le cose importanti sono la farina, l’olio e lo zucchero. Ma come puoi proteggere la tua esistenza con la farina? Preferisco che si tengano i soldi della farina e li spendano in educazione. Abbiamo bisogno di cultura. Pensa se avessimo 3 o 4 Mahmoud Darwish; immagina 3 o 4 Edward Said.
Ramzi non ha freni e sembra non averne neppure la sua macchina che zigzagando a velocità mortale nel traffico di Ramallah ci porta alla sede di Al Kamandjati, nella parte vecchia della città. In 10 anni di attività, l’associazione ha fondato 8 scuole e porta i suoi corsi di musica su un territorio che dalla Striscia di Gaza arriva fino ai campi profughi del Libano. Io sono qui assieme a Jibril, Francesco e Vincenzo per girare un documentario sull’associazione. La storia di Ramzi Aburedwan, sembra saltata fuori da un romanzo (e infatti qualcuno lo sta scrivendo). Allo scoppio della Prima Intifada nel 1987, Ramzi ha 8 anni e vive nel campo profughi di Al Amari, alle porte di Ramallah. All’inizio non capisce di preciso cosa succede poi inizia a vedere i soldati che arrestano i suoi vicini, i feriti, la gente ammazzata per strada. Un giorno Ramzi è assieme al suo migliore amico; stanno tornando da scuola quando incappano in un’operazione militare israeliana. L’amico di Ramzi si accascia a terra, centrato da un colpo in fronte. Ramzi raccoglie un sasso e lo lancia contro un blindato israeliano. Di quel periodo rimane una foto che lo ritrae mentre carica il braccio destro per scagliare una pietra, nell’altra mano ne tiene un’altra che è grossa la metà della sua testa. Bambino e sassi assieme non arrivano a 30 chili. La foto fa il giro del mondo e Ramzi diviene il simbolo dei “ragazzi delle pietre”, un termine che in arabo indica i bambini che stavano in prima linea durante le battaglie di resistenza della Prima Intifada.

Ramzi ieri e oggi.
Ramzi adotta la tecnica del mordi e fuggi che lo renderà famoso nel campo. Colpisce i soldati e poi si getta nei vicoli di Al Amari, una ragnatela inestricabile che però lui conosce a perfezione. Passa dai tetti, dai buchi nei muri, dalle sale da pranzo dei conoscenti; si lancia da una casa all’altra per sorprendere i soldati alle spalle e centrarli con un’altra pietra. Li sfida, li deride, dice loro di farsi avanti senza armi se sono degli uomini. Corre veloce Ramzi, ma le pallottole lo raggiungono lo stesso; la prima volta a 8 anni, quando si becca un proiettile di gomma in piena testa e finisce all’ospedale; la seconda a 11, ma stavolta il proiettile è vero e gli trapassa il braccio destro da parte a parte. Cresce veloce Ramzi e la sua corsa sembra destinata a finire in una prigione israeliana o a fargli guadagnare l’onore di un manifesto da martire. Ha 17 anni quando un’amica gli chiede se vuole imparare a suonare uno strumento. A Ramzi l’idea piace e ottiene un invito per partecipare a un corso di musica. Impara le prime note sul violino, ma il suo vero amore diventerà la viola. Ramzi suona tutto il giorno e quando non suona è per strada a battersi. Va avanti così finché non arrivano gli anni brevi dell’ottimismo, quelli che seguono gli accordi di Oslo del 1993, quando Rabin e Arafat posavano davanti alla Casa Bianca stringendosi la mano. Oggi sono morti tutti e due: il primo freddato a colpi di pistola; il secondo consumato da un male oscuro e improvviso che lo porterà alla tomba nell’arco di un paio di mesi. Durerà poco e già nel 2000 scoppia la Seconda Intifada, ma gli anni novanta offrono aperture e opportunità a un sacco di gente, incluso Ramzi che studia prima per un anno all’Edward Said National Conservatory of Music, poi nel 1997 vola in New Hampshire, USA, per partecipare a un campo estivo di perfezionamento musicale. La svolta decisiva arriva nel 1998, quando Ramzi ottiene una borsa di studio per il conservatorio di Angers, in Francia.
8 aprile 2013
Spostato di nuovo. Prima al 10, poi al 17 aprile. Stanno giocando al posticipo. Il 13 esce di prigione Issa Amro, coordinatore di Youth Against Settlements. Lo hanno arrestato pochi giorni fa dalle parti di Hebron mentre dimostrava davanti alla colonia di Qiryat Araba. Issa è per le autorità israeliane quel che si dice un pain in the ass. Uno che va in giro per i villaggi a insegnare agli abitanti come usare una videocamera per documentare gli abusi dell’esercito e dei coloni. Nonostante che tutte le sue azioni abbiano un carattere non violento, Issa è stato imprigionato troppe volte per tenere il conto. L’accusa nei suoi confronti è più o meno sempre la solita, “incitamento al terrorismo”. Jibril scopre che Issa era rinchiuso nel carcere di Ofer e gli chiede notizie di Oday. Questi gli stralci della loro conversazione su Skype :
J- Bentornato a casa.
I- Grazie, davvero. Oday era con me in prigione, eravamo nella stessa cella. Ci hanno trasferiti insieme al tribunale militare di Ofer.
J- Davvero? E come sta?
I- Sta bene, ma i soldati l’hanno picchiato di brutto e la polizia si è rifiutata di fotografare i segni lasciati sulle gambe.
J- Che ti ha detto?
I- Ha respinto ogni accusa ed è sicuro che lo rilasceranno. Mentre ci portavano in aula per il processo, cantava. Ha cantato canzoni per tutti noi. Ha dato ispirazione a tutti i prigionieri, anche a me.
25 giugno 2011
Dopo 10 giorni di lavoro ininterrotto ci prendiamo una giornata libera. Si va al mare, ad Haifa. I nostri passaporti italiani ci consentono di passare da una parte all’altra del muro senza troppe formalità: non serve un permesso e possiamo percorrere le strade più veloci, quelle dei coloni, senza preoccuparci di evitare i checkpoint. Questo muro di 8 metri che ci accompagna dall’inizio del viaggio ha solidità diverse e diversi gradi di permeabilità, dipende da chi sei, da cosa c’è scritto sui tuoi documenti, da dove sei nato, dalla targa dell’auto che guidi. Secondo i dati raccolti da B’Tselem, il noto gruppo israeliano per i diritti umani, sono 312 i chilometri di strada in territorio palestinese proibiti alle macchine con targa palestinese.
Forse apartheid non è la parola giusta, ma è la prima che viene in mente.
Il muro si fa improvvisamente più solido quando un’amica decide di venire con noi. Lei è palestinese ed è un pezzo che non va al mare. Lo ha già fatto altre volte e se lascia i capelli scoperti è convinta che nessuno controllerà i documenti. Se invece controllano è un casino, lei lo sa ma è disposta a pagare il prezzo. Vuole vedere il mare. Alla fine vince il buon senso e andiamo tutti in piscina.
18 aprile 2013
Durante l’udienza, i soldati che hanno arrestato Oday si sono contraddetti a vicenda, così riferisce l’avvocato, e il giudice vuole ascoltare i testimoni uno per uno, sentire di nuovo l’accusato infine mandare i periti a fare un sopralluogo sulla collina di Al Fawwar e a scattare un paio di fotografie. Secondo l’avvocato la corte mira a patteggiare una condanna lieve, di qualche mese, ma finché Oday continua a dichiararsi innocente resta in carcere. Statistica dopo statistica, udienza per udienza ho capito una cosa sola: la posta in gioco non è mai stata colpevolezza/innocenza, ma pena lunga/pena breve.
30 Giugno 2011
Mentre il taxi ci accompagna all’areoporto Ben Gurion di Tel Aviv, il conducente riceve una chiamata. E’ il direttore della compagnia di taxi che però non vuole parlare con il suo autista, vuole parlare con me. Si raccomanda di non dire al controllo passaporti che siamo stati nei Territori Occupati o avremo delle noie. Gli rispondo che non c’è da preoccuparsi, abbiamo una lettera d’invito del consolato francese e comunque arriveremo all’areoporto con 3 ore di anticipo. Non è convinto e ha ragione. Alla lettera danno si e no un’occhiata, appiccicano dei codici a barre sul retro dei nostri passaporti e ci dividono. Io ho il carico più scottante, le cassette con tutto il girato. Alcune delle cose filmate sono crimini secondo le leggi israeliane. La pallina finisce sul pari e passo senza problemi. Va peggio ai miei compagni. Mancano quaranta minuti al volo quando spunta Francesco. Gli hanno sequestrato il registratore audio digitale, ma per fortuna ha una copia di back-up nel computer. Per ultimo arriva Vincenzo, è provato e gli hanno sequestrato una delle luci che usavamo per le interviste. Dice che hanno voluto smontarla e quando hanno visto il trasformatore si sono insospettiti.
“ What is this?”
Vincenzo non sa dire in inglese “trasformatore di corrente da 220V a 12V”, neppure io so come si dice. Fa quel che può, ma la sua spiegazione non convince i funzionari. Gli dicono di lasciare i documenti sulla scrivania e di seguirli. Si ritrova in una stanzetta con altri due tizi che continuano l’interrogatorio. Il grado di gentilezza dei funzionari scende a ogni domanda e quando scoprono che un obiettivo monta un microchip si incazzano di brutto. Quel microchip serve per controllare la messa a fuoco attraverso i comandi della camera, Vincenzo glielo ripete mille volte. Va avanti per un pezzo e arriva al gate che è già iniziato l’imbarco. Mancano almeno 1.000 euro di attrezzatura rispetto all’andata, confiscata per non si sa quale motivo. Servirà un numero infinito di telefonate, mail, lettere, reclami per riottenere la nostra roba e della luce torneranno solo pezzi e frantumi.
9 maggio 2013
Ha resistito 2 mesi, ma alla fine Oday si è dichiarato colpevole. L’avvocato è soddisfatto, dice che è andata bene e che uscirà entro la metà di giugno. Sembra una buona notizia; rispetto ai 10 anni che rischiava, 3 mesi non sono gran cosa. Dovrei essere contento, ma non ci riesco. E poi c’è un altro aspetto della faccenda, con una condanna sulle spalle per Oday sarà molto più difficile uscire dal paese e le sue esibizioni all’estero potrebbero essere finite. Inoltre, se lo prendono mentre cerca di entrare a Gerusalemme senza permesso stavolta ha dei precedenti e gli fanno vedere i sorci verdi. Quando la porta della cella si aprirà, Oday troverà il mondo più piccolo o una prigione più grande.
Epilogo
Oday è uscito il 4 giugno, ad aspettarlo fuori dalla prigione di Ofer ha trovato una folla di amici e parenti. I soldati l’hanno picchiato e ha l’aspetto un po’ malconcio, ma più delle botte a bruciare è la vergogna; per aver lasciato dentro i compagni, per l’esiguità della pena scontata, per aver ceduto a un ricatto infame.
In Palestina non ho sentito spari né esplosioni; in quelle settimane nessun evento eclatante ha occupato le prime pagine dei giornali. Non è successo niente ed è a quel niente che ho guardato, a ciò che sta sotto la linea del discorso, alla vita normale quando tutto è anomalia, e sul fondo della vita normale ho trovato una parola che torna come un brusio: tasrih, permesso in arabo. Serve un permesso delle forze occupanti per stare dove stai e uno per andare altrove, uno per vivere con la tua famiglia e uno per non viverci, uno per scavare un pozzo e uno per coltivare la tua stessa terra e uno per lavorare e uno per raggiungere l’ospedale e uno per cantare con la tua orchestra e uno per andare al mare. E c’è sempre un motivo per il quale il permesso non viene concesso o viene revocato all’ultimo momento oppure per averlo devi fare mille trafile e alla fine rinunci o ne hai abbastanza e ti ribelli e non chiedi il permesso a nessuno e se ti beccano carcere, multe, espropri, ordini di demolizione, ritorsioni, punizioni. E’ questo che succede quando non succede niente, un’occupazione di tipo burocratico le cui armi sono gli application form e un sistema capillare di leggi e regolamenti. Questo è il grado zero della violenza, punto di partenza perché una violenza più grande abbia luogo. E se normale è ciò che accade quando nessuno spara, è una normalità del cazzo.
The post Notes for a Musical Intifada appeared first on Giap.

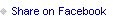






July 4, 2013
Istanbul. Profumo di lacrimogeni, tintinnii di bulldozer
Lo scorso 12 giugno, Wu Ming 2 ha partecipato alla rassegna Viaggi d’autore, organizzata dalla casa editrice Il Mulino e dal Centro San Domenico di Bologna.
La serata si intitolava: Istanbul. Tintinnii d’oro e d’argento. Gli altri invitati erano Maria Pia Pedani, Paolo Rumiz e Deniz Özdoğan.
In origine, il tema dell’intervento di WM2 dovevano essere gli stereotipi e i pregiudizi orientalisti nello sguardo dei viaggiatori italiani in Turchia, a partire dal travelogue di Edmondo De Amicis su Costantinopoli, pubblicato dall’editore Treves nel 1878. L’idea era quella di contestare la cornice stessa della serata, dai “tintinnii” del titolo, al fatto che, per parlare di Istanbul, ci si fosse rivolti a tre italiani, mentre l’attrice turca Deniz Özdoğan si sarebbe espressa soltanto con il canto.
L’irrompere della rivolta di Gezi Park ha ovviamente modificato l’impostazione della serata, e gli organizzatori sono stati subito disponibili a ripensare il programma. Ecco una selezione degli interventi.
Deniz Özdoğan, che ha raggiunto Bologna direttamente da Gezi Park, ha preso la parola per prima con una testimonianza diretta:
Intervento introduttivo di Deniz Özdoğan – 7’17″
poi ha cantato le canzoni Sari Gelin (4’27″):
Deniz Özdoğan – Sari Gelin – 4’27″
e Ayrılık (4’54″):
Deniz Özdoğan – Ayrilik – 4’54″
Wu Ming 2 si è concentrato sui processi di speculazione edilizia e di resistenza che hanno preceduto e trasformato in “scintilla” il “rinnovamento urbano” di Piazza Taksim. Quindi ha suggerito agli oltre quattrocento presenti la visione del documentario “Ekümenopolis. City without limits”, girato nel 2011 dal regista turco Imre Azem. L’intervento dura 19’58″.
Wu Ming 2 – Istanbul. Profumo di lacrimogeni, tintinnii di bulldozer – 19’58″
Deniz ha concluso l’incontro con un pensiero alla lotta NO TAV della Val di Susa, e un’ultima canzone, Pencereden Kar Geliyor.
Deniz Özdoğan – Intervento finale e Pencereden Kar Geliyor – 6’17″
***
Ekümenopolis è una visione illuminante che consigliamo davvero a tutti, specie a quanti hanno criticato il nostro articolo su Internazionale, Occupy Landscape, sostenendo che nella rivolta di Istanbul la questione urbanistica e di “diritto al paesaggio” sarebbe un aspetto marginale, simbolico, pretestuoso.
(se non visualizzate i sottotitoli inglesi, cliccate sulla prima icona tra quelle sotto l’angolo destro dell’inquadratura e selezionateli)
Dalla presentazione del documentario sul sito del progetto (bilingue turco/inglese):
«La trasformazione neoliberista che ha travolto l’economia mondiale nel corso degli anni ’80, ha portato con sé una profonda trasformazione nelle città di tutto il mondo. Per questa nuova struttura economica centrata sulla finanza, il territorio urbano è diventato uno strumento per l’accumulazione di capitale. A Istanbul, gli amministratori della città hanno adottato ciecamente l’approccio neoliberista e ognuno ha combattuto per ottenere una parte di bottino. Il risultato è una megabaraccopoli di 15 milioni di persone, sempre in lotta per una vita decente. Specialmente negli ultimi 10 anni – come prescritto dalla Banca Mondiale nei suoi rapporti – Istanbul è passata da città industriale a città di servizi finanziari, in competizione con altre città del mondo per gli investimenti. Rendere attraente Istanbul per gli investitori richiede non solo l’eliminazione dei controlli legali che tutelano il bene pubblico, ma anche una parallela trasformazione degli utenti della città. Così la classe operaia, che ha costruito la città come centro industriale, non ha più un posto nella nuova metropoli, centrata sui servizi, sulla finanza e sul consumo. Che cosa si prevede per queste persone? Qui entrano in gioco i progetti di “rinnovamento urbano”. Armati di nuovi poteri mai immaginati prima, la TOKI (Ente Statale per l’Edilizia Popolare), insieme con i comuni e gli investitori privati, stanno cercando di ridisegnare il paesaggio urbano. Con il capitale internazionale alle spalle, le mappe catastali nelle mani, metri quadrati e coefficienti di costruzione nella testa, costoro stanno demolendo i quartieri, per costruire grattacieli, autostrade e centri commerciali. Ma a chi servono questi nuovi spazi? L’enorme divario tra ricchi e poveri a Istanbul si riflette sempre di più nel paesaggio urbano, e allo stesso tempo si nutre della segregazione spaziale. Mentre i ricchi si isolano in comunità chiuse, nuovi cicli di povertà continuano a spingere milioni di individui nella disperazione. Chi è responsabile dell’eredità sociale che stiamo lasciando alle generazioni future? Mentre miliardi di dollari vengono sprecati per nuove gallerie stradali, svincoli e viadotti – con un totale disprezzo per il dato scientifico secondo cui tutte le nuove strade finiscono per creare il proprio traffico – Istanbul nel 2010 deve fare i conti con una singola linea di metropolitana da otto stazioni. A causa degli stanziamenti insufficienti per il trasporto pubblico, milioni di persone sono tormentate dal traffico, e miliardi di dollari-tempo escono dal tubo di scarico. E che fanno i nostri amministratori? Avete indovinato: più strade.
Tutto cambia così in fretta in questa città di 15 milioni di abitanti che è impossibile anche soltanto fotografarne la situazione. I piani urbanistici diventano obsoleti in corso d’opera. Un caso cronico di mancata pianificazione. Nel frattempo, la popolazione continua ad aumentare e la città si espande in maniera incontrollata spingendosi verso Tekirdağ a est e Kocaeli a ovest.
Nel 1980 venne stilato il primo piano urbanistico per Istanbul su scala metropolitana. Nella relazione, si osserva che la topografia e la natura geografica della città sono in grado di sopportare una popolazione massima di 5 milioni di abitanti. In quel momento, Istanbul ne aveva 3,5 milioni. Ora siamo 15 milioni, e in 15 anni arriveremo a 23 milioni. Quasi 5 volte la dimensione sostenibile. Oggi portiamo l’acqua a Istanbul da un luogo lontano come Bolu, e succhiamo tutta l’acqua della Tracia, distruggendo l’ambiente naturale. Le aree forestali del nord scompaiono a un ritmo rapido, e il progetto di un terzo ponte sul Bosforo sta minacciando le rimanenti foreste e le falde che dissetano Istanbul. I ponti che collegano i due continenti introducono segregazione attraverso la speculazione edilizia che scatenano. Cosa sta facendo la gente di Istanbul contro questo saccheggio? Se le città sono un riflesso della società, che cosa possiamo dire di noi stessi, guardando Istanbul? Che tipo di città consegniamo al futuro? I limiti ecologici sono stati superati. I limiti economici sono stati superati. I limiti di popolazione sono stati superati. La giustizia sociale è perduta. Ecco il quadro dell’urbanistica neoliberista: Ecumenopolis. Dalle baraccopoli demolite alle cime dei grattacieli, dalle profondità del tunnel Marmaray ai percorsi alternativi al terzo ponte, dagli investitori immobiliari all’opposizione urbana, il film ci porterà in un lungo viaggio dentro questa città senza limiti. Parleremo con esperti, accademici, scrittori, investitori, cittadini e leader di comunità, e getteremo uno sguardo complessivo sulla città attraverso mappe e grafici animati. Forse potrete riscoprire la città in cui vivete e speriamo che non sceglierete di mettervi a guardare questa trasformazione, ma che vi alzerete per discuterla. In fondo questo è ciò che la democrazia richiede da noi.»
***

TESTIMONE A GEZI PARK – DI LUCA TINCALLA – PDF
Luca Tincalla è un narratore freelance e un “attivista per caso”. Nato a Roma nel 1974, da qualche tempo vive a Istanbul. Ha partecipato in prima persona alla sollevazione antigovernativa delle ultime settimane, intensamente, mettendoci il corpo e le parole per raccontarla. Gli abbiamo chiesto un cut-up/reportage, lui ha raccolto storie, ricordi, testimonianze, brandelli di analisi, fotografie, e ci ha spedito “Testimone a Gezi Park”. Ora Luca prende parte ai forum che si tengono nei parchi dei quartieri di Istanbul, dove si è spostata la protesta dopo l’attacco militare al parco Gezi. E’ tra quegli alberi che si parla, ci si scontra, ci si confronta e si propongono soluzioni a breve/medio termine per resistere e ripartire. Buona lettura.
The post Istanbul. Profumo di lacrimogeni, tintinnii di bulldozer appeared first on Giap.

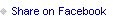






July 1, 2013
Storie #notav. Un anno e mezzo nella vita di Marco Bruno

Marco Bruno ad Avigliana (TO), 25 aprile 2013. Foto di Laura Giorda
Per diventare “narrazione tossica”, una storia deve essere raccontata sempre dallo stesso punto di vista, nello stesso modo e con le stesse parole, omettendo sempre gli stessi dettagli, rimuovendo gli stessi elementi di contesto e complessità.
E’ sempre narrazione tossica la storia che gli oppressori raccontano agli oppressi per giusticare l’oppressione, che gli sfruttatori raccontano agli sfruttati per giustificare lo sfruttamento, che i ricchi raccontano ai poveri per giustificare la ricchezza.
Una narrazione tossica non si limita a giustificare l’esistente, ma è anche diversiva, cioè sposta l’attenzione su un presunto pericolo incarnato dal “nemico pubblico” di turno.
E il nemico pubblico di turno, guardacaso, è sempre un oppresso, uno sfruttato, un discriminato, un povero.
Stringi stringi, la fabula della narrazione tossica è la guerra tra poveri.
Subire una narrazione tossica non significa conoscere una storia.
A lungo la narrazione tossica sui No Tav “NIMBY”, “intolleranti” e “nemici del progresso” ha impedito di conoscere la storia del movimento No Tav della Val di Susa, forse il movimento più internazionalista, armato di pazienza, fondativo e rivolto al futuro che si sia visto in Italia negli ultimi trent’anni. Abbiamo provato a raccontarlo qui.
Fuori dalla Val di Susa, nessuno sa niente di Marco Bruno.
Eppure, nel febbraio dell’anno scorso, tutti hanno creduto di sapere tutto di lui. Era “quello della pecorella”, e tanto bastava.
Quando tutti credono di conoscere una storia di cui non sanno niente, bisogna prenderla, scuoterla, capovolgerla per far scorrere fuori i veleni, infine raccontarla dal principio con pazienza.
Ci vuole tanta pazienza, per raddrizzare un torto.
Volevamo rendere giustizia a Marco.
Per questo abbiamo scritto la sua storia. Con l’io narrante, perché solidarietà è anche “dare dell’io a qualcun altro”.
La trovate su Internazionale, divisa in 6 pagine oppure tutta di seguito. Noterete che sotto ci sono già teste di cazzo che intervengono contro Marco senza nemmeno aver letto. Stay cool. Dicevamo: bisogna avere pazienza.
Qui la versione pdf circolata in valle nei giorni scorsi.
The post Storie #notav. Un anno e mezzo nella vita di Marco Bruno appeared first on Giap.

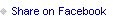






Wu Ming 4's Blog
- Wu Ming 4's profile
- 50 followers




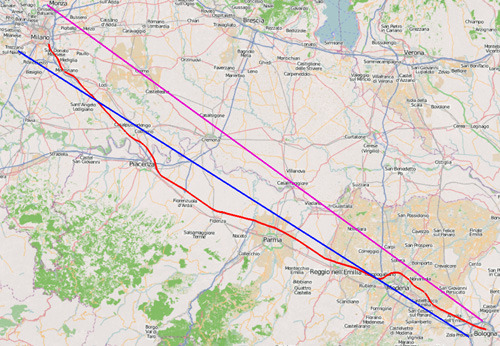

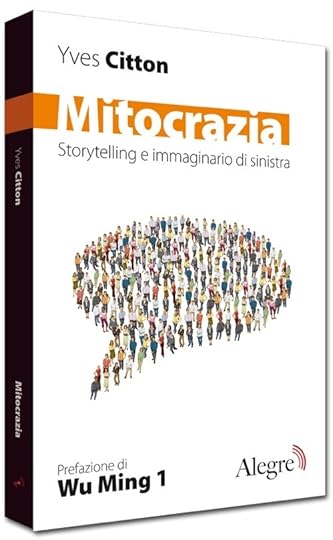

 –
–