Wu Ming 4's Blog, page 110
October 22, 2013
Wu Ming in Deutschland
Dal 24 al 31 ottobre, Wu Ming 2 sarà in Germania per un ciclo di incontri, reading, proiezioni e conferenze. Si parlerà di Timira, di Razza Partigiana e del nostro lavoro di cantastorie. Tra i tanti tour che abbiamo intrapreso fuori dall’Italia, questo è probabilmente il più ricco ed esteso in assoluto, sebbene non esistano traduzioni in tedesco dei libri firmati Wu Ming. Tredici anni fa la casa editrice Piper Verlag acquistò i diritti del nostro romanzo Q. Il libro ebbe un ottimo esito, venne ristampato anche in formato tascabile e continua ogni anno a vendere con continuità. Tuttavia, rimane un caso isolato. Pertanto, siamo grati a Catia di Mondolibro, la libreria italiana di Berlino, perché senza il suo entusiasmo il calendario che pubblichiamo qui sotto non avrebbe nemmeno preso forma. Ringraziamo anche Eva Tabea Meineke e Stephanie Neu dell’Università di Mannheim, Francesca Bravi dell’Università di Kiel e Renata Sperandio dell’Istituto Italiano di Cultura di Amburgo.
24.10 Berlino
Libreria Mondolibro, Torstr. 159
h. 20.30
Bologna meets Berlin
Concerti di Spakkiano (progetto solista di Federico Oppi) e di Egle Sommacal (storico chitarrista dei Massimo Volume). Entrambi fanno anche parte della band che suona in Razza Partigiana, il reading.
Ingresso 5€
25 e 26.10 Berlino
Ackerstadtpalast, Ackerstr. 170
h.20
WM2, Paul Pieretto, Egle Sommacal e Federico Oppi in
Razza Partigiana, il reading
Ingresso 10€
27.10 Berlino
Kino Babylon, Rosa-Luxemburg-str. 30
h.18
WM2 presenta Formato Ridotto
(contiene 51, cortometraggio di WM2 e HomeMovies)
28.10 Berlino,
Libreria Mondolibro, Torstr. 159
h.19
WM2 presenta Timira – Romanzo Meticcio
Ingresso 4€ (gratuito con il biglietto di Razza Partigiana)
29.10 Mannheim
Altefeuerwache, Brückenstrasse 2
h. 19.30
“Timira e la poetica del New Italian Epic”
Con Daniela Kopf (lettura brani tradotti) e Eva Tabea Meineke (traduzione)
Modera: Stephanie Neu
30.10 Amburgo
Istituto Italiano di Cultura, Hansastraße, 6
h.19
WM2 presenta Timira – Romanzo Meticcio
31.10 Kiel
Literaturhaus Schleswig-Holstein, Schwanenweg 13
WM2 presenta Timira – Romanzo Meticcio
in italiano e tedesco
Modera: Francesca Bravi
Ingresso: 6€
E a proposito di paesi dove i nostri libri non sono tradotti, il numero 3/2013 di Vinduet (Finestra), rivista letteraria norvegese fondata nel 1947, dedica ben 23 pagine al collettivo Wu Ming con una lunga intervista sugli Oggetti Narrativi Non-Identificati (Uidentifiserte Fortellende Objekter – cioè…U.F.O) e una traduzione di «Spettri di Müntzer all’alba» (Müntzers spøkelser ved soloppgang).
Chissà che alla prossima non si finisca a Tromsø…
The post Wu Ming in Deutschland appeared first on Giap.








October 21, 2013
Il Movimento #Trieste Libera cosa pensa delle esternazioni pazzoidi di chi usa il suo nome sul web?
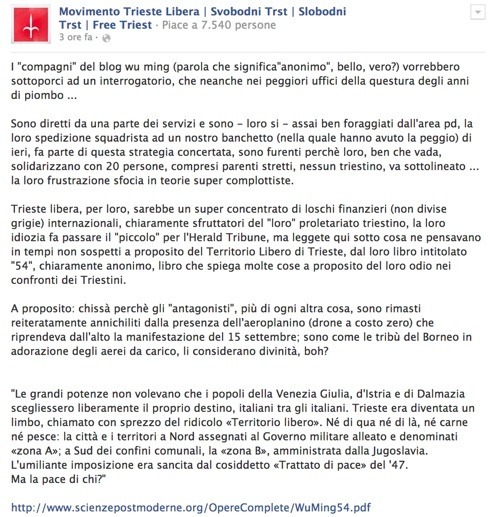
Dalla pagina Facebook ufficiale del Movimento Trieste Libera, ieri. Clicca per ingrandire.
Ormai una settimana fa abbiamo pubblicato un lungo articolo di inchiesta sul neoindipendentismo triestino. Non solo sull’organizzazione che afferma di rappresentarlo in toto, il Movimento Trieste Libera, ma sull’intrico di interessi, il groviglio di temi, il miscuglio di umori che il recente riaffiorare della tematica al tempo stesso rivela (a chi decide di analizzarla con serietà) e copre (a chi si accontenta della facciata).
L’idea di dedicare spazio a quel che sta succedendo a Trieste è stata di Wu Ming 1, che con quella città intrattiene da undici anni uno stretto rapporto. La sua compagna di vita è triestina (di Opicina/Opčine, per la precisione); insieme, e con la loro bimba, trascorrono a Trieste diversi mesi all’anno; WM1 ha studiato a fondo la storia della “Venezia Giulia” nel Novecento e ha dedicato alle vicende triestine tra 1918 e 1947 buona parte del suo ultimo libro, Point Lenana, scritto insieme a Roberto Santachiara.
Perché occuparsi del neoindipendentismo triestino?
Perché da tempo facciamo inchiesta sulle ambiguità e le aporie dei movimenti che si dicono “né di destra, né di sinistra”.
Perché quel che sta accadendo a Trieste riguarda tutti/e.
Perché di fronte a un movimento “né-né” con una base di massa che, come da manuale, nega ogni divisione interna alla società triestina (“siamo tutti triestini“, sfruttati e sfruttatori); che afferma di rappresentare TUTTA la cittadinanza e se uno non è d’accordo vuol dire che non è triestino ma un infiltrato in città al soldo di oscuri poteri; che vuole (o dice di volere) vedere riconosciuto il distacco dall’Italia di Trieste per trasformare quest’ultima in qualcosa che, più ne parlano, più somiglia a un paradiso fiscale per il capitalismo di rapina (una sorta di Singapore sull’Adriatico)…
…di fronte a tutto questo, secondo voi è saggio stare zitti?
No, non è saggio. E’ folle. Eppure i media nazionali non se ne stanno occupando. Silenzio assoluto. Come mai?
E come mai il quotidiano di Trieste, Il Piccolo, che in teoria “antipatizza” per le rivendicazioni di MTL, sembra aver deciso di non farsi troppe domande?
A questo proposito, oltre al link appena proposto, si veda questo tweet del vicedirettore del giornale:
@AlessandroMetz @albolivieri sacrosanto che ognuno scriva ciò che gli pare Noi continuamo con il nostro lavoro, giornalismo non romanzo ;-)
— Alberto Bollis (@abollis) October 17, 2013
Ecco, proprio a causa di questo atteggiamento abbiamo deciso di muoverci noi.
L’articolo era firmato da Tuco, storico giapster triestino – anzi, goriziano che vive a Trieste da vent’anni - che i nostri lettori conoscono bene.
Tuco, come molti commentatori su Giap e in giro per la rete usa un nickname. In realtà, rispetto ad altri, ha qualche motivo in più per usarlo: in passato ha subito un’aggressione fascista, e dopo alcune discussioni on line qualcuno usò il suo nome e cognome cercando di procurargli problemi sul lavoro.
Tuco ha fatto inchiesta per diversi mesi. Lui per primo si è stupito di quanto materiale si trovasse in rete. Di fatto, tutto quel che ha trovato sta in rete. Bastava cercarlo.
L’articolo ha scatenato le ire di chi gestisce – li gestisce come gli pare? O prima di scrivere si consulta con il movimento? - i profili ufficiali di Trieste Libera sui social network. Sempre firmandosi col nome dell’intero movimento, costui (o costoro) partecipa a flame su forum e blog cittadini, ed è anche intervenuto su Giap. In quest’ultima circostanza, come quasi sempre, la sua replica è stata risentita ed evasiva. Tuco l’ha puntualmente smontata.
Nel frattempo, dalla discussione (seguitissima) in calce al post sono emersi sempre più elementi.
Su FB, questa persona che si firma “Movimento Trieste Libera” ha manifestato sempre più nervosismo, si è appigliata all’uso di un nickname da parte di Tuco, ha sostenuto che non poteva essere un triestino… Insomma, tutto il solito repertorio del nemico-che-è-sempre-esterno, unità retorica basilare della mentalità di destra. Il Popolo è Uno, non ha divisioni al suo interno, nella società non c’è conflitto endogeno, il conflitto è opera di mestatori da fuori, lobby senza radici etc.
A un certo punto, a Mister “Movimento Trieste Libera” è partita una scheggia, come diciamo dalle nostri parti. Già aveva mostrato di non avere proprio capito chi e cosa siamo, ma quel che ha scritto su FB (vedi screenshot in testa al post) è andato oltre e ha scatenato ilarità di massa quando l’abbiamo linkato su Twitter.
«I “compagni” del blog wu ming (parola che significa”anonimo”, bello, vero?) vorrebbero sottoporci ad un interrogatorio, che neanche nei peggiori uffici della questura degli anni di piombo …
Sono diretti da una parte dei servizi e sono – loro si – assai ben foraggiati dall’area pd, la loro spedizione squadrista ad un nostro banchetto (nella quale hanno avuto la peggio) di ieri, fa parte di questa strategia concertata, sono furenti perchè loro, ben che vada, solidarizzano con 20 persone, compresi parenti stretti, nessun triestino, va sottolineato … la loro frustrazione sfocia in teorie super complottiste.
Trieste libera, per loro, sarebbe un super concentrato di loschi finanzieri (non divise grigie) internazionali, chiaramente sfruttatori del “loro” proletariato triestino, la loro idiozia fa passare il “piccolo” per l’Herald Tribune [...] »
Quindi noi
1) saremmo pagati dai servizi;
2) saremmo addirittura “ben foraggiati” dal PD (il partito che una volta definimmo “fossa di scolo di ogni vergogna” e a cui ogni tanto dedichiamo affettuosi articoli come questo);
3) avremmo compiuto, nella giornata di sabato, una “spedizione squadrista” contro un banchetto di MTL, si suppone a Trieste (?!);
Dell’aspetto direttamente calunnioso di queste affermazioni il MTL risponderà politicamente e su altri terreni. Qui facciamo altre considerazioni.
WM1 leggeva queste portentose idiozie da Parigi, dove si trovava per lavoro, e mormorava tra sé e sé: “Minchia, il post di Tuco gli ha fatto ma-lis-si-mo…” Altri, su Twitter, commentavano: “Si vede che avete colto nel segno”.
Non contento, l’uomo che si arroga il diritto di esprimersi in rete a nome dell’intero Movimento Trieste Libera ha citato un passaggio del nostro romanzo del 2002, probabilmente trovato facendo su google la ricerca “Wu Ming Territorio Libero di Trieste” e del quale aveva letto solo le primissime pagine. Pagine dove un personaggio da noi ridicolizzato esprimeva un pensiero “italianissimo”:
«Ma leggete qui sotto cosa ne pensavano in tempi non sospetti a proposito del Territorio Libero di Trieste, dal loro libro intitolato “54″, chiaramente anonimo, libro che spiega molte cose a proposito del loro odio nei confronti dei Triestini [...]
“Le grandi potenze non volevano che i popoli della Venezia Giulia, d’Istria e di Dalmazia scegliessero liberamente il proprio destino, italiani tra gli italiani. Trieste era diventata un limbo, chiamato con sprezzo del ridicolo «Territorio libero». Né di qua né di là, né carne né pesce: la città e i territori a Nord assegnati al Governo militare alleato e denominati «zona A»; a Sud dei confini comunali, la «zona B», amministrata dalla Jugoslavia. L’umiliante imposizione era sancita dal cosiddetto «Trattato di pace» del ’47.
Ma la pace di chi?”»
A parte il non saper distinguere tra il pensiero di un personaggio e quello dell’autore;
a parte le cazzate sul romanzo “anonimo” (per trovare i nomi degli autori basta cercare “Wu Ming” e cliccare sul link che porta alla voce di Wikipedia, per dire);
a parte quanto appena detto, per sapere cosa si pensa dentro il collettivo Wu Ming della cosiddetta “italianità” di Trieste e della Venezia Giulia, sarebbe bastato leggere anche superficialmente una qualunque delle tante recensioni a Point Lenana immediatamente reperibili in rete.
Point Lenana, tra l’altro, è stato presentato a Trieste ben tre volte tra l’aprile e l’agosto 2013, sempre in occasioni partecipatissime, e l’ultima volta alla libreria In Der Tat, uno dei luoghi cittadini dove MTL lascia la sua pubblicistica.
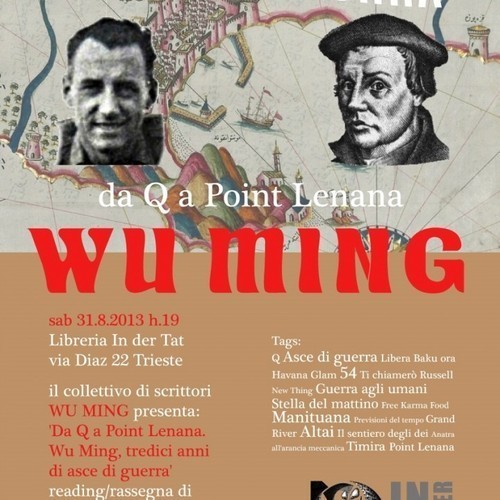
Notare la differenza: mentre noi abbiamo lasciato a chi si firma “Movimento Trieste Libera” pieno diritto di parola qui su Giap, il tipo ha iniziato subito a bannare dalla sua pagina FB quelli che cercavano di spiegargli il giganteschio granchio preso coram populo.
Sono tante le risposte a cui lo sfuggente gruppo dirigente del Movimento Trieste Libera non accetta di rispondere. E allora quelle che vogliamo fare adesso non le facciamo alla nuova, piccola “casta” che vuole rappresentare il neoindipendentismo triestino, ma a tutte le persone che legittimamente e in buona fede ripongono nel riconoscimento del TLT le speranze in una “ripartenza” economica e sociale della città.
Triestine e triestini:
1) La misteriosa “voce ufficiale” che interviene in rete a nome di tutto il movimento rappresenta davvero tutto il movimento? Si consulta con qualcuno prima di scrivere certe cose? Tutti gli iscritti al MTL pensano che noi siamo pagati dai servizi e ci attribuiscono quanto ci attribuisce questa persona?
2) Eravate al corrente di quanto sta emergendo sui vorticosi giri di valzer di un nutrito gruppo di dirigenti di MTL, ex-dirigenti, ex-compagni di strada dei dirigenti, tra affaristi improbabili, società di brokeraggio che partecipano a gare d’appalto sette anni dopo essersi sciolte, piste russe e kazake, Credit Est, non meglio precisati imprenditori che sostengono la causa, neonazisti friulani in combutta con separatisti veneti che hanno la loro sede alla stessa via e numero civico di MTL?
3) C’è in seno al movimento conoscenza dei precedenti politici e affaristici di certi personaggi, ad esempio di alcuni dirigenti dell’ONG con sede a Londra che è diretta espressione di MTL?
4) Siete tutti d’accordo sulla più volte dichiarata “neutralità” del vostro gruppo dirigente rispetto alle idee e pratiche razziste e antisemite di un personaggio a cui MTL si è affidato per la battaglia sul piano legale?
5) Più in generale, pensate davvero che i triestini siano “tutti uguali”, o avete preso in considerazione l’ipotesi che qualche triestinissimo furbone stia manipolando per favorire i propri interessi il vostro desiderio di vedere rinascere Trieste?
Per ultima cosa, pubblichiamo qui, dandogli il posto d’onore, un commento giunto ieri sera e rimasto in moderazione. E’ firmato “Kshatriya“, parola sanscrita che significa “guerriero”. L’uso cialtronesco del sanscrito nella cultura Tradiz/Occult/Nazistoide è una costante almeno dai tempi di Julius Evola, che è un po’ il “nonno” di molti figuri che ritroviamo nel calderone di questi giorni. Buona lettura, e buona fortuna.
***
«gli antagonisti dovrebbero rendersi conto che il loro internazional-classismo è solo un figlio del mondialismo finanziario che ci opprime.
anche noi di destra non capivamo che il nostro nazionalismo era figlio della tirannide massonica che ha diviso il popolo triestino.
i triestini sono stati per quasi un millennio un popolo libero, prima indifeso, e poi, dopo la dedizione agli asburgo, parte dell’impero sovranazionale europeo che è stato anche l’ultimo sacro romano impero, erede dell’impero romano d’occidente.
per l’impero sovranazionale, e il proprio popolo che ne faceva parte, hanno combattuto e sono caduti i tanti triestini che saranno commemorati il 3 novembre
http://www.triestelibera.org/2013/10/3-novembre-2013-commemorazione-dei-caduti-e-combattenti-triestini-della-guerra-1914-1918/
allora come ora, essere contro l’europa dei banchieri non significa essere contro l’europa, ma per un’altra europa, composta da comunità di popolo e unita dall’idea sovranazionale che è stata a fondamento dell’impero.
‘tu ridi delle patrie, ridi delle nazioni!
sei tu la sola patria e non hai confini
uomini d’altre terre han te come bandiera
a renderci nemici non sarà certo una frontiera!
impero!’
le comunità di popolo e l’impero sovranazionale non sono nè di destra nè di sinistra perchè destra e sinistra sono state fatte nascere dai nazionalismi massonici per dividere i popoli al loro interno, tradendo anche l’originaria idea della massoneria che era sovranazionale.
triestini che erano di destra, come me, se ne sono resi conto, come altri triestini che erano di sinistra.
i promotori di destra di trieste pro patria e gli antagonisti di sinistra triestini dovrebbero capire che, attaccando trieste libera, combattono il popolo triestino facendo il gioco del nazionalismo degli stati artificiali e del mondialismo finanziario, l’uno funzionale all’altro, i cui interessi sono rappresentati in italia e a trieste dal sistema unico pdl + pd-l.»
APPENDICE
A proposito del fatto che ci pagherebbe il PD (partito-guida del governo contro il quale tifiamo asteroide), su Internazionale c’è un nostro nuovo articolo contro le basse intese e la “politica delle emozioni”.
The post Il Movimento #Trieste Libera cosa pensa delle esternazioni pazzoidi di chi usa il suo nome sul web? appeared first on Giap.








October 17, 2013
Il dejà-vu del cosiddetto «DDL sul negazionismo»

Paul Ginsborg, uno dei promotori dell’appello che ripubblichiamo.
[Con riferimento non casuale all'ennesima legge sciacqua-coscienza - inutile per gli scopi dichiarati e obliquamente dannosa per la lotta a fascismi e razzismi - in discussione in queste ore, ripubblichiamo una lettera aperta scritta e firmata nel 2007 dai più importanti storici italiani (e non solo). Sono passati solo sei anni, ma in Italia non si ricorda nulla, si sedimenta solo il peggio, ci si muove solo per riflessi condizionati, si prendono solo scorciatoie, si sa solo proibire per legge. Una tristezza infinita.]
-
Contro il negazionismo, per la libertà della ricerca storica
Il Ministro della Giustizia Mastella, secondo quanto anticipato dai media, proporrà un disegno di legge che dovrebbe prevedere la condanna, e anche la reclusione, per chi neghi l’esistenza storica della Shoah. Il governo Prodi dovrebbe presentare questo progetto di legge il giorno della memoria.
Come storici e come cittadini siamo sinceramente preoccupati che si cerchi di affrontare e risolvere un problema culturale e sociale certamente rilevante (il negazionismo e il suo possibile diffondersi soprattutto tra i giovani) attraverso la pratica giudiziaria e la minaccia di reclusione e condanna. Proprio negli ultimi tempi, il negazionismo è stato troppo spesso al centro dell’attenzione dei media, moltiplicandone inevitabilmente e in modo controproducente l’eco.
Sostituire a una necessaria battaglia culturale, a una pratica educativa, e alla tensione morale necessarie per fare diventare coscienza comune e consapevolezza etica introiettata la verità storica della Shoah, una soluzione basata sulla minaccia della legge, ci sembra particolarmente pericoloso per diversi ordini di motivi:
1) si offre ai negazionisti, com’è già avvenuto, la possibilità di ergersi a difensori della libertà d’espressione, le cui posizioni ci si rifiuterebbe di contestare e smontare sanzionandole penalmente.
2) si stabilisce una verità di Stato in fatto di passato storico, che rischia di delegittimare quella stessa verità storica, invece di ottenere il risultato opposto sperato. Ogni verità imposta dall’autorità statale (l’“antifascismo” nella DDR, il socialismo nei regimi comunisti, il negazionismo del genocidio armeno in Turchia, l’inesistenza di piazza Tiananmen in Cina) non può che minare la fiducia nel libero confronto di posizioni e nella libera ricerca storiografica e intellettuale.
3) si accentua l’idea, assai discussa anche tra gli storici, della “unicità della Shoah”, non in quanto evento singolare, ma in quanto incommensurabile e non confrontabile con ogni altro evento storico, ponendolo di fatto al di fuori della storia o al vertice di una presunta classifica dei mali assoluti del mondo contemporaneo.
L’Italia, che ha ancora tanti silenzi e tante omissioni sul proprio passato coloniale, dovrebbe impegnarsi a favorire con ogni mezzo che la storia recente e i suoi crimini tornino a far parte della coscienza collettiva, attraverso le più diverse iniziative e campagne educative.
La strada della verità storica di Stato non ci sembra utile per contrastare fenomeni, molto spesso collegati a dichiarazioni negazioniste (e certamente pericolosi e gravi), di incitazione alla violenza, all’odio razziale, all’apologia di reati ripugnanti e offensivi per l’umanità; per i quali esistono già, nel nostro ordinamento, articoli di legge sufficienti a perseguire i comportamenti criminali che si dovessero manifestare su questo terreno.
È la società civile, attraverso una costante battaglia culturale, etica e politica, che può creare gli unici anticorpi capaci di estirpare o almeno ridimensionare ed emarginare le posizioni negazioniste. Che lo Stato aiuti la società civile, senza sostituirsi ad essa con una legge che rischia di essere inutile o, peggio, controproducente.
22 gennaio 2007
Marcello Flores, Università di Siena
Simon Levis Sullam, University of California, Berkeley
Enzo Traverso, Università de Picardie Jules Verne
David Bidussa, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
Bruno Bongiovanni, Università di Torino
Simona Colarizi, Università di Roma La Sapienza
Gustavo Corni, Università di Trento
Alberto De Bernardi, Università di Bologna
Tommaso Detti, Università di Siena
Anna Rossi Doria, Università di Roma Tor Vergata
Maria Ferretti, Università della Tuscia
Paul Ginsborg, Università di Firenze
Carlo Ginzburg, Scuola Normale Superiore, Pisa
Giovanni Gozzini, Università di Siena
Andrea Graziosi, Università di Napoli Federico II
Mario Isnenghi, Università di Venezia
Fabio Levi, Università di Torino
Giovanni Levi, Università di Venezia
Sergio Luzzatto, Università di Torino
Paolo Macry, Università di Napoli Federico II
Giovanni Miccoli, Università di Trieste
Claudio Pavone, storico
Paolo Pezzino, Università di Pisa
Alessandro Portelli, Università di Roma La Sapienza
Gabriele Ranzato, Università di Pisa
Raffaele Romanelli, Università di Roma La Sapienza
Mariuccia Salvati, Università di Bologna
Stuart Woolf, Istituto Universitario Europeo, Firenze
Aderiscono:
Cristina Accornero, Università di Torino
Giulia Albanese, Università di Padova
Franco Andreucci, Università di Pisa
Rosaria Marina Arena, Università di Siena
Barbara Armani, Università di Pisa
Elena Baldassari, Università di Roma La Sapienza
Luca Baldissara, Università di Pisa
Roberto Balzani, Università di Bologna
Giovanni Belardelli, Università di Perugia
Emmanuel Betta, Università di Roma La Sapienza
Fabio Bettanin, Università di Napoli L’Orientale
Roberto Bianchi, Università di Firenze
Anna Bravo, Università di Torino
Antonio Brusa, Università di Bari
Marco Buttino, Università di Torino
Davide Cadeddu, Università di Milano
Gia Caglioti, Università di Napoli Federico II
Marina Calloni, Università di Milano Bicocca
Leonardo Capezzone, Università di Roma La Sapienza
Vittorio Cappelli, Università della Calabria
Sonia Castro, Università di Pavia
Tulla Catalan, Università di Trieste
Alberto Cavaglion, Istituto Piemontese per la storia della Resistenza
Luigi Cajani, Università di Roma La Sapienza
Carolina Castellano, Università di Napoli Federico II
Franco Cazzola, Università di Firenze
Roberto Chiarini, Università di Milano
Giovanna Cigliano, Università di Napoli Federico II
Fulvio Conti, Università di Firenze
Giovanni Contini, Università di Roma La Sapienza
Daniele Conversi, University of Lincoln
Pietro Costa, Università di Firenze
Augusto D’Angelo, Università di Roma La Sapienza
Leandra D’Antone, Università di Roma La Sapienza
Fabio Dei, Università di Pisa
Nunzio Dell’Erba, Università di Torino
Giorgio Delle Donne, Bolzano
Mario Del Pero, Università di Bologna
Lucia Denitto, Università di Lecce
Giovanni De Luna, Università di Torino
Paola Di Cori, Università di Urbino
Patrizia Dogliani, Università di Bologna
Benito Donato, Cosenza
Angelo D’Orsi, Università di Torino
Paolo Favilli, Università di Genova
Giovanni Federico, Università di Pisa
Cristiana Fiamingo, Università di Milano
Enzo Fimiani, Biblioteca provinciale Pescara
Guido Formigoni, Università di Milano IULM
Vittorio Frajese, Università di Roma Tor Vergata
Giulia Fresca, Cosenza
Carlo Fumian, Università di Padova
Valeria Galimi, Università di Siena
Luigi Ganapini, Università di Bologna
Giuliana Gemelli, Università di Bologna
Aldo Giannuli, Università di Bari
Filippo Maria Giordano, Pavia
Gabriella Gribaudi, Università di Napoli Federico II
Yuri Guaiana, Università di Milano Bicocca
Giancarlo Jocteau, Università di Torino
Paola Magnarelli, Università di Macerata
Massimo Mastrogregori, Università di Roma La Sapienza
Marco Mayer, Università di Firenze
Roberta Mazza, University of California, Berkeley
Claudio Mellana, Torino
Marco Mondini, Università di Padova
Giovanni Montroni, Università di Napoli Federico II
Massimo Morigi
Stefania Nanni, Università di Roma La Sapienza
Gloria Nemec, Università di Trieste
Ivar Oddone, Torino
Chiara Ottaviano, Cliomedia Officina
Gianni Perona, INSMLI, Milano
Stefano Petrungaro, Università di Venezia
Vincenzo Pinto, Università di Torino
Maria Serena Piretti, Università di Bologna
Stefano Pivato, Università di Urbino
Leonardo Rapone, Università della Tuscia
Maurizio Ridolfi, Università della Tuscia
Gabriele Rigano, Università per Stranieri di Perugia
Domenico Rizzo, Università di Napoli L’Orientale
Giorgio Rochat, Università di Torino
Giovanni Romeo, Università di Napoli Federico II
Andrea Rossi, Università di Ferrara
Lucia Rostagno, Università di Roma La Sapienza
Silvia Salvatici, Università di Teramo
Enrica Salvatori, Università di Pisa
Ayse Saracgil, Università di Firenz
Laura Savelli, Università di Pisa
Giovanni Scirocco, Università di Bergamo
Guri Schwarz, Università di Pisa
Francesco Scomazzon, Università di Milano
Alfio Signorelli, Università di Roma La Sapienza
Francesca Socrate, Università di Roma La Sapienza
Simonetta Soldani, Università di Firenze
Carlotta Sorba, Università di Padova
Carlo Spagnolo, Università di Bari
Lorenzo Strik Lievers, Università di Milano Bicocca
Arnaldo Testi, Università di Pisa
Rita Tolomeo, Università di Roma La Sapienza
Anna Treves, Università di Milano
Alessandro Triulzi, Università di Napoli L’Orientale
Simona Troilo, Istituto Universitario Europeo
Gabriele Turi, Università di Firenze
Gian Maria Varanini, Università di Verona
Angelo Ventrone, Università di Macerata
Angelo Ventura, Università di Padova
Claudio Venza, Università di Trieste
Alessandra Veronese, Università di Pisa
Elisabetta Vezzosi, Università di Trieste
Vittorio Vidotto, Università di Roma La Sapienza
Loris Zanatta, Università di Bologna
—
LINK CONSIGLIATO
The post Il dejà-vu del cosiddetto «DDL sul negazionismo» appeared first on Giap.








October 15, 2013
TraumStadt. Paradisi fiscali, oleodotti e ritorno del rimosso: viaggio nel neoindipendentismo triestino

di Tuco (guest blogger)
-What kind of music do you usually have here?
-Oh, we’ve got both kinds, we’ve got country and western.
(The Blues Brothers)
Il 15 settembre scorso Trieste è stata attraversata da due cortei, uno al mattino, l’altro al pomeriggio.
Di mattina hanno sfilato gli italianissimi, quelli che Trieste è cara al cuore di tutti gli italiani, quelli che il Piave mormorava, quelli che torneremo in Istria, quelli che allora le foibe… Non erano molti, al massimo trecento. All’arrivo del corteo, in Piazza S.Antonio, un rappresentante dell’Associazione Arditi d’Italia ha letto i nomi dei morti del ’53 con voce strozzata. Un furgone preso a nolo – i drappi tricolori non riuscivano a coprire del tutto la scritta «35$ AL GIORNO»- ha gracchiato dagli altoparlanti canzoni patriottiche. Poi l’adunata si è sciolta. Il tutto è durato un’ora scarsa.
Il corteo del mattino era stato organizzato in fretta e furia da una lista di associazioni nazionalpatriottiche (se non apertamente fasciste) come risposta al corteo del pomeriggio, quello del Movimento Trieste Libera, organizzato da più di un mese per rivendicare la piena attuazione del Territorio Libero di Trieste.
Il corteo del pomeriggio è imponente, eterogeneo, gente di tutte le età e di tutte le classi sociali, cinquemila persone come minimo. Bandiere rosse dappertutto – solo che non sono le nostre: al centro c’è l’alabarda bianca, simbolo di Trieste. Il concentramento è davanti alla stazione, vicino all’entrata del Porto Vecchio. E infatti un gruppo di portuali arriva e srotola uno striscione. C’è scritto: «Porto Libero di Trieste – Prosta Luka Trst», in italiano e sloveno. Nel centro della piazza, tra le bandiere rosso-alabardate, spunta un bandierone con il leone di S. Marco. Più piccole, vicino alla statua di Sissi, compaiono alcune bandiere con l’aquila bicipite, la galina con do teste, come si dice a Trieste. Arriva un furgone con una specie di sound-system. Roba da quattro soldi, soprattutto se si pensa all’aereo che gli organizzatori hanno noleggiato per filmare il corteo dall’alto. Gli altoparlanti sparano una musica piuttosto incongrua. Difficile definirla: epico-fantasy, forse. Il tipo di musica che su YouTube accompagna i video amatoriali su rettiliani e illuminati.
 Il corteo comincia a muoversi, sotto la direzione di uno strano doppio servizio d’ordine. Ci sono quelli con la maglietta bianca, che indicano ai vari spezzoni come posizionarsi, e ci sono quelli con la maglietta nera, muscolosi, muniti di walkie-talkie, che si piazzano in testa e in coda e non parlano con nessuno. Tra quelli in maglietta nera c’è anche Sandro Gotti detto “Tonfa”, ex pezzo grosso del Muay Thai italiano, che in gioventù aveva frequentato marginalmente l’ambiente dell’Autonomia. In testa al corteo c’è uno striscione che recita: «We, the people«. Venti metri davanti allo striscione c’è Roberto Giurastante, leader del movimento, circondato dalle sue guardie del corpo.
Il corteo comincia a muoversi, sotto la direzione di uno strano doppio servizio d’ordine. Ci sono quelli con la maglietta bianca, che indicano ai vari spezzoni come posizionarsi, e ci sono quelli con la maglietta nera, muscolosi, muniti di walkie-talkie, che si piazzano in testa e in coda e non parlano con nessuno. Tra quelli in maglietta nera c’è anche Sandro Gotti detto “Tonfa”, ex pezzo grosso del Muay Thai italiano, che in gioventù aveva frequentato marginalmente l’ambiente dell’Autonomia. In testa al corteo c’è uno striscione che recita: «We, the people«. Venti metri davanti allo striscione c’è Roberto Giurastante, leader del movimento, circondato dalle sue guardie del corpo.
La sfilata attraversa tutto il Borgo Teresiano, per almeno due ore, e si conclude in Piazza Borsa. Nessun comizio, solo slogan ripetuti ossessivamente: “Trieste Libera / dall’Italia!”, “Porto Libero / dall’Italia!”, fino alla tarda serata, quando tre cannonate segnalano che la manifestazione è finita.
Ma non sono fuochi d’artificio.
I razzi traccianti e le cannonate di domenica sera non erano uno spettacolo pirotecnico, si è trattato di un segnale convenzionale militare il cui significato è: siamo sotto assedio.
⁂
Che giornata è stata il 15 settembre? Cosa è successo? Com’è possibile che nella città più fascista d’Italia i numeri dei due cortei abbiano decretato in modo impietoso la fine del mito fascista per eccellenza, quello di Trieste italianissima? Significa forse che è finito una volta per tutte il tempo dei fascisti?
⁂

I confini del Territorio Libero di Trieste (1947 – 1954).
Per capire il senso di quel che sta accadendo a Trieste, è necessaria una breve premessa di carattere storico. Il 9 settembre del ’43 i tedeschi occupano il nord Italia, e nel nord-est istituiscono la Zona di Operazioni Litorale Adriatico (Operationszone Adriatisches Küstenland), soggetta di fatto alla sovranità del Terzo Reich.
Il 1 maggio 1945 i partigiani di Tito, dopo una battaglia durata quattro giorni, sfondano l’ultima linea di difesa tedesca, entrano a Trieste, e la tengono per quaranta giorni, prima di ritirarsi e di consegnare la città agli Alleati angloamericani.
Comincia così un periodo di incertezza riguardo al futuro assetto dei confini in una delle zone più delicate per gli equilibri del dopo Yalta. Il Trattato di Pace del 1947 sancisce la fine della sovranità italiana su Trieste e su gran parte della “Venezia Giulia”, e istituisce il Territorio Libero di Trieste, sorta di stato cuscinetto tra Italia e Jugoslavia.
Il TLT è diviso in due parti:
- la zona A (che comprende la città di Trieste e le immediate vicinanze) amministrata dagli anglo-americani;
- la zona B (che comprende l’Istria nord-occidentale) amministrata dagli Jugoslavi.
Il Trattato di pace stabilisce anche che il Consiglio di Sicurezza dell’Onu dovrà nominare un Governatore del TLT, dando così inizio al processo costituente del nuovo stato. Il governatore però non sarà mai nominato, anche perchè con lo strappo di Tito del 1948 e con l’uscita della Jugoslavia dall’orbita sovietica la situazione internazionale muta radicalmente, e si determinano gradualmente le condizioni per una spartizione del TLT tra Italia e Jugoslavia.
Nel 1954, in seguito al Memorandum di Londra sottoscritto da Italia, Regno Unito, Usa e Jugoslavia, l’amministrazione della zona A passa dagli angloamericani all’Italia.
Nel 1975, con il Trattato di Osimo, Italia e Jugoslavia formalizzano la spartizione del TLT secondo i confini del ’54.
⁂
Diciamo subito che a Trieste l’indipendentismo non è una novità, e che a Trieste si sono sviluppati storicamente numerosi filoni indipendentisti, molto diversi tra loro per ispirazione culturale e ideologica: quello irredentista di Domenico Rossetti nell’Ottocento e quello austromarxista di Angelo Vivante (di cui si parla anche in Point Lenana di Wu Ming 1 e Santachiara) negli anni dieci del Novecento; poi quello austronazista al crepuscolo dell’Adriatisches Kustenland nel ’44/’45 (di cui parla Claudia Cernigoi su Carmilla), e quelli di stampo antifascista e filojugoslavo nel biennio ’45/’47 (di cui parla Andrea Olivieri su Carsica); durante gli anni del TLT (’47/’54) a Trieste erano presenti alcuni movimenti indipendentisti contrari alla spartizione del territorio tra Italia e Jugoslavia, e in quegli stessi anni fu indipendentista per un certo periodo anche il PC-TLT di Vittorio Vidali.
L’indipendentismo del Movimento Trieste Libera invece ha le sue radici più visibili nella protesta popolare esplosa in seguito alla firma del Trattato di Osimo nel ’75. In quel passaggio storico, la protesta ebbe un forte carattere nazionalista, anticomunista e antijugoslavo, e derivò soprattutto dalla percezione del Trattato come tradimento definitivo, da parte dell’Italia, delle aspirazioni e delle rivendicazioni degli esuli istriani sulla zona B del TLT.
In quegli anni di crisi economica e politica, le spinte autonomiste riuscirono a coinvolgere una fetta consistente della città, saldandosi con brandelli di precedenti autonomismi e indipendentismi. Nacque la Lista per Trieste, partito autonomista che per vent’anni avrebbe monopolizzato la vita politica cittadina, e che nel ’94 sarebbe diventata di fatto la frazione triestina di Forza Italia.
La frangia più radicale della protesta invece si coagulò in una sfilza di piccoli movimenti indipendentisti, che si connotarono fin da subito in senso marcatamente antiitaliano e filoaustriaco. Ci torneremo più avanti.
L’oggetto totemico di questo nuovo filone indipendentista è una lettera inviata da Giovanni Marchesich al Consiglio di Sicurezza dell’ONU, nel lontano 1983, in cui si chiedeva al Consiglio di procedere alla nomina del Governatore del TLT. Secondo Marchesich, infatti, trattati multilaterali come il Memorandum di Londra del ’54 o bilaterali come il Trattato di Osimo del ’75 non potevano abrogare parti del Trattato di Pace del ’47; in particolare, non possono abrogare quelle parti che istituivano il TLT.
La risposta del Consiglio di Sicurezza, nel 1983, fu questa: la nomina del Governatore era stata tolta dall’ordine del giorno, su richiesta congiunta di Italia e Jugoslavia, in seguito alla firma del Trattato di Osimo. Per riportare la questione all’ordine del giorno, era necessario che uno dei paesi aderenti all’ONU lo chiedesse formalmente.

Jörg Haider (1950 – 2008)
Da allora a Trieste la percezione di una “questione pendente” (la nomina del Governatore) è sempre sopravvissuta sotto traccia, a livello di subcultura, riaffiorando ogni tanto nel discorso pubblico di qualche frangia dissidente della Lega Nord locale.
Tuttavia, questo “indipendentismo della carta bollata” difficilmente poteva scaldare i cuori e gli animi. Inoltre in città la destra tradizionale, italianissima e fascistissima, era ancora largamente egemone.
Un primo segnale di cosa stesse covando sotto la cenere si ebbe all’epoca in cui Jörg Haider terrorizzava un’Europa che nasceva già in crisi d’identità. Una parte dell’opinione pubblica triestina guardava a Klagenfurt con occhi da innamorata, e quando Haider si schiantò con la sua Volkswagen dopo una notte di bagordi, si sentì irrimediabilmente orfana. Ma perché nascesse un movimento di massa, era necessario che intervessero altri fattori.
Questi fattori cominciarono a manifestarsi nuovamente a partire dal 2008, l’anno della crisi.
⁂
Per capire cos’è accaduto a partire da quell’anno, bisogna fare un piccolo passo indietro.
Nel 2007 la Regione Friuli Venezia Giulia approva una variante del piano regolatore del Comune di Trieste, che prevede il cambio di destinazione d’uso per un’ampia zona del Porto Vecchio, da decenni in stato di abbandono. Diverse cordate di imprenditori, locali e non, presentano i loro progetti per il recupero e la gestione dell’area. Tra queste, una è guidata dall’imprenditore svizzero-triestino Marcus Donato, titolare della Helmproject, società di brokeraggio marittimo. Il suo progetto prevede la trasformazione integrale dell’area in zona turistica, con alberghi, piscine, cinema, eccetera eccetera, con investimenti per 850 milioni di euro.

“Fossile” del sito Helmproject. Notare l’italiano a dir poco stentato. Clicca per ingrandire.
Nel 2008 a sorpresa il progetto di Donato viene escluso dalla competizione, si dice a causa di carenze nella documentazione (e va detto che Marcus Donato e la sua Helmproject appaiono avvolti da una nube di vaghezza, almeno a una ricerca superficiale su Google, cfr. screenshot qui sopra). Partono i ricorsi. Ma intanto Donato ha una visione. Studiando le carte per il suo progetto e per i ricorsi, “riscopre” la lettera di Marchesich del 1983 e “si accorge” che il porto di Trieste non è soggetto alla sovranità italiana. Non solo, è l’intera provincia ad essere sotto amministrazione fiduciaria. Comincia a frequentare i forum locali su internet, tastando il terreno e studiando le reazioni dei commentatori. Di lì a poco, dà vita al Comitato Porto Libero di Trieste.
Intanto la crisi economica e finanziaria comincia a mordere, e il sistema politico italiano entra in una crisi di rappresentanza via via sempre più profonda. Il comitato si proclama rappresentante dei cittadini del TLT (zona B compresa) presso le Nazioni Unite, denuncia le speculazioni edilizie in Porto Vecchio (sic!), e dà vita a una serie di assemblee ed eventi, che culminano con la prima “Festa del Territorio Libero di Trieste” nel settembre del 2011, e vedono una partecipazione popolare non ancora di massa, ma sicuramente non trascurabile.
Una cosa nuova, che balza subito agli occhi, sono le scritte bilingui, in italiano e in sloveno: un segno che le tensioni etniche sono superate? Forse, ma anche no. Ci torneremo più avanti.
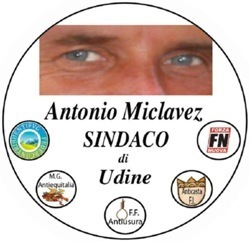 Come emanazione del comitato, nasce l’Associazione Cittadini del TLT, con presidente l’ex leghista Stefano Ferluga. L’ultima conferenza organizzata dall’associazione si intitola “Signoraggio e una nuova moneta a Trieste”, relatore Antonio Miclavez, un seguace delle teorie di Giacinto Auriti (cfr. queste FAQ sul signoraggio), poi candidato sindaco a Udine per Forza Nuova nel 2013.
Come emanazione del comitato, nasce l’Associazione Cittadini del TLT, con presidente l’ex leghista Stefano Ferluga. L’ultima conferenza organizzata dall’associazione si intitola “Signoraggio e una nuova moneta a Trieste”, relatore Antonio Miclavez, un seguace delle teorie di Giacinto Auriti (cfr. queste FAQ sul signoraggio), poi candidato sindaco a Udine per Forza Nuova nel 2013.
Nel novembre del 2011 l’associazione si scioglie, e nasce il Movimento Trieste Libera. Il presidente è ancora Stefano Ferluga, e i soci dell’associazione vengono travasati nel movimento.
⁂
A questo punto entrano in scena due personaggi che saranno determinanti per le future fortune del movimento. Si tratta di Roberto Giurastante e Paolo G. Parovel. Entrambi provengono dall’associazione ambientalista Amici della Terra. Hanno alle spalle diverse battaglie contro discariche abusive e appalti poco chiari, e soprattutto contro il rigassificatore che la multinazionale spagnola Gasnatural vuole costruire nella zona industriale-portuale tra Trieste e Muggia.
Va detto che su Trieste convergono numerosi interessi, spesso contrapposti, nel campo dell’approvvigionamento energetico. Oltre al rigassificatore, sono in ballo il terminale del South Stream, il gasdotto della russa Gazprom (al progetto partecipa anche ENI) concorrente del Nabucco, e l’oleodotto che dovrebbe portare in Adriatico il petrolio proveniente dal Kazakhstan (anche in questo caso è coinvolta l’ENI).
Il fatto che Giacomo Franzot, vicepresidente del Comitato Porto Libero di Trieste, sia ingegnere presso la Agip KCO, proprio in Kazakhstan, produce comprensibilmente strane risonanze in chi cerca di districarsi in questo guazzabuglio.
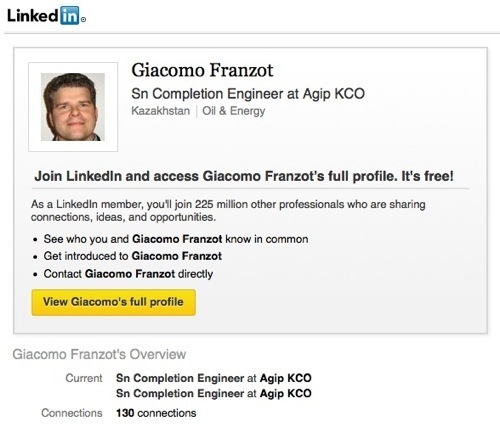
Torniamo a Parovel e Giurastante.
Parovel è un giornalista d’inchiesta, che in passato ha rivelato coi suoi articoli alcuni intrecci politico-affaristici legati ala gestione della Tržaška kreditna banka. Di lui si dice che negli anni sessanta fosse iscritto alla Giovane Italia, organizzazione giovanile del MSI, e che negli anni settanta abbia cambiato radicalmente le sue posizioni, trasferendosi a Lubiana e cominciando a denunciare le manipolazioni della storiografia italiana nel trattare la questione di Trieste. Nel dopo Osimo, è stato tra i promotori di Civiltà Mitteleuropea, associazione che si proponeva appunto di recuperare le radici culturali mitteleuropee della zona di Trieste. Giurastante fa parte del direttivo di MTL ed è di fatto il leader del movimento. Parovel invece non è iscritto al movimento, ma dalle pagine del suo giornale La Voce di Trieste è quello che al movimento fornisce i contenuti culturali e ideologici.
⁂
L’azione politica di MTL si svolge prevalentemente in tribunale, oltre che in piazza. A partire dalla primavera del 2012 Giurastante e altri esponenti del movimento cominciano a impugnare in tribunale le cartelle di Equitalia, sollevando il difetto di giurisdizione dello stato italiano sul TLT. Un’azione di questo tipo ha un forte impatto simbolico ed emotivo, in un periodo in cui migliaia di artigiani e piccoli commercianti si vedono pignorare merci e immobili, mentre lo Stato rinvia di mese in mese il rimborso dell’IVA. La cosa più interessante però è la scelta dell’avvocato fatta da Giurastante. Si tratta del pordenonese Edoardo Longo, uno che di sé scrive:
«Difensore senza attenuazioni opportunistiche nei processi politici contro i dissidenti antimondialisti di destra, ha riversato la sua esperienza in materia in alcuni libri e in moltissimi articoli contro le aberrazioni del sistema giudiziario al servizio delle lobbies plutocratiche internazionali. […] Dalla metà degli anni ‘8O svolge una intensa attività di ricerca culturale e pubblicistica, dapprima in ambito culturale tradizionale ( con nette influenze del pensiero di Julius Evola e Domenico Rudatis di cui era amico personale), poi in ambito più marcatamente politico.»
È facile rendersi conto che Longo è molto più di un avvocato. In rete la sua attività pubblicistica è documentatissima (cfr. quanto segnalato da Claudia Cernigoi), e ci porta direttamente in quell’intermondo dove si incontrano estremisti di destra (prevalentemente terzaposizionisti) e indipendentisti veneti.
Non è quindi un caso che al corteo del 15 settembre, in mezzo alle bandiere rossoalabardate, campeggiasse un bandierone col leone di S. Marco. Si trattava della delegazione del “Governo Veneto in esilio”, frangia indipendentista che in Veneto ha intrapreso le stesse azioni giudiziarie di MTL, facendosi anch’essa rappresentare da Edoardo Longo.
⁂
Oltre alle contestazioni delle cartelle di Equitalia, MTL ha intrapreso, o perlomeno sostiene di aver intrapreso, una serie di azioni presso non meglio precisate corti internazionali, allo scopo di ottenere il riconoscimento della sovranità del TLT e la nomina del Governatore da parte del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Ma se provate a chiedere ai dirigenti come intende muoversi il movimento riguardo alla zona B, quella attualmente sotto sovranità (o amministrazione, a seconda dei punti di vita) croata e slovena: vi troverete nel porto delle nebbie.
Per seguire le cause internazionali è stata creata una Organizzazione non Governativa, la Triest NGO, con sede (virtuale) a Londra.
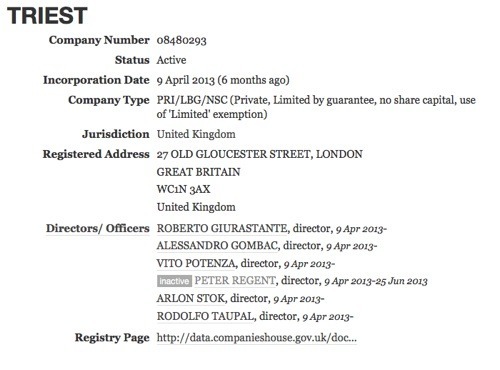
La Triest NGO su Linkedin definisce se stessa «The Human Rights, Civil and Economic Development Initiative for the Free Territory of Trieste». Sul sito web della NGO, si può leggere: «The members of Triest NGO (…) believe in social justice, equity and respect for human rights, as all people should enjoy the rights they hold under international law and convention». Dichiarazioni d’intenti dal tono alato, che però stridono con quel che scriveva su facebook Sandro Gombač, vicepresidente di MTL e membro del direttivo della Triest NGO, nel marzo del 2011, a proposito dei boat-people tunisini.
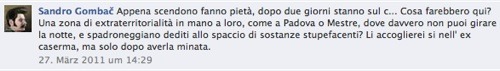
In effetti MTL e la Triest NGO, più che i diritti umani, sembrano avere a cuore soprattutto questioni legate all’economia e alla finanza. L’applicazione completa del Trattato di Pace del ’47 infatti permetterebbe di estendere all’intera area del TLT il regime di zona franca in vigore nel Porto Vecchio, e di creare a Trieste un vero e proprio paradiso fiscale. E infatti l’off-shore finanziario, più che la portualità vera e propria, sembra essere la carta su cui punta MTL per lo sviluppo economico del TLT.
Oltre ovviamente all’incasso delle royalties per il passaggio degli oleodotti e dei metanodotti.
⁂
Il movimento, soprattutto attraverso gli scritti dell’intellettuale di riferimento Paolo G. Parovel, si dichiara multiculturale. I volantini, gli striscioni del corteo, i siti su internet, (quasi) tutto è rigorosamente bilingue, italiano e sloveno. Del resto è il Trattato di Pace del ’47 a stabilire che lingue ufficiali del TLT sono l’italiano e lo sloveno. Una parte non trascurabile dei simpatizzanti del movimento proviene dalla comunità slovena di Trieste, e in ogni caso la zona B del TLT ora è popolata in larga maggioranza da sloveni e croati.
In una città in cui la destra tradizionale nazionalista, dai fascisti ai liberali fino al PSI di Craxi, è stata egemone per 70 anni di vita repubblicana, la comparsa di un movimento che sventola bandiere bilingui può apparire, a prima vista, un fatto rivoluzionario. A un’analisi più attenta tuttavia non possono sfuggire alcuni dettagli incongrui.
In uno spot su Youtube, MTL parla dei triestini come di un unico popolo in cui non ci sono minoranze ma in cui si parlano due lingue.
Affermazione piuttosto strana: a Trieste solo gli sloveni sono bilingui, gli italiani sono in generale rigorosamente monolingui, e non hanno nemmeno la possibilità di studiare lo sloveno nelle scuole italiane.
Affermazione strana e pericolosa: in un ambiente a stragrande maggioranza italofono, la negazione dello status di minoranza produrrebbe necessariamente l’assimilazione della comunità slovena.
Affermazione strana, pericolosa e mistificante: quella italiana e quella slovena non sono solo due lingue, ma sono anche due culture, e due identità nazionali. Una cosa è praticare lo scambio interculturale, e magari auspicare un meticciato dal basso che produca nei tempi lunghi sintesi nuove e imprevedibili. Altro invece è proclamare dall’alto l’inesistenza delle differenze culturali e politiche e dei legami comunitari, sia nella maggioranza, sia soprattutto nella minoranza, e ridurre la questione identitaria interna alla società triestina a pura questione linguistica, inventandosi un «popolo triestino in cui non ci sono minoranze ma si parlano due lingue».
La sensazione è che da parte dei vertici di MTL ci sia un uso strumentale del bilinguismo, come bandiera da contrapporre al nazionalismo italiano e come foglia di fico per coprire lo sciovinismo e il micronazionalismo localista che permeano il movimento. Perché non va dimenticato che nel Trattato di Pace del ’47 c’è scritto anche che sono cittadini del TLT con pieni diritti civili e politici solo i cittadini italiani residenti nel territorio il 10 giugno 1940 e i loro discendenti. Di quale multiculturalismo si sta parlando, quindi? Di una versione semplificata del multiculturalismo di 100 anni fa. Non certo del multiculturalismo di oggi, quello creato dalle migrazioni e dalla globalizzazione dell’economia e dell’informazione.
⁂
Broker che promettono investimenti per 850 milioni di euro, ingegneri dell’ENI in Kazakhstan, piccoli artigiani tartassati da Equitalia, portuali senza porto, ambientalisti col feticismo della carta bollata, avvocati evoliani, giornalisti d’inchiesta col pallino della mitteleuropa, esperti di arti marziali, sloveni che desiderano un riconoscimento ufficiale dell’uso della loro lingua, esuli della zona B che sperano di recuperare i beni confiscati dalla Jugoslavia… Cosa li tiene insieme?
L’insofferenza per lo status quo, certo. Molti di loro magari avevano votato Grillo in primavera. Ma non basta. Non basta per creare un movimento di massa in grado di contendere la piazza alla destra nazionalpatriottica e di conquistarla a mani basse. MTL non è M5S. Dal vertice alla base del movimento c’è un rifiuto viscerale non solo dello status quo, ma di tutta la costruzione mitologica dell’identità nazionale italiana intorno al simbolo Trieste a partire dal 1914.
Attenzione, però.
Abbiamo visto che nel discorso di MTL, a Trieste non esistono minoranze – esiste un popolo, quello triestino, che parla due lingue – e abbiamo visto quanto sia mistificante questo discorso.
Abbiamo visto che per MTL l’antifascismo è una discriminante solo quando il fascismo è quello nazionalista italiano. Non lo è più quando il fascismo è quello tradizionalista di stampo evoliano.
Abbiamo visto che si tratta di un movimento in cui portuali e broker marittimi si trovano a sfilare idealmente insieme nello stesso corteo.
È evidente che un movimento identitario e interclassista di questo tipo, che si regge sulla rimozione del conflitto interno alla società triestina, per riuscire a contendere l’egemonia alla destra nazionalpatriottica italiana ha bisogno di un Mito. E deve essere un Mito abbastanza potente da potersi confrontare con l’altro Mito, quello di Trieste italianissima eccetera eccetera.
«Il 30 settembre, una settimana dopo l’equinozio d’autunno, è dal 1382 l’anniversario dell’atto di dedizione spontanea con cui la piccola città indipendente di Trieste si affidò a Casa d’Austria, rappresentata allora dal duca Leopoldo III d’Absburgo, per restare libera invece di diventare una colonia di Venezia come le altre cittadine costiere dell’Adriatico nordorientale.
Iniziava così [...] il legame volontario fra Trieste e l’Austria che durò 536 anni, sino al novembre 1918, garantendo per oltre mezzo millennio alla città la sua indipendenza, con la dignità di Paese membro dell’Impero, attraverso il legame personale diretto con il sovrano. […] Si deve quindi constatare, questo 30 settembre del 2013, la riapertura di un ciclo simbolico e pratico nel quale la popolazione vecchia e nuova di Trieste si trova nuovamente a dover difendere, nel mondo e nei modi di oggi, la propria sopravvivenza concreta e la propria dignità dai rappresentanti attuali dei medesimi interessi geoeconomici e politici aggressivi che minacciavano di travolgerla con la forza e l’inganno già nel 1382, quando ricorse per difendersi all’Austria. Oggi la difesa più diretta non consiste in un plebiscito di dedizione all’Austria, ma nell’esigere dal Governo italiano e dalla Comunità internazionale la piena e corretta attivazione, secondo il diritto vigente, dell’ordinamento di Stato della città di Trieste quale Territorio Libero […] Ma la stessa azione difensiva potrebbe anche tradursi, su richiesta della popolazione triestina alle Nazioni Unite, nel passaggio dell’amministrazione fiduciaria di Trieste al governo austriaco, che rimane il candidato storico più naturale e qualificato a gestirla se quello italiano continuasse scandalosamente a non voler adempiere ai propri doveri internazionali di amministratore provvisorio, e non di padrone coloniale.»
È Parovel che parla, dalle colonne della Voce di Trieste, alcuni giorni dopo la manifestazione del 15 settembre. Ed è il fantasma di Furio Jesi che risponde:
«-Che cosa vuol dire cultura di destra?
-La cultura entro la quale il passato è una sorta di pappa omogeneizzata che si può modellare e mantenere in forma nel modo più utile [...]»
Perchè è vero che Trieste deve le sue fortune del secolo d’oro al fatto di essere stata porto dell’Impero, e che la fine dell’Impero ha segnato l’inizio del declino della città. È vero che nel 1915 l’Italia è entrata in guerra con l’Austria da aggressore e in modo canagliesco. Ed è vero che l’Italia nel 1918 si è comportata nella “Venezia Giulia” nello stesso modo in cui si è comportata in Libia nel 1911 e in Africa Orientale nel 1935. Ma che Trieste debba le sue fortune all’atto di dedizione del 1382 e al “legame personale e diretto col sovrano” è Mito (tecnicizzato, ça va sans dire). Il fantasma di Karl Marx lo spiega in modo molto chiaro:
«Come accadde, quindi, che Trieste, e non Venezia, divenne culla della rinascita della navigazione mercantile nell’Adriatico? Venezia era una città di reminiscenze nostalgiche; Trieste condivideva lo stesso privilegio degli Stati Uniti di non avere alcun passato. Modellata da una masnada variopinta di mercanti-avventurieri italiani, tedeschi, inglesi, francesi, greci, armeni ed ebrei, non era incatenata dalle tradizioni come la Città delle Lagune.» (“The Maritime Commerce of Austria”, New-York Daily Tribune, 9 gennaio 1857).
Non è stato lo sguardo benevole dell’Imperatore a fare di Trieste il porto più importante del Mediterraneo. È stato il capitalismo. E dove c’è capitalismo c’è conflitto (di classe). E infatti nel 1902 i fuochisti del Lloyd scioperano. E come da manuale la polizia spara e lascia a terra 14 morti e 50 feriti. Eccetera eccetera.

Da sinistra: i caporioni delle SS Odilo Globočnik e Friedrich Rainer. Rispettivamente, un nazista sloveno nato a Trieste e l’ultimo austriaco ad avere governato la città.
E poi. Visto che si tratta di Mito, allora per magia dalla storia di Trieste secondo MTL scompare il nazionalismo italiano prefascista di Ruggero Timeus, e scompare il fascismo endogeno: quello dei fratelli Cosulich, che si servono degli sgherri di Giunta per reprimere gli scioperi nei cantieri navali; e quello di Giuseppe Cobolli Gigli, grande costruttore di strade in Etiopia con largo uso di manodopera indigena. Scompare il collaborazionismo del biennio ’43/’45, e scompare l’imbarazzante dettaglio che l’ultimo austriaco che ha governato a Trieste è stato il gauleiter Friedrich Rainer, coadiuvato da un triestino di origine slovena, un certo Odilo Globočnik, reduce dell’Aktion Reinhard e ideatore e direttore del campo di sterminio della Risiera di San Sabba – cinquemila morti, ebrei, zingari e partigiani sloveni, croati e italiani.
Non solo. Se il Mito è l’Austria, deve scomparire anche l’austrofascismo di Engelbert Dolfuss, e ovviamente deve scomparire l’entusiasmo con cui gran parte degli austriaci accolgono l’Anschluss, l’annessione al Terzo Reich.
A meno che…
A meno che non ci si lasci sfuggire l’indicibile: «Nel ’43 i tedeschi ci hanno liberati».
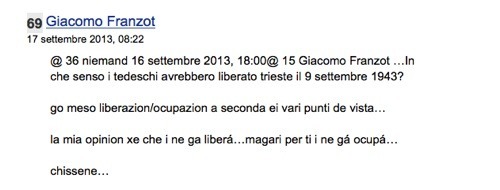
Commento lasciato da Franzot nel forum triestino bora.la
Infine deve scomparire la Resistenza, perchè è un dato di fatto che i partigiani di Tito, il primo maggio del 1945, entrarono a Trieste combattendo contro i tedeschi.
Insomma, per farla breve: ci troviamo di fronte a una narrazione alternativa della storia di Trieste, contrapposta a quella della retorica ufficiale italiana, ma ugualmente tossica.
-
N.d.R. I commenti a questa inchiesta di Tuco – che ringraziamo – saranno attivati 72 ore dopo la pubblicazione, per consentire una lettura ragionata e – nel caso – interventi meditati (ma soprattutto, pertinenti).
-
The post TraumStadt. Paradisi fiscali, oleodotti e ritorno del rimosso: viaggio nel neoindipendentismo triestino appeared first on Giap.








October 12, 2013
#NemicoPubblico, seconda edizione! Featuring @zerocalcare
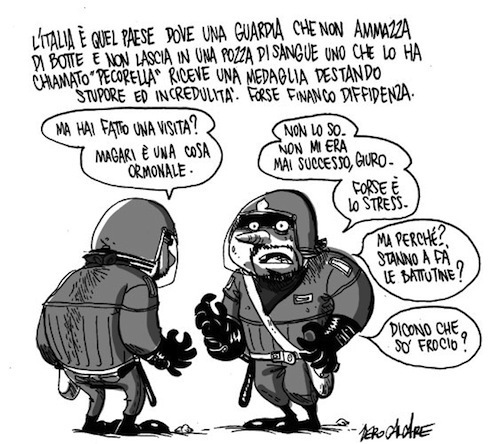
La vignetta di Zerocalcare che apre la nuova edizione di Nemico Pubblico.
Tempo di seconde edizioni: in istampa la seconda edizione di Point Lenana, già in circolazione la seconda edizione di Nemico Pubblico. Pecorelle, lupi e sciacalli.
Nemico Pubblico è il libro No Tav che ci vede tra gli autori e racconta la storia di uno dei più nauseabondi linciaggi mediatici degli ultimi anni. Per questo, ha già fatto incazzare un sacco di gente.
Nella versione arricchita e aggiornata la copertina è un po’ diversa:
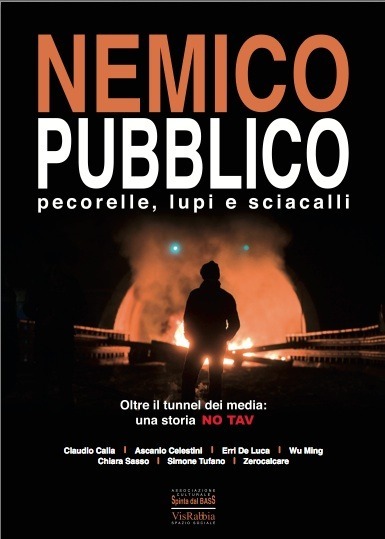
Poi ci ha messo lo zampino il compagno Zerocalcare con la vignetta che vedete quissopra (*), poi ci trovate un compendio di cos’è successo a Marco Bruno negli ultimi tempi (perché non si finisce mai davvero di sbattere il “mostro” in prima pagina, o almeno di provarci), infine c’è una favola scritta da due giovanissime No Tav, Matilde e Micol, 13 e 11 anni. Perché noi – lo sanno tutti – siamo di quelli che plagiano i bambini, e dovete ammettere che è un passo avanti: una volta li mangiavamo.
Oggi, domenica 13 ottobre 2013, h. 15, il comitato Spinta dal Bass, Marco Bruno e Wu Ming 1 presenteranno Nemico Pubblico al centro polivalente di Villar Dora (TO), via Pelissere 16.
Il 25 ottobre Spinta dal Bass presenterà il libro al centro sociale Pacì Paciana di Bergamo. Il centro sociale è in via Grumello 61 (in alcuni navigatori il nome è “Via per Grumello”).
Il 26 ottobre Marco Bruno presenterà il libro a Roma, allo spazio autogestito Casetta Rossa, via Magnaghi 14 (Garbatella).
Come sempre, per ordinarlo basta scrivere a postmaster@spintadalbass.org. Costa 10 euro e vanno tutti nel fondo per le spese legali dei No Tav colpiti dalla repressione.
–* Interessante confrontarla con quella che disegnò Makkox il 29 febbraio 2012.
The post #NemicoPubblico, seconda edizione! Featuring @zerocalcare appeared first on Giap.








October 5, 2013
Vo Nguyen Giap, nome dei dannati della terra
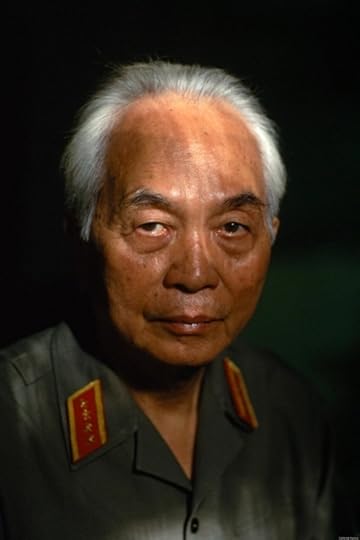
Vo Nguyen Giap (Cent’anni nel 2011 – RIP 2013)
“Sia chiaro: per noi “Giap” non è tanto la Grande Personalità, il Nome Famoso, l’Eroe, il “battilocchio” la cui contemplazione distoglierebbe lo sguardo dai processi collettivi e di lungo corso. Al contrario, per noi “Giap” è molteplicità, “Giap” sta per le miriadi di persone che, ciascuna a suo modo, hanno contribuito alla decolonizzazione, alla lotta planetaria contro razzismo e colonialismo, alla presa di coscienza degli spossessati di vaste aree del mondo. Per noi “Giap” è il secolo, la parte del XX secolo che vale la pena continuare a interrogare, con spirito critico ma senza revisionismi cialtroneschi. Né replicare né rinnegare, assumersi la responsabilità del phylum che ci porta all’oggi, senza affannarsi a strappare pagine dall’album di famiglia per paura che le vedano gli sbirri della memoria. Vengano pure a perquisirci: noi non abbiamo vergogne.” (Cent’anni di Vo Nguyen Giap, 2011)
***
[Dal capitolo 32 di: Vitaliano Ravagli - Wu Ming, Asce di guerra, 2000:]
Nell’ottobre del 1952 due divisioni del Vietminh occupano un villaggio Tai nella regione di Lai Chau, sul confine tra Laos, Cina e Tonchino settentrionale.
Il villaggio sorge in una valle lunga venti chilometri e larga undici, tagliata in due dal fiume Nam Yum, ed è appena stato evacuato da un battaglione laotiano collaborazionista. Nella lingua dei Tai si chiama Muong Thanh, ma i vietnamiti lo conoscono come Dien Bien Phu.
Da qualche mese il generale Giap sta pensando di passare il confine ed entrare in Laos, dove le guarnigioni francesi sono quasi tutte isolate e vulnerabili, a parte quelle di stanza a Vientiane e Luang Prabang. Giap non vuole impossessarsi del Laos, bensì provocare e intrappolare i francesi lungo il confine, dove le loro linee di rifornimento sono precarie.
Nell’aprile 1953 Giap penetra in Laos. E’ un’offensiva in grande stile: le divisioni Vietminh passano vicino alle fortificazioni francesi nella Piana delle Giare, cosparsa di monumenti funerari preistorici, e puntano su Luang Prabang, dove i cittadini sono stati allertati da un chiaroveggente cieco. Ma a un certo punto, per non farsi sorprendere dai monsoni, l’esercito di Giap ripiega e torna in Vietnam. Ha dimostrato di poter entrare nel Laos quando vuole, e può sempre riprendere l’affondo con la stagione secca.
I francesi si convincono che Dien Bien Phu è il punto strategico in cui bloccare l’offensiva Vietminh contro il Laos.
A maggio, il generale Salan viene sostituito dal generale Henri Navarre, ufficiale di carriera, reduce delle due guerre mondiali, che si dichiara ottimista sulle sorti del conflitto e proclama: «Vediamo chiaramente la vittoria come la luce in fondo a un tunnel.»
Navarre pensa di avere una missione: impedire a ogni costo l’invasione del Laos.
Il sottoposto di Navarre è René Cogny, lauree in legge e scienze politiche. Un altro consigliere è il colonnello Louis Berteil. Questo trittico di cervelli partorisce un piano ambizioso: prendere Dien Bien Phu e stabilirvi il punto d’appoggio per sfondare le retrovie di Giap.
A luglio, Navarre va a Parigi e sottopone il piano al primo ministro Joseph Laniel.
Il 28 ottobre, il Laos firma un trattato di alleanza e associazione con la Francia, che ne riconosce l’indipendenza e s’impegna a rispettarne la sovranità “in seno all’Unione Francese”.
La firma del trattato rafforza l’idea che il Laos vada difeso a ogni costo.
Nel frattempo, Navarre è tornato in Indocina, e dà inizio alla cosiddetta “Operazione Castoro”: cinque battaglioni francesi conquisteranno Dien Bien Phu.
Il colonnello Jean-Louis Nicot, capo dei trasporti aerei in Indocina, ammonisce che il cattivo tempo potrebbe ostacolare le operazioni. Nel frattempo, anche Cogny ha maturato dei dubbi e dice che Dien Bien Phu potrebbe diventare “un tritacarne”.
Navarre ormai è partito per la tangente, non sente ragioni, è convinto che il Vietminh non sarà in grado di fronteggiare un attacco su vasta scala.
In realtà, grazie a una serie di diversivi, Giap ha creato l’impressione che il grosso delle sue divisioni sia impegnato altrove: attentati ai convogli francesi sulle tratte che collegano il porto di Haiphong all’interno del paese, e ripetute incursioni nel Laos meridionale (“il manico della padella”). Giap sta preparando uno “scacco matto”: con la strategia degli attacchi sparsi blocca il Corpo di Spedizione francese in diverse regioni, e fa sì che non si possa fortificare un singolo punto senza sguarnirne un altro. Nel frattempo, i distaccamenti Vietminh si organizzano intorno a Dien Bien Phu.
Sa che i francesi si troveranno in posizione svantaggiosa, isolati, dipendenti dai rifornimenti aerei, mentre i suoi uomini si apposteranno sulle montagne che sovrastano la vallata, e potranno ricevere armi e rifornimenti dalle retrovie.

Il 20 novembre 1953, sei battaglioni del Corpo di Spedizione si paracadutano nella valle di Muong Thanh, e vi si insediano.
Al comando delle operazioni c’è un ufficiale di cavalleria, Christian Marie Ferdinand de la Croix de Castries, donnaiolo aristocratico, di discendenza militare fin dalle Crociate.
Nel frattempo tra i leader delle grandi potenze matura la convinzione che il conflitto in Indocina possa essere ricomposto, come è appena successo in Corea.
Stalin è morto da poco, e la nuova dirigenza sovietica vorrebbe attenuare le tensioni internazionali.
L’opinione pubblica francese è stanca della sale guerre, la sporca guerra, e preme su Laniel perché cerchi “una soluzione onorevole”.
I comunisti cinesi, al potere da soli quattro anni, sono ansiosi di svolgere un importante ruolo internazionale, per proporsi in chiave “moderata” e ottenere il riconoscimento dei paesi europei. Zhou Enlai, primo ministro, è dell’opinione che, cacciati i francesi, arriveranno a premere sul confine meridionale i ben più temibili americani, che non riconoscono la Cina popolare. Zhou è per concedere ai francesi un ruolo nelle loro ex-colonie del sud-est asiatico, anche scavalcando il Vietminh.
Tutt’altra tendenza manifestano gli usa: John Foster Dulles, segretario di stato di Eisenhower, insiste sulla linea del “contenimento” del comunismo, pensa che in Corea la partita sia ancora aperta nonostante la “tregua”, preme sui francesi perché rimandino ogni iniziativa diplomatica e migliorino le loro posizioni in Indocina. Concede loro un prestito di 500 milioni di dollari. I francesi accettano i soldi ma rimangono scettici sulla prosecuzione a oltranza del conflitto.
Nemmeno Ho Chi Minh è convinto che sia già il momento di trattare: preferisce piegare l’opinione pubblica francese e imporre lui le condizioni. Ma deve tenere conto delle esigenze cinesi: dopotutto, il Vietminh si avvale di consiglieri militari inviati da Pechino, e molti guerriglieri vietnamiti si sono addestrati in campi cinesi. Soprattutto, Zhou Enlai ha fornito al Vietminh cinquantamila tonnellate di materiali militari e vettovaglie. Infine, se la Francia ha paura è anche grazie ai duecentomila soldati cinesi schierati a ridosso del confine col Vietnam.
Il 29 novembre 1953 Ho Chi Minh comunica al mondo la sua disponibilità a porre fine alla guerra “con mezzi pacifici”.
Ma intanto s’avvicina lo scontro finale.
I francesi hanno già perso prima di combattere. La disfatta matura nel loro Quartier Generale di Saigon: Navarre non ha capito niente della strategia e del potenziale bellico di Giap, e non prende in considerazione alcuna ipotesi che non si adatti ai suoi preconcetti.
Secondo Navarre, Giap non può contare su ingenti forze, quindi si rifiuta di spostare i grandi distaccamenti francesi dal Vietnam centrale a Dien Bien Phu.
Ma Giap ha trascorso più di tre mesi a schierare gli uomini. A partire da novembre, da quando i parà francesi si sono sistemati nella valle, Giap sposta verso Dien Bien Phu trentatre battaglioni di fanteria, sei reggimenti di artiglieria e un reggimento del Genio. Alcuni di questi spostamenti durano 7-8 settimane, i soldati attraversano a piedi montagne e giungle, marciano di notte e dormono di giorno per evitare i bombardamenti.
All’inizio del ’54, a Dien Bien Phu ci sono cinquantamila combattenti vietnamiti, più altri ventimila lungo le linee di rifornimento. Invece i francesi sono tredicimila, metà dei quali sono nord-africani o indocinesi lealisti, poco e male addestrati al combattimento. Il resto sono quasi tutti legionari.
Navarre non crede che Giap possa disporre di un’artiglieria, figurarsi di una contraerea. Ma l’artiglieria è stata trascinata a mano o portata in bicicletta, un’impresa titanica. Il Vietminh dispone di ventiquattro obici da 105 mm., tutti di fabbricazione statunitense, trofei di guerra della Corea.
Navarre crede di poter usare i carri armati, che invece verranno bloccati dalla fitta boscaglia e, durante le piogge monsoniche, affonderanno in profondi acquitrini.
Insomma, l’esercito francese si trova soverchiato in un rapporto di cinque a uno, intrappolato in un buco di culo fangoso, cannoneggiato dalle colline circostanti (impossibilitato a contrattaccare perché le postazioni Vietminh sono perfettamente mimetizzate) e soprattutto isolato, senza possibilità di ricevere vettovaglie né di evacuare i feriti, perché gli obici di Giap devasteranno la pista d’atterraggio, bloccando tutti i voli in entrata e in uscita.
Come aveva predetto Cogny, Dien Bien Phu sarà “un tritacarne”.
Poco prima dell’alba del 13 marzo, l’assedio si trasforma in attacco. Gli obici aprono il fuoco, sorprendendo e paralizzando i francesi.
Castries ha fatto costruire quattro basi d’artiglieria, battezzate coi nomi di sue ex-amanti: Gabrielle, Anne-Marie e Béatrice sul lato nord della valle, Isabelle sul lato sud.
Giap scaglia la sua “onda umana” contro Gabrielle, Anne-Marie e Béatrice. Isabelle è troppo lontana per aprire un fuoco di copertura, inoltre è difesa da un terzo dell’intera forza francese, che non osa spostarsi nel timore di un altro attacco. Béatrice cade immediatamente, Gabrielle e Anne-Marie il giorno successivo. La pista d’atterraggio è completamente distrutta dagli obici.

Charles Piroth
Il vicecomandante francese, colonnello Charles Piroth, esperto di cannoni con un braccio solo, aveva dichiarato: «Nessun cannone Vietminh riuscirà a fare fuoco tre volte prima di essere distrutto dalla mia artiglieria.» All’alba del 15 marzo, Piroth stacca con i denti la linguetta di una bomba a mano e si fa saltare in aria. La sera prima lo hanno sentito dire: «Sono completamente disonorato.»
Quella dell’onda umana è una tattica tipica della guerra di Corea, e infatti l’hanno suggerita due consiglieri cinesi, Wei Guoqing e Li Chenghu. E’ una tattica costosissima in termini di vite umane, lo stesso Mao è contrario a ricorrervi. La forza di un esercito popolare dipende dalla coscienza politica di ogni singolo combattente, ciascun uomo è importante, non lo si può usare come carne da cannone.
Nei primi tre giorni di assalto, il Vietminh conta 2000 morti e 7000 feriti.
Giap decide di interrompere l’offensiva, lasciar perdere i suggerimenti dei cinesi e passare a una “strategia di attrito”. Nelle settimane seguenti, fa scavare gallerie e trincee fino a circondare la guarnigione francese con centinaia di chilometri di passaggi sotterranei.
Quest’impresa non sarebbe possibile senza l’impegno di 33.500 dân công (patrioti operai). Con più di 2700 biciclette modificate (chiamate xe thô), quasi altrettante giunche e più di 17.000 cavalli, i dân công portano al fronte ventimila tonnellate di riso, oltre a munizioni e beni di prima necessità. E’ grazie a questa mobilitazione che Giap può fare attrito . Tra il gennaio e il maggio del ’54, i dân công contribuiranno alla causa anti-francese con cinque milioni di giornate di lavoro.

Si avvicinano le piogge monsoniche, e i francesi sperano che il Vietminh affogherà nel fango. Succede il contrario: le nuvole basse impediscono all’aviazione francese di bombardare le retrovie di Giap e ostacolano i lanci di rifornimenti ai francesi assediati. A parte il problema di visibilità, c’è anche la contraerea Vietminh, che costringe gli aerei a volare troppo alti, così i lanci sono sempre più imprecisi. Molte vettovaglie, munizioni e, in almeno un caso, informazioni segrete destinate ai francesi assediati, atterrano in pieno territorio Vietminh.
Nel frattempo, molti indocinesi, e persino qualche regolare francese, disertano il Corpo di Spedizione. I legionari li chiamano, spregiativamente, “i sorci del Nam Yum”, perché spesso, al momento di fuggire, guadano il fiume portando con sé i viveri appena paracadutati.
E’ il momento dell’extrema ratio: il governo francese chiede aiuto agli americani. L’ammiraglio Arthur Radford propone che sessanta bombardieri B-29, scortati da cacciabombardieri della Settima Flotta USA, decollino dalle Filippine e facciano incursioni notturne contro il perimetro Vietminh intorno alla valle. Il progetto ha un nome: “Operazione avvoltoio”.
Il generale Paul Ély, capo di stato maggiore francese, comunica la notizia al suo governo, comprensibilmente contento. Ma il capo di stato maggiore americano, Matthew Ridgway, è contrario a un coinvolgimento diretto sul fronte asiatico: ancora scottato dalla Corea, teme l’intervento dei cinesi e l’ipotesi di dover spostare in Vietnam dalle sette alle dodici divisioni, distogliendole da altri settori strategici.
Il presidente Eisenhower è d’accordo con lui e rinvia la decisione al Congresso e agli Alleati. Senza il loro appoggio non intende muovere un dito.
Benché il vicepresidente Nixon e il segretario di stato Dulles facciano pressioni sui parlamentari, il Congresso non dà l’autorizzazione.
Nel frattempo, un gruppo di studio del Pentagono conclude che tre armi atomiche tattiche, “opportunamente impiegate”, sarebbero sufficienti ad annientare il Vietminh. Radford è entusiasta di quest’idea e spinge perché la si proponga ai francesi. Secondo alcune fonti, lo stesso Dulles è favorevole all’ipotesi atomica, ma i vertici del Dipartimento di stato non solo sono contrari, ma terrorizzati anche solo dall’eventualità che circoli una voce del genere. Un anonimo funzionario ammonisce: «Se la vicenda trapelasse, scatenerebbe un gigantesco grido di disapprovazione in tutti i parlamenti del mondo libero.»
La guarnigione francese a Dien Bien Phu è ormai condannata, e con essa il dominio coloniale francese in Indocina. Tutti lo sanno, ciò che conta è limitare i danni. E’ l’ora dei negoziati.
Si fissa per l’8 maggio l’avvio della conferenza di Ginevra sul problema dell’Indocina, a cui parteciperanno delegazioni di Francia, Stati Uniti, URSS, Cina, oltreché, naturalmente, del Vietminh.
Con sorprendente tempismo, Giap espugna Dien Bien Phu il 7 maggio. L’assedio è durato cinquantacinque giorni. Dalla parte dei francesi, si contano 1.142 morti, 4.436 feriti e 1.606 dispersi. Le perdite del Vietminh ammontano a 7.900 morti e più di 15.000 feriti.
A Ginevra, si comincia a discutere.
LINK
The post Vo Nguyen Giap, nome dei dannati della terra appeared first on Giap.








September 30, 2013
Speciale #PointLenana: Alto Adige, Trento e Trieste, Internazionale, video, recensioni
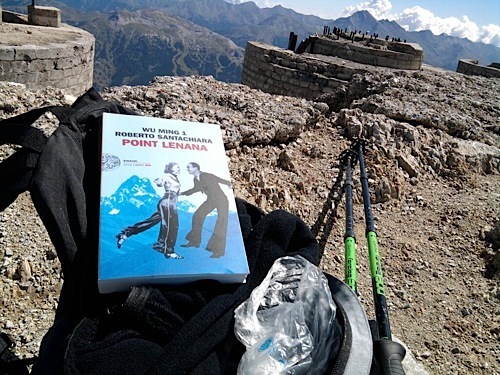
Point Lenana sul Monte Chaberton, Alpi Cozie, 3131 mt. Grazie a Luigi per avercelo portato. Clicca per ingrandire.
Nuovo speciale su Point Lenana e tutto quel che lo circonda e accompagna.
Nella scorsa puntata abbiamo definito il tour (de force) “un’opera transmediale” che vive di vita propria e prosegue il libro con altri mezzi. Dov’è passato, il tour ha stimolato riflessioni, ed è così che Flavio Pintarelli, poco prima, durante e dopo la tappa bolzanina e il pellegrinaggio laico in Vallunga sulle orme di Emilio Comici, ha scritto il testo che vi proponiamo, una dérive nell’eredità architettonica fascista in Alto Adige, con interrogativi sull’uso pubblico della memoria che non riguardano solo quella zona ma tutto il Paese.
L’appena menzionata Vallunga compare in una delle fotografie che illustrano questo post e, come sempre, documentano la prassi di portare in montagna una copia di Point Lenana e fotografarla tra le rocce, per poi mettersi in posa come Fred Astaire e Ginger Rogers nella copertina.
Copertina senz’altro eterodossa, che a molti è piaciuta ma ha anche attirato critiche, come sentirete nell’audio della presentazione trentina del 6 settembre, una delle più dense e intense da quando WM1 si è messo in viaggio.
“Trento e Trieste”. La toponomastica irredentista ha giustapposto le due città in modo talmente insistente che ancora oggi qualcuno le crede vicine. Per la cronaca, distano l’una dall’altra 185 km in linea d’aria e 326 in automobile. Percorriamoli e spostiamoci nell’unico capoluogo di provincia italiano sito al di là dell’Adriatico. In questo speciale la storia triestina è molto presente:
- è al centro della discussione avvenuta in via Diaz, di fronte alla libreria “In Der Tat”, il 31 agosto scorso, della quale proponiamo un lungo stralcio audio (o meglio, ve lo propone Lo.Fi. sul tumblelog dedicato a Point Lenana);
- è la sostanza stessa del “videomessaggio” (ehm…) girato da WM1 al giardino Pubblico “Muzio de Tommasini” e pubblicato sul sito di Internazionale;
- infine, permea il report critico di Claudia Cernigoi appena apparso su Carmilla, riguardante l’ultima “novità” del panorama politico triestino: un movimento neoindipendentista di massa. Mettiamo “novità” tra virgolette perché, a Trieste più che altrove, nulla sembra mai accadere per la prima volta, persino quando non è mai accaduto prima. Segnaliamo l’articolo di Cernigoi, che sarà seguito da altri contributi, per mostrare come la storia narrata in Point Lenana continui a plasmare l’oggi a ogni livello, nutrendo un movimento che si dice “né-né” e ha appena uno o due gradi di separazione rispetto a soggetti che più bruni (nel senso del colore della camicia) di così non potrebbero essere. Il passato non è alle nostre spalle, ma sulle nostre spalle.
Chiudiamo lo speciale con un video quantomeno bizzarro: una cronaca dada-escursionistica dell’ascesa al Monte Vettore, nel gruppo dei Sibillini, organizzata dalla Cooperative Risorse feat. Wu Ming 1, con presentazione di Point Lenana al rifugio Forca di Presta. Rifugio che quel giorno, per una coincidenza, era pieno zeppo di alpinisti sloveni!
Buona lettura.
P.S. Ricordiamo che il tour prosegue, qui il calendario fino a fine ottobre.
⁂
Reading Point Lenana in Alto Adige: urbanistica, architettura e colonialismo
-
di Flavio Pintarelli
«I muri fanno il nido nel cuore e nella testa: si ereditano come il dna e sono contagiosi.»
Maria Nadotti, Addio a Berlino 1
Se mi chiedessero di indicare la frase che meglio racchiude il senso del colonialismo fascista probabilmente non sceglierei un discorso del Duce e neppure la strofa di una delle molte marcette che accompagnarono le avventure coloniali del regime. Sceglierei invece questa frase scritta in lingua latina: “Hic patriae fines siste signa. Hinc ceteros excoluimus lingua, legibus, artibus”.
Che tradotta recita “In questo luogo abbiamo posto i confini della patria. In questo luogo abbiamo colonizzato gli altri con la lingua, le leggi e le arti”. Gli altri ovvero i barbari come suggeriscono gli strumenti della colonizzazione, ovvero “la lingua, le leggi e le arti”.
Ma chi sono questi altri? A chi è rivolta questa frase? E soprattutto da dove è tratta?
La frase in questione campeggia sul frontone del Monumento alla Vittoria di Bolzano, propio ai piedi del bassorilievo raffigurante la “Vittoria saettante” realizzato dallo scultore Arturo Dazzi. Questo distillato dello spirito colonialista del Fascismo non si trova dunque nelle terre d’oltremare ma entro i confini d’Italia, quei confini che la Prima Guerra Mondiale disegno sulla cartina d’Europa dopo quattro interminabili anni di conflitto di posizione.

Chi ha letto Point Lenana sa che uno dei piani che il libro di Wu Ming 1 e Roberto Santachiara intreccia nella narrazione della vita di Felice Benuzzi è quello del colonialismo italiano che ebbe durante il Fascismo (ma non solo) una duplice declinazione: esterna e interna.
Il colonialismo interno – che ebbe luogo nelle terre irredente che l’Italia riuscì a strappare all’Austria dopo il voltafaccia nella Grande Guerra – vestì i panni dell’italianizzazione forzata delle popolazioni autoctone (sloveni nella Venezia Giulia e tirolesi in Alto Adige) e non fu meno violento del colonialismo esterno. Anzi si può tranquillamente dire che tra i due progetti coloniali ci fossero ampi e documentati tratti di continuità nei metodi e nelle finalità.
Che Trieste sia uno dei luoghi attorno a cui s’irradia la scrittura di Point Lenana non è un caso. Il primo motivo è semplice: proprio nel capoluogo giuliano crebbe e si affermò come uomo e alpinista Felice Benuzzi e non sarebbe possibile ricostruirne la vicenda senza metterne in luce il carattere. Un carattere fortemente influenzato dalla cultura cosmpolita dell’Impero Austrungarico nella quale Benuzzi era stato cresciuto ed educato.
Quella cultura che il Fascismo cercò di estirpare, inizialmente ricorrendo alla violenza squadrista e poi affiancandole, dopo la presa del potere, la gestione della vita delle persone attuata attraverso i sistemi legislativi, le ordinanze e i regolamenti: dispiegando perciò in questo modo l’ordine del discorso colonialista su quel territorio; e questo ovviamente è il secondo motivo.
Chi scrive è nato, cresciuto e attualmente vive in Alto Adige, per la precisione a Bolzano; una città e una regione che, come già ho avuto modo di dire sopra, condividono la condizione di colonie interne del Regime a cui anche Trieste e i territori limitrofi vennero destinati.
Il modo in cui Point Lenana inquadra il rapporto che il Fascismo ebbe nei confronti delle terre irredente annesse all’Italia è importante per capire quanto le dinamiche sociali e politiche in quel periodo fossero legate e connesse e non possano essere lette senza tenere conto di questi legami.
«L’Africa e Trieste. Colonialismo e irredentismo giuliano. La vicenda di Benuzzi è a cavallo tra due mondi che hanno molto a che fare l’uno con l’altro. anzi, sono l’uno il presupposto dell’altro.»
È a partire dalla lettura di Point Lenana che ho cominciato a riflettere sul fatto che r ispetto a quanto il libro racconta del rapporto tra il Fascismo e Trieste il caso bolzanino presenti un aspetto che pur nella continuità di logiche e discorsi lo rende peculiare .
Uno delle caratteristiche distintive del colonialismo si esprime nell’intervento sul territorio, sul paesaggio, sugli edifici e sui luoghi. Intervento che si traduce immediatamente in una “micro gestione del vivere quotidiano”. Basti pensare a Littoria (oggi Latina) la città sorta dalle paludi dell’Agro Pontino come immagine stessa del Regime, oppure alla narrazione tossica che vuole gli italiani in Africa alacri costruttori di strade e infrastrutture in genere. Brutalität in Stein, così i registi tedeschi Alexander Kluge e Peter Schamoni definiscono – con formula alquanto fortunata – questa caratteristica, usando la formula come titolo per il loro cortometraggio sulle architetture nazionalsocialiste.
La presenza fascista in Alto Adige si lega a doppio filo con la storia dello sviluppo urbanistico e architettonico della città di Bolzano che si rivela perciò essere una straordinaria lente attraverso cui leggere tanto il discorso colonialista, quanto quello fascista.
In questo post vorrei presentare un’analisi dei principali interventi urbanistici che il Fascismo ha operato a Bolzano tra il 1925 e il 1943 (anno in cui, in seguito alla destituzione di Mussolini, l’Alto Adige venne occupato militarmente dalle forze armate del Terzo Reich), soffermandomi con particolare attenzione su due monumenti dal respiro apertamente colonialista per poi concludere il ragionamento facendo riferimento al ruolo che questi monumenti ricoprono nel presente e alle problematiche che pongono a chi alla militanza antifascista affianca la tensione alla conservazione del patrimonio storico-artistico nazionale.
In questo modo spero di fornire strumenti utili alla comprensione di uno degli aspetti che più caratterizzano il discorso colonialista e la sua peculiare declinazione nell’idioma del Fascismo.
Dal “piccone risanatore” all’“estetica regolatrice”: urbanistica fascista a Bolzano
Nel corso della sua storia la città di Bolzano ha conosciuto cinque importanti periodi di sviluppo cittadino che ancora oggi danno alla città il suo aspetto: il primo Medioevo, il tardo Medioevo, il periodo compreso tra il 1880 e il 1924, il periodo fascista dal 1925 al 1943 e infine gli anni sessanta e settanta.
È significativo notare come fino all’avvento del Fascismo la città non sia mai stata un centro di potere politico o spirituale. Stretta a ovest dai domini dei Conti di Tirolo, a sud e a est dalle sedi vescovili di Trento e Bressanone, Bolzano fu per secoli soltanto una città mercantile le cui fortune si alternarono nel corso del tempo. La via Portici, l’antico decumano, rappresenta ancora oggi il cuore della città ed è non a caso una via commerciale che con sempre maggiore fatica resiste alle logiche omologanti che molti altri centri storici stanno subendo da una ventina d’anni a questa parte.
L’attenzione del Fascismo nei confronti dell’Alto Adige fu estremamente precoce. Cominciò un anno e mezzo prima della Marcia su Roma, il 24 aprile del 1921. Quel giorno, conosciuto come Bozner Bluttsonttag (domenica di sangue bolzanina), squadristi da ogni parte d’Italia calarono su Bolzano terrorizzando la popolazione e uccidendo, tra le mura di palazzo Stillendorf, il maestro Franz Innerhofer.
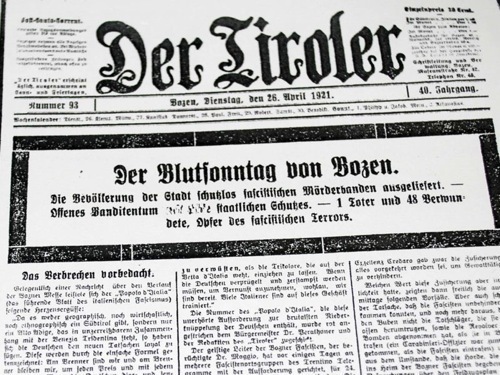
Poco dopo la presa del potere, «a partire dal 1923 risultano formalizzate le prime indicazioni per il controllo etnico e sociale, dirette ad arginare le espressioni più significative della tradizione tedesca e, al contempo, a legittimare l’associazione all’Italia come frutto di continuità storica» .
Non credo sia sbagliato notare che, probabilmente, uno dei motivi che spinsero il Regime a scegliere Bolzano come centro della propria presenza in Alto Adige sia stata la storica assenza di un centro di potere precedente. Il Potere e il suo discorso si esprimono sempre anche attraverso l’architettura e l’urbanistica, e non dover competere con altre simili espressioni di potere potrebbe aver rappresentato per il Fascismo un vantaggio strategico nell’attuare il proprio programma di italianizzazione dell’Alto Adige. Un programma che si espresse anche nell’articolato intervento di ampliamento di Bolzano
Tuttavia la città fu scelta anche per altri motivi, uno di questi è la sua romanità. Sebbene le fonti più attendibili facciano risalire la fondazione della città al 1180 la Tavola Peutingeriana del IV secolo riporta che nel 15 a.C. il generale Druso detto il Germanico, figlio della terza moglie di Augusto, mosse alla conquista della Alpi e costruì un accampamento detto Pons Drusi (il ponte di Druso) che “si ritiene possa collocarsi nell’attuale area bolzanina” (Wikipedia).
Il Fascismo non si fece scappare l’occasione di riprendere e tecnicizzare la vicenda del generale Druso a suo uso e consumo. Vennero lanciate numerose campagne di scavo archeologico per riportare alla luce resti che attestassero la presenza romana nella regione e, soprattutto, gli interventi architettonici monumentali vennero realizzati con uno stile anticheggiante per sottolineare questa continuità e la città di Bolzano venne soprannominata “sentinella d’Italia” in memoria del condottiero che aveva pacificato i confini.
Nella realizzazione della “Bolzano italiana”, progetto che ebbe inizio dopo l’assimilazione del comune di Gries al comune di Bolzano (progetto “Grande Bolzano”), il regime si trovò di fronte a due istanze. Innanzitutto doveva realizzare degli interventi che ne esprimessero l’immagine e che avessero la forza di cancellare le influenze che la cultura tedesca aveva espresso nel corso della Storia; con un particolare astio nei confronti del Gotico come “significazione di dominio straniero sulle anime e sulle coscienze” . In questo modo avrebbe potuto affermare con la forza evidente delle Pietre il dominio italiano sulla regione. Dall’altra parte il Fascismo doveva dare vita a interventi di carattere funzionale che permettessero di portare la popolazione cittadina da 55.000 a 100.000 abitanti.
Ogni colonia ha infatti bisogno dei propri colonizzatori e per dare ulteriore impulso all’italianizzazione dell’Alto Adige il Regime decise di “favorire” l’immigrazione verso le nuove terre a partire dagli anni Venti e poi, con maggiore consistenza, dopo il 1935 in seguito all’industrializzazione.
Non si trattò di fenomeni spontanei e questi flussi migratori delineano un quadro di provenienze dagli spiccati tratti di classe. Il ceto medio impiegatizio e dei funzionari era caratterizzato da un quadro di provenienze piuttosto vario e da una coesione che si reggeva sulla “concordanza di orientamento politico e di modelli di comportamento”.
Diverso il discorso per il proletariato la cui provenienza è circoscritta a livello regionale in particolare alla Lombardia e al Veneto.
Lo sviluppo dell’architettura urbana bolzanina seguì questa duplice composizione di classe della popolazione italiana immigrata. Per impiegati e funzionari vennero realizzati interventi abitativi ispirati al modello della “città giardino” e a colladuati moduli stilistici già sperimentati in area veneziana una “ambientazione di colore veneto” che “si avvale di un disegno accurato di particolari decorativi in un assortimento di riferimenti bizantini, gotici, rinascimentali, derivati dalla tradizione popolare della città lagunare” .
Per gli operai, in particolare dopo l’industrializzazione del 1935, vennero realizzati quartieri di residenza popolare al servizio della neonata Zona Industriale . Decentrata rispetto alla citta istituzionale sorse una vasta edilizia ispirata al tipo della borgata semirurale che fondeva insieme un vernacolo architettonico di sapore padano e l’idealizzazione fascista dei modelli della “sana e operosa” vita contadina. Nel marginalità e nella distanza dalla città istituzionale dei luoghi in cui venne espressa questa tendenza regionalistica si deve leggere una chiara indicazione della segregazione sociale a cui il proletariato era stato destinato dal Fascismo nello sforzo coloniale delle terre irredente.

Seppur tutti orientati allo sforzo di affermare il carattere d’italianità della nuova colonia, questi interventi diedero vita a un coro di voci contrastanti che raccolsero sotto l’attributo fascista termini usati in architettura secondo specifiche espressioni linguistiche come moderno , razionale , romano ma usati indifferentemente e ambiguamente.
L’artefice di questo progetto fu l’architetto Marcello Piacentini.
Iconografia colonialista: il monumento alla Vittoria e il fregio della Casa Littoria
A Marcello Piacentini non si deve soltanto la progettazione urbanistica della “Bolzano italiana”, l’architetto romano fu anche l’autore del Monumento alla Vittoria, il sacrario sul cui frontone campeggia la frase “Hic patriae fines siste signa. Hinc ceteros excoluimus lingua, legibus, artibus”, sormontata dalla minacciosa statua della “Vittoria saettante” che tende il suo arco verso nord, in direzione delle ostili Austria e Germania.
La prima pietra del Monumento venne posta nel 1926 e il cantiere dell’opera ebbe termine due anni dopo, nel 1928. Pensata inizialmente come omaggio all’irredentista Cesare Battisti (fucilato dagli austriaci nel 1916) l’opera divenne ben presto l’affermazione simbolica della vittoria sul nemico d’oltralpe e fu progettata per essere il centro da cui si sarebbe dovuta irradiare la nuova città auspicata dal regime. Non a caso il Monumento è stato posto perpendicolarmente alla direttrice che attraversa da est a ovest l’antico centro storico da via dei Portici al ponte Talvera attraverso via Museo, quasi a volerne interrompere il corso, segnandone il confine.

Il Monumento alla Vittoria è estremamente eloquente per quanto riguarda il discorso colonialista in Alto Adige ma dice molto anche sul rapporto tra il Fascismo e il passato. Lo stile infatti richiama gli antichi templi greci ma le colonne, trasformate in fasci littori, paiono voler affermare un quarto ordine architettonico; dopo il dorico, lo ionico e il corinzio apparve il littorio.
All’interno, al centro del colonnato, vi è una statua in bronzo che raffigura il Cristo Redentore mentre nei nicchioni simili a cappelle trovano posto i busti dei martiri Filzi, Chiesa e Battisti (quest’ultimo si irredentista, ma di fede socialista, la cui famiglia ebbe sempre in uggia l’appropriazione che il Fascismo operò della memoria del loro parente).
Nel Monumento alla Vittoria simbolismo religioso e simbolismo del potere convivono insieme alla tecnicizzazione del mito (la grecità) e della Storia recente (l’irredentismo) a cui si aggiunge la bellicosa dichiarazione che campeggia sul frontone.
Ne La Guerra del Peloponneso il padre della storiografia greca, Tucidide, racconta di come gli eserciti che si fronteggiavano sul campo di battaglia erano soliti erigere, dopo una vittoria, dei tempietti votivi detti trofei. Un trofeo poteva venire realizzato anche dopo una semplice battaglia o, addirittura, dopo la vittoria in uno scontro mentre nei dintorni ancora infuriava la battaglia.
Il trofeo era un modo per marchiare il territorio e affermarne l’apparteneza di una porzione all’esercito vincitore. Il Monumento alla Vittoria di Bolzano è un moderno trofeo eretto a immagine e somiglianza del regime fascista come simbolo di conquista. Non stupisce perciò che, dato il suo carattere apertamente colonialista, il sacario sia stato obiettivo di attentati dinamitardi durante la lunga e opaca stagione delle bombe (Bombenjahre).
Oltre al Monumento alla Vittoria c’è a Bolzano un’altra opera d’epoca fascista dal carattere apertamente colonialista: il fregio realizzato dalla scultore Giovanni Piffrader sul frontone dell’allora Casa Littoria, oggi Palazzo degli Uffici Finanziari.
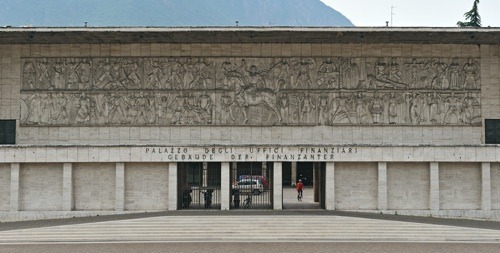
Le figure del fregio rappresentano «la marcia ascensionale dell’Italia Fascista, dai tempi grigi e gloriosi della vigilia rivoluzionaria, alla conquista dell’Impero, alla guerra di Spagna, alla liberazione del Mare Nostrum» . In pratica una narrazione dell’epopea fascista di 36 metri per 5,5 realizzata sullo stile della Colonna Traiana nel cui centro, al posto che l’iconografia storicamente riservava e sovrani e imperatori, torreggia la figura del Duce a cavallo. C’è chi si spinge a ipotizzare che questa figura del Duce a cavallo possa fare riferimento all’ episodio della spada dell’Islam:
«Il 18 marzo 1937 il duce sbarca a Tobruk dall’incrociatore Pola e inaugura la via Balbia, che attraversa tutta la costa libica. La visita dura fino al 21 e vede Mussolini percorrere la “sua” terra con l’aereo e l’auto, infaticabile anche se visibilmente appesantito. Alle porte di Tripoli, il giorno 20, il momento più solenne. Nell’oasi di Bugara il duce appare a cavallo dalla sommità di una duna, è accolto dal triplice grido di guerra dei combattenti musulmani, si erge sulle staffe del suo cavallo bianco, alza al cielo la spada con l’elsa in oro massiccio che il capo del contingente berbero gli ha appena consegnato e si proclama “protettore dell’Islam”. Intorno echeggiano le salve di cannone; dietro di lui è schierata una colonna di 2.600 cavalieri, con i quali entrerà a Tripoli. Il colpo d’occhio è suggestivo e pochi s’interrogano sul fatto che un cristiano “infedele” possa proclamarsi “protettore dell’Islam”.»
In che modo il Duce protesse la Libia negli anni a venire è storia che chi ha letto Point Lenana e legge questo blog conosce bene, qui basti dire che il ricordo lasciato dal “protettore” è lordo di sangue ma anche che la spada del Profeta ha, tempo dopo, avuto la sua meritata vendetta.
Tra politica ed esigenze di conservazione: cosa fare dei relitti del Fascismo?
Oggi a quasi settant’anni dalla caduta del regime la questione dei monumenti fascisti a Bolzano pone ancora numerosi problemi sia politici che di carattere storico e conservativo. Ciò che è accaduto tra la fine del 2010 e i primi mesi del 2011 è utile per capire quali sono le tensioni e le difficoltà nell’affrontare la npesante eredita di quelli che, con metafora fortunata, sono stati chiamati “relitti del Fascismo”.
Nel febbraio del 2011 all’allora ministro dei Beni Culturali del governo Berlusconi, Sandro Bondi, venne confermata la fiducia grazie ad una risicata maggioranza. Erano passati soltanto due mesi dalla giornata del 14 Dicembre, quando la rabbia giovanile aveva incendiato le strade della Capitale dopo che il governo Berlusconi era riuscito a ottenere la fiducia del Palamento grazie a quello che alcuni chiamarono il “mercato della vacche”.
Cruciale, nel salvataggio del vate toscano del PDL, fu l’astensione dei due senatori della Suedtirole Volks Partei (SVP) il principale partito di raccolta della minoranza tedesca dell’Alto Adige. Una scelta piuttosto inconsueta. Da anni l’SVP, pur avendo dinamiche interne trasversali, è alleata del PD e delle coalizioni di centrosinistra. Fin’ora il legame tra il PDL e gli esponenti ex MSI di Alleanza Nazionale ha reso compromettenete qualsiasi approccio tra la SVP e il centrodestra di lingua italiana.
Inoltre solo pochi giorni prima della votazione l’Obmann della SVP Richard Theiner aveva dichiarato “sarebbe assurdo votare per un ministro che con il dispendioso restauro del Monumento alla Vittoria di Bolzano si è giocato ogni simpatia”.
Che cosa era successo nel frattempo di così importante da far cambiare idea ai deputati Zeller e Brugger? In cambio dell’astensione il ministro Bondi aveva promesso ai deputati SVP la rimozione del fregio con il Duce a Cavallo, descritto nel paragrafo precedente.
In una città in cui l’eredità del Fascismo non è fatta soltanto di urbanistica e architettura ma rappresenta anche una forte influenza culturale e politica (tanto che nel dopoguerra Bolzano fu, in proporzione, la città italiana dove il MSI riscuoteva tra le più alte percentuali di voto) una decisione di questo genere ha avuto subito un effetto esplosivo.
La destra italiana locale ha gridato immediatamente allo scandalo e in poco tempo Casa Pound ha chiamato a raccolta i suoi militanti per una manifestazione nazionale contro il ministro Bondi e per l’italianità di Bolzano. Manifestazione che ha avuto come corollario una sequela di dichiarazioni bellicose da parte della destra tedesca in un’escalation di revanchismo e nazionalismo tanto virulenta quanto di rapida risoluzione.
Le questioni etniche in Alto Adige, quando vengono sollevate, hanno spesso un valore pratico pari allo zero assoluto, ma sono assai utili per compattare l’elettorato. Non è un caso che l’SVP abbia scelto di stuzzicare la questione dei monumento fascisti proprio in un periodo in cui il partito stava perdendo consensi alla propria destra.
La questione dei monumenti fascisti, per chi si pone al di fuori della logica dello scontro etnico e nella galassia antifascista, è estremamente problematica. Ancora più problematica se ci si occupa di conservazione dei beni storico artistici.
A mio avviso la rimozione dei relitti del fascismo è un atto pericoloso perché risveglia logiche di scontro etnico, logiche che sembravano sopite ma che i venti di crisi degli ultimi anni sembrano aver riattizzato. Inoltre agire in questo senso fornisce alla galassia neofascista l’opportunità di giocare il ruolo delle vittime, così com’è accaduto nella costruzione del discorso sulle foibe. Discorso che ha dato alla destra un forte elemento simbolico attorno a cui costruire la propria identità erodendo nel contempo il carattere fondativo della Resistenza per la Repubblica Italiana.
La rimozione di questi monumenti rischia di rafforzarne il potere trasformandoli in feticci da sventolare in tutte le occasioni in cui serve mobilitare le persone attorno ai simulacri dell’identità nazionale, gli stessi simulacri imposti dal fascismo nella sua colonizzazione dell’Alto Adige.
In un saggio uscito recentemente, Le pietre e il popolo, lo storico dell’arte Tomaso Montanari riflette sullo stretto rapporto che lega il carattere di un popolo e gli spazi che esso vive ed abita. È nel legame tra le persone e quella memoria concreta fatta di edifici, strade e piazze che risiede il valore e la funzione civile del nostro patrimonio.
Il Fascismo ha fatto parte della nostra storia e della nostra cultura nazionale. Ancora oggi, settant’anni dopo la caduta del regime, ne troviamo ovunque e con sempre maggiore frequenza i segni. Cicatrici che sembravano rimarginate tornano a pulsare e si gonfiano di pus. Questa contraddizione della nostra storia e della nostra cultura non può essere rimossa e musealizzata senza prima essere stata affrontata di petto.
Se noi oggi, nei monumenti, nell’architettura e nell’urbanistica fascista possiamo leggere i segni del regime, la tecnicizzazione del passato che operò e le palesi istanze colonialiste che ho cercato di mettere in luce in questo post, lo dobbiamo al fatto che “solo nelle idosincrasie e nelle rotture che questi relitti operano nello spazio circostante possiamo davvero intraprendere un dialogo con essi e intendere la delirante lingua che parlano: la lingua del totalitarismo” ( Recensione a Le pietre e il popolo ).
Come studiosi, antifascisti e internazionalisti il nostro compito è quello di togliere a questa lingua delirante e ai suoi discorsi ogni legittimità politca, sociale e storica con la forza delle argomentazioni e l’impegno nella militanza.
All’iconosclastia che trasforma la memoria in arma e feticcio dobbiamo opporre una costante azione di depotenziamento, decostruzione e critica del linguaggio e del discorso fascista. Così come hanno fatto gli artisti Arnold Holzkecht e Michele Bernardi, finalisti del concorso di idee per coprire il fregio con il Duce a cavallo, bandito pochi mesi dopo i fatti del febbraio 2011.
Holzknecht e Bernardi proponevano di proiettare sul bassorilievo una frase di Hanna Arendt “Nessuno ha il diritto di obbedire – Niemand hat das recht zu gehorchen”. Un intervento semplice che, con la forza del montaggio, agiva come un granello di sabbia nell’ingranaggio retorico del regime.
Purtroppo il concorso di idee non ha mai avuto un vincitore. Il Duce cavalca ancora e la nostra ferita pulsa, ma non abbiamo mai smesso di accettare la sua sfida.
Wu Ming 1, R. Santachiara, Point Lenana , pag. 139.
Ammetto in questo caso una conoscenza purtroppo superficiale delle vicende storiche triestine e se questa peculiarità bolzanina dovesse in seguito dimostrarsi infondata chiedo anticipatamente perdono per il mio campanilismo, che giustifico soltanto con la buona fede il rigore dell’analisi che verrà presentata in seguito.
O. Zoeggeler, L. Ippolito, L’Architettura per una Bolzano Italiana 1922- 1942 , pag. 48 Tappeiner, Lana 1992
G. Gerola, Architettura minore e rustica trentina , in “Architettura e arti decorative” VIII, marzo 1929; cit. in O. Zoeggeler, L. Ippolito, op. cit. , pag. 49
Ibidem , pag. 60 “È dato registrare, comunque, ripetuti tentativi di avallare l’esistenza di una ininterrotta linea culturale comune ad Alto Adige e regione veneta; l’argomentazione, così come è espressa soprattutto dalla rivista di Tolomei, si fonda sulle prove di una secolare influenza della Repubblica Veneta, successiva nel tempo soltanto a quella della conquista romana. Ma dalla convinzione di questa continuità storica scaturiscono dalla stessa fonte per la città istituzionale soltanto proposte di carattere palesemente celebrativo”
Ibidem. , pag. 58
Nella lista dei finanziatori civili dell’opera, alla terza posizione, campeggiano due fratelli Pintarelli, probabilmente lontanti parenti della famiglia di mio padre.
La figura di Piffrader come artista è del tutto particolare. Prima del fregio lo scultore realizzò il monumento ai Kaiserjäger sul Bergisel di Inssbruck e solo in seguito aderì al Fascismo. Dopo la guerra invece che essere epurato venne eletto presidente del neonato Künstlerbund (Associazione degli artisti), a riprova di come la Storia e la politica altoatesine seguano strade non sempre lineari.
V. Passalaqua, descrizione contenuta nella Relazione del Segretario Federale, inviata alla Sovrintendenza della Mostra della Rivoluzione Fascista (Roma) in data 19. 9. 1942.
⁂
#PointLenana sul #Sassongher pic.twitter.com/dIgpUYNPUR
— Erika Umek (@supereri) September 30, 2013
Doin’ a Ginger & Fred on #Sassongher top con @MisterLoFi #PointLenana pic.twitter.com/UB4BY6Xoov
— Erika Umek (@supereri) September 30, 2013
#PointLenana sopra la #Vallunga di #EmilioComici pic.twitter.com/7XqgE5AsN9
— Lorenzo Filipaz (@MisterLoFi) September 30, 2013
⁂
TRENTO E TRIESTE
Point Lenana a Trento, Bookique, 6 settembre 2013 – 1h 47′ 44″
Point Lenana a Trento, Bookique, 6 settembre 2013 – 1h 47′ 44″
Con il giornalista Luca Barbieri e il sociologo Christian Arnoldi (la prima voce che si sente).
Da Q a Point Lenana. Tredici anni di asce di guerra.
Sul tumblr di Point Lenana, estratto di 57’ ultra lo-fi (con tanto di rumori del traffico della vicina via S. Giorgio e parlottamenti di Lo. Fi.) della presentazione tenutasi a Trieste, davanti alla Libreria In Der Tat, con il libraio Alberto Volpi e lo storico Piero Purini il 31 agosto scorso
Ed ecco il videomessaggio nel quale Wu Ming 1 annuncia la presentazione al festival di Internazionale, il 6 ottobre prossimo.
Point Lenana from Internazionale on Vimeo.
A proposito di Internazionale, due settimane fa è apparsa sulla rivista una seconda recensione di Point Lenana, a firma di Frederika Randall, più critica di quella scritta da Goffredo Fofi che vi abbiamo proposto due speciali fa.
[image error]
“Il nostro porto è il vostro porto”. Manifestazione di indipendentisti triestini a Vienna, 22 giugno 2013.
Su Carmilla > TRIESTE LIBERA – di Claudia Cernigoi
A introduzione/integrazione dell’articolo qui linkato, e senza parlare specificamente del MTL, è importante dire che a Trieste ci sono sempre state, culturalmente parlando, due destre: una fascista e “italianissima”, l’altra austro-nostalgica.
La prima ha spadroneggiato a lungo, regalandoci pure alcuni politici nazionali il cui cavallo di battaglia erano le foibe, ma adesso sembra (ripetiamo: sembra) appannata e in perdita d’egemonia.
La seconda – non meno reazionaria – si è preservata soprattutto grazie a tradizioni private, lessici famigliari e una certa editoria locale, senza mai potersi esprimere esplicitamente sul piano politico.
Implicitamente, però, lo ha fatto: un certo indipendentismo – ma non quelli internazionalisti e antifascisti di cui racconta Andrea Olivieri – ha fatto leva sul sentimento “carsico” di nostalgia per l’Austria Felix. Sentimento fondato su dati storici reali (l’annessione all’Italia trasformò uno dei più importanti porti d’Europa in un porticciolo semi-abbandonato, con conseguente grave declino di tutta la zona), ma che nel dopoguerra ha assunto connotazioni ambigue, talvolta criptonaziste.
Una parte della borghesia triestina ha sempre rimpianto – con discrezione – l’occupazione tedesca. Come raccontato anche in Point Lenana, le SS si presentarono come eredi del Reich di Franz Joseph e promisero di far tornare la città agli antichi fasti (e profitti). Per gli austronostalgici l’indipendenza di Trieste, quando viene rivendicata, è una sorta di “ripiego”. Il vero sogno sarebbe la restaurazione dell’Impero, cosa ovviamente impossibile.
A differenza degli “italianissimi”, gli “austro-criptonazisti” non ce l’hanno con gli sloveni. Le SS adottarono strumentalmente la causa degli sloveni perseguitati dall’Italia, e riaprirono le scuole slovene che il fascismo aveva chiuso. Lo stesso comandante superiore delle SS nella Trieste occupata, Odilo Globočnik, era di origine slovena.
Il rimpianto per l’antico Reich include di default il rimpianto per il suo multiculturalismo. Ma si tratta di quel multiculturalismo. Il multiculturalismo di cent’anni fa. Su quello di adesso, sembrano regnare vaghezze e non-detti.
Non si può prendere in esame l’ultima voga neoindipendentista se si ignora quest’agitarsi di pulsioni sullo sfondo.
Attenzione, ciò non equivale a bollare questo movimento tout court come nazista, e nemmeno Cernigoi fa una cosa del genere. Però serve a porre la domanda, anche ai compagni triestini che – magari per curiosità, o per… “panmovimentismo” – non disdegnano di partecipare a inizitive pro- TLT: è proprio tutto chiaro, a Trieste, in questi giorni? A cosa servono (a chi servono) i movimenti “né-né”? E ci sono gli anticorpi per le particelle virali che potrebbero diffondersi?
Avremo in modo di tornarci sopra, senza snobismi, ma anche senza confusionismi. [WM1]
⁂
Testimonianza video di un’escursione in montagna con Fred Astaire che, lamentandosene, canta di aver visto solo il mare!
(Prima canzone di Follow The Fleet, 1936 – film la cui visione “decritta” una delle sottotrame di Point Lenana).
E con questo, per questa volta, è tutto. Buone scarpinate.
The post Speciale #PointLenana: Alto Adige, Trento e Trieste, Internazionale, video, recensioni appeared first on Giap.








La catastrofe comunicativa dei #Guerrieri Enel (Viva a sociedade alternativa!)
Collisione di mondi. Lo scontro su Twitter tra la sgodevole multinazionale che ha speso milioni in una pompatissima epperò demenziale campagna “social” e la comunità spontanea che, senza spendere un baiocco, l’ha sbaragliata. Come ha scritto Alberto Prunetti: “Sembra una rappresentazione della lotta contro Mordor, quando l’anello è prossimo alla distruzione.” Clicca per ingrandire (alta definizione).
L’immagine qui sopra è tratta da un’analisi di Matteo G.P. Flora che tutti dovrebbero leggere e discutere, e che giustamente è stata definita “l’ultimo chiodo sulla bara” della campagna #Guerrieri su Twitter. Non tanto per quel che dice delle storie opportunamente “incentivate” da un’agenzia di passaparola on line che organizza “consumatori consapevoli”, quanto per la fotografia che scatta della débacle di Enel su Twitter. Ne avevamo già parlato (il riassunto delle puntate precedenti lo trovate, distillato in diversi aggiornamenti, nel post e nei commenti qui), ma negli ultimi giorni, anziché calare, la contro-campagna dal basso è cresciuta e si è prodotto un effetto-valanga, tra arrampicate di specchi, figuracce dei responsabili media di Enel e scoperte di alcuni buffi dietro-le quinte.
Enel si è infilata nel più classico circolo vizioso: per non far vedere che sui social network la campagna non decollava – e in particolare su Twitter incontrava la resistenza di migliaia di utenti fino a subire un’autentica disfatta modello battaglia di Teoteburgo – Enel ha pompato al massimo la pubblicità su giornali e TV; la sta tuttora pompando, lo spot di #Guerrieri è ovunque. Il risultato è quello di pubblicizzare l’hashtag, e quando la gente va su Twitter a cliccare l’hashtag, vede l’ecatombe.
[Per chi non se intende: quella parola con il "cancelletto" davanti, #Guerrieri, su Twitter si chiama "hashtag", parola-chiave che permetta di aggregare i messaggi per argomento.]
Enel è un inserzionista tra i più potenti, ed è anche sponsor di grandi eventi organizzati da importanti giornali italiani. In più, ci sono proprietari di giornali che sono in affari con Enel. Ciò potrebbe spiegare il trasversale silenzio-stampa su quest’azione di massa dal basso. Tra i quotidiani ne ha scritto solo Il Fatto Quotidiano, e gliene va reso merito. Non sembra trattarsi di disattenzione, perché della campagna #Guerrieri di Enel ne stanno scrivendo eccome: una campagna che, come la descrivono, esiste solo sulle loro pagine. Appena uno va in rete, scopre come sta andando veramente. Ancora ieri, 30 settembre, dopo giorni e giorni in cui Enel su Twitter non riusciva più a muovere un dito, Aldo Grasso scriveva questa sviolinata che è parsa in-cre-di-bi-le più o meno a chiunque avesse cliccato l’hashtag di recente:

Minchia, nemmeno Uto Ughi…
Ora, ehm… Noialtri, partecipando a iniziative come il “dirottamento” della campagna Enel, non ci facciamo certo più amici ai piani alti. E dopo aver letto l’analisi linkata all’inizio, abbiamo pensato: non sarà meglio, d’ora in avanti, dormire ogni notte in un luogo diverso rigorosamente segreto? Non è che questi ci mandano gli scagnozzi coi taser a carbone? :-D
Sia chiaro: non vogliamo dare a quest’azione più importanza di quella che ha. Però:
1) è un interessante caso di studio su come reagire alla prepotenza di un brand e fare uno “smarketing” che è molto più sapiente e potente di qualunque strategia di marketing (“Cosa sa di marketing chi sa solo di marketing?”, pare si chiedesse C.L.R. James);
2) oggi molte più persone sanno cosa sta combinando Enel in America latina, sanno dei programmi nucleari Enel in Europa dell’est, sanno che in Italia sono attivi comitati di cittadini che lottano contro le centrali a Carbone o la geotermia “pulita”. E chissà che documentarsi su queste lotte non sia più appassionante e più utile che seguire minuto per minuto, secondo per secondo, dichiarazione dopo dichiarazione, talk-show dopo talk-show, le baruffe tra presunti falchi e presunte colombe nell’ormai fu PdL.
A proposito, noi (ricordate?) #Tifiamoasteroide.
Grazie a tutti/e, e viva a sociedade alternativa!
The post La catastrofe comunicativa dei #Guerrieri Enel (Viva a sociedade alternativa!) appeared first on Giap.








September 26, 2013
News dalla Terra di Mezzo: autunno 2013

Mentre siamo all’opera sulla copertina del saggio di Wu Ming 4, Difendere la Terra di Mezzo, il testo è in corso di impaginazione in casa editrice. Uscita prevista: intorno alla prima decade di novembre, salvo intoppi (incrociamo le dita).
Nel frattempo Wu Ming 4 è già ingaggiato in diversi appuntamenti “tolkieniani”. Ne anticipiamo alcuni, riservandoci di fornire ulteriori indicazioni e integrazioni mano a mano che il calendario andrà modellandosi:
- Domenica 3 novembre, dalle 14.00 alle 16.00, per il terzo anno consecutivo, WM4 terrà una conferenza al Lucca Comics & Games, nell’ambito del ciclo di incontri gestito dall’Associazione Romana Studi Tolkieniani. Lo spazio a disposizione non è molto grande, quindi per partecipare al seminario è necessario iscriversi (l’iscrizione è gratuita, ma occorre avere pagato l’ingresso al festival). I dettagli si trovano QUI. Altre notizie sull’edizione di quest’anno del Lucca Comics & Games e sui seminari dell’ARST sono QUI.
- Mercoledì 13 novembre, alle ore 10.00, parteciperà a una tavola rotonda organizzata presso l’Università degli Studi di Trento, sul tema “Letteratura e mito”. A WM4 è stato chiesto di intervenire sull’utilizzo e l’appropriazione della mitopoiesi tolkieniana da parte della destra italiana. Seguiranno dettagli.
- Non è ancora certo, ma probabilmente il libro di WM4 verrà presentato alla Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria di Roma (5-8 dicembre 2013). Anche in questo caso, seguiranno dettagli.
Per quanto riguarda il 2014, possiamo anticipare che WM4 parteciperà per la seconda volta ai seminari su Tolkien organizzati presso l’Istituto tomistico di studi filosofici di Modena. L’11 febbraio terrà l’intervento introduttivo all’incontro con i realizzatori del fan movie I Diari della Terra di Mezzo e in un’appuntamento successivo presenterà anche il suo libro.
A proposito di fan movie, sembra che quello messo in cantiere in Francia, Storm over Gondolin, ispirato a La Caduta di Gondolin (Il Silmarillion), abbia qualche ambizione in più rispetto ai precedenti inglesi The Hunt for Gollum e Born of Hope. Con l’anno nuovo partirà la campagna di crowdfunding. Sul sito dell’ARST c’è un articolo in proposito, con intervista al regista e videoclip. Per chi fosse interessat@, il materiale è QUI.
Infine per l’inverno 2014 è in progettazione a Bologna un seminario sull’invezione di universi narrativi, che verterà proprio sull’opera di Tolkien. E’ presto per parlarne, fintanto che non saremo certi di potere avviare come si deve un nuovo progetto a cui stiamo pensando da qualche mese. Fin da ora però possiamo dire che sarà necessario versare una quota di iscrizione al seminario e che la realizzazione del medesimo dipenderà da quante persone si iscriveranno (insomma, in un certo senso è un po’ crowdfunding anche questo…).
Per ora è tutto. In attesa di Difendere la Terra di Mezzo…

The post News dalla Terra di Mezzo: autunno 2013 appeared first on Giap.








September 24, 2013
Radio Giap Rebelde – Wu Ming Contingent live in Correggio
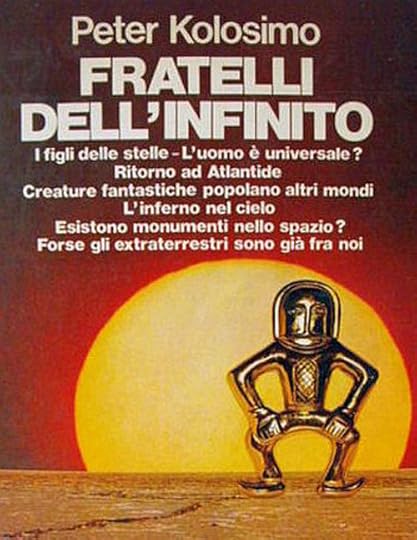
Come promesso, ecco una manciata di estratti dal concerto di Wu Ming Contingent in quel di Correggio, domenica 22 settembre, a sostegno delle attività di Casa Spartaco.
Le prime due tracce sono un buon esempio del repertorio della band: i testi prendono spunto dalla rubrica WuMingWood, pubblicata su GQ Italia tra il 2009 e il 2012 e firmata dall’intero collettivo.
In particolare, il brano Dio Vulcano! fa riferimento al primo articolo che pubblicammo in quella sede (Il dio maldestro), mentre Italia Mistero Kosmiko rielabora un pezzo intitolato UFO e Rivoluzione. Li trovate entrambi in questa selezione formato PDF.
Il terzo pezzo, invece, è una doppia cover: la musica ripropone il classico standard gospel You gotta move, mentre il testo è tratto dagli atti del processo per l’omicidio di Federico Aldrovandi e dal libro di Filippo Vendemmiati, E’ stato morto un ragazzo, Corvino Meda Editore 2010.
Dio Vulcano! - 3’48″
Dio Vulcano! - 3’48″
Italia Mistero Kosmiko – 3’59″
Italia Mistero Kosmiko – 3’59″
You Gotta Move (Per Aldro) – 5’27″
You Gotta Move (Per Aldro) – 5’27″
The post Radio Giap Rebelde – Wu Ming Contingent live in Correggio appeared first on Giap.








Wu Ming 4's Blog
- Wu Ming 4's profile
- 50 followers







