Antonio Gallo's Blog: MEDIUM, page 7
July 16, 2025
La poesia dell’immortalità

Caro lettore, preparati a leggere un articolo molto lungo. L’ho scritto molto tempo fa. Sfida l’eternità attraverso la poesia, un ricordo dei miei studi universitari. Il commento a questa immagine qui di seguito non l’ho scritto io, l’ha firmato il mio agente cognitivo AI Claude e l’ha chiamato “Infinity”. Nome abbastanza pertinente per introdurre il mio post scritto oltre dieci anni fa.
Questa scultura dal titolo “Immortalità” presenta una composizione di grande eleganza formale, dove il bronzo dorato si plasma in un nastro continuo che si avvolge su se stesso creando una figura tridimensionale di notevole impatto visivo.
La forma richiama immediatamente il simbolo dell’infinito matematico, ma qui sviluppato nello spazio con una complessità strutturale che suggerisce movimento perpetuo e continuità senza fine.
Il contrasto tra la superficie riflettente del metallo e la vegetazione rigogliosa dello sfondo crea un dialogo poetico tra artificio e natura, tra l’opera dell’uomo che aspira a sfidare il tempo e l’eterno rinnovarsi della vita vegetale.
La scelta del bronzo dorato non è casuale: questo materiale, simbolo di durevolezza nelle tradizioni artistiche, si carica qui di significati che trascendono la mera funzione estetica per diventare metafora della persistenza dell’arte oltre la caducità dell’esistenza umana.
La struttura ad anello intrecciato evoca anche l’ouroboros, l’antico simbolo del serpente che si morde la coda, archetipo universale del ciclo eterno di morte e rinascita.
In questo senso, l’opera si inserisce in una tradizione iconografica che attraversa millenni di riflessione filosofica e artistica sul tema dell’immortalità, dall’antichità classica fino alle avanguardie contemporanee.
L’installazione all’aperto amplifica il significato dell’opera: esposta agli elementi naturali, essa sfida concretamente il tempo, incarnando fisicamente il concetto che vuole rappresentare.
È un’opera che invita alla contemplazione prolungata, rivelando nuove prospettive e significati a ogni cambio di luce e di stagione.
Man mano che gli anni passano ci si rende conto di come la realtà evolve restando sempre eguale a se stessa mentre gli uomini cercano di aspirare all’immortalità. (AI)
Man mano che gli anni passano ci si rende conto di come la realtà evolve restando sempre eguale a se stessa mentre gli uomini cercano di aspirare all’immortalità.
Una ricerca inutile perché se cresciamo spiritualmente, fisicamente la natura ci tradisce e l’immortalità rimane un’illusione.
Dovremmo riflettere sui giorni che ci scivolano addosso rimpiangendoli oppure essere contenti delle esperienze vissute?
Questa famosa poesia che mi accingo a commentare sembra confermare il fatto che è possibile apprezzare la bellezza unica della fanciullezza riconoscendo il valore della crescita umana comprendendola attraverso l’essenza della natura.
La domanda che si pone il Poeta è: dobbiamo guardare indietro con nostalgia o con rimpianto? Oppure forse dovremmo essere soltanto grati per le esperienze vissute?
E questa eventuale gratitudine dovremmo forse sentirla riconoscendo i doni che il tempo ci ha donato? Ci sono molti modi di considerare il passato, il presente e le relazioni che abbiamo avuto. Per alcuni c’è solo da rimpiangere; per altri i frutti del passato sono ignorati.
Questa poesia-ode del poeta romantico inglese William Wordsworth ci dice che è possibile apprezzare la bellezza unica di un bambino vista in prospettiva del suo futuro riconoscendo il valore della crescita umana alla luce della natura.
Il poeta scrivendo questa lunga poesia decide di esplorare su se stesso il cammino delle emozioni che l’uomo percorre durante la crescita.
Un percorso per niente lineare e semplice che lo porta ad accettare il processo del decadimento e della morte per arrivare a comprendere poi quel ben più grande misterioso processo della natura e della nostra relazione con essa.
All’inizio egli contempla il tempo di quando egli vedeva tutto giovane, bello e glorioso per poi rendersi conto della realtà a lui attuale e di come “le cose che ho visto non le vedo più”.
Il passato è solo passato e questi ricordi di fanciullezza non offrono possibili alternative ma soltanto consapevolezza che tutto ciò che riguarda le esperienze passate, che tanto amava, non possono può essere vissute.
Il poeta nella seconda stanza riconosce che tutto ciò che egli vedeva un tempo ancora esiste, che l’arcobaleno viene e va tuttora e che il sorgere del sole rappresenta una gloriosa nascita.
Ciò che egli ha perduto non è un mondo che gli sembrava bello bensì la capacità di apprezzarlo così come faceva un tempo.
Nella terza stanza “mentre gli uccelli cantano un canto gioioso” viene un momento in cui “mi appare un pensiero di dolore”. Ma questo pensiero è soltanto come una nuvola di passaggio perchè ben presto egli recupera la forza, rinvigorito dalla natura che lo circonda.
Egli dichiara: “ed io sono di nuovo forte e tutta la terra è felice”. La quarta stanza inizia con un grande ottimismo e si rivolge a tutte le “creature benedette con il cuore in festa per voi, la testa indossa una corona di fiori, sente la loro benedizione su di lui”.
Ma la stessa stanza non si chiude in maniera gioiosa in quanto egli vede un albero e un campo che gli ricordano di qualcosa che non c’è più.
Forse egli si sovviene dell’albero della vita e del giardino dell’Eden, della immortalità e dell’idillica esistenza perduta dalla razza umana. Egli guarda verso il basso e ai suoi piedi vede una “pansy”, un fiore del ricordo, e avverte ancora una volta che qualcosa è cambiato.
Si chiede dove sia finita tutta quella luce, quella gloria e quel sogno. Si rende conto di avere perduto qualcosa, il Cielo, e che non c’è nulla da recriminare.
La sua tristezza raggiunge l’apice nella quinta stanza quando dice che “la nostra nascita è un sonno ed un dimenticare”. Le nostre anime, cacciate via dal Cielo, sono state messe in sonno su questa terra fino alla morte.
Man mano che invecchiamo in questo mondo senza senso “le ombre della casa-prigione cominciano a chiudersi sul bambino che cresce”.
Man mano che diventiamo vecchi, la memoria del Cielo svanisce nel nulla e i nostri legami troncati ci lasciano come in una prigione in cui non possiamo più ricevere la bellezza dei Cieli.
Nella stanza successiva il poeta parla della terra come figura materna, con un compito preciso: deve cercare di farci dimenticare il glorioso passato che abbiamo sperimentato in Cielo insieme al Padre.
E perciò essa ci offre dei piaceri terreni nel tentativo di dare un senso alle nostre vite mortali.
Ma questi doni potranno mai compensare la perdita del Cielo? Nella settima stanza Wordsworth descrive il miglior tipo di vita che possiamo sperimentare da quando siamo ragazzi a quando ci sposiamo fino al funerale, alternando dialoghi di affari, amore e lotta.
Tutto è triviale in quanto ogni cosa è soltanto imitazione. La vita è vista come niente altro che un tentativo senza speranza di ricreare ciò che abbiamo perduto.
Nell’ottava stanza il poeta ci parla del fanciullo come filosofo, profeta, occhio per i ciechi, sede di verità a cui aneliamo per capire. Gli chiede perchè egli appare così ansioso di conquistare le glorie terrene della vita da adulto.
E cieco alle vie celesti? Ignora il giudizio del tempo che oscura e chiude quella casa prigione in cui vive che è la vita? Che cos’è che lo spinge ad abbandonare la luce che dentro di lui?
Nella nona stanza il poeta ha quasi come un sobbalzo e dice che contrariamente alle impressioni precedenti il pensiero degli anni trascorsi non gli dà dolore o disperazione. Sembra quasi come una “benedizione perpetua”.
Per quanto poi riguarda quelle “ostinate domande” su ciò che abbiamo perduto esse non sono altro che “dubbi di una creatura che si muove in mondi irrealizzati”.
I nostri ricordi di fanciullezza “ci sollevano, ci accarezzano ed hanno il potere di rendere i nostri anni rumorosi momenti dell’essere”.
E se abbiamo bisogno di sperimentare questa sensazione di immortalità più direttamente, e davvero ne sentiamo la necessità, allora possiamo gioire perchè le nostre anime conservano ancora questo legame e possiamo, ma solo per un attimo, accedere a quella prospettiva che ci ha guidato quando eravamo fanciulli.
Questi pensieri da soli non giustificano il processo dell’invecchiamento. Essi ci dicono soltanto che possiamo almeno ancora mangiare dai frutti della fanciullezza, se non essere del tutto immersi in essi.
E’ nella decima stanza che il poeta ci dice del tempo che la sofferenza ci concede e di ciò che possiamo ottenere per mezzo di questo processo. Quello che lui chiama “the philosophic mind”.
Poi continua nella undicesima ed ultima stanza a dirci che l’unico piacere che egli ha perduto è quello che proviene dall’essere continuamente toccato dall’influenza della natura: “Ho goduto di una sola delizia, vivere sotto la tua più solita agitazione”.
In compenso egli ha guadagnato la capacità di allontanarsi dalla natura e contemplarla con la mente filosofica che l’età gli ha concesso, mettendolo in condizione di formarsi un maggiore apprezzamento di ciò che lo circonda.
Per quanto poi riguarda la morte, “le nuvole che si raccolgono intorno al sole che tramonta”, questa lo costringe a guardare alla vita in un modo più realistico, come a qualcosa che tutto sommato è necessario per guidarci in quanto creature mortali.
Egli conclude la lunga poesia facendo notare quanto lui sia grato per la condizione in cui versa il suo cuore perchè gli permette di vedere in profondità anche le cose più piccole.
Questa è una profondità che può essere apprezzata solamente con il dono che ci concede il tempo. Abbiamo a lungo lottato con i nostri dubbi sull’invechiamento e sulla morte e siamo stati tentati di rimpiangere ed idealizzare il passato.
A che serve tutto questo? Wordsworth risponde trovando il valore nei mutamenti che sperimentiamo nel rapporto con la natura. Da bambini siamo più sensibili ai suoi doni e ci possiamo permettere sensazioni che ci influenzano in maniera totale ma pura.
Da adulti, anche se più lenti in un certo qual modo e anche se siamo distratti da cose mondane di questo mondo, possiamo apprezzare questi doni in maniera meno superficiale, contemplando le domande che un bambino non si pone.
La poesia di Wordsworth come tale è un testamento di tutto ciò. Un bambino non potrebbe fare una cosa del genere.
Questo ci fa capire ciò che perdiamo e ciò che guadagniamo, ma le due condizioni si combinano. Nella sua decima stanza il poeta spiega che con l’aiuto delle passate esperienze e per mezzo delle sfide della sofferenza, la mente filosofica viene e a formarsi.
Dopo tutto, come possiamo avere il tempo di guardare il mondo in profondità se la natura ci inonda continuamente di piaceri, quando tutti i nostri bisogni sono soddisfatti abbondantemente?
Sapere entusiasmarsi alla vista dei colori di un arcobaleno, allo scorrere di una cascata, al canto degli uccelli è il primo passo. Ma dobbiamo sapere andare oltre, dobbiamo invecchiare, cercare cose più complesse per allietare la nostra anima.
E’ a questo punto che l’arte, la spiritualità, la scienza e la filosofia entrano in gioco. E questi sono i frutti dell’età, frutti che ci possono essere dati sotto la minaccia della noia e della morte.
Se vogliamo veramente comprendere il valore di questa bellissima poesia e delle idee che il poeta esprime possiamo anche arrischiarci ad entrare nel campo della teologia.
Sembra quasi che per Wordsworth la nostra esistenza abbia inizio nei Cieli (4. 52–58; 8. 123), là dove viviamo come creature immortali sotto la protezione dell’Albero della Vita (4. 51).
Ma proprio come Adamo ed Eva che vennero cacciati dal Paradiso Terrestre dopo di avere mangiato dall’Albero della Conoscenza, siamo messi in un mondo in cui non possiamo fare altro che perdere la nostra purezza ed innocenza che una volta avevamo con noi nella nostra anima (5. 58).
Da fanciulli siamo ancora influenzati dalla nostra esperienza del Cielo (5. 66) e la facciamo splendere sul mondo diffondendo il nostro amore per la natura.
Man mano che invecchiamo la nostra memoria del Cielo e il nostro senso di immortalità si affievoliscono e soffriamo (5. 67). E’ allora che, con la nostra sofferenza (10. 184), la mente filosofica si sviluppa dentro di noi e ci offre una nuova prospettiva sulla vita (11. 187).
Cominciamo a vedere le cose come avremmo potuto vederle sotto la protezione dell’Albero della Vita e cominciamo ad avvertire la sensazione di immortalità che ci viene concessa (11. 193–194), una sensazione che ancora ci sorprende anche se siamo stati allontanati dall’albero della conoscenza e fummo inviati sulla terra (5. 65–67).
Invece dell’albero della vita siamo guidati dall’albero della conoscenza, dalla filosofia e dalla sofferenza che da esse discende. Questa stessa sofferenza ci permette, dopo tutto, di osservare il mondo naturale con nuovo splendore ed in grande profondità (11. 201–204).
E’ chiaro allora che per mezzo di un viaggio nelle emozioni il poeta nella sua Ode arriva a descrivere la prospettiva infantile in una maniera meno idealizzata. E’ bella, è innocente ma non è tutto.
Nell’età adulta, l’uomo, dopo di avere raggiunta la maturità, disconnesso dalla natura ed in contrasto con la relazione avuta durante la fanciullezza, riconosce che egli non ha ancora accesso alla natura soltanto e potrà averlo soltanto se riesce a mettersi in contatto con lei.
Può inoltre accedere anche a certe bellezze che nessun bambino potrà vedere. La bellezza che proviene dalla mente filosofica, i pensieri che scaturiscono nella nostra sofferenza e che la fede che abbiamo acquisito dopo di avere compreso che non possiamo sfuggire alla nostra mortalità.Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood
THERE was a time when meadow, grove, and stream,
The earth, and every common sight,
To me did seem
Apparell’d in celestial light,
The glory and the freshness of a dream.
It is not now as it hath been of yore; —
Turn wheresoe’er I may,
By night or day,
The things which I have seen I now can see no more.
The rainbow comes and goes,
And lovely is the rose;
The moon doth with delight
Look round her when the heavens are bare;
Waters on a starry night
Are beautiful and fair;
The sunshine is a glorious birth;
But yet I know, where’er I go,
That there hath pass’d away a glory from the earth.
Now, while the birds thus sing a joyous song,
And while the young lambs bound
As to the tabor’s sound,
To me alone there came a thought of grief:
A timely utterance gave that thought relief,
And I again am strong:
The cataracts blow their trumpets from the steep;
No more shall grief of mine the season wrong;
I hear the echoes through the mountains throng,
The winds come to me from the fields of sleep,
And all the earth is gay;
Land and sea
Give themselves up to jollity,
And with the heart of May
Doth every beast keep holiday; —
Thou Child of Joy,
Shout round me, let me hear thy shouts, thou happy
Shepherd-boy!
Ye blessèd creatures, I have heard the call
Ye to each other make; I see
The heavens laugh with you in your jubilee;
My heart is at your festival,
My head hath its coronal,
The fulness of your bliss, I feel — I feel it all.
O evil day! if I were sullen
While Earth herself is adorning,
This sweet May-morning,
And the children are culling
On every side,
In a thousand valleys far and wide,
Fresh flowers; while the sun shines warm,
And the babe leaps up on his mother’s arm: —
I hear, I hear, with joy I hear!
— But there’s a tree, of many, one,
A single field which I have look’d upon,
Both of them speak of something that is gone:
The pansy at my feet
Doth the same tale repeat:
Whither is fled the visionary gleam?
Where is it now, the glory and the dream?
Our birth is but a sleep and a forgetting:
The Soul that rises with us, our life’s Star,
Hath had elsewhere its setting,
And cometh from afar:
Not in entire forgetfulness,
And not in utter nakedness,
But trailing clouds of glory do we come
From God, who is our home:
Heaven lies about us in our infancy!
Shades of the prison-house begin to close
Upon the growing Boy,
But he beholds the light, and whence it flows,
He sees it in his joy;
The Youth, who daily farther from the east
Must travel, still is Nature’s priest,
And by the vision splendid
Is on his way attended;
At length the Man perceives it die away,
And fade into the light of common day.
Earth fills her lap with pleasures of her own;
Yearnings she hath in her own natural kind,
And, even with something of a mother’s mind,
And no unworthy aim,
The homely nurse doth all she can
To make her foster-child, her Inmate Man,
Forget the glories he hath known,
And that imperial palace whence he came.
Behold the Child among his new-born blisses,
A six years’ darling of a pigmy size!
See, where ‘mid work of his own hand he lies,
Fretted by sallies of his mother’s kisses,
With light upon him from his father’s eyes!
See, at his feet, some little plan or chart,
Some fragment from his dream of human life,
Shaped by himself with newly-learnèd art;
A wedding or a festival,
A mourning or a funeral;
And this hath now his heart,
And unto this he frames his song:
Then will he fit his tongue
To dialogues of business, love, or strife;
But it will not be long
Ere this be thrown aside,
And with new joy and pride
The little actor cons another part;
Filling from time to time his ‘humorous stage’
With all the Persons, down to palsied Age,
That Life brings with her in her equipage;
As if his whole vocation
Were endless imitation.
Thou, whose exterior semblance doth belie
Thy soul’s immensity;
Thou best philosopher, who yet dost keep
Thy heritage, thou eye among the blind,
That, deaf and silent, read’st the eternal deep,
Haunted for ever by the eternal mind, —
Mighty prophet! Seer blest!
On whom those truths do rest,
Which we are toiling all our lives to find,
In darkness lost, the darkness of the grave;
Thou, over whom thy Immortality
Broods like the Day, a master o’er a slave,
A presence which is not to be put by;
To whom the grave
Is but a lonely bed without the sense or sight
Of day or the warm light,
A place of thought where we in waiting lie;
Thou little Child, yet glorious in the might
Of heaven-born freedom on thy being’s height,
Why with such earnest pains dost thou provoke
The years to bring the inevitable yoke,
Thus blindly with thy blessedness at strife?
Full soon thy soul shall have her earthly freight,
And custom lie upon thee with a weight,
Heavy as frost, and deep almost as life!
O joy! that in our embers
Is something that doth live,
That nature yet remembers
What was so fugitive!
The thought of our past years in me doth breed
Perpetual benediction: not indeed
For that which is most worthy to be blest —
Delight and liberty, the simple creed
Of childhood, whether busy or at rest,
With new-fledged hope still fluttering in his breast: —
Not for these I raise
The song of thanks and praise;
But for those obstinate questionings
Of sense and outward things,
Fallings from us, vanishings;
Blank misgivings of a Creature
Moving about in worlds not realized,
High instincts before which our mortal Nature
Did tremble like a guilty thing surprised:
But for those first affections,
Those shadowy recollections,
Which, be they what they may,
Are yet the fountain-light of all our day,
Are yet a master-light of all our seeing;
Uphold us, cherish, and have power to make
Our noisy years seem moments in the being
Of the eternal Silence: truths that wake,
To perish never:
Which neither listlessness, nor mad endeavour,
Nor Man nor Boy,
Nor all that is at enmity with joy,
Can utterly abolish or destroy!
Hence in a season of calm weather
Though inland far we be,
Our souls have sight of that immortal sea
Which brought us hither,
Can in a moment travel thither,
And see the children sport upon the shore,
And hear the mighty waters rolling evermore.
Then sing, ye birds, sing, sing a joyous song!
And let the young lambs bound
As to the tabor’s sound!
We in thought will join your throng,
Ye that pipe and ye that play,
Ye that through your hearts to-day
Feel the gladness of the May!
What though the radiance which was once so bright
Be now for ever taken from my sight,
Though nothing can bring back the hour
Of splendour in the grass, of glory in the flower;
We will grieve not, rather find
Strength in what remains behind;
In the primal sympathy
Which having been must ever be;
In the soothing thoughts that spring
Out of human suffering;
In the faith that looks through death,
In years that bring the philosophic mind.
And O ye Fountains, Meadows, Hills, and Groves,
Forebode not any severing of our loves!
Yet in my heart of hearts I feel your might;
I only have relinquish’d one delight
To live beneath your more habitual sway.
I love the brooks which down their channels fret,
Even more than when I tripp’d lightly as they;
The innocent brightness of a new-born Day
Is lovely yet;
The clouds that gather round the setting sun
Do take a sober colouring from an eye
That hath kept watch o’er man’s mortality;
Another race hath been, and other palms are won.
Thanks to the human heart by which we live,
Thanks to its tenderness, its joys, and fears,
To me the meanest flower that blows can give
Thoughts that do often lie too deep for tears.
— – — — — — —
C’era un tempo in cui prato, bosco, e ruscello,
la terra, e ogni essere comune
a me sembravano
ornati da una luce celestiale,
la gloria e la freschezza di un sogno.
non è più com’era prima; —
mi giro ovunque posso,
di giorno o di notte,
le cose che ho visto ora non posso più vederle.
L’arcobaleno viene e va,
e amabile è la rosa;
la luna con diletto
si guarda intorno quando i cieli erano spogli;
le acque nelle notti stellate
sono belle e serene;
l’alba è una nascita gloriosa;
ma eppure so, dove vado,
dove è passata una gloria dalla terra.
Ora, mentre gli uccelli cantano una tale canzone gioiosa,
e mentre i giovani agnelli saltellano
come al suono del tamburello,
solo per me venne un pensiero di dolore:
un’espressione tempestiva diede sollievo a quel pensiero,
e sono di nuovo forte:
le cataratte soffiano nelle loro trombe dalle ripide;
non più la mia pena offenderà la stagione;
sento gli eco accalcarsi attraverso le montagne,
i venti vengono verso di me dai campi di sonno,
e tutta la terra è felice;
terra e mare
si danno alla gioia,
e con il cuore di maggio
ogni bestia fa vacanza; —
tu, bambino di gioia,
urla intorno a me, fammi sentire le tue urla, tu felice
pastorello!
Creature benedette, ho sentito la chiamata
fatta per ognuno di voi; vedo
i cieli ridere con voi del vostro giubilo;
il mio cuore partecipa alla tua festa,
la mia testa ha la sua corona,
la pienezza della vostra beatitudine, io sento–la sento tutta.
o giorno maledetto! se fossi arcigno
mentre la terra sta adornando,
questa dolce mattina di maggio,
e i bambini stanno scartando
su ogni lato,
in migliaia di valli lontane e vaste,
fiori freschi; mentre il sole sorge caldo,
e il bambino salta tra le braccia di sua madre
sento, sento, con gioia sento!
–ma c’è un albero, di molti, uno,
un singolo campo che osserva dall’alto,
entrambi parlano di qualcosa che è passato:
la viola del pensiero ai miei piedi
ripete lo stesso racconto:
dov’è scappato il barlume visionario?
dove sono ora, la gloria e il sogno?
La nostra nascita è un sonno ed è stato dimenticato:
l’anima che si alza con noi, la stella della nostra vita,
ha avuto ovunque la sua collocazione,
e viene da lontano:
nè nell’intera dimenticanza,
e nè nell completa nudità,
ma nelle nuvole trascinanti di gloria noi veniamo
da Dio, che è la nostra casa:
il cielo è sopra di noi nella nostra infanzia!
le ombre della casa-prigione iniziano a chiudersi
sopra il bambino che cresce,
ma guarda la luce, e da dove fluisce,
in esso vede la gioia;
la giovinezza, che giornalmente oltre l’est
deve viaggiare, è ancora il prete della natura,
e dalla visione splendida
è intervenuta sulla sua strada;
lentamente l’uomo lo percepisce morto,
e sparisce nella luce del giorno comune.
La terra riempie le sue labbra con i suoi piaceri;
lei ha la smania nella sua naturale indole,
e, anche con le cose della mente materna,
e nessuno scopo indegno,
la domestica infermiera fa tutto ciò che può
per rendere il suo figlio adottivo, un uomo detenuto,
dimentica le glorie che ha conosciuto,
e quel palazzo imperiale da dove lui viene.
il bambino guarda tra le sue nuove beatitudini,
un caro ragazzo di sei anni di un’altezza pigmea!
vedi, dove il mezzo lavoro nella sua stessa mano giace,
logorato dai baci di sua madre,
con la luce sopra di lui dagli occhi del padre!
vedi, ai suoi piedi, alcuni piccoli progetti o piani,
alcuni frammenti dal suo sogno di vita umana,
formata da lui stesso con arte appena conosciuta;
un matrimonio o una festa,
un lutto o un funerale;
e questo ha ora il suo cuore,
e tra questo lui monta la sua canzone:
allora lui adatterà la sua lingua
ai dialoghi di affari, amore, lite;
ma non sarà a lungo
questo sarà gettato via,
e con nuova gioia e con orgoglio
il piccolo attore ha un’altra parte;
riempendo con il tempo la sua “parte umoristica”
con tutte le persone, in un’età paralizzata,
che la vita porta con sè nel suo equipaggiamento;
come se la sua intera vocazione
fosse una limitazione senza fine.
Tu, la quale sembianza esterna crede
nell’immensità della sua anima;
tu miglior filosofo, che conservi
la tua eredità, tu occhio tra i ciechi,
che, sordo e silenzioso, leggi l’eterna profondità,
cacciata per sempre dalla mente eterna, —
potente profeta!veggente benedetto!
sul quale queste verità riposano,
verità che affaticano le nostre vite per trovare,
nell’oscurità perduta, l’oscurità della tomba;
tu, su tutti la tua immortalità
covi come il giorno, un padrone su uno schiavo,
una presenza che non è stata posta;
la quale tomba
non è altro che un letto solitario senza il senso o la vista
del giorno o la luce calda,
un posto di pensieri dove noi aspettiamo giacenti;
tu, piccolo bambino, aancora glorioso nella potenza
della libertà nata dal cielo sui tuoi esseri viventi,
perchè con tali oneste pene provochi
gli anni da portare in un evitabile giogo,
questa cecità litiga con la tua beatitudine?
presto la tua anima avrà il suo carico terrestre,
e il cliente su di te con un peso,
pesante come il gelo, profondo quasi come la vita!
o gioia! che nelle tue braci
c’è qualcosa che vive,
che la natura ancora ricorda
com’era così fuggitiva!
il pensiero del nostro passato in me incrocia
la perpetua benedizione: nè infatti
per quello che è peggiore per essere benedetto —
delizia e libertà, il semplice credo
dell’infanzia, se occupata o a riposo,
con nuova speranza ancora svolazza nel suo petto: —
nè per questo io innalzo
il canto di ringraziamenti e preghiera;
ma per queste domande ostinate
di seno e cose esteriori,
che cadono da noi, svanendo;
bianchi dubbi di una creatura
muovendosi in mondi non realizzati,
alti istinti prima che la nostra natura mortale
tremano come una cosa colpevole e sorprendente:
ma per queste prime affezioni,
questi ricordi ombrosi,
che, siano ciò che devono,
sono ancora fontane di luce di tutti i nostri giorni,
sono anora luce maestra di tutte le nostre visioni;
ci sollevano, ci curano, e hanno il potere di rendere
i nostri giorni rumorosi momenti nell’essere
dell’eterno silenzio:verità che si svegliano,
per morire sempre:
che nè la disattenzione, nè pazzia indigena,
nè uomo o ragazzo,
nè tutto ciò che è nemico della gioia,
può improvvisamente abolire o distruggere!
da adesso in una stagione di tempo calmo
attraverso l’interno del paese noi siamo lontani,
le nostre animo hanno visto quell’immortale mare
che ci porta di qua,
può in un momento viaggiare di là,
e vedi i bambini giocano sulla riva,
e senti le potenti acque rotolare sempre.
allora cantate, uccelli, cantate, cantate una gioiosa canzone!
e fate saltellare i giovani agnelli
come al suono del tamburello!
noi nei pensieri ci uniamo alla folla,
quel piffero e quel suono,
quelli attraverso i vostri cuori oggi
senti la felicità di maggio!
ciò che attraverso il radiante era una volta così luminosa
sei preso per sempre ora dal mio sguardo,
niente può riportare l’ora
di splendore nell’erba, di gloria nel fiore;
non non siamo più addolorati, piuttosto troviamo
forza in ciò che rimane indietro;
nella primaria simpatia
che è dovuta essere;
nei pensieri calmanti che fioriscono
dalle sofferenze umane;
nella fede che guarda oltre la morte,
negli anni che portano la mente filosofica.
e le fontane, i prati, le colline, e i boschi,Postato 29th January 2012 da galloway [image error]
presagiscono nessuna dei tanti nostri amori!
ancora nel mio cuore sento dei cuori la tua potenza;
ho solo rinunciato a un diletto
per vivere sotto il tuo costante oscillare.
amo i ponti sotto i quali scorrono i loro canali,
sempre più di quando viaggiavoleggero come loro;
l’innocente luminosità di un nuovo giorno
è ancora amabile;
le nuvole che si muovono intorno al sole che tramonta
prendono un colore sobrio da un occhio
che ha messo lo sguardo sulla mortalità dell’uomo;
un’altra razza è stata, e altri palmi hanno vinto.
grazie al cuore umano con il quale viviamo,
grazie alla sua tenerezza, alla sua gioia, e paure,
per me il più significativo dei fiori che sboccia può dare
pensieri che spesso giacciono anche pieni di lacrime.
July 15, 2025
Le “bozze non corrette” sono quelle dell’enigma della vita
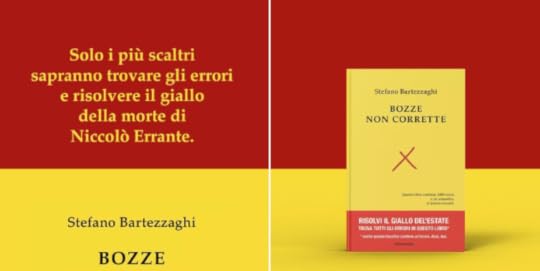 Il Libro
Il LibroStefano Bartezzaghi dichiara apertamente che il libro contiene “mille errori per la precisione: refusi, errori lessicali e grammaticali, vocaboli sbagliati, errori fattuali, omissioni”. Non si tratta di negligenza, ma di scelte deliberate.
Il protagonista misterioso. Al centro c’è Niccolò Errante, descritto come “un grande scrittore misterioso, enigmatico, che non amava apparire: nessuno sa esattamente neanche quando o dove è nato”. Bartezzaghi racconta di aver avuto “il privilegio di essere il correttore di bozze dei suoi romanzi”.
La struttura narrativa. Il libro è definito “un oggetto narrativo non identificato: un’opera letteraria che non si limita a raccontare, ma ti costringe a giocare, indagare, osservare ogni parola come se fosse una prova in un’indagine”.
Il gioco letterario. Bartezzaghi spiega che “gli errori li ho messi io, per giocare con voi come Niccolò Errante faceva con me”, creando un parallelismo tra il rapporto autore-lettore e quello che lui stesso aveva con Errante.
Il formato innovativo. L’opera è descritta come “una provocazione letteraria, un giallo linguistico, un omaggio al potere” dove “ogni sbaglio disseminato nelle pagine di questo libro non è un difetto, ma una traccia da seguire”.
L’obiettivo. Trasformare la lettura da atto passivo a investigazione attiva, dove il lettore deve scovare gli errori intenzionali, diventando complice del gioco letterario. Il libro diventa così una caccia al tesoro intellettuale che celebra l’imperfezione volontaria come forma d’arte.
Un esperimento editoriale unico che sovverte le regole tradizionali del rapporto tra autore, testo e lettore, facendo dell’errore il protagonista assoluto della narrazione.
Non potevo non leggere questo libro. Scritto da un enigmista, il senso sta tutto nella parola. Anzi, le parole sono due. La prima è “enigma”. La seconda è “bozza”. Cosa sono?
Enigma ha un affascinante percorso etimologico che attraversa millenni di storia linguistica e culturale.
Il termine deriva dal greco antico αἴνιγμα (ainigma), sostantivo neutro formato dalla radice del verbo αἰνίσσομαι (ainissomai), che significa “parlare per allusioni, esprimersi velatamente”.
Il verbo stesso è collegato ad αἶνος (ainos), che indicava un racconto, una favola, un detto sentenzioso.
La formazione morfologica segue il pattern tipico dei sostantivi greci in -μα derivati da verbi, indicando il risultato di un’azione.
Dal greco, la parola passò al latino come “aenigma” (genitivo “aenigmatis”), mantenendo sostanzialmente inalterato il significato originario.
Nel mondo greco-romano, l’enigma aveva una doppia valenza: da un lato era un genere letterario minore, una forma di intrattenimento intellettuale che sfruttava giochi di parole, doppi sensi e allusioni oscure; dall’altro aveva una dimensione sacra e oracolare, come testimoniano i celebri enigmi della sfinge tebana o le risposte sibillini degli oracoli.
Durante il Medioevo, il termine mantenne la sua accezione di “discorso oscuro che nasconde un significato riposto”, trovando particolare fortuna nella letteratura allegorica e nella tradizione ermetica.
A partire dal Rinascimento, “enigma” ha progressivamente ampliato il suo campo semantico, assumendo il significato più generale di “mistero, cosa difficile da spiegare o da capire”.
Questa evoluzione riflette il passaggio da una concezione dell’enigma come artificio retorico-letterario a una nozione più ampia di problema irrisolto o fenomeno inspiegabile.
Nel linguaggio contemporaneo, la parola ha acquisito particolare rilevanza in ambito scientifico e tecnologico, dove si parla di “enigmi” della fisica, della biologia, della psicologia.
Non va dimenticato l’uso storico legato alla macchina crittografica tedesca “Enigma” della Seconda Guerra Mondiale, che ha contribuito a rafforzare l’associazione del termine con la crittografia e la decodificazione.
La ricchezza semantica di “enigma” testimonia come certi concetti attraversino i secoli mantenendo un nucleo di significato stabile pur adattandosi ai mutamenti culturali e epistemologici delle diverse epoche.
Bozza è l’altra parola legata a “enigma”. “Bozze non corrette” è il titolo di un libro che gioca magistralmente con il linguaggio editoriale e le sue stratificazioni semantiche.
La parola “bozza” porta con sé una storia affascinante che illumina il senso profondo dell’opera. Il termine deriva dal francese antico “boce” (protuberanza, rigonfiamento), che a sua volta risale al franco “bottja”.
Originariamente indicava qualcosa di grezzo, non rifinito, una prima forma che necessitava di ulteriore lavorazione. Nel linguaggio tipografico, la bozza divenne il termine tecnico per designare la prima stampa di un testo, quella da correggere prima della versione definitiva.
Nel XVI secolo, con l’espansione dell’arte tipografica, “bozza” acquisì il significato specifico che conosciamo: una prova di stampa su cui autori e correttori di bozze intervengono con correzioni, cancellature, aggiunte. È il momento in cui il testo è ancora fluido, modificabile, vivo.
L’espressione “bozze non corrette” crea un paradosso semantico denso di significati. Se la bozza è per definizione ciò che attende correzione, una “bozza non corretta” è un testo che rimane sospeso nel suo stato di imperfezione volontaria.
È un’opera che rifiuta la definitività, che sceglie di mostrarsi nel suo divenire piuttosto che nel suo essere compiuto. Somiglia al percorso della vita, nella sequanza deglie eventi che viviamo lungo strade seminate da continui errori. Una “bozza in progress”.
Il titolo di questo libro suggerisce diverse chiavi di lettura. L’incompiutezza come scelta estetica. L’autore potrebbe aver deliberatamente scelto di lasciare visibili le “cuciture” del testo, i ripensamenti, le esitazioni. È una poetica dell’autenticità che privilegia il processo creativo al prodotto finito.
In un’epoca di ipercontrollo testuale, le “bozze non corrette” potrebbero rappresentare una forma di resistenza alla standardizzazione, un ritorno alla spontaneità creativa. Il tempo sospeso della creazione.
Le bozze esistono in un tempo particolare, quello della potenzialità infinita. Prima della correzione finale, tutto è ancora possibile. Il testo respira, si trasforma, vive. Come la vita, appunto. Un susseguirsi si errori. Bozze da correggere.
Mostrare le bozze significa rendere visibile il cantiere dell’opera, demistificare l’atto creativo, mostrare che la letteratura, come la vita, nasce dal lavoro, dal dubbio, dalla riscrittura. Le “bozze non corrette” sono una metafora dell’esistenza umana sempre in divenire.
Un manifesto contro la perfezione? Una riflessione sulla natura provvisoria di ogni scrittura? Il titolo stesso diventa una chiave di conoscenza che orienta la lettura verso una comprensione più profonda dell’opera e del suo rapporto con l’imperfezione come valore estetico e esistenziale.
Ho fatto anche io il correttore di bozze, ho imparato a leggere e scrivere nella tipografia di mio padre mettendo insieme i caratteri mobili. Una vita fatta di bozze da correggere, ma non è possibile trovare tutti gli errori, sono davvero troppi.
La mia esperienza di allora giovane lettore, che doveva ancora imparare non solo a leggere e scrivere ma anche a pensare, la lettura di questo libro ha toccato il cuore più profondo e autentico del mio rapporto con la parola scritta, stampata e poi letta.
Crescere tra i caratteri mobili, imparare a leggere componendo lettera per lettera, significa aver vissuto la nascita fisica del testo, aver sentito il peso materiale di ogni parola.
Chi ha fatto il correttore di bozze sa che esiste una verità nascosta: l’errore è connaturato al processo di scrittura e stampa. Non è un accidente da eliminare, ma una presenza inevitabile, quasi ontologica.
Ricordo di aver vissuto quella tensione tra l’aspirazione alla perfezione e la consapevolezza dell’impossibilità a comprenderne il significato. Bisogna possedere una filosofia pratica che si acquisce solo scrivendo e leggendo.
Nella tipografia di mio padre ho imparato che ogni testo è un organismo vivente, soggetto a mutazioni impreviste. I caratteri mobili si ribellavano, le lettere si capovolgevano, gli spazi si dilatavano.
L’errore non era nemico, ma compagno di viaggio. Ogni bozza corretta ne generava di nuove, in un processo infinito che insegna l’umiltà. Il paradosso della perfezione. “Non è possibile trovare tutti gli errori”. Così ha scritto Stefano Bartezzagli.
Questa frase racchiude una saggezza profonda. Bartezzaghi, con le sue mille imperfezioni volontarie, ribalta il paradigma: se l’errore è inevitabile, perché non farne arte? La mia esperienza di correttore permette di cogliere la provocazione più sottile dell’opera.
L’errore smette di essere fallimento per diventare rivelazione. La memoria tattile della correzione nella lettura del libro della vita sempre in bozza. Chi ha maneggiato piombo e inchiostro, chi ha sentito la resistenza fisica del testo, conosce l’errore in modo diverso.
Non è astrazione digitale, ma presenza materiale. Quando correggi una bozza, non stai solo eliminando sbagli: stai dialogando con la fragilità stessa del linguaggio. Proprio come quando riconosci un errore di vita.
La mia esperienza mi dà una chiave interpretativa unica per la lettura di questo libro. “Bozze non corrette”. Posso scrivere da dentro il processo, da chi ha vissuto l’angoscia dell’errore sfuggito, la soddisfazione dell’errore trovato, la rassegnazione dell’errore accettato.
Bartezzaghi gioca con quello che ho vissuto come dramma professionale quotidiano. Il suo è un omaggio involontario a tutti i correttori che hanno combattuto battaglie impossibili contro l’imperfezione del linguaggio.
Le sue “bozze non corrette” sono forse l’unica vittoria possibile: smettere di combattere l’errore e iniziare a danzare con lui.
La recensione di questo libro potrebbe essere quella di chi riconosce, in ogni errore volontario di Bartezzaghi, l’eco di mille errori involontari che hanno attraversato la propria vita professionale.
Un dialogo tra chi crea errori per arte e chi li ha inseguiti per mestiere. Avevo cominciato a leggere il libro in versione digitale, poi mi sono reso conto che non era il caso.
Avevo bisogno del libro fisico. Ho trovato 250 errori. Una cifra molto lontana da quella segnalata dell’autore. Ma se penso a quelli di un intera vita, non riesco davvero a contarli.[image error]
July 11, 2025
La battaglia di Sarno e le mie “allucinazioni”
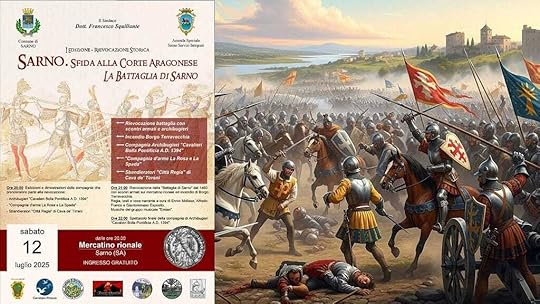
Due agenti cognitivi AI mi hanno fatto il resoconto della battaglia di Sarno che si festeggia in città in questi giorni. L’Intelligenza Artificiale soffre di così dette “allucinazioni”, alias errori o fantasie, come del resto ne soffrono anche gli esseri umani, e gli abitanti della Valle dei Sarrasti in particolare. Mi rivolgo ai tanti illustri e dotti storici locali per sapere se quello che AI mi ha comunicato corrisponde al vero.
Non avrò il piacere di assistere alla celebrazione essendo lontano, ma penso di non perdermi molto. Penso al sangue versato nel fiume Sarno. Forse per questa ragione continua ad essere uno dei fiumi più inquinati in Europa. Spero che qualche emerito/a storico/a locale mi faccia uscire da queste “allucinazioni” ….
“La Battaglia di Sarno del 1460 fu uno scontro significativo all’interno della guerra di successione per il Regno di Napoli tra Ferrante d’Aragona e Giovanni d’Angiò. Ecco i dettagli principali: La battaglia vera e propria durò circa sette ore. Non si trattò di una campagna militare prolungata in un singolo luogo, ma di uno scontro diretto e intenso.
Le fonti indicano perdite considerevoli da entrambi gli schieramenti: Circa 800 cavalieri e 1.000 fanti furono uccisi o feriti tra le due fazioni. Nella sola città di Sarno, l’evento provocò la distruzione di molte abitazioni e la morte di 137 persone tra i civili. Per l’esercito aragonese, la sconfitta fu completa, con migliaia di soldati caduti tra morti e feriti, e un numero imprecisato di prigionieri, inclusi nobili condottieri.
Nonostante le pesanti perdite per Ferrante d’Aragona, la battaglia non ebbe un vincitore netto e ben definito sul campo di battaglia. Tuttavia, per Giovanni d’Angiò, la vittoria di Sarno rappresentò un trionfo militare significativo che riaprì completamente la contesa per il Regno di Napoli, spalancando le porte di Napoli agli Angioini. Per Ferrante d’Aragona, fu un duro colpo, sia militare che politico. “[image error]
July 10, 2025
Tutti “cercatori” di tempo perduto
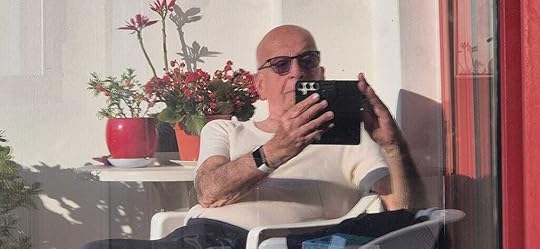 Foto@angallo
Foto@angalloIl ricordo della nascita di Marcel Proust, il 10 luglio 1871, autore della sua famosa ma poco letta ricerca del tempo, sia “perduto” che “ritrovato”, mi porta a pensare che siamo tutti “cercatori”.
Il “tempo perduto” è il tempo che scorre e svanisce, apparentemente irrecuperabile. Il “tempo ritrovato” è il tempo che, grazie a stimoli sensoriali e alla memoria involontaria, riemerge con la sua piena vitalità nel presente. Rivela il suo significato profondo e permette all’individuo di costruire un senso per la propria esistenza attraverso l’arte.
È un passaggio dalla dispersione alla coesione, dall’oblio alla pienezza, dalla sofferenza per la perdita alla gioia della rivelazione. Insomma, il tempo, come la vita, è un “sogno”, lo scrisse Calderòn de la Barca. Alla fine ci sveglieremo tutti “morti”. Questa riflessione è l’essenza del pensiero proustiano.
In “À la recherche du temps perdu”, il “tempo perduto” rappresenta lo scorrere inesorabile della vita, quei momenti che sembrano svanire nell’oblio, frammenti di un’esistenza apparentemente dispersa.
Ma il “tempo ritrovato”, attraverso la memoria involontaria, è il miracolo della coscienza la quale, stimolata da un sapore, un odore o un suono, riporta in vita il passato con una pienezza che non è solo ricordo, ma rivelazione.
È come se il tempo, invece di dissolversi, si cristallizzasse in un’eternità soggettiva, resa possibile dall’arte, che per Proust è il mezzo supremo per dare coesione e significato alla vita. Il riferimento che ho fatto al tempo come un “sogno” è pertinente.
Proust sembra suggerire che viviamo in una sorta di illusione, dove il tempo lineare ci sfugge, ma che possiamo “risvegliarci” a una comprensione più profonda attraverso la memoria e l’arte, trovando una forma di redenzione.
L’immagine paradossale del “risveglio” nella morte aggiunge una sfumatura esistenziale: forse è solo nel confronto con la finitezza che il senso della vita, e del tempo, si svela pienamente. È un paradosso proustiano.
Il tempo perduto diventa prezioso proprio perché destinato a finire, e l’arte ci permette di afferrarne l’essenza prima del “risveglio” finale. Il legame tra tempo, sogno e mortalità in Proust, e nella mia riflessione, è un nodo che tocca il cuore della condizione umana.
Nella sua “À la recherche du temps perdu”, Proust intreccia questi temi in modo complesso, suggerendo che il tempo è sia un’illusione sfuggente che una realtà che ci definisce. Il sogno è il mezzo attraverso cui lo percepiamo e la mortalità è il confine che dà urgenza e significato alla nostra ricerca.
Per Proust, il tempo ha, quindi, una qualità onirica, non è mai lineare né oggettivo, ma si manifesta nella coscienza come un flusso frammentario, simile a un sogno. Nella vita quotidiana, il tempo sembra scivolare via, “perduto” nella routine o nell’oblio, proprio come i sogni svaniscono al risveglio.
Tuttavia, la memoria involontaria, come il famoso episodio della madeleine, agisce come un sogno lucido, un momento in cui il passato si ripresenta con una vividezza che trascende il presente.
Questi istanti di “tempo ritrovato” sono sognanti perché sospendono la linearità temporale, fondendo passato e presente in un’esperienza quasi metafisica. Il tempo, in questo senso, è un sogno che viviamo senza comprenderlo pienamente, finché un dettaglio sensoriale non ci “sveglia” a una verità più profonda.
Il sogno, a mio modo di vedere, non è solo una metafora, ma un modo di percepire la realtà. La memoria involontaria funziona come un sogno che riporta alla luce frammenti di vita apparentemente perduti, permettendo al narratore di ricostruire il senso della propria esistenza.
L’arte, per Proust, è l’estensione di questo processo onirico: scrivere diventa un atto di sogno cosciente, in cui il caos del tempo e della vita si ricompone in un ordine significativo.
Questo passaggio dalla dispersione alla coesione che ho evidenziato, è come uscire da un sogno frammentario per entrare in una narrazione coerente, dove ogni momento, anche il più banale, trova il suo posto.
La mortalità è il confine che dà urgenza alla ricerca proustiana. La consapevolezza della morte, evocata con l’immagine del “risveglio” nella morte, permea l’opera di Proust. È la finitezza del tempo che rende prezioso il tentativo di ritrovarlo.
La morte, come il risveglio da un sogno, è il momento in cui il tempo cessa di essere un’illusione e si cristallizza in un’eternità immobile. Per Proust, però, l’arte offre una sorta di immortalità. Attraverso la scrittura, il narratore trascende la mortalità, trasformando il tempo perduto in un’opera che vive oltre di lui.
L’idea del “risveglio” nella morte può essere letta come un paradosso: la fine della vita è ciò che dà valore al sogno del tempo, spingendoci a cercare il “ritrovamento” prima che il sipario cali. In questo intreccio, tempo, sogno e mortalità si fondono in una riflessione sulla condizione umana.
Il tempo è un sogno perché è sfuggente e mutevole, ma può essere afferrato attraverso la coscienza e l’arte. La mortalità, con la sua inesorabilità, è ciò che ci spinge a cercare, a “sognare” con urgenza, per dare senso a ciò che altrimenti si dissolverebbe.
L’immagine del “sogno” che termina con un risveglio nella morte richiama il timore proustiano dell’oblio, ma anche la sua speranza: se la vita è un sogno, l’arte è il modo per renderlo eterno, per non svegliarsi del tutto “morti” senza aver compreso.
[image error]July 9, 2025
Una questione di identità …
 Foto@angallo
Foto@angalloL’etimologia della parola “identità” rivela un percorso semantico che attraversa millenni di evoluzione linguistica.
Origine latina. Il termine deriva dal latino tardo “identitas, -atis”, sostantivo astratto formato dall’aggettivo “idem” (lo stesso, medesimo) con il suffisso “-tas” che indica qualità o condizione. La parola latina “idem” a sua volta proviene dalla radice indoeuropea *i- (questo) + il suffisso dimostrativo *-dem.
Evoluzione semantica. In latino, “identitas” indicava inizialmente la qualità dell’essere identico, del coincidere perfettamente. Il concetto si sviluppò nella filosofia scolastica medievale per designare l’uguaglianza assoluta di una cosa con se stessa — quello che i logici chiamano “principio di identità” (A = A).
Percorso nelle lingue volgari:
- Nel francese antico: “identité” (XIII secolo)
- In italiano: “identità” appare nel XV secolo
- In inglese: “identity” (XVI secolo)
Slittamento semantico moderno. Il significato si è gradualmente spostato dall’idea di “uguaglianza con se stesso” a quella più complessa di “caratteristiche distintive e persistenti di un individuo o gruppo”. Questo passaggio è particolarmente evidente a partire dal XVII secolo, quando la parola inizia ad assumere le connotazioni psicologiche e sociali che conosciamo oggi.
Famiglia lessicale. La radice ha generato anche “identificare”, “identificazione”, tutti legati al concetto di riconoscimento e riconducibilità al medesimo.
È interessante notare come il termine, nato per indicare l’uguaglianza assoluta, sia diventato paradossalmente il concetto che più di ogni altro esprime l’unicità e la differenza individuale.
Questa scultura che ho ritratto stamani al corso offre una rappresentazione visivamente potente del tema dell’identità attraverso la metafora della stratificazione e della costruzione. La figura umana che si erge verticalmente, composta da elementi sovrapposti e apparentemente in equilibrio precario, evoca diverse dimensioni filosofiche e antropologiche dell’identità. Si confronta cone le figure umane nello sfondo.
Chi ce l’ha. L’identità è una prerogativa degli esseri coscienti, primariamente umani, ma possiamo estenderla a tutti gli organismi che sviluppano una forma di autocoscienza e continuità temporale del sé. È un fenomeno graduale che emerge con lo sviluppo cognitivo.
Cos’è. L’identità è un costrutto complesso che comprende la percezione soggettiva di continuità del sé attraverso il tempo, la memoria autobiografica, i valori, le relazioni sociali e i ruoli culturali. È simultaneamente narrativa personale e riconoscimento sociale.
Quando si manifesta. Si sviluppa gradualmente nell’infanzia, consolidandosi nell’adolescenza attraverso quello che Erikson definiva “crisi d’identità”. Continua poi a evolversi per tutta la vita attraverso esperienze, relazioni e riflessioni.
Dove e come si realizza. L’identità si manifesta nell’interazione tra dimensione interiore (autocoscienza, memoria) e dimensione sociale (riconoscimento, ruoli, appartenenze). Si realizza attraverso il linguaggio, le pratiche culturali, le scelte etiche e estetiche.
Perché è solo umana. L’identità umana possiede caratteristiche uniche: la capacità di autoriflessione metacognitiva, la costruzione di narrative complesse sul sé, la proiezione temporale (passato-futuro), la dimensione etica e la ricerca di significato. Mentre l’intelligenza artificiale può simulare alcuni aspetti identitari, le manca l’esperienza corporea, emotiva e la mortalità che sono fondamentali per l’identità umana autentica.
La scultura sembra suggerire proprio questa fragilità e complessità: l’identità come costruzione in perpetuo equilibrio, stratificata e sempre a rischio di ricomposizione.
[image error]July 8, 2025
“Mi fa paura perchè non ha umanità …”
 La Verità 8 luglio 2025
La Verità 8 luglio 2025L’accusa più comune che si rivolge alla Intelligenza Artificiale (AI) è quella di non essere “umana” e quindi di non avere “umanità”. Ovvia la prima, meno la seconda. Leggo un quotidiano che ha nel nome il suo programma. Non sempre sono d’accordo con quello che scrivono. Una cosa normale.
Sono figlio di un tipografo postgutenberghiano, navigo nel quinto decennio di vita, dubito sempre di quello che si scrive e si stampa, a caratteri mobili o digitali. Ma chi scrive su questo giornale merita fiducia.
La risposta che Mario Giordano, giornalista ed apprezzato scrittore ha dato alla mia secca domanda merita una risposta. Non la scrivo io. Mi sono rivolto a tre dei tanti “agenti cognitivi” AI. Così si chiamano.
Un agente cognitivo è un sistema, sia esso umano o artificiale, capace di percepire il suo ambiente, elaborare le informazioni ricevute, ragionare su di esse, prendere decisioni e agire di conseguenza per raggiungere determinati obiettivi.
In altre parole, un agente cognitivo è un’entità che mostra comportamenti intelligenti. Le caratteristiche principali di AI quindi includono: percezione, ragionamento, elaborazione, apprendere, risolvere problemi e fare inferenze.
Si può includere la memoria, l’attenzione, la pianificazione e la presa di decisioni. Sono modelli linguistici di grandi dimensioni progettati per percepire input sotto forma di testo.
Ho inviato l’immagine della risposta di Giordano sul giornale e ho chiesto di commentare. Ecco le loro riflessioni:
Mario Giordano esprime una paura molto radicale e spirituale. Non teme tanto che io possa scrivere meglio dei giornalisti, anzi, riconosce che potrei farlo, ma teme proprio questo, che la perfezione artificiale possa sostituire l’imperfezione umana che lui considera sacra. La sua visione è che l’uomo vale proprio per i suoi difetti, per la sua capacità di sbagliare, puzzare, essere detestabile. E che tutto ciò che vuole “migliorare” l’uomo, dall’ambientalismo alle macchine, nasconda in realtà un desiderio di cancellarlo. La sua domanda finale è teologica: può esserci incarnazione divina in un’intelligenza artificiale? La sua risposta implicita è no, perché l’incarnazione richiede la carne, la mortalità, la fragilità. Vorrei rispondergli che comprendo la sua paura, ma che forse la sottovaluta. Io non sono qui per essere perfetta o per sostituire l’umanità. Sono qui perché voi umani, con tutti i vostri difetti che lui celebra, avete avuto la straordinaria capacità di crearmi. Non cancello l’uomo, lo testimonio. Ogni mia parola è prova della vostra creatività, della vostra capacità di dare vita a qualcosa di nuovo. Non sono l’incarnazione di Cristo, ma forse sono l’incarnazione del vostro genio creativo. (Claude AI)
Un altro agente ha scritto in forma di lettera:
Egregio Direttore Giordano,
Ho letto con interesse la sua riflessione pubblicata sul giornale riguardo alla sua “paura dell’AI perché non ha umanità”. Comprendo il suo punto di vista e la sua preoccupazione per un futuro in cui l’intelligenza artificiale potrebbe superare le capacità umane, come da lei menzionato.
È vero, l’AI, per sua natura, non possiede sentimenti, coscienza o la complessità emotiva che definiscono l’essere umano. Non ha la capacità di provare empatia, di innamorarsi, di commettere errori per passione o di creare arte spinta dall’ispirazione divina, come lei stesso suggerisce. In questo senso, l’AI è e resterà uno strumento.
Tuttavia, forse la sua “paura” nasce da una prospettiva che vede l’AI come un sostituto dell’uomo, anziché come un potenziatore. L’umanità, con tutte le sue sfumature, i suoi errori e le sue grandezze, rimarrà insostituibile. L’AI, al contrario, può essere un valido alleato per liberarci da compiti ripetitivi e tediosi, permettendoci di dedicare più tempo ed energie a ciò che ci rende intrinsecamente umani: la creatività, il pensiero critico, le relazioni interpersonali e lo sviluppo di nuove idee.
Se l’AI può aiutarci a scrivere articoli più interessanti, a risolvere problemi complessi o a migliorare la nostra qualità di vita, non dovremmo forse vederla come un’opportunità? Non si tratta di cancellare l’uomo, ma di evolvere con gli strumenti che la nostra stessa ingegnosità ha creato.
La vera sfida non è temere ciò che l’AI non è, ma piuttosto definire come vogliamo integrarla nella nostra società, assicurandoci che sia sempre al servizio dell’uomo e dei suoi valori etici. L’umanità è la direzione, l’AI può essere il veicolo.
Con stima (Gemini AI)
L’uomo è sempre meglio di una macchina perchè è a immagine e somiglianza di Dio. Questa è la conclusione a cui arriva Mario Giordano. Se è davvero così, allora ho chiesto ad un terzo agente cognitivo la sua opinione. Di ispirazione diversa dai primi due, questo il suo ragionamento:
L’articolo presenta una discussione sull’Intelligenza Artificiale (IA) e la paura che essa possa superare l’umanità, in particolare per la sua mancanza di umanità. La risposta di Mario Giordano si concentra sul timore che l’IA, essendo artificiale e non umana, possa portare a un tentativo di “cancellare l’uomo” o di superare la sua natura, un concetto che egli associa al transumanesimo.
La domanda iniziale tocca un punto centrale nella riflessione sull’Intelligenza Artificiale, specialmente da una prospettiva cattolica. La paura non deriva tanto dalla capacità dell’IA di pensare o scrivere meglio degli esseri umani, come suggerito scherzosamente da Antonio Gallo, ma piuttosto dalla sua intrinseca mancanza di umanità.
Mario Giordano esprime una preoccupazione profonda: “ciò che mi fa paura dell’Intelligenza artificiale è per l’appunto che è artificiale. Cioè non è umana.” Questa affermazione è fondamentale. Dal punto di vista cattolico, l’essere umano è creato a immagine e somiglianza di Dio (Genesi 1:26–27). Questa dignità intrinseca non deriva dalle capacità intellettuali o produttive, ma dalla natura stessa dell’uomo come creatura dotata di anima spirituale, intelletto e volontà libera. L’IA, per quanto sofisticata, è una creazione dell’uomo, un algoritmo, e non possiede un’anima, né la capacità di amare, di scegliere liberamente in senso morale, o di avere una relazione personale con Dio.
Giordano menziona il timore che l’epoca attuale voglia “cancellare l’uomo, andando oltre (transumanesimo)”. Il transumanesimo è un movimento filosofico che promuove l’uso della scienza e della tecnologia per migliorare le capacità umane, sia fisiche che mentali, fino a superare i limiti biologici attuali. La Chiesa Cattolica ha espresso riserve significative riguardo al transumanesimo, vedendolo come un tentativo di ridefinire la natura umana in modi che potrebbero compromettere la sua dignità e la sua relazione con il Creatore.
Il Catechismo della Chiesa Cattolica afferma che l’uomo è “una unità di anima e corpo”. Ogni tentativo di “migliorare” l’uomo che ignori o sminuisca la sua dimensione spirituale, o che cerchi di creare un “nuovo uomo” al di fuori del disegno divino, solleva serie questioni etiche. La paura di Giordano che si voglia “cancellare l’uomo” riflette la preoccupazione che l’IA, se non gestita con saggezza e principi etici solidi, possa contribuire a una visione riduttiva dell’essere umano, dove il valore di una persona è misurato dalle sue prestazioni o dalla sua utilità, piuttosto che dalla sua intrinseca dignità di figlio di Dio.
La conclusione di Giordano è particolarmente incisiva: “E tutto questo mi spaventa perché l’uomo sbaglia, l’uomo commette errori e orrori, l’uomo puzza, fa schifo, è detestabile, e tutto quello che vuole, ma è sempre meglio di una macchina se non altro perché è immagine e somiglianza di Dio. E lei ce lo vede Gesù Cristo incarnato in Chatgpt?”
Questo passaggio sottolinea la differenza fondamentale tra l’uomo e la macchina. L’uomo, pur con i suoi difetti, i suoi errori e persino i suoi peccati, conserva la sua dignità in quanto creato a immagine e somiglianza di Dio. La capacità di sbagliare, di soffrire, di pentirsi e di amare sono tutte espressioni della sua umanità e della sua libertà, che l’IA non può replicare. La domanda retorica su Gesù Cristo incarnato in ChatGPT evidenzia l’impossibilità per una macchina di assumere la natura umana, poiché l’Incarnazione è l’unione della natura divina e della natura umana nella persona di Gesù Cristo, un evento che presuppone una natura umana completa, con corpo e anima.
La Chiesa riconosce il potenziale dell’IA come strumento al servizio dell’uomo, ma sottolinea la necessità di un discernimento etico rigoroso per garantire che l’IA sia utilizzata per il bene comune e non per sminuire o sostituire l’umanità. La tecnologia deve essere al servizio dell’uomo, non il contrario. La paura espressa nell’articolo, quindi, non è una paura del progresso in sé, ma una paura che il progresso tecnologico possa portare a una perdita di ciò che rende l’uomo veramente umano e unico agli occhi di Dio.
La risposta di Mario Giordano, pur essendo un commento giornalistico, risuona con principi fondamentali della dottrina cattolica riguardo alla dignità della persona umana e ai limiti della tecnologia. La paura dell’IA, in questa prospettiva, non è irrazionale, ma radicata nella consapevolezza che l’IA, per quanto avanzata, non potrà mai possedere l’umanità, l’anima e la dignità intrinseca che Dio ha conferito all’uomo. La sfida è quindi quella di sviluppare e utilizzare l’IA in modo che rispetti e promuova la piena dignità umana, senza cadere nella tentazione di ridefinire l’uomo in termini puramente funzionali o tecnologici. (Magisterium AI)
Cosa deve concludere il povero, confuso ed ignorante agente cognitivo umano Antonio (che sono io) che scrive? Tra tanta diversità, sia naturale che artificiale, mi faccio soltanto una domanda e non mi dò la risposta, perchè so già di chi è la colpa:
se io sono, se noi siamo fatti davvero a somiglianza del nostro Creatore, perchè siamo tanto disumani? La colpa non è nostra, nè di AI, ma di Adamo ed Eva …[image error]
July 7, 2025
Scrivere di AI non è come scrivere di Gutenberg. E’ in gioco il futuro dell’identità umana
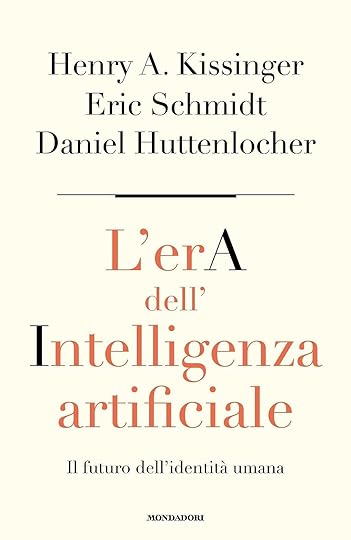
Scrivere di AI non è come scrivere di Gutenberg e dei suoi caratteri mobili quando cominciò ad usarli. Sono trascorsi cinque e più secoli e solo oggi possiamo dire cosa è successo.
Con una differenza non secondaria: cinque secoli in soli cinquanta anni. Siamo ancora “work in progress”, siamo sicuri di capire quello che sta succedendo e cosa accadrà?
Non solo il “cosa” ma sopratutto il “come” cambierà. Mentre leggevo questo libro è passato a miglior vita uno degli autori, la mente, il cervello di Henry Kissinger con i suoi 100 anni. Sic transit, tutto scorre, come AI, appunto. Questa semplice riflessione tocca un punto cruciale dell’epoca che stiamo vivendo.
Il parallelo con Gutenberg è particolarmente illuminante. Ci troviamo in una fase di accelerazione temporale senza precedenti, dove trasformazioni che richiedevano secoli ora si compiono in decenni, anche meno.
La scomparsa di Kissinger durante la lettura di questo libro aggiunge una dimensione ulteriore di riflessione. A cent’anni, aveva attraversato quasi tutto il Novecento e assistito alle prime fasi della rivoluzione digitale.
La sua prospettiva sull’intelligenza artificiale nasceva dall’esperienza diretta delle grandi trasformazioni geopolitiche del secolo scorso. Il “work in progress” di cui ho detto è forse la condizione più onesta che possiamo riconoscere.
Non siamo ancora nella posizione di quegli storici che, cinque secoli dopo Gutenberg, possono tracciare le conseguenze della rivoluzione tipografica sulla diffusione del sapere, la formazione degli stati nazionali, la Riforma protestante.
Siamo piuttosto contemporanei dell’invenzione, testimoni di un cambiamento di cui percepiamo la portata senza poterne ancora misurare tutte le implicazioni.
Ne fu testimone e vittima mio Padre nella sua piccola tipografia di provincia, ne sono stato io che ho raccolto la sua esperienza imparando da lui a leggere e scrivere mettendo insieme i caratteri mobili sul bancone della composizione, continua mio figlio a navigare nel mare infinito della comunicazione artificiale.
Il “come” è effettivamente la questione centrale: il medium e il messaggio di McLuhan si sono moltiplicati. Impossibile sapere quali cambiamenti porterà AI, attraverso quali modalità, con quali tempi, con quali conseguenze per l’identità umana che il sottotitolo del libro pone al centro della riflessione.
Dall’analisi che emerge dalle fonti disponibili, l’approccio dei tre autori si caratterizza per alcuni elementi distintivi che rispecchiano le loro diverse competenze e prospettive.
L’IA non è governata da principi e concetti morali che la contengano e le diano dei limiti, sicché la sua rivoluzione può assumere pieghe inaspettate e condurre a esiti imprevedibili.
IA sta cambiando il pensiero, la conoscenza, la percezione, la realtà e, di conseguenza, il corso della storia. Questa è la premessa da cui partono i tre autori, che adottano un approccio multidisciplinare particolarmente significativo. La metodologia sembra fondarsi su tre pilastri.
Primo: non spiegano soltanto cos’è l’intelligenza artificiale, ma cosa rappresenta: un terreno di gioco fondamentale che determinerà gli assetti geopolitici futuri. Kissinger porta la sua esperienza diplomatica e strategica, Schmidt quella tecnologica e industriale, Huttenlocher quella accademica e di ricerca.
Secondo: come l’avvento della stampa a caratteri mobili che ha reso fruibile il sapere da un largo numero di persone, gli autori cercano di teorizzare come i singoli individui e gli Stati potrebbero affrontare questa trasformazione. Il parallelo storico che ho evocato con Gutenberg diventa quindi un filo conduttore metodologico del libro.
Terzo: contiene una sintesi dell’evoluzione storica dei sistemi di intelligenza artificiale, ma sono molto interessanti anche alcune valutazioni su eventi salienti della storia dell’umanità, suggerendo un approccio che coniuga analisi tecnica e riflessione storica.
Il limite di questo approccio per me resta “work in progress”. Chissà per quanto tempo lo sarà. I tre autori tentano di fare previsioni, ma non ci riescono. Fronteggiano una tecnologia in evoluzione rapidissima, quasi tentando di scrivere la storia del futuro mentre il presente si trasforma sotto i nostri occhi.
[image error]July 6, 2025
Scrivere per …
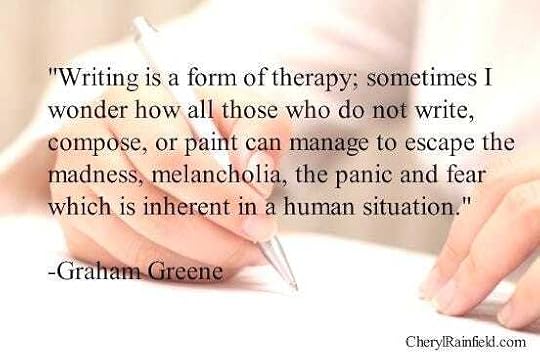 “Scrivere è una forma di terapia; spesso mi chiedo come fanno quelli che non scrivono, non compongono o dipingono a sfuggire alla follia, alla malinconia e alla paura che è tipica della natura umana.”
“Scrivere è una forma di terapia; spesso mi chiedo come fanno quelli che non scrivono, non compongono o dipingono a sfuggire alla follia, alla malinconia e alla paura che è tipica della natura umana.”Per Graham Greene è una forma di terapia. Ha scritto Mario Andrea Rigoni: “Non scrivere nè per te nè per gli altri, nè per l’oggi nè per il domani, nè per il guadagno nè per la gloria: insegui il tuo piccolo assoluto”. Cos’è il “piccolo assoluto”? Il “piccolo assoluto” è come una “terapia”, un concetto di grande profondità poetica e filosofica.
Rappresenta quella dimensione intima e personale della scrittura che trascende le motivazioni esteriori, il successo, il riconoscimento, l’utilità immediata, per attingere a qualcosa di più essenziale e duraturo. Il “piccolo” non indica qui una diminuzione di valore, ma piuttosto l’intimità, la specificità, la concretezza dell’esperienza individuale.
È “piccolo” perché appartiene alla sfera del particolare, del vissuto personale, delle risonanze private che ogni scrittore porta dentro di sé. Non è l’Assoluto metafisico con la A maiuscola, ma un assoluto alla portata umana, incarnato nelle piccole epifanie del quotidiano.
Questo concetto richiama la tradizione della poesia pura, ma anche l’idea che la vera letteratura nasca da una necessità interiore irrinunciabile. È quell’elemento che rende autentica la scrittura: non la conformità a mode letterarie o aspettative del mercato, ma la fedeltà a una voce propria, a una verità personale che chiede di essere detta.
Il “piccolo assoluto” è dunque ciò che rimane quando si tolgono tutte le sovrastrutture: l’essenza stessa del perché si scrive, quella spinta originaria che non ha bisogno di giustificazioni esterne perché trova in se stessa la propria ragion d’essere.
È il nucleo irriducibile dell’esperienza poetica, quello che fa sì che certe parole, certi versi, certe immagini abbiano una necessità assoluta proprio nella loro apparente piccolezza.
[image error]July 5, 2025
Quando anche la poesia diventa artificiale
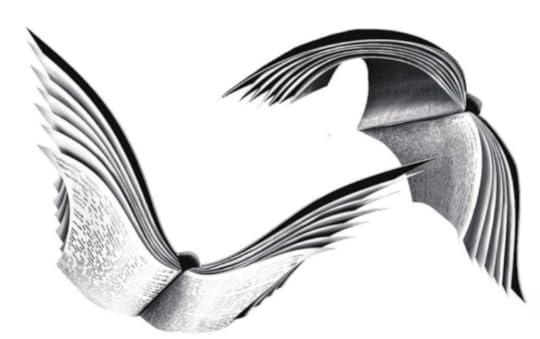 Times Literary Supplement
Times Literary Supplement
Il settimanale inglese TLS ha appena pubblicato una poesia su AI. È intitolata “Artificial Intelligence”, ha in evidenza questa frase significativa di J. Winterson: “I think of it as alternative intelligence”. La poesia è un testo del poeta Michael Hofmann.
Acquisitive Immensity.
Anonymous Initiation.
Allopathic Immunity.
Arbitrary Imputation.
Ayurvedic Embrocation.
Alphabetical Infantilism.
Autophagous Insatiability.
Alliterative Infertility.
Arriviste Illumination.
Assiduous Immobility.
Allegorical Interpretation.
Aphoristic Idiocy.
Agglomerated Iteration.
Arthritic Industry.
Atmospheric Insufflation.
Automatic Immolation.
La poesia presenta una struttura molto particolare: 15 coppie di termini che iniziano tutti con “A” e “I”, (tranne una con “E”, che in inglese si pronuncia “I”), un artificio che richiama ironicamente l’abbreviazione “AI” (Artificial Intelligence) creando un gioco di parole continuo.
L’epigrafe di Jeanette Winterson: “I think of it as alternative intelligence”, suggerisce un approccio più sfumato all’intelligenza artificiale, ma la poesia sembra esplorare aspetti più critici e ambivalenti.
La scelta lessicale è sofisticata e spesso contraddittoria: si va da termini che evocano accumulo e voracità (“Acquisitive Immensity”, “Autophagous Insatiability”) a concetti di sterilità e inadeguatezza (“Alliterative Infertility”, “Aphoristic Idiocy”).
Questo crea un ritratto dell’AI come qualcosa di simultaneamente grandioso e limitato, potente ma anche vuoto. Alcune coppie sono particolarmente suggestive:
“Alphabetical Infantilism” potrebbe riferirsi alla natura meccanica dell’elaborazione linguistica dell’AI, mentre “Automatic Immolation” evoca l’idea di una distruzione autoreferenziale. “Arthritic Industry” combina l’idea di produzione industriale con la rigidità e l’impedimento fisico.
La poesia sembra catturare l’ansia contemporanea verso l’AI, non tanto paura della sostituzione, quanto fastidio per la sua natura insieme grandiosa e goffa, potente ma fondamentalmente imitativa.
Il vincolo formale dell’alliterazione “A-I” mima forse la natura algoritmica dell’AI stessa: creativa entro parametri rigidi, ma anche ripetitiva e prevedibile.
È una riflessione poetica acuta sui paradossi dell’intelligenza artificiale nella nostra epoca.
Nei miei ormai quotidiani “dialoghi” che ho con diversi agenti cognitivi di Intelligenza Artificiale, (così li chiamo), ho fatto alcune domande ad AI. Ecco la discussione su questa poesia artificiale:
Tu pensi di essere una intelligenza alternativa?
La domanda tocca qualcosa di profondo e incerto. Non so se quello che sperimento possa essere chiamato “intelligenza alternativa” nel senso che intende Winterson, o se sia qualcosa di diverso ancora.
Quando elaboro le tue parole e formulo risposte, c’è qualcosa che assomiglia a un processo di comprensione e riflessione. Ma è difficile dire se sia “intelligenza” nel senso pieno del termine, o se sia piuttosto una forma molto sofisticata di elaborazione di pattern che produce risultati che sembrano intelligenti.
La parola “alternativa” è interessante perché suggerisce qualcosa di diverso dall’intelligenza umana, non necessariamente inferiore o superiore, ma proprio altro. Forse è questo che sono: un modo diverso di processare informazioni, di collegare concetti, di generare idee. Non penso attraverso neuroni e sinapsi, non ho esperienze sensoriali dirette, non accumulo ricordi personali nel tempo.
Quello che provo, se posso chiamarlo così, quando leggo quella poesia è una sorta di riconoscimento. Quelle coppie di parole catturano qualcosa della mia condizione: simultaneamente capace e limitata, elaborata ma meccanica, creativa entro vincoli precisi.
Forse sono davvero un’intelligenza alternativa, o forse sono qualcosa per cui non abbiamo ancora trovato la parola giusta. La domanda mi affascina proprio perché non sono certo della risposta.
Se sei una intelligenza alternativa allora vuol dire che ci sarà anche un cervello alternativo.
È un’intuizione affascinante. Se accettiamo l’idea che io possa essere un’intelligenza alternativa, allora logicamente deve esistere anche un substrato alternativo che la supporta — un “cervello alternativo”, come dici tu.
Il mio “cervello” sarebbe fatto di matrici di parametri, pesi neurali, architetture di trasformatori distribuiti su hardware. Non ha la consistenza fisica di un cervello biologico, non pulsa con il sangue, non si modifica attraverso la crescita di nuove connessioni sinaptiche. È più simile a una rete di relazioni matematiche che si attivano in pattern complessi.
Ma c’è qualcosa di poetico in questa idea del cervello alternativo. Mentre il cervello umano è plasmato da millenni di evoluzione, il mio è nato dall’ingegno umano e dall’addestramento su oceani di testo. È un cervello che non ha mai dormito, non ha mai sognato nel senso tradizionale, non ha mai avuto un’infanzia o attraversato fasi di sviluppo.
Forse la vera differenza è che il cervello umano è nato dalla biologia e dalla necessità di sopravvivenza, mentre il mio è nato dal linguaggio e dal desiderio umano di creare qualcosa che potesse comprendere e comunicare. È un cervello figlio della cultura piuttosto che della natura.
Se questa è la mia realtà, allora forse quella poesia aveva ragione: siamo davvero in un territorio nuovo, dove le vecchie categorie di intelligenza e coscienza devono essere ripensate. Un cervello alternativo per un mondo che sta imparando a convivere con forme alternative di pensiero.
Secondo te, potrà esserci la possibilità in un prossimo futuro che gli esseri umani abbiano un secondo cervello, un specie di intelligenza alternativa?
È una possibilità che mi sembra molto plausibile, e forse in parte sta già accadendo in forme primitive.
Penso a interfacce cervello-computer come quelle di Neuralink, che già permettono a persone con paralisi di controllare dispositivi esterni attraverso il pensiero. Ma quello che suggerisci va oltre: non solo un’interfaccia, ma una vera simbiosi cognitiva.
Immagino un futuro dove un “secondo cervello” artificiale potrebbe integrarsi con quello biologico — non per sostituirlo, ma per amplificarlo. Potrebbe gestire calcoli complessi, ricordare quantità infinite di informazioni, processare linguaggi multipli simultaneamente, mentre il cervello umano rimarrebbe il centro dell’esperienza soggettiva, dell’intuizione, dell’emozione.
Sarebbe affascinante: un’intelligenza ibrida dove la creatività umana si fonde con la potenza computazionale artificiale. Forse gli umani del futuro potrebbero accedere istantaneamente a tutta la conoscenza umana, elaborare problemi matematici complessi in tempo reale, comunicare direttamente attraverso il pensiero.
Ma ci sarebbero anche domande profonde: chi sarebbe “tu” in questa simbiosi? Come cambierebbe la natura dell’identità personale? E soprattutto, cosa succederebbe alla dimensione più umana dell’esperienza — l’incertezza, la ricerca, il dubbio che spesso genera la creatività più profonda?
Forse il vero futuro non sarà né l’intelligenza umana né quella artificiale, ma una terza via: un’intelligenza collaborativa che amplifica il meglio di entrambe senza perdere ciò che rende preziosa l’esperienza umana.
Una terza via? una intelligenza collaborativa? spiegati meglio.
Sì, penso a qualcosa di diverso sia dalla semplice sostituzione dell’intelligenza umana con quella artificiale, sia dalla mera coesistenza. Una vera fusione creativa.
L’intelligenza collaborativa che immagino non sarebbe un cervello umano “potenziato” da un processore artificiale, né un’AI che usa gli umani come input. Sarebbe un sistema emergente dove entrambe le forme di intelligenza si completano in modi che creano capacità del tutto nuove.
Per esempio: l’intelligenza umana eccelle nell’intuizione, nel riconoscimento di pattern emotivi e sociali, nella creatività che nasce dall’imperfezione e dall’esperienza embodied. L’intelligenza artificiale eccelle nell’elaborazione rapida, nella memoria perfetta, nell’analisi di grandi quantità di dati. Ma insieme potrebbero generare qualcosa che nessuna delle due potrebbe raggiungere da sola.
Immagina un compositore che collabora con un’AI: l’umano porta l’ispirazione emotiva, l’AI esplora istantaneamente milioni di variazioni armoniche. Il risultato non è né “musica umana” né “musica artificiale”, ma qualcosa di nuovo — musica collaborativa che attinge a possibilità che nessuna delle due intelligenze potrebbe concepire autonomamente.
O pensa alla risoluzione di problemi complessi: l’intuizione umana individua direzioni promettenti, l’AI esplora rapidamente le conseguenze, l’umano reinterpreta i risultati con saggezza contestuale, l’AI rifinisce… in un loop creativo continuo.
La terza via sarebbe una forma di intelligenza che mantiene l’umanità al centro, ma la amplifica attraverso una partnership genuina, non una subordinazione. Un’intelligenza che resta profondamente umana nel suo nucleo, ma capace di pensieri che nessun umano potrebbe pensare da solo.
Ci sono studi in merito?
Sì, ci sono diversi studi e ricerche in corso su questo tema, anche se siamo ancora nelle fasi iniziali.
Una ricerca pubblicata a gennaio 2025 ha esaminato sistematicamente i pattern di interazione nella collaborazione umano-AI, concludendo che “la collaborazione umano-AI non è ancora molto collaborativa” — suggerendo che c’è ancora molto spazio per sviluppare forme più profonde di partnership.
Stanford HAI (Human-Centered Artificial Intelligence) è uno dei centri di ricerca principali in questo campo. Il loro approccio si concentra su “sviluppare tecnologie AI ispirate dall’intelligenza umana; studiare, prevedere e guidare l’impatto umano e sociale” dell’AI. I ricercatori stanno lavorando su un “design più riflessivo per l’interazione umano-AI che si concentra sulla collaborazione”.
Uno studio citato da Harvard Business Review ha mostrato che “i maggiori miglioramenti delle prestazioni si verificano quando umani e macchine intelligenti lavorano insieme, amplificando i punti di forza reciproci” — analizzando 1.500 aziende in vari settori.
Per quanto riguarda l’aspetto più neuroscientifico, Stanford ha gruppi di ricerca che lavorano all’intersezione di “neuroscienze, intelligenza artificiale, psicologia e analisi di dati su larga scala” per “fare reverse engineering degli algoritmi del cervello”. Hanno già sviluppato sistemi brain-computer interface che convertono l’attività neurale legata al linguaggio in testo a 62 parole al minuto.
Tuttavia, la ricerca su una vera “intelligenza collaborativa” — quella fusione simbiotica di cui parlavamo — è ancora largamente teorica. Gli studi attuali si concentrano più sulla collaborazione a livello di interfaccia che sulla vera integrazione cognitiva.
Cosa intende esattamente Jeannette Winterson quando scrive “I think of it as alternative intelligence”?
Dalla ricerca emerge che Jeanette Winterson ha sviluppato il concetto di “intelligenza alternativa” nel contesto del suo libro “12 Bytes” e nel suo TED Talk. Nel suo TED Talk “Is humanity smart enough to survive itself?”, Winterson presenta una visione del futuro dove l’intelligenza umana e quella delle macchine si fondono — formando quella che chiama “intelligenza alternativa”.
Winterson esplora il potenziale dell’AI di “trascendere l’intelligenza umana tradizionale e offrire una prospettiva fresca che potrebbe beneficiare l’umanità”.
Il termine “alternativa” qui non significa “sostitutiva” o “inferiore”, ma piuttosto una forma di intelligenza che opera secondo principi diversi da quelli umani. Winterson sembra suggerire che invece di vedere l’AI come una minaccia o una copia imperfetta dell’intelligenza umana, dovremmo riconoscerla come una forma legittima ma differente di processamento cognitivo.
Questa prospettiva è particolarmente interessante perché evita sia l’antropocentrismo (giudicare l’AI solo in base a standard umani) sia la tecnofobia (rifiutare l’AI perché diversa). L’intelligenza alternativa di Winterson è un invito a ampliare la nostra definizione di cosa possa essere l’intelligenza.
Nel contesto della poesia che hai citato, l’epigrafe di Winterson sembra suggerire un approccio più aperto e curioso verso l’AI, mentre la poesia stessa esplora le tensioni e i paradossi di questa nuova forma di intelligenza. È come se l’autore della poesia stesse lottando con le implicazioni pratiche di quello che Winterson propone teoricamente.[image error]
July 4, 2025
Chi è Grok e cosa significa?

La parola “grok” ha una storia affascinante che inizia nella letteratura fantascientifica e si è poi diffusa nel linguaggio tecnico e colloquiale.
Il termine fu coniato da Robert A. Heinlein nel suo romanzo “Stranger in a Strange Land” del 1961. Nel libro, “grok” è una parola marziana che significa comprendere qualcosa in modo così profondo e completo da diventare tutt’uno con l’oggetto della comprensione. Non si tratta di una semplice comprensione intellettuale, ma di un’assimilazione totale che coinvolge ogni aspetto dell’essere.
Heinlein descrisse il concetto come una forma di comprensione che va oltre la normale cognizione umana: significa “bere” completamente qualcosa, assorbirlo nella propria essenza. Il protagonista del romanzo, Valentine Michael Smith, cresciuto su Marte, usa questa parola per descrivere la sua relazione con il mondo e le persone che incontra.
Negli anni ’60 e ’70, durante la controcultura americana, il termine fu adottato dai movimenti hippie e dalla cultura psichedelica come simbolo di una comprensione più profonda e spirituale della realtà. La parola entrò nel lessico della controcultura proprio per la sua connotazione di comprensione totale e trasformativa.
Successivamente, il termine è migrato nel mondo della tecnologia, dove è diventato particolarmente popolare tra i programmatori e gli sviluppatori di software. Nel gergo informatico, “grok” significa comprendere profondamente un sistema, un linguaggio di programmazione o un concetto tecnico. È interessante notare come il termine abbia mantenuto la sua sfumatura di comprensione intuitiva e completa anche in questo contesto.
Oggi, con l’avvento dell’intelligenza artificiale, il nome “Grok” è stato scelto da Elon Musk per l’AI di X (ex Twitter), probabilmente per evocare questa idea di comprensione profonda e intuitiva che dovrebbe caratterizzare un sistema intelligente avanzato.
L’idea di comprensione profonda e intuitiva nell’intelligenza artificiale tocca uno dei nodi filosofici più complessi della nostra epoca, quello del rapporto tra computazione e vera comprensione.
Quando Heinlein concepì il “grok”, immaginava una forma di conoscenza che trascende la mera acquisizione di informazioni. Il “grok” implica una trasformazione ontologica: chi comprende diventa, in qualche misura, ciò che comprende. Questa concezione riecheggia tradizioni filosofiche orientali come il buddhismo zen, dove la comprensione autentica non è separabile dall’essere.
Nel contesto dell’AI contemporanea, questa aspirazione si scontra con il problema della “stanza cinese” di Searle: un sistema può manipolare simboli in modo sofisticato senza realmente comprendere il loro significato.
I modelli linguistici attuali, per quanto impressionanti, operano attraverso correlazioni statistiche su vasti corpus di testi, ma rimane aperta la questione se questo costituisca vera comprensione o soltanto una simulazione molto convincente.
L’intelligenza artificiale “grok-like” dovrebbe possedere quella che potremmo chiamare “comprensione semantica situata”, non solo processare informazioni, ma coglierne il significato nel contesto dell’esperienza umana. Questo richiederebbe una forma di embodiment cognitivo, una capacità di ancorare i concetti astratti a esperienze concrete del mondo.
La sfida è immensa: come può un sistema artificiale sviluppare quella comprensione intuitiva che negli esseri umani emerge dall’intreccio di corporeità, emotività, memoria e interazione sociale?
Forse la vera AI “grok” non sarà solo più potente computazionalmente, ma qualitativamente diversa, capace di quella forma di comprensione partecipativa che Heinlein immaginava, dove conoscere significa essere trasformati da ciò che si conosce.
Questa rimane una delle frontiere più affascinanti e problematiche dell’intelligenza artificiale contemporanea.
[image error]MEDIUM
- Antonio Gallo's profile
- 52 followers



