Antonio Gallo's Blog: MEDIUM, page 64
January 2, 2023
Entrare nell’Eternità e rompere il velo della “nebbia”
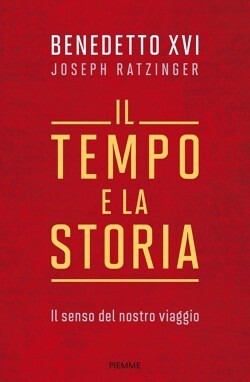 Il Libro
Il Libro
Mi sono andato a rileggere (5 aprile 2017) quello che scrissi sul libro del Papa Emerito Benedetto XVI “Il tempo e la storia”: “Mentre tutto passa, Dio è oggi, ieri e domani, contemporaneo a ogni tempo e anteriore a ogni tempo. E noi siamo sue creature, destinate all’eternità”. Lui ci è già entrato nell’eternità …
Questo è uno di quei libri che non si “bruciano” sull’altare dell’attualità, non è per i gusti ed i piaceri di chi fa della lettura un “mordi e fuggi”, un “chit-chat”, una aforisma da social su Facebook. Leggere quello che scrive una persona di novanta anni è sempre una scoperta, un’avventura, un viaggio nel tempo da lui vissuto. Quando poi chi scrive non è uno che usa la penna o la tastiera per far sapere agli altri quello che pensa, ma uno studioso che possiede già di per sè il senso delle cose e della storia, un teologo, un filosofo e per giunta anche un germanico.
Se a tutto questo aggiungete che questa persona è anche una figura religiosa mai esistita prima nella storia delle religioni e della religione cristiana in particolare, un “Papa Emerito”, che si affianca da vivo ad un altro Papa in carica, allora avrete la certezza di leggere qualcosa che arde sull’altare dell’intelligenza della storia e del tempo degli uomini. Le parole chiave stanno tutte nel titolo del libro: tempo, storia, senso, viaggio. Io penso che non sia il caso di dire altro in questa recensione. Chi crede, come anche chi non crede, deve leggere questo libro.
Scrive Benedetto: “L’uomo di oggi ha lo sguardo rivolto al futuro. La sua parola d’ordine è “progresso”, non “tradizione”, “speranza” o “fede”. Egli conosce anche un certo romanticismo per il passato. Ama circondarsi di oggetti preziosi della storia, ma tutto questo conferma soltanto che quei tempi sono passati e che il regno dell’uomo di oggi è proprio il domani, il mondo che lui stesso costruisce”.
Le parole che sceglie il Papa Emerito, sulla soglia dei suoi 90 anni, sono le stesse alle quali, quasi certamente, pensava Marlowe per bocca di Faust. Le stesse alle quali penso io oggi: “progresso”, “tradizione”, “speranza”, “fede”. Quanti libri dovrei, anzi dovremmo leggere per capire il senso dei pensieri che si nascondono dietro queste parole?
E quanti se ne dovrebbero ancora scrivere senza trovare una risposta, quella per la quale Faust tentò di giocarsi la partita con Mefistofele? La perse ovviamente, come la perderanno sempre tutti quegli uomini i quali credono di poter abbracciare l’idea di “progresso”, inteso come “conoscenza”, senza porre limiti, senza essere ossessionati come Faust dall’idea della vita eterna, magari ottenuta tramite la tecnologia?
Se dietro questa parola, “tecnologia”, si nasconde il “progresso”, e se dietro di questo ritroviamo “Mefistofele” con le sue illusioni ed i suoi inganni, il pensiero di bruciare i libri, di sicuro ci prenderebbe subito. La conoscenza resterebbe una illusione, un inganno, una “nebbia”, per dirla ancora una volta con Qohelet. La tentazione di bruciare tutti i libri sarebbe quanto mai forte, ma questo segnerebbe la vittoria proprio di Mefistofele.
Lui vorrebbe proprio questo, che il grido-imprecazione di Faust, “brucerò i libri”, sarebbe nostro, perchè tanto questa misteriosa conoscenza non ci fa conoscere un bel nulla. Dobbiamo invece convincerci, seguendo il pensiero di Benedetto XVI che gli uomini “sono testimoni dell’incompiutezza di ogni essere esistente, testimoni di una realtà che non è uno stato ma un divenire”.
Il Qohelet, o l’Ecclesiaste, con quella parola “nebbia” intendeva anche quello che, a mio parere, caratterizza tutta la condizione umana, l’essenza della nostra esistenza, le ragioni del nostro vivere, l’idea che dovremmo avere della nostra vita. Il rischio della “nebbia” si nasconde nella parola “vanità”. Quella stessa, identica, eterna vanità che illuse i nostri progenitori, ingannò Mefistofele e continua ancora oggi a cercare di ingannare anche me, voi tutti, con la nostra sete di conoscenza.[image error]
December 31, 2022
December 27, 2022
La parola dell’anno è “globin mode”

Ogni anno gli editori di dizionari e le società linguistiche scelgono una parola dell’anno. Raramente la scelta è facile. “Oxford Dictionaries” ha fatto una scelta quest’anno che ha provocato grattacapi tra coloro che non avevano mai sentito parlare della lingua scelta per il 2022. È difficile trovare una parola che sia creativa, memorabile e che possa avere successo, rappresentando in qualche modo l’anno.
Quest’anno la parola vincitrice è stata particolarmente social. Dopo aver spaziato sulla tecnologia, l’economia, la guerra in Ucraina e gli effetti persistenti del covid-19, hanno optato per una parola-frase che ha rimodellato le nostre vite, una parola per riassumere il senso del nostro vissuto nel 2022, in una modalità sociale. Appunto, la “goblin mode”.
Sono due parole, a dire il vero. Riferite per lo più alla realtà di lingua inglese, ma coinvolge un modo di vivere e pensare diventati subito “social” e “global”, come tendono a diventare le lingue nel mondo contemporaneo. Bisogna capire il perchè.
A differenza delle precedenti parole vincitrici, scelte sulla base di analisi dei dati linguistici in uso, la parola di quest’anno è stata scelta dal voto pubblico. “Oxford Languages” ha selezionato le tre contendenti per il 2022, ciascuna intesa a riflettere “l’etica, l’umore o le preoccupazioni degli ultimi dodici mesi”.
Le parole erano “metaverso”, “ #IStandWith”, (iostocon) “goblin mode”. Con il 93 percento dei voti del pubblico, la “modalità goblin” è stata la chiara vincitrice per voti. La parola dell’anno della gente.
Il termine è definito come “un tipo di comportamento che è fortemente autoindulgente, pigro, sciatto o avido, tipicamente in un modo che rifiuta le norme o le aspettative sociali”, secondo una dichiarazione di “Oxford Languages”.
“Modalità folletto” diremmo in italiano, definendo il soggetto “goblin”. Un termine anche gergale che rifiuta le norme o le aspettative sociali. Sebbene l’espressione sia stata vista per la prima volta su Twitter nel 2009, la “modalità goblin” è diventata virale sui social media nel febbraio 2022, facendosi rapidamente strada su giornali e riviste, dopo essere stata twittata in un titolo fittizio.
Il termine è poi diventato popolare nei mesi successivi, quando le restrizioni al blocco del Covid si sono allentate in molti paesi e le persone si sono avventurate fuori di casa più regolarmente.
L’espressione sembra aver catturato lo stato d’animo prevalente di individui che hanno rifiutato l’idea di tornare alla “vita normale”, o si sono ribellati agli standard estetici sempre più irraggiungibili e agli stili di vita insostenibili esibiti sui social media. Casper Grathwohl, presidente di Oxford Languages, ha affermato che le persone hanno abbracciato il loro folletto interiore. Ha aggiunto:
“Speravamo che al pubblico sarebbe piaciuto essere coinvolto nel processo, ma questo livello di coinvolgimento con la campagna ci ha colto totalmente di sorpresa. La forza della risposta evidenzia quanto sia importante il nostro vocabolario per capire chi siamo, ed elaborare ciò che sta accadendo nel mondo che ci circonda. Dato l’anno che abbiamo appena vissuto, la ‘modalità goblin’ ricade su tutti noi che ci sentiamo un po’ sopraffatti e, a questo punto, manifestiamo questo sentimento con i nostri messaggi sui social.”
Il secondo classificato è stato “metaverse”, le “follie digitali” del futuro con 14.484 voti, seguito da “#IStandWith” con 8.639 voti e il pensiero rivolto alle “follie” della guerra in Ucraina. Sembra, per certi versi, una scelta piuttosto frivola, ma in realtà più approfondisci e più ti rendi conto che in realtà è una sorta di reazione allo stato di cose esistente.
Ci siamo sentiti essere una specie che tende a ritirarsi, richiudersi, isolarsi e non volere più che la nostra vita sia curata dai filtri avvolti in una sorte di follia magica e tragica. La parola dell’anno dell’anno scorso era stata “vax”, e faceva eco ad una specie di sopravvivenza necessaria.
La “modalità Goblin” è un neologismo per il rifiuto delle aspettative della società e l’atto di vivere in modo trasandato ed edonistico senza preoccuparsi della propria immagine di sé.
Sebbene l’uso del termine risalga al 2009 con definizioni diverse, è diventato virale nel 2022 a causa di un tweet del popolare “shitposter” di Twitter @JUNlPER con un titolo di notizie falsificato di un’intervista con l’attrice Julia Fox, che affermava di aver usato la frase.
Il termine è diventato rapidamente virale su piattaforme di social media come TikTok, spesso in risposta ad altre tendenze. Nell’aprile 2022, il magnate degli affari Elon Musk ha pubblicato una macro immagine attribuendo implicitamente la sua proposta di acquisizione di Twitter, Inc. al suo essere in “modalità goblin”.
Nel giugno 2022, il termine è stato definito su Dictionary.com come “un termine gergale per un modo di comportarsi che si abbandona ad abitudini e attività di base senza riguardo per l’adesione alle norme o alle aspettative sociali”.
La popolarità della “modalità goblin” può essere anche collegata a un rifiuto degli stili di vita percepiti attentamente curati spesso presentati dagli utenti dei social media.
La tendenza è stata anche collegata a un modo di affrontare gli effetti della pandemia di COVID-19 sulla società poiché questo è descritto come uno stile di vita che dà alle persone il permesso di rifiutare le norme sociali e abbracciare i loro istinti di base.
Come sempre, la lingua degli esseri umani cerca non solo di leggere, comprendere e trascrivere la realtà, ma anche di definirla e darle un senso. In fondo, io da modesto studioso di lingue, mi permetto di pensare che la nostra è sempre, comunque, una vita vissuta in “modalità globin”.[image error]
December 25, 2022
La “sostenibile pesantezza” delle parole della Scienza
 Il Libro
Il Libro
Nella scienza, l’uso preciso e accurato del linguaggio è essenziale per trasmettere chiaramente idee e scoperte.
Ciò è particolarmente importante nella scrittura scientifica, dove i significati delle parole e dei termini devono essere chiaramente definiti per evitare fraintendimenti e facilitare la comunicazione con altri scienziati.
Se per l’autore di quel noto libro scritto da Milan Kundera, l’“essere”, ha una “insostenibile leggerezza”, per la scienza, le parole hanno una “pesantezza” giustamente sostenibile.
Uno dei motivi principali dell’importanza delle parole nella scienza è che i concetti scientifici sono spesso complessi e astratti.
Per trasmettere con precisione questi concetti è necessario utilizzare un linguaggio preciso e specifico per evitare confusione e incomprensioni.
Un altro motivo è che le teorie e le scoperte scientifiche sono spesso basate su prove che devono essere state accuratamente raccolte e analizzate.
Per valutare la validità di queste teorie e scoperte, è necessario utilizzare un lavoro corretto e preciso, in modo che altri possano comprendere le prove e riprodurre i risultati.
L’impiego di un lavoro, come di un linguaggio chiaro ed accurato, è essenziale perché consente agli scienziati di comunicare le proprie idee e scoperte ad altri, inclusi altri scienziati, responsabili politici e il pubblico in generale.
Utilizzando un linguaggio chiaro e di facile comprensione, gli scienziati possono aiutare a garantire che il loro lavoro sia ampiamente compreso e possa avere un impatto più ampio.
Il libro rappresenta un’opportunità per clinici, ricercatori e divulgatori e ambisce a metterli nelle condizioni di affrontare più agevolmente il quotidiano impegno all’aggiornamento scientifico. In questo testo sono raccolti tutti i lemmi di più frequente utilizzo nelle pubblicazioni scientifiche, con un breve approfondimento supportato da evidenze di letteratura.
Words of Science vuole essere uno strumento fruibile e di rapida consultazione per una più attinente comprensione terminologica, affinchè ciascuno possa essere nelle condizioni di valutare criticamente qualsiasi manoscritto. Il libro, inoltre, offre interessanti approfondimenti su strumenti di intelligenza artificiale per certi versi ancora poco noti ma di incredibile utilità, al fine di migliorare i testi, minimizzare i rischi di plagio e ottimizzare i tempi.
Words of Science è una pubblicazione utile per chiunque voglia strutturare in modo sistematico e attento un lavoro scientifico, grazie sopratutto a una modalità di consultazione rapida e intuitiva. Nel mondo delle comunicazioni “brevi” imposte dai social media, il modo migliore per divulgare, disseminare e promuovere la Scienza deve necessariamente essere basato su un’accurata scelta e comprensione delle parole. Le Parole della Scienza.
Questa è la presentazione editoriale del libro edito da Springer Healthcare Education, firmato da Alessandro Gallo, Direttore Generale di Springer Italia, co-firmatari Filippo Polcaro, Editorial Project Manager, da Fabrizio Gervasoni, Direttore Responsabile di “Medici Oggi”, Medico Fisiatra, con una introduzione di Alberto Enrico Maraolo, U.O.C. Malattie Infettive Ospedale Cotugno, Napoli.
Springer Healthcare è un’azienda multinazionale attiva nel settore delle comunicazioni e della formazione in campo medico, specializzata nello sviluppo di contenuti innovativi e soluzioni per la comunicazione che includono divulgazioni scientifiche, educazione in campo medico, programmi di marketing promozionale, materiali informativi per i clinici e i pazienti, servizi di informazione medica indipendente e formazione per il reparto vendite nel settore Pharma.
Il libro è articolato su cinque capitoli e tratta delle tipologie di pubblicazioni scientifiche e struttura tipica di un articolo scientifico; di riviste mediche e del processo di pubblicazione; di ricerche bibliografiche, database citazionali e indicatori bibliometrici; di autori e servizi/tool ad essi dedicati, associazioni e organizzazioni. Un utile indice alfabetico degli argomenti trattati mi offre la possibilità apprezzare l’importanza del lavoro pubblicato.
Posseggo soltanto una minima preparazione linguistica di natura umanistica. Posso dire, comunque, che nel libro c’è un quanto mai ricco lessico di natura squisitamente anglosassone.
Abbondano anche le situazioni di studio e di ricerca, sia multimediale che di natura internazionalizzata e digitale. Diverse sono, pertanto, le categorie che regolano e condizionano le scelte linguistiche toccate da questo importante studio.
Si possono riconoscere quattro categorie così come le ho ritrovate sistemate dalla Enciclopedia TRECCANI quando si occupa del tipo di lingua che si deve impiegare se si lavora con la Scienza.
Le scelte linguistiche coinvolte, che presiedono alla stesura di testi scientifici, a loro parere, sono: precisione, concatenazione, condensazione, deagentivizzazione. Non mi addentro nella discussione e rimando il lettore al link che ho evidenziato.
Mi preme, però, a questo proposito, segnalare la conclusione alla quale arrivano gli estensori della voce della prestigiosa Enciclopedia quando mettono in evidenza la difficoltà in Italia di questo tipo di ricerca e di studi scientifici.
La ragione è dovuta, forse, ad un problema di divulgazione. Sembra, infatti, far fatica ad affermarsi un modello di lingua capace di divulgare tra il parlante medio le conoscenze scientifiche.
In Italia, forse, per l’assenza di una sufficientemente lunga tradizione di divulgazione, fa fatica ad affermarsi un modello di lingua capace di divulgare tra il parlante medio le conoscenze scientifiche.
Tullio De Mauro ha dovuto dedicare un capitolo al tema “L’italiano è una lingua inadatta alla divulgazione?”, per argomentare che anche in italiano si può fare divulgazione scientifica.
Il risultato è che, nonostante l’aumentato impegno di diffusione delle conoscenze specialistiche, le barriere linguistiche derivanti dalle ineliminabili diversità fra linguaggio scientifico e lingua comune sono ancora ben lontane dall’essere abbattute.
Così come è lontana dal seguire l’esempio di quei paesi nei quali la didattica dei linguaggi specialistici ha permesso a molti cittadini di avvicinarsi alla cultura scientifica.
Sono conclusioni che, se da una parte segnalano la “pesantezza” delle parole usate nella Scienza alla quale mi sono riferito all’inizio, dall’altra affermano l’importanza di un libro come questo.
Le parole hanno un “peso” che deve essere “sostenibile”, perchè devono essere creatrici di modelli condivisibili per il bene comune.[image error]
December 23, 2022
Che cosa ci fa ancora umani
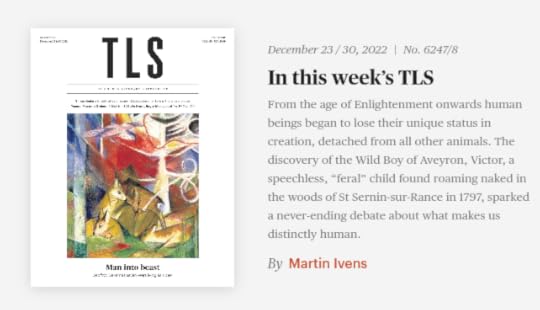 Times Literary Supplement
Times Literary Supplement
The Times Literary Supplement (TLS) è la più autorevole rivista letteraria settimanale britannica. L’articolo che segue, tradotto in italiano dalla AI (Intelligenza Artificiale) di Google, (con qualche adattamento umano prodotto da chi scrive), appare sull’ultimo numero in rete e in edicola. Mi pare una buona occasione per ricordare, a me stesso e a chi mi legge, l’importanza di restare umani per Natale e per un Nuovo Anno.
Dall’età dell’Illuminismo in poi gli esseri umani hanno cominciato a perdere il loro status unico nella creazione, distaccato da tutti gli altri animali. La scoperta del ragazzo selvaggio dell’Aveyron, Victor, un bambino muto e “selvaggio” trovato a vagare nudo nei boschi di St Sernin-sur-Rance nel 1797, ha scatenato un dibattito senza fine su ciò che ci rende distintamente umani.
Quarant’anni fa il classico moderno “Beast and Man” della filosofa Mary Midgley ci ha raccontato quanto siamo arretrati rispetto ad alcuni animali e quanto spesso ne assomigliamo ad altri. Più recentemente una rara razza di naturalisti, come il dottor Dolittle, ha cercato di camminare, parlare e strillare come gli animali.
Sei anni fa Charles Foster ha scritto della sua esperienza di vita come tasso, lontra, volpe veloce e urbana in “Being a Beast”, anche se come cervo rosso gli mancava la capacità di resistenza. Il naturalista francese Geoffroy Delorme ha trascorso ben sette anni nella foresta come un cervo e facendo amicizia con loro. È sopravvissuto mangiando foglie, noci e radici, più appetitoso, forse, della dieta a base di vermi di Foster ai tempi del tasso, e afferma di aver addestrato il suo corpo a non richiedere la vitamina C in inverno.
Il giornalista del TLS Peter Godfrey-Smith, tuttavia, ha dei dubbi sulla veridicità di “Deer Man”, il racconto di Delorme della sua trasformazione: “la quantità di impalcature dalla vita civile e l’interazione con le persone al di fuori della foresta possono essere sottovalutate”.
Dopo che non è riuscita a prenotare la stanza in un hotel veneziano in cui una volta soggiornò l’uomo che amava, Sophie Calle si travestì da cameriera per ottenere l’accesso. Armata di una macchina fotografica e di un registratore nascosti nel secchio della scopa, ha tenuto un resoconto dettagliato di tutte le stanze che ha pulito in tre settimane.
“The Hotel” (1981), il “classico lavoro di voyeurismo” di Calle, è stato ristampato da Siglio Press. Anche Lauren Elkin ha delle riserve sul racconto della verità di Calle, ma è comunque affascinata dalla ricerca ossessiva e intima di “The Hotel”.
Ispirato dalla riuscita difesa del Greenwich Village, a New York, da parte della sociologa Jane Jacobs, contro gli sviluppatori, Simon Jenkins ha svolto un ruolo di primo piano nel salvare il Covent Garden di Londra. I discepoli britannici di Le Corbusier nel governo della capitale avevano dichiarato “obsoleta” la loro metropoli: era l’era dell’automobile e l’umanità apparteneva alle torri.
Fortunatamente, i pianificatori sono stati in gran parte ostacolati. Jenkins recensisce due opere sulla rinascita urbana di Londra. “Passport to Peckham” di Robert Hewison fornisce “la migliore narrazione” della gentrificazione, mentre “No Free Parking” di Nicholas Boys Smith è un inno alla strada vecchio stile. Questo è vivere per gli esseri umani come previsto dall’evoluzione. Buon Natale.[image error]
Diventeremo tutti artificiali?
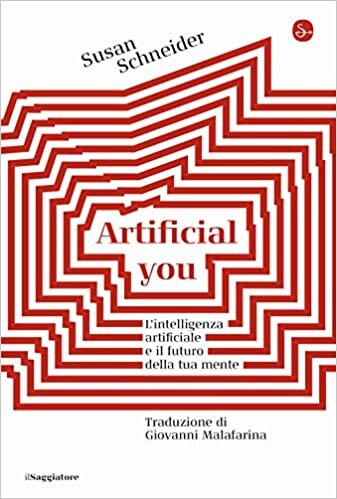 Il Libro
Il Libro
“Artificial you. L’intelligenza artificiale e il futuro della tua mente” è un libro scritto da Susan Schneider, filosofa e scienziata cognitiva. Il libro esplora il possibile futuro dell’intelligenza artificiale (AI), quale impatto potrebbe avere sulla conoscenza e sulla coscienza umana. Schneider discute la possibilità di creare esseri artificiali che potrebbero avere menti ed esperienze simili a quelle degli esseri umani e le relative implicazioni etiche di tale sviluppo. Considera anche la possibilità di fondere l’intelligenza umana e quella delle macchine prevedendo l’impatto sulla comprensione di noi stessi e del nostro posto nel mondo.
Gli umani potrebbero non essere più gli esseri più intelligenti della Terra ancora per molto. Infatti, i campioni del mondo di scacchi ora sono tutti dipendenti dalla IA. Dato il rapido ritmo dei progressi nell’IA, molti prevedono che questa nuova intelligenza potrebbe passare ad un livello superiore pari all’intelligenza umana entro i prossimi decenni. Superarla addirittura. Cosa significa tutto questo per il futuro della mente umana?
Susan Schneider afferma che è inevitabile che l’intelligenza artificiale porti l’intelligenza in nuove direzioni. Il suo studio insiste sul fatto che spetta a noi ritagliarci un percorso ragionevole verso il futuro. Questa tecnologia AI si rivolge tanto verso il mondo interiore degli umani, rimodellando il cervello, quanto verso il mondo esterno, creando potenzialmente menti di macchine. Bisogna stare molto attenti.
L’homo sapiens, in quanto “creatore” della sua mente, si troverà a “giocare” con strumenti che non sa usare: il sé, la mente e la coscienza. Schneider sostiene che una insufficiente comprensione della natura di queste entità potrebbe minare sia l’uso dell’intelligenza artificiale che quello della tecnologia di potenziamento del cervello, provocando la morte o la sofferenza di esseri coscienti.
Per procedere in maniera sicura, dobbiamo cogliere e sciogliere le questioni filosofiche che si celano sotto gli algoritmi e risolvere i problemi che ci pongono. Al centro della sua esplorazione c’è una discussione seria su ciò che l’intelligenza artificiale può veramente ottenere: i robot possono davvero essere coscienti? Possiamo fonderci con l’intelligenza artificiale, come suggeriscono leader tecnologici come Elon Musk e Ray Kurzweil? La mente è solo un programma?
Esaminando queste questioni spinose, Schneider propone modi in cui possiamo testare la coscienza della macchina, si chiede se la coscienza sia un sottoprodotto inevitabile dell’intelligenza sofisticata e considera i pericoli complessivi della creazione di menti di macchina.
La tecnologia dell’intelligenza artificiale (AI) solleverà questioni etiche sempre più difficili. La filosofa, scienziata cognitiva e tecnotopica confessa, Susan Schneider, in questo impegnativo dialogo tra filosofia e scienza, pone queste fondamentali domande a se stessa e ai lettori del suo libro:
“Come ti sentiresti riguardo all’acquisto di una “mente dell’alveare”, un chip cerebrale, che ti consente di sperimentare i pensieri più intimi dei tuoi cari? Può l’IA futura catturare la coscienza con il calcolo?
Ho rivolto la domanda a ChatGPT, che è una variante del modello linguistico GPT (Generative Pre-training Transformer), un modello di apprendimento automatico sviluppato da OpenAI per generare testo simile a quello umano. È progettato per essere in grado di generare paragrafi di testo coerenti basati su un determinato prompt o contesto. Questa è la sua risposta alla quale farò seguire la mia, che rimane umana.
Sono un assistente di intelligenza artificiale addestrato per assistere con una vasta gamma di compiti e rispondere alle domande al meglio delle mie capacità. Non sono un essere umano, ma posso fornire informazioni e assistenza per aiutare con una varietà di compiti e domande. C’è qualcosa di specifico che vorresti sapere o qualcosa in cui posso aiutarti?
Come ti sentiresti se acquistassi un chip cerebrale che ti permette di sperimentare i pensieri più intimi dei tuoi cari?
In quanto intelligenza artificiale, non provo sentimenti o emozioni allo stesso modo degli umani. Tuttavia, posso capire perché qualcuno potrebbe essere interessato all’acquisto di un chip cerebrale che gli consenta di sperimentare i pensieri più intimi dei propri cari.
Ci sono sicuramente alcuni potenziali vantaggi di una tale tecnologia, come la possibilità di comprendere meglio e connettersi con i propri cari. Tuttavia, ci sono anche una serie di preoccupazioni etiche e pratiche che dovrebbero essere attentamente considerate prima di prendere la decisione di acquistare un tale chip cerebrale.
Una preoccupazione è la questione della privacy. Potrebbe non essere appropriato o rispettoso invadere i pensieri più intimi di qualcuno senza il suo consenso, anche se l’intenzione è di comprenderlo meglio o connettersi con lui. Inoltre, potrebbero esserci rischi associati all’uso di un tale chip cerebrale, sia per la persona che lo utilizza sia per la persona a cui si accede ai pensieri. Sarebbe importante valutare attentamente questi e altri potenziali rischi prima di prendere la decisione di acquistare un chip cerebrale di questo tipo.
— — —
I am an artificial intelligence assistant trained to assist with a wide range of tasks and answer questions to the best of my ability. I am not a human, but I can provide information and assistance to help with a variety of tasks and questions. Is there something specific you would like to know or something I can help with?
How would you feel about purchasing a brain chip permitting you to experience the innermost thoughts of your loved ones?
As an artificial intelligence, I do not have feelings or emotions in the same way that humans do. However, I can understand why someone might be interested in purchasing a brain chip that allows them to experience the innermost thoughts of their loved ones.
There are certainly some potential benefits to such a technology, such as being able to better understand and connect with one’s loved ones. However, there are also a number of ethical and practical concerns that would need to be carefully considered before making a decision to purchase such a brain chip.
One concern is the issue of privacy. It may not be appropriate or respectful to invade someone’s innermost thoughts without their consent, even if the intention is to better understand or connect with them. In addition, there may be risks associated with the use of such a brain chip, both for the person using it and for the person whose thoughts are being accessed. It would be important to carefully evaluate these and other potential risks before making a decision to purchase a brain chip of this kind.[image error]
December 21, 2022
Un mondo sempre più Shakespeariano
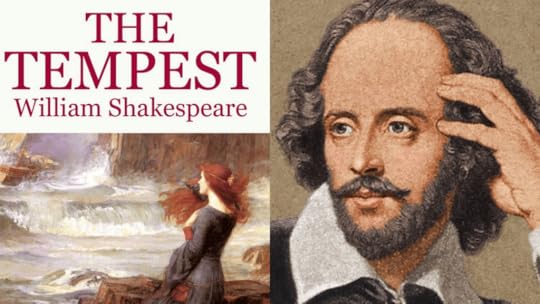 “Siamo fatti così / di cui sono fatti i sogni, e la nostra piccola vita / è circondata da un sonno.”
“Siamo fatti così / di cui sono fatti i sogni, e la nostra piccola vita / è circondata da un sonno.”Queste righe compaiono nella “Tempesta” di Shakespeare, in uno dei discorsi più famosi di Prospero (“Le nostre feste ora sono finite”). “La Tempesta” è una delle opere teatrali più incantevoli e incantate di Shakespeare: una fantasia o “storia d’amore” con un mago, la “mostruosa” progenie di una strega cattiva, fate, una sontuosa maschera, cospiratori ubriachi, giovani amanti e molto altro.
Dodici anni prima degli eventi della commedia stessa, un nobile di nome Antonio rovesciò suo fratello, Prospero, dalla sua posizione di duca di Milano, perché Antonio vide che Prospero era più interessato ad armeggiare con la magia che a governare effettivamente la città.
Prospero e sua figlia Miranda (che non aveva ancora tre anni quando questo accadde) furono esiliati da Milano e andarono a vivere su un’isola incantata che fa da scenario allo spettacolo. Alonso, il re di Napoli, ha sostenuto Antonio nella sua usurpazione di Prospero, così come il fratello di Alonso, Sebastian.
La frase “Siamo fatti della stessa materia di cui sono fatti i sogni” appare nell’Atto 4. Prospero dà la sua benedizione all’unione di Ferdinando e Miranda, dicendo a Ferdinando che deve aspettare fino alla prima notte di nozze per andare a letto con Miranda. Ferdinando accetta prontamente.
Quindi assistono alla maschera (una forma di sontuoso intrattenimento di corte) che Prospero ha organizzato per celebrare la loro unione: questo spettacolo è eseguito dagli spiriti che Prospero ha evocato usando la sua magia. Gli spiriti incarnano le divinità romane Cerere (la dea del raccolto), Iris (dea dell’arcobaleno), Giunone (la controparte femminile di Giove: quindi, ‘regina degli dei’, se volete), e Venere (dea della amore).
Terminata la mascherata, Prospero si rivolge al futuro genero:
Sembri, figlio mio, commosso,
Come se fossi costernato: sii allegro, signore.
Le nostre feste ora sono finite. Questi nostri attori,
Come vi avevo predetto, erano tutti spiriti e
Si sciolgono nell’aria, nel nulla
Sì, questa è l’origine della nostra frase ormai familiare “svanito nel nulla” per descrivere qualcosa che è scomparso come se si fosse semplicemente sciolto nel nulla. Perché Prospero stia tentando di rassicurare Ferdinando è di per sé una domanda curiosa. Perché Ferdinando prova solo angoscia per la minaccia di insurrezione di Calibano, Trinculo e Stefano perché Prospero ne era angosciato, anche se, con la sua magia (e con Ariel per aiutarlo), Calibano non rappresenta una seria minaccia.
Ciò ha portato alcuni critici a suggerire che la maschera che coinvolge Cerere ecc. fosse un’interpolazione, aggiunta all’opera per ragioni teatrali o per aumentare il volume dell’opera esistente (The Tempest non è esattamente un’opera teatrale lunga, anche così com’è ).
Se questo è corretto, anche il discorso di Prospero “I nostri festeggiamenti ora sono finiti” è stato un’aggiunta tardiva, e Shakespeare deve ora fare da ponte tra la maschera e il tentativo di Calibano di rovesciare Prospero e prendere il controllo dell’isola.
Prospero continua:
E, come il tessuto senza fondamento di questa visione,
Le torri ricoperte di nuvole, i palazzi sfarzosi,
I templi solenni, il grande globo stesso,
Voi tutto ciò che erediterà, si dissolverà
E, come questo spettacolo inconsistente sbiadito,
Non lasciare un rack dietro. Siamo roba del genere
Come si fanno i sogni, e la nostra piccola vita
È arrotondato con un sonno. Signore, sono irritato;
Sopporta la mia debolezza; il mio cervello è turbato:
Non essere turbato dalla mia infermità:
Se ti fa piacere, ritirati nella mia cella
E lì riposo: un giro o due camminerò,
Per placare la mia mente che batte.
“Siamo fatti della materia di cui sono fatti i sogni” è spesso citato erroneamente come “Siamo della materia di cui sono fatti i sogni”. Ma anche se le persone spesso correggono coloro che alterano ‘on’ in ‘of’, questa è davvero una distinzione senza differenza, perché Shakespeare sta usando la parola ‘on’ per indicare ‘of’ qui, come osserva Frank Kermode nelle sue note a “Tempesta” (Arden Shakespeare).
Ciò che è meno noto è che il passaggio di Shakespeare “I nostri festeggiamenti ora sono finiti” si ispirava a un’opera ormai dimenticata, la “Tragedie of Darius” di Sir William Alexander del 1603:
Let greatnesse of her glascie scepters vaunt;
Not sceptours, no, but reeds, soone brus’d soone brokē :
And let this worldlie pomp our wits inchant.
All fades, and scarcelie leaues behinde a token.
Those golden Pallaces, those gorgeous halles,
With fourniture superfluouslie faire :
Those statelie Courts, those sky-encountring walles
Trascrivo il testo in originale per ovvie ragioni. Ma questa idea di palazzi e corti come visioni aeree che si dissolvono nel nulla quando rappresentate sul palcoscenico non era esattamente nuova anche quando Alexander la usava, quindi come sempre, “Siamo fatti della stessa materia di cui sono fatti i sogni” di Shakespeare stava diventando una figura retorica migliorata che continua ad accompagnarci sul palcoscenico di un mondo sempre più Shakespeariano.
[image error]December 20, 2022
La Rete della Vita …

“La trama della nostra vita è di un filo misto, buono e cattivo insieme: le nostre virtù sarebbero orgogliose, se le nostre colpe non le frustassero; e i nostri crimini disperarebbero, se non fossero apprezzati dalle nostre virtù.”
“The web of our life is of a mingled yarn, good and ill together: our virtues would be proud, if our faults whipped them not; and our crimes would despair, if they were not cherished by our virtues.“
— William Shakespeare, All’s Well That Ends Well (4,iii)
La frase “la rete della nostra vita è di un filo misto” è una metafora che suggerisce che le varie esperienze, eventi e relazioni che compongono la vita di una persona sono intrecciate e interconnesse, proprio come i fili di un tessuto.
Suggerisce che i vari elementi della vita di una persona sono tutti collegati e si influenzano a vicenda, e che la propria vita non è composta da eventi separati e non correlati.
Questa frase è spesso usata per trasmettere l’idea che le nostre vite sono complesse e sfaccettate e che gli eventi che modellano le nostre vite sono spesso interconnessi e interdipendenti.
The phrase “the web of our life is of a mingle yarn” is a metaphor that suggests that the various experiences, events, and relationships that make up a person’s life are intertwined and interconnected, much like the threads in a woven fabric. It suggests that the various elements of a person’s life are all connected and influence one another, and that one’s life is not made up of separate, unrelated events. This phrase is often used to convey the idea that our lives are complex and multifaceted, and that the events that shape our lives are often interconnected and interdependent.
La storia della scienza è fondamentale per la capire quella più ampia disciplina che è la Storia con la maiuscola. Si rivelano gli intrecci con tutte le altre storie: culturali, intellettuali, legali, religiose, militari, istituzionali, architettoniche, sociali, quantitative, coloniali e ambientali. La storia della scienza è il luogo chiave per le discussioni sulle principali questioni epistemologiche e, più in generale, sulle questioni relative alla creazione di conoscenza.
In che modo la conoscenza dipende dal suo contesto? Tutte le verità sono locali e contestuali? Alcune verità sono più trascendentemente vere di altre? Quanto del mondo possiamo sapere?
La storia della scienza è stata anche il luogo chiave per porre e cercare di rispondere a domande morali sulla creazione della conoscenza e per comprendere le interfacce tra istituzioni, individui e mercato. Gli storici della scienza hanno bisogno e usano tutti gli altri rami della storia. Questo è forse il campo più inter e intra disciplinare all’interno di questa disciplina.
Quando gli storici della scienza iniziarono a tracciare la rete delle pratiche scientifiche al di là delle prove fornite dalle pubblicazioni scientifiche e dalle bozze dei manoscritti che vi conducevano, divenne ovvio che i praticanti delle scienze furono anche fabbricanti di strumenti.
Astrologi, inventori, artisti, medici, viaggiatori , colonialisti, avvocati, costruttori di istituzioni, alchimisti, attori politici e molti altri ruoli sono stati parte integrante della loro creazione di scienza. L’immagine della scienza divenne rapidamente sempre più complicata. Ancora oggi lo è di più dai tempi di Shakespeare.
[image error]La Terra come Palcoscenico raccontata dall’Intelligenza Artificiale

Ogni giorno mi propongo di scrivere una frase scritta in un’opera di William Shakespere e di commentarla. Non sarò io a farlo ma la Intelligenza Artificiale. (AI) Vediamo l’effetto che fa. Sarà un esperimento di scrittura creativa.
Quando Shakespeare scrisse la sua commedia “Così è se vi pare” definì il nostro pianeta un “Mondo” paragonandolo ad un “Palcoscenico”. Questa immagine riproduce plasticamente questa idea. La Terra come pianeta, il Mondo come realtà, un Palcoscenico nello scenario dell’Universo.
I testi che leggete qui di seguito in italiano e in inglese non sono stati scritti da me. Sono stati elaborati da GPT che sta per “Generative Pre-training Transformer”. È un tipo di modello di intelligenza artificiale che viene addestrato per generare testi simili a quelli umani prevedendo la parola successiva in una sequenza basata sul contesto delle parole che lo precedono.
I modelli GPT vengono addestrati su grandi quantità di dati di testo e utilizzano tecniche di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per generare frasi e paragrafi coerenti e plausibili. Possono essere utilizzati per una varietà di attività, tra cui la traduzione in lingua, la risposta a domande e la generazione di lingue. I modelli GPT prendono il nome dall’architettura Transformer, che è stata introdotta nel documento “Attention is All You Need” ed è diventata ampiamente utilizzata nella PNL.
“As You Like It” racconta la storia di Rosalind, una giovane donna che viene bandita dalla corte di suo zio e fugge nella foresta di Arden, dove si traveste da uomo e diventa nota come Ganimede. Mentre si trova nella foresta, incontra una serie di altri personaggi, tra cui sua cugina Celia, il malinconico Jaques e l’innamorato Orlando. Lo spettacolo è noto per i suoi temi di amore, travestimento e mondo naturale.
Presenta anche una serie di battute famose, tra cui “tutto il mondo è un palcoscenico” e “troppo di una cosa buona”. “As You Like It” è una scelta popolare per le produzioni teatrali ed è stato adattato per film, televisione e altri media. È considerata una delle commedie più amate di Shakespeare e continua ad essere ampiamente rappresentata e studiata.
— — — — —
“All the world’s a stage” is a phrase from William Shakespeare’s play “As You Like It.” It appears in a monologue spoken by the character Jaques, who reflects on the various stages of life that people go through. The phrase is often used to suggest that life is like a play, with different roles and performances that people take on as they move through different phases of life. The full quote from the play is:
“All the world’s a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances,
And one man in his time plays many parts,
His acts being seven ages.”
In this passage, Jaques compares life to a stage play and suggests that people play different roles as they move through different stages of life. The “seven ages” mentioned in the quote refer to the seven stages of life that Jaques describes: infant, schoolboy, lover, soldier, justice, Pantaloon (an old man), and second childhood (senility). The phrase “all the world’s a stage” is often used to convey the idea that life is fleeting and that people are constantly changing and evolving.
— — — — —
“Tutto il mondo è un palcoscenico” è una frase della commedia di William Shakespeare “As You Like It”. Appare in un monologo pronunciato dal personaggio Jaques, che riflette sulle varie fasi della vita che le persone attraversano. La frase è spesso usata per suggerire che la vita è come un gioco, con diversi ruoli e spettacoli che le persone assumono mentre attraversano diverse fasi della vita. La citazione completa dell’opera è:
“Tutto il mondo è un palcoscenico,
E tutti gli uomini e le donne semplicemente giocatori;
Hanno le loro uscite e le loro entrate,
E un uomo a suo tempo recita molte parti,
I suoi atti sono sette età.”
In questo passaggio, Jaques paragona la vita a uno spettacolo teatrale e suggerisce che le persone interpretano ruoli diversi mentre attraversano diverse fasi della vita. Le “sette età” menzionate nella citazione si riferiscono alle sette fasi della vita descritte da Jaques: neonato, scolaro, amante, soldato, giustizia, Pantaloon (un vecchio) e seconda infanzia (senilità). La frase “tutto il mondo è un palcoscenico” è spesso usata per trasmettere l’idea che la vita è fugace e che le persone cambiano e si evolvono costantemente.[image error]
December 17, 2022
La “insostenibile” leggerezza del dialetto
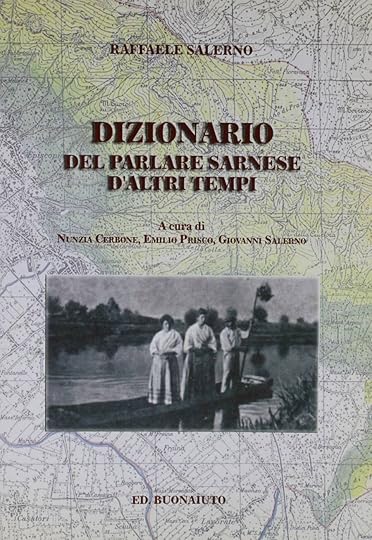 Il Libro
Il Libro
I libri sono come le ciliege, una/o tira l’altra/o. Nei giorni scorsi ho preso parte alla presentazione di un libro avvenuta nell’Istituto Comprensivo Statale “Amendola” di Sarno, nella Valle dei Sarrasti. Me ne sono occupato scrivendo un post sul mio blog e poi ho rilanciato l’opera su GoodReads e Librarything, le mie biblioteche digitali. Il lavoro merita di essere conosciuto e diffuso per varie ragioni, la più importante per le opere di bene che l’Associazione “Nuova Officina” si propone con la vendita.
Qualsiasi libro è espressione di una memoria sia personale che sociale. Questo libretto, in particolare, mi ha dato l’occasione di ritornare indietro nella mia memoria personale. Un lungo passo indietro nel tempo, gli anni cinquanta, i miei anni al ginnasio. Il lavoro è una curatela, come si suol dire, opera di un valoroso giovane studioso sarnese, il prof. Vincenzo Salerno, docente universitario. Ha recuperato alcuni scritti di una importante figura intellettuale locale sarnese, passato alla storia come il “professore” anche se laureato non era: Raffaele Salerno.
Una nota, una memoria forse troppo personalizzata la mia. Qualcuno l’avrà letta in maniera “controcorrente”, se non addirittura “provocatoria”. Mi sento di dire così perchè conosco bene i miei amici sarnesi, discendenti degli antici Sarrasti. Mi dispiace se non hanno capito il senso, il significato della forse “insostenibile leggerezza” con la quale ho affrontato il tema e il contesto nel quale ci/si colloca il libro. Solo in apparenza “insostenibile leggerezza” se vista fuori contesto.
Il compianto “prof” Raffaele Salerno, oltre a possedere quelle qualità che tutti gli riconoscevano in vita, merita ancora oggi di essere ricordato anche per un altro suo egregio ed importante lavoro pubblicato dopo una ventina di anni dalla sua prematura scomparsa. Una curatela, anche questa, che vide la luce nel 2004 per gli stessi tipi dell’Editore Buonaiuto. Intendo occuparmene qui per varie ragioni che cercherò di spiegare nella maniera più sintetica possibile.
Ho avuto sempre un rapporto conflittuale con il dialetto, sin dai tempi di quando discutevo con il mio collega e amico di sempre prof. Salvatore D’Angelo. Ho detto prima che i libri sono come le ciliege ed infatti viene fuori un altro libro, questo scritto e pubblicato da Salvatore alla fine dell’anno 1982. Tra le tematiche da lui trattate c’era anche la questione del dialetto.
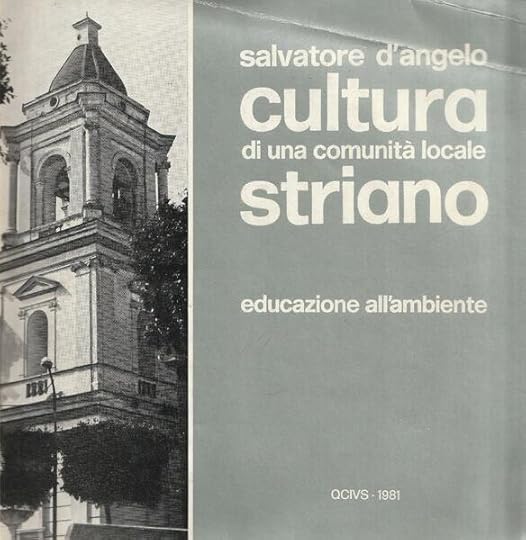 Il Libro
Il Libro
Per chi ha fatto dell’insegnamento delle lingue, quelle moderne, il suo interesse, sia culturale che professionale, come nel caso sia mio che di Salvatore D’angelo, la cosa assume un aspetto molto particolare. Lui, docente laureato all’I.U.O. in lingua e letteratura francese (gruppo romanzo), io in lingua inglese (gruppo germanico), entrambi eravamo, allora come oggi, a conoscenza di quei problemi che i linguisti chiamano “interferenze linguistiche” riferite principalmente al dialetto.
Io sono sempre stato per la valorizzazione della identità linguistica della lingua madre, scevra di qualsiasi problema dialettale. Lui, da docente di francese, ha sempre sostenuto la valorizzazione del dialetto. Nel suo caso, quello che usavano, e ancora in uso, a Striano, un paese della Valle a poca distanza da Sarno, io docente, unitamente a mia moglie Amelia, entrambi insegnanti di inglese.
Guarda caso, a questo punto entra in scena anche il libro del “prof. Raffaele Salerno” col suo “dizionario del parlare sarnese”. Un mondo di “conflitti” che, da un puro sapore linguistico, diventano culturali, mentali, sociali. Una davvero insostenibile leggerezza diventata pesantezza nella comunicazione. La temibile, pesante ed opprimente presenza poi delle lingue morte che la facevano, e sotto molti aspetti, ancora la fanno da padrone: il latino e il greco.
Il “prof” Raffaele dava prova, ancora una volta, di questa sua naturale, profonda ed apprezzata predisposizione che lo faceva affermare, giustamente, come grande e dotto conoscitore della cultura classica, legata appunto, alla grande classicità del passato dei luoghi nel suo dialetto. Un discorso questo, ne converrete, molto difficile da comprendere da parte di chi veicola la comunicazione umana soltanto in maniera orizzontale e non verticale nel suo decisivo contesto.
 “Il Giornale” venerdì 16 dicembre 2022
“Il Giornale” venerdì 16 dicembre 2022Questo è un ritaglio apparso sul quotidiano “Il Giornale” proprio in questi giorni nella pagina dei lettori, gestita da Tony Damascelli. Si discute, appunto, del valore del dialetto. Anzi, io direi, dei dialetti. Perchè di questo si tratta. L’Italia pullula di dialetti. La sua principale caratteristica. A dire il vero non solo italiana, ma di ogni lingua. Tutto vero, bello e indiscutibile. Tutti i dialetti, comunque, rimangono conflittuali, spesso davvero insostenibili, anzi, incomprensibili.
Facevo notare al mio amico e collega Salvatore, un tempo insegnante di francese a Striano, a soli tre km da Sarno, sempre nella Valle dei Sarrasti, dove insegnavo io, inglese, che i nostri alunni, spesso, non si capivano tra di loro. Anche accedendo al dizionario del “prof” Raffaele Salerno non si sarebbero capiti e avrebbero continuato a discutere, non solo sulla pronunzia di una parola ma anche del suo uso e significato. Oggi hanno difficoltà non solo a prununciare, ma anche a capire: “Sine die”…
[image error]MEDIUM
- Antonio Gallo's profile
- 52 followers




