Antonio Gallo's Blog: MEDIUM, page 45
October 13, 2023
La scrittrice che divenne scrittore
 Il 14 ottobre 1856 viene al mondo Vernon Lee, nato(a) Violet Paget, viene qui ricordato(a) in tre modi diversi: come matto(a), in una biografia e dalla Intelligenza Artificiale (AI)
Il 14 ottobre 1856 viene al mondo Vernon Lee, nato(a) Violet Paget, viene qui ricordato(a) in tre modi diversi: come matto(a), in una biografia e dalla Intelligenza Artificiale (AI)Vernon Lee nasce Violet Paget da una famiglia poco convenzionale di inglesi cosmopoliti che praticavano il nomadismo: viaggiavano per l’Europa fermandosi in vari luoghi alcuni mesi, per poi spostarsi, fino a quando si fermarono nei pressi di Firenze, in una villa chiamata Il Palmerino. Violet, ingegno vivace e predisposizione per la scrittura, decide, nel 1878, all’età di 22 anni, di assumere identità maschile: sarà Vernon Lee, non solo in arte, ma anche nella vita, adottando un abbigliamento da uomo. Quali le ragioni di questa scelta? Forse si era convinta che cultura e doti naturali non bastavano: poteva aspirare al successo come autrice di romanzi, ma non era ancora venuto il momento per le donne — siamo nella seconda metà del XX secolo — di acquisire credito nel campo della saggistica, genere «serio», riservato agli uomini. Oppure, più semplicemente, rifiutava l’identità di genere. Come Vernon Lee firmerà tutti i suoi scritti, saggi filosofici, storici, di estetica, oltre a romanzi fantasy, genere letterario che è tra i primi a coltivare. Opere tutte che le danno notorietà, oggi ingiustamente dimenticate. Ha dato il meglio nella descrizione di borghi o paesaggi naturali dove trovare tracce di antichi miti e di misteriose presenze (Genius loci il suo libro più famoso), e nei racconti di fantasmi. Innamorata dell’Italia, ha vissuto sempre a Il Palmerino, con le due compagne della sua vita, Clementine Anstruther Thomson prima, e Irene Cooper Willis che le sarà accanto fino alla morte, avvenuta nel 1935. È stata un’intellettuale stravagante che conobbe e frequentò molti uomini famosi, con i quali i rapporti non furono però sempre facili a causa di giudizi taglienti e impietosi nei loro confronti che distribuiva senza alcun riguardo. La possiamo vedere in un bel ritratto di John Singer Sargent: viso delicato, capelli cortissimi, occhiali tondi da intellettuale, abito di foggia maschile, sguardo lontano. (ALMAMATTO)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 La Biografia
La Biografia
Vernon Lee, nata Violet Paget nel 1856 da genitori inglesi che vivevano nel continente, unì due mondi e molte culture. Era vittoriana (donna) di nascita ma visse nel secondo quarto del ventesimo secolo come uomo. La sua patria prescelta fu l’Italia, ma trascorse gran parte di ogni anno in Inghilterra, dove pubblicò negli anni un numero impressionante di libri: romanzi, racconti, saggi di viaggio, studi sull’arte e sulla musica italiana, estetica psicologica, polemiche. Era ampiamente riconosciuta come una donna di lettere e si muoveva liberamente nei principali circoli letterari e sociali, incontrando e talvolta stringendo amicizie con un gran numero dei maggiori scrittori e intellettuali del suo tempo, tra cui Robert Browning, Walter Pater, Henry James , H. G. Wells, Bertrand Russell, Bernard Berenson e Mario Praz. Sebbene non si sia mai impegnata in un programma di attivismo politico, era una sostenitrice del femminismo e della riforma sociale e durante la prima guerra mondiale fu un’ardente pacifista. Nei suoi ultimi anni osservò con sgomento l’emergere del fascismo. Vernon Lee ebbe una vita affollata e intellettualmente movimentata dalle sue lettere e diari inediti, nonché dai suoi libri stessi. Una vita travagliata, dalla sua infanzia in un’eccentrica famiglia di espatriati alle sue numerose relazioni amorose infelici con donne fino al suo sincero riconoscimento che il suo lavoro, per quanto brillante, è rimasto non apprezzato. Nonostante tutto questo, Vernon Lee si è aggrappata alla sua fede nella vita della mente e, attraverso l’avvincente racconto biografico di Colby, emerge oggi come una scrittrice degna di rinnovata attenzione e ammirazione. (Il Libro)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
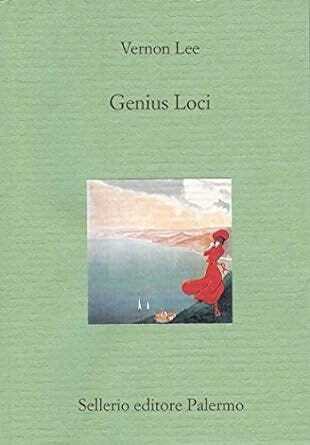 Il fascino del paesaggio e delle città italiane ed europee: Vernon Lee incanta raccontando antichi borghi e territori plasmati da civiltà secolari. Luoghi densi di miti, di divinità, di entità misteriose che non hanno perso la loro anima.
Il fascino del paesaggio e delle città italiane ed europee: Vernon Lee incanta raccontando antichi borghi e territori plasmati da civiltà secolari. Luoghi densi di miti, di divinità, di entità misteriose che non hanno perso la loro anima.(chatGPT) Una figura affascinante e pionieristica nella storia della letteratura: Violet Paget, meglio conosciuta come Vernon Lee. Questa straordinaria scrittrice del XIX secolo è ricordata non solo per i suoi contributi letterari, ma anche per il suo coraggio nel vivere la sua vita secondo i propri termini, sfidando le convenzioni sociali dell’epoca.
Nata nel 1856 a Boulogne-sur-Mer, in Francia, Violet Paget crebbe in una famiglia di intellettuali britannici. Fin da giovane dimostrò un interesse per l’arte e la letteratura, e la sua fervida immaginazione la portò a sviluppare uno stile di scrittura unico e sperimentale. Con il passare degli anni, Violet iniziò a scrivere romanzi, saggi e raccolte di racconti, ma fu solo quando adottò lo pseudonimo di Vernon Lee che ottenne il successo e l’attenzione che meritava.
La scelta di assumere un nome maschile non fu casuale. Violet voleva essere presa sul serio come scrittrice in un’epoca in cui le donne erano spesso considerate inferiori nel campo letterario. Il suo pseudonimo le permise di sfuggire alle aspettative di genere e di esplorare temi e argomenti che altrimenti sarebbero stati considerati inappropriati per una donna.
Uno dei lavori più noti di Vernon Lee è il libro intitolato “Genius Loci”. Pubblicato nel 1899, il libro esplora il concetto di “genius loci”, ovvero lo spirito o l’essenza di un luogo. Vernon Lee analizza come l’ambiente e il paesaggio influenzino le persone e le loro esperienze, offrendo una prospettiva unica sulla connessione tra l’uomo e il suo ambiente.
“Genius Loci” è un’opera di grande profondità e bellezza, in cui Vernon Lee utilizza una prosa ricca e descrittiva per trasportare i lettori in un viaggio sensoriale attraverso luoghi e paesaggi immaginari. Il libro affronta temi come l’identità, la memoria e l’influenza dell’ambiente sulla psiche umana, anticipando molte delle idee che sarebbero diventate centrali nel campo della psicologia ambientale.
Nonostante il suo talento e la sua influenza, Vernon Lee è spesso trascurata nella storia letteraria. Tuttavia, il suo coraggio nel vivere la sua vita secondo i suoi termini e la sua dedizione all’arte meritano di essere celebrati. Violet Paget, la scrittrice che divenne scrittore, ha lasciato un’impronta duratura nel panorama letterario, aprendo la strada a molte altre donne che si sono affermate come autrici di successo.
Vernon Lee, con il suo libro “Genius Loci” e il suo stile di scrittura unico, ha lasciato un’eredità duratura nella letteratura. La sua determinazione nel superare le barriere di genere e il suo contributo all’esplorazione della connessione tra l’uomo e l’ambiente sono testimonianza del suo spirito innovativo e della sua importanza come scrittrice. Vale la pena di riscoprire le sue opere e di celebrare il suo impatto duraturo.
Violet Paget, ha avuto una vita personale interessante e complessa. Mentre gran parte delle informazioni sulla sua vita privata sono state tramandate attraverso le sue stesse scritture e la corrispondenza con amici e colleghi, ci sono alcune informazioni disponibili. Era una donna lesbica e la sua sessualità influenzò profondamente la sua vita e il suo lavoro. Durante la sua vita, ebbe diverse relazioni romantiche e amicali con donne, e alcune di queste relazioni furono di grande importanza per la sua ispirazione creativa.
Una delle sue relazioni più significative fu quella con la scrittrice ed esploratrice Mary Robinson, conosciuta come “Mamma” Robinson. Le due donne vissero insieme per molti anni a Villa Il Palmerino, vicino a Firenze, in Italia, dove coltivarono un ambiente creativo e ospitarono numerosi intellettuali dell’epoca. Vernon Lee ebbe anche una stretta amicizia con la scrittrice Amy Levy, che alla fine si suicidò nel 1889. Questo evento ebbe un profondo impatto su Lee e si riflette nella sua opera successiva.
È importante notare che, nonostante la sua sessualità e le relazioni che ebbe con donne, Vernon Lee mantenne una certa discrezione sulla sua vita privata. In un’epoca in cui l’omosessualità era ancora strettamente condannata e considerata inappropriata, Lee si sentiva spesso costretta a nascondere la sua vera identità e a utilizzare lo pseudonimo maschile per proteggere se stessa e la sua reputazione.
Oltre alla sua vita amorosa, Vernon Lee si dedicò appassionatamente alla sua carriera letteraria e all’attivismo sociale. Fu una sostenitrice dei diritti delle donne e dell’uguaglianza di genere, e scrisse numerosi saggi e articoli su questi temi. Trascorse gran parte della sua vita in Italia, ma viaggiò anche in altre parti d’Europa, tra cui la Germania, la Francia e l’Inghilterra. La sua esperienza di viaggio e l’esplorazione di diversi luoghi e culture influenzarono profondamente il suo lavoro, compreso il suo interesse per il concetto di “genius loci” che espresse nel suo libro “Genius Loci”.
Vernon Lee continua ad essere considerata una figura di spicco nella storia letteraria e un’icona per la sua audacia nel vivere la sua vita come desiderava, sfidando le convenzioni sociali dell’epoca. La sua eredità come scrittrice e come figura queer rimane un importante contributo alla cultura e all’arte. (chatGPT)[image error]
October 12, 2023
Le parole sono pietre. Le pietre sono parole
 Foto@angallo
Foto@angalloIn senso letterale, le parole non sono pietre. Le pietre sono oggetti fisici, mentre le parole sono entità immateriali. Le pietre possono essere lanciate, usate per costruire o per danneggiare, si pensa che non possono essere usate per comunicare o per esprimere emozioni. Eppure, le pietre, che vedete nella foto che correda questo post, parlano. Ci parlano di un tempo lontano, lontanissimo e misterioso, in una lingua sconosciuta.
In senso figurato, le parole possono essere paragonate a pietre. In questo caso, le parole sono pietre. Possono essere state usate per costruire o per distruggere, per ferire o per guarire. Le parole possono essere un’arma potente e possono avere un impatto significativo sulle persone. Di certo, anche queste pietre furono protagoniste di eventi rimasti sconosciuti.
Il proverbio “le parole non sono pietre” vuole significare che le parole non sono così pericolose come le pietre. Non è vero. Le pietre possono causare danni fisici, le parole possono causare danni emotivi. Tuttavia, non sappiamo bene quale funzione ebbero queste pietre, se di difesa o di violenza. Le parole possono anche essere usate per guarire e per costruire, come potettere essere anche questi macigni. Ma le parole possono essere usate anche come pietre, per ferire.
Un insulto può offendere i sentimenti di una persona. Una critica può far sentire qualcuno inadeguato. Le parole possono essere usate per manipolare. Un ricatto emotivo può essere usato per controllare il comportamento di qualcun altro. Le parole possono essere usate per diffondere odio. La propaganda può essere usata per incitare alla violenza o alla discriminazione. Le stesse cose possono aver fatto queste pietre.
Tuttavia, le parole possono anche essere usate per costruire, per esprimere amore. Un complimento può far sentire qualcuno apprezzato. Una parola di incoraggiamento può dare a qualcuno la forza di andare avanti. Le parole possono essere usate per educare. Un insegnante può usare le parole per trasmettere conoscenza e competenze. Le parole possono essere usate per ispirare. Un discorso può motivare le persone a cambiare il mondo.
Le parole non sono pietre, ma possono essere usate per costruire o per distruggere. È importante usare le parole con cura e consapevolezza, in modo che possano essere usate per il bene. sono un linguista. Mi piacciono le parole. Sono strumenti potenti e versatili che consentono di esprimere una vasta gamma di concetti e significati. In termini di quantità, le parole sono virtualmente infinite. La lingua è un sistema dinamico e in continua evoluzione, in cui nuove parole vengono create, modificate o aggiunte regolarmente.
Esistono migliaia di lingue in tutto il mondo, ognuna con il proprio vocabolario e insieme di parole uniche. Anche all’interno di una singola lingua, come l’inglese ad esempio, si stima che esistano centinaia di migliaia di parole. Questo include parole di base, come sostantivi, verbi e aggettivi, oltre a parole specializzate che descrivono concetti specifici in campi come la scienza, la tecnologia, l’arte, la medicina e molti altri.
Inoltre, le parole possono essere combinate in modo creativo per formare espressioni, frasi e testi che possono avere significati e sfumature diverse. La capacità di combinare e manipolare le parole offre un’ampia gamma di possibilità linguistiche e comunicative. Medesime cose possono fare le pietre, o sbaglio?
Quindi, in definitiva, il numero di cose che le parole possono rappresentare o descrivere è praticamente illimitato, poiché le parole sono uno strumento fondamentale per esprimere pensieri, emozioni, concetti e conoscenza in tutte le sfere della nostra vita. Le parole svolgono un ruolo cruciale nella comunicazione, consentendoci di esprimere i nostri pensieri, sentimenti e idee. Ecco alcuni altri aspetti che vale la pena esplorare:
Ricchezza semantica: le parole hanno profondità semantica e possono portare molteplici significati e sfumature. Una singola parola può evocare connotazioni o sfumature di significato diverse a seconda del contesto o del background culturale. Questa ricchezza semantica consente flessibilità e precisione nella comunicazione.
Evoluzione della lingua: le lingue non sono statiche; evolvono nel tempo. Nuove parole vengono costantemente coniate o prese in prestito per descrivere concetti emergenti o progressi tecnologici. Allo stesso modo, le parole possono uscire dall’uso comune o cambiare significato, riflettendo i cambiamenti nella società, nella cultura e nella tecnologia.
Significato culturale e storico: le parole spesso hanno un significato culturale e storico. Possono incapsulare i valori, le tradizioni e le esperienze di una particolare comunità o riflettere eventi e influenze storiche. Esplorare l’etimologia e le associazioni culturali delle parole può fornire informazioni sul patrimonio condiviso e sulla diversità delle culture umane.
Espressione poetica e artistica: le parole non sono solo funzionali ma servono anche come strumenti per l’espressione artistica. Nella poesia, nella letteratura, nei testi delle canzoni e in altre forme di scrittura creativa, le parole vengono scelte e disposte con cura per evocare emozioni, creare immagini e trasmettere idee complesse. La bellezza e il potere del linguaggio possono essere trovati nella sua capacità di evocare immagini mentali vivide e stimolare l’immaginazione.
Linguaggio e identità: le parole sono profondamente intrecciate con le identità personali e collettive. Le lingue che parliamo, le parole che usiamo e il modo in cui ci esprimiamo contribuiscono al nostro senso di sé e al modo in cui siamo percepiti dagli altri. La lingua può modellare la nostra visione del mondo, influenzare le nostre affiliazioni culturali e favorire un senso di appartenenza.
Linguaggio e pensiero: il rapporto tra linguaggio e pensiero è un’affascinante area di studio. Le parole non solo esprimono i nostri pensieri, ma modellano e influenzano anche i nostri processi mentali. Le lingue che parliamo possono influenzare il modo in cui percepiamo il mondo, categorizziamo le informazioni e concettualizziamo idee astratte.
Le parole non sono solo strumenti di comunicazione; sono gli elementi costitutivi dell’espressione, della cultura e della conoscenza umana. Esplorare le complessità del linguaggio può fornire una comprensione più profonda di noi stessi, delle nostre società e del modo in cui interagiamo con il mondo. Anche le pietre di Stonehenge parlano. Di un mistero millenario.
Ogni qualvolta ho l’opportunità di andarci, mi raccontano storie diverse. Stonehenge, il monumento neolitico situato nella pianura di Salisbury, nel sud dell’Inghilterra, è uno dei siti archeologici più enigmatici e affascinanti al mondo. Composto da grandi pietre erette in cerchio, si pensa che sia stato costruito tra il 3000 e il 2000 a.C. Ha da sempre incuriosito e stimolato la fantasia di studiosi, archeologi e visitatori.
Oltre alla sua struttura imponente e alla sua collocazione suggestiva, Stonehenge è stato oggetto di speculazioni riguardo alla sua funzione e al suo significato per secoli. Ma c’è un aspetto che spicca in modo particolare: le pietre parlanti di Stonehenge. L’idea che le pietre possano parlare sembra fantascienza o pura fantasia, ma ci sono testimonianze che suggeriscono che Stonehenge fosse considerato un luogo sacro e un centro cerimoniale, dove si credeva che le pietre avessero una sorta di voce o potere.
Questa credenza è stata tramandata attraverso le generazioni e ha portato a numerose leggende e storie che coinvolgono le pietre parlanti. Secondo alcune leggende, le pietre di Stonehenge erano in grado di comunicare con gli dei o con gli antichi spiriti. Si diceva che avessero il potere di predire il futuro, di curare malattie o di trasmettere messaggi divini. Alcune persone credevano che se si ascoltava attentamente, si potessero percepire sussurri o voci misteriose provenire dalle pietre.
Queste storie sono state tramandate oralmente, non esistono prove concrete che le pietre di Stonehenge abbiano effettivamente avuto la capacità di parlare. Tuttavia, i miti e le leggende che circondano il sito hanno contribuito a creare un’aura di mistero e magia intorno ad esso. Gli antichi costruttori di Stonehenge, appartenenti alla cultura neolitica, avevano una profonda connessione con la natura e con il mondo spirituale. Le pietre erano considerate sacre e rappresentavano un ponte tra il mondo umano e quello divino. Quindi, anche se non parlavano nel senso letterale del termine, si pensava che fossero portatrici di un qualche tipo di energia o messaggio.
Oggi, Stonehenge è un importante sito turistico e un patrimonio dell’umanità. Gli archeologi continuano a studiare e a fare scoperte sul suo scopo originale e sulla sua storia. Nonostante siano state fornite spiegazioni razionali sulla sua costruzione e funzione come un osservatorio astronomico o un luogo di sepoltura, il fascino e il mistero delle pietre parlanti di Stonehenge persistono. Rappresentano un legame con il passato e ci ricordano che la storia dell’umanità è ricca di credenze, miti e storie che ci aiutano a comprendere il nostro posto nel mondo. Anche se non possiamo ascoltare direttamente le voci delle pietre, possiamo ancora apprezzare il loro valore simbolico e lasciarci affascinare dal loro potere evocativo.
Rimangono un enigma irrisolto. Sebbene non ci siano prove concrete che supportino la loro capacità di comunicare, la loro presenza e il loro significato simbolico continuano ad affascinare e a ispirare l’immaginazione umana. Stonehenge si erge come un monumento immortale, un testimone silenzioso di un passato remoto e delle storie che ancora oggi ci racconta, anche se solo attraverso le pietre e l’immaginazione. Un luogo avvolto da numerose leggende e storie affascinanti. Ecco alcune delle più note:
La Leggenda di Merlino: Secondo una leggenda popolare, il leggendario mago Merlino avrebbe portato le pietre di Stonehenge dalla sua patria in Irlanda o in Galles. Si dice che Merlino abbia utilizzato i suoi poteri magici per spostare le pietre e le abbia posizionate nel luogo in cui si trovano oggi. La leggenda suggerisce che Merlino avesse anche il dono di far parlare le pietre e che avesse utilizzato Stonehenge come luogo per consultare gli dei e ricevere profezie.
L’Influsso Lunare: Stonehenge è allineato in modo tale che le pietre siano orientate verso il sorgere del sole durante il solstizio d’estate. Questo ha portato a una leggenda secondo cui le pietre emettono un suono armonioso quando vengono colpite dalla luce lunare durante le notti di luna piena. Alcuni visitatori hanno riferito di aver udito un suono simile a un canto provenire dalle pietre. Questa leggenda alimenta l’idea che le pietre di Stonehenge abbiano un legame speciale con il ciclo lunare e le forze cosmiche.
Il Gioco delle Pietre Parlanti: Secondo una storia popolare, le pietre di Stonehenge avrebbero avuto la capacità di rispondere alle domande degli individui che si avvicinavano ad esse. Si dice che le pietre abbiano fornito saggezza, consigli o risposte profetiche. Per ottenere una risposta, le persone avrebbero dovuto toccare le pietre o sussurrare le loro domande all’orecchio di una pietra specifica. Questa leggenda riflette la credenza che Stonehenge fosse un luogo sacro dove le pietre avevano un potere divino.
La Leggenda dei Giganti: Secondo un’altra storia, Stonehenge sarebbe stato costruito dai giganti. Si dice che i giganti abbiano portato le enormi pietre dalle lontane montagne dell’Irlanda o del Galles e le abbiano posizionate sul sito. Questa leggenda conferisce un elemento di magia e mistero alla costruzione di Stonehenge, suggerendo che le pietre abbiano un’origine soprannaturale.
Queste sono solo alcune delle leggende e delle storie che circondano Stonehenge. Ogni racconto contribuisce a creare un’atmosfera di mistero e incanto intorno a questo antico sito, nutrendo la nostra immaginazione e la nostra connessione con il passato. In fondo, l’intera storia umana è fatta di pietre e di parole.
[image error]Ottobre: il mese delle illusioni

Dieci anni fa scrissi questo post sul mio archivio-blog Unideadivita. Fanno più di cento anni da quell’ottobre del 1917 quando la Rivoluzione Russa celebrò il suo trionfo. Ricordo l’evento con una poesia del poeta contadino Sergej Aleksandrovic Esenin nato il 3 ottobre 1895 a Konstantinovo (oggi Esenino), nella regione di Rjazan (Russia). Figlio unico di genitori contadini.
Esponente più importante della cosidetta scuola dei “poeti contadini”. Nei suoi versi traspare il mondo rurale della Russia di inizio Novecento. Le sue parole esaltano inizialmente le bellezze della campagna e l’amore verso il regno animale. Aderì sin dagli inizi alla rivoluzione con infantile entusiasmo, ma a partire dal 1920 la delusione serpeggia nelle sue liriche.
Lentamente questo stato d’animo si trasforma in angoscia, poi in disprezzo per la propria vita, sino alla maturazione dell’idea del suicidio consumato a soli trenta anni, in una camera d’albergo bordello a Leningrado tra vizi e alcool. La poesia che leggete qui sotto getta come una luce rivelatrice sull’atto finale che porterà alla conclusione delle sue illusioni. Non ci resta che ricordarlo con grande rispetto e pietà.
Noi adesso che ce ne andiamo
Noi adesso ce ne andiamo a poco a poco
verso il paese dov’è gioia e quiete.
Forse, ben presto anch’io dovrò raccogliere
le mie spoglie mortali per il viaggio.
Care foreste di betulle!
Tu, terra! E voi, sabbie delle pianure!
Dinanzi a questa folla di partenti
non ho forza di nascondere la mia malinconia.
Ho amato troppo in questo mondo
tutto ciò che veste l’anima di carne.
Pace alle trèmule che, allargando i rami,
si sono specchiate nell’acqua rosea.
Molti pensieri in silenzio ho meditato,
molte canzoni entro di me ho composto.
Felice io sono sulla cupa terra
di ciò che ho respirato e che ho vissuto.
Felice di aver baciato le donne,
pestato i fiori, ruzzolato nell’erba,
di non aver mai battuto sul capo
le bestie, nostri fratelli minori.
So che là non fioriscono boscaglie,
non stormisce la ségala dal collo di cigno.
Perciò dinanzi a una folla di partenti
provo sempre un brivido.
So che in quel paese non saranno
queste campagne biondeggianti nella nebbia.
Anche perciò mi sono cari gli uomini
che vivono con me su questa terra.
Sergej Aleksandrovič Esenin
Sergej Esenin in:
“Poesia russa del Novecento”
traduzione di A. M. Ripellino
Feltrinelli , Milano 1960
Chi la chiama “rivoluzione d’ottobre”, chi “rivoluzione d’autunno”, chi “rivoluzione bolscevica”, chi “rivoluzione russa”, chi “vento d’ottobre”. Una cosa certa è che accadde nel mese di ottobre del 1917. Un secolo fa che sembra un millennio. Il post che segue è la cronaca degli eventi così come si svolsero, senza alcuna manipolazione ideologica. Bisogna ricordare che in Russia a quel tempo si usava il calendario giuliano e quindi la rivoluzione avvenne nel mese di novembre e per questa ragione viene detta anche “Rivoluzione di novembre”.
A dire il vero, tutto ebbe inizio prima. Le vicende non si svilupparono in maniera ordinata ed organica. Come sempre succede in situazioni del genere, qualcuno al potere venne spodestato e fu sostituito da qualche altro. In questo caso furono molti gli “altri”. Vediamo in breve cosa accadde in questa che mi piace chiamare la stagione dell’“autunno rosso”. Tutto, quindi, non accadde così all’improvviso. Non è che da un giorno all’altro lo Zar Nicola II fu spodestato e sostituito da Lenin e dai Bolscevichi . Diversi fatti accaddero nel 1917 i quali scatenarono due diverse e distinte rivoluzioni, a febbraio ed ottobre. Tra questi due mesi un grande numero di fatti politici si susseguirono portando il grande Paese russo alla guerra civile prima ed alla formazione dello stato comunista poi.
Il primo fatto importante accadde a febbraio. Concluse un periodo di grande confusione sia politica che militare. Le cause di questa grande instabilità vanno ritrovate nella ostilità di gran parte della popolazione nei confronti dello Zar e degli aristocratici proprietari terrieri. Non possono essere facilmente descritte ed analizzate in così breve spazio. Tra i diversi fattori chiave fu il conflitto tra il trattamento crudele dei contadini da parte dei nobili, le tristi condizioni di lavoro dei lavoratori nelle fabbriche ed un crescente senso di coscienza politica e sociale delle classi inferiori sotto la spinta delle idee di democrazia che provenivano dall’Occidente.
A tutto ciò si aggiungevano errori militari, mancanza di generi alimentari di prima necessità. La Russia nel 1905 aveva sperimentato perdite umilianti nella guerra russo-giapponese. Durante una dimostrazione contro questa guerra in questo anno le truppe dello Zar avevano fatto fuoco sulla folla allargando il solco tra Nicola II ed il suo popolo. Seguirono scioperi, sommosse e disordini come il famoso episodio della corazzata Potemkin .
Se questo era il clima nel 1905 si spiega perchè lo stesso Zar, contro la sua stessa volontà, si decidesse a stendere nel suo manifesto di ottobre di quell’anno, la prima Costituzione e la Duma , un parlamento eletto dal popolo. Egli comunque pensava che anche con queste concessioni potesse continuare a governare per diritto divino. Un’idea questa che forse continua a dominare nell’animo di molti governanti russi, e non solo russi, ancora oggi.
Quando l’ Arciduca d’Austria venne assassinato in Serbia nel 1914 l’impero austro-ungarico dichiarò guerra ai suoi vicini. La Serbia si rivolse alla Russia per aiuto. Lo Zar Nicola II vide l’opportunità di guadagnarsi il favore popolare contro un nemico comune e compensare le umiliazioni subite nella guerra russo-giapponese. Ma la cosa non funzionò. Sotto molti aspetti la partecipazione russa alla prima guerra mondiale fu il colpo finale al potere dello Zar.
Nella battaglia di Tannenberg l’esercito russo perse migliaia di uomini. L’anno successivo vide continuare a crollare il morale della popolazione che si trovava a vivere in condizioni di grande difficoltà. La pentola della ribellione bolliva sempre più forte. Il 23 febbraio del 1917 la Giornata Internazionale della Donna a San Pietroburgo si trasformò in una grande manifestazione popolare contro le difficoltà del vivere. Il giorno successivo le dimostrazioni continuarono.
Gli uomini si unirono alle donne ed anche gli attivisti politici fecero sentire la loro presenza. Ogni attività produttiva si fermò. Lo Zar Nicola fece intervenire la polizia ma i militari non vollero partecipare negando così la loro fiducia allo Zar. Molti passarono dalla parte dei dimostranti. La città era in pieno caos.
Alcuni storici hanno accertato che il 28 ottobre si ammutinarono circa 80.000 membri dell’esercito. I disordini si diffondevano a macchia d’olio. Lo Zar si vide costretto ad abdicare a favore del fratello Michele il quale non accettò chiedendo di essere eletto dalla Duma. Si dimise anche lui e lasciò la Russia senza un capo. Venne formato un governo provvisorio condotto da membri della Duma che venne riconosciuto da numerosi paesi stranieri. Doveva governare lo stato fino a nuove elezioni. Il suo potere si rivelò né forte né stabile.
Il Partito Radicale dei Soviet di Pietrogrado era un sindacato dei lavoratori e di soldati con un grande seguito e una forte influenza. propugnava spinte verso idee socialiste su vasta scala in opposizione a forme democratiche più moderate sostenute da membri del governo provvisorio. Dopo secoli di governo imperiale la Russia veniva presa da una imprevista frenesia politica. Ma le idee e le fazioni erano troppe e lasciavano sperare nessuna stabilità.
Una persona ansiosa di avvantaggiarsi della situazione caotica che si era creata a San Pietroburgo era Vladimir Ilych Ulyanov , conosciuto come Lenin. Egli aveva viaggiato e lavorato in molti paesi europei, correndo molti rischi per la sua vita a causa delle idee socialiste. Era considerato nemico del regime e quando lo Zar venne arrestato, colse la grande opportunità di assumere il comando del suo partito, i Bolscevichi, per conquistare il potere.
Dalla Svizzera, dove si trovava, negoziò il suo ritorno in patria. I tedeschi lo fecero passare nel famoso “treno blindato”. Il 3 aprile del 1917 il treno entrò a Pietrogrado alla Stazione Finlandia tra la folla plaudente. Il ritorno di Lenin non unì le numerose fazioni esistenti e le sue ferventi convinzioni ideologiche ostili sia al Governo provvisorio che ai Soviet di Pietrogrado. Nelle sue famose tesi di aprile pubblicate sul giornale bolscevico la Pravda egli auspicava nessuna collaborazione con i liberali, vale a dire chi non era convinto comunista, e una immediata fine della guerra.
In principio queste sue idee lo isolarono insieme ai suoi seguaci i Bolscevichi. Ma col tempo i suoi slogan del tipo “Pace, Terra e Pane” e le sue idee penetrarono fecero breccia nei cuori e nella mente del popolo Russo incapace ormai di sopportare ancora tanta fame e miseria. Nell’estate del 1917 Lenin fece diversi tentativi di provocare un’altra rivoluzione simile a quella di febbraio con lo scopo di rovesciare il Governo provvisorio.
Quando il reggimento dei mitraglieri si rifiutò di lasciare la città per andare al fronte di guerra Lenin cercò di manipolarli invece di fare un “colpo di stato”. Alexander Fedorovich Kerensky , che era una importante figura politica, membro sia del Governo provvisorio che del Soviet di Pietrogrado, abilmente evitò il tentativo anche con l’intervento di truppe arrivate in città a bloccare i dissidenti. I Bolscevichi vennero accusati di essere collusi con i tedeschi. Molti vennero arrestati mentre Lenin fuggì in Finlandia.
Nonostante questo disastro politico strategico Lenin continuò a complottare e progettare. Nel frattempo Kerensky perse molto del suo potere e fu costretto addirittura a chiedere aiuto militare ai Bolscevichi quando si accorse che il ministro della guerra Kornilov stava tentando un colpo di mano militare. Verso l’inizio dell’autunno i Bolscevichi erano in ascesa, avevano la maggioranza dei voti sia nei Soviet di Pietrogrado che a Mosca.
Leon Trotsky venne eletto presidente a Pietrogrado. Con i politici russi in continuo fermento Lenin si rese conto che era giunto il tempo per lui di fare tesoro della fama che si era guadagnato nel corso del tempo. Egli progettò un colpo di stato in modo da rovesciare il debole Governo provvisorio e rimpiazzarlo con quello dei Bolscevichi. Il 10 ottobre egli tenne la famosa riunione con i dodici capi di partito e cercò di persuaderli della necessità della rivoluzione. Solo 10 di essi aderirono al progetto.
Il 24 ottobre era la data decisa per il colpo e quel giorno le truppe fedeli ai Bolscevichi si impossessarono delle posizioni cruciali della città, i telefoni, le banche, le ferrovie, gli uffici postali e i ponti principali. Molti militari appartenenti al Governo provvisorio passarono all’altra parte senza resistenza. Il 25 ottobre ogni punto chiave are sotto controllo del Bolscevichi, tranne il Palazzo d’Invernodove Kerensky e gli altri ministri si erano asserragliati con poche guardie.
Alle ore nove del 25 ottobre Kerensky fuggì in auto dal palazzo e dalla Russia senza mai più ritornarvi. Il 26 il palazzo venne preso con solo qualche colpo di fucile. La Rivoluzione era fatta con qualche scaramuccia e senza spargimento di sangue. Nonostante il grande potere conquistato Lenin ben presto scoprì che non aveva il potere assoluto. La sua politica di pace con i tedeschi era molto impopolare poichè concedette a questi una grande quantità di territorio russo.
Poco dopo la rivoluzione, la guerra civile russa scoppiò tra i “rossi”, i comunisti, e i “bianchi”, i nazionalisti, conservatori, imperialisti ed altri gruppi antibolscevichi. Dopo quattro anni di scontri sanguinosi Lenin e i “rossi” vinsero formando l’Unione Sovietica nel 1922 pagando il prezzo di oltre 15 milioni di morti oltre milaidi di rubli. Nel 1923 Lenin morì e gli succedette il generale Stalin al comando del Partito Comunista. Questo regime è durato fino al 1991 allorquando la così detta URSS si dissolse e lo stato riprese il suo antico nome di Russia.
Cosa resta oggi, XXI° secolo, di quell’ “autunno rosso”? Forse una “magnifica illusione”. Come tutte le “rivoluzioni”.
Infinita è la bibliografia sulla Rivoluzione d’Ottobre in tutte le lingue. Chi fosse interessato ad eventuali approfondimenti in lingua italiana può leggere questi libri .
Postato 7th October 2012 da galloway
[image error]October 11, 2023
Se l’essere umano è un sistema “complesso” e per giunta “adattativo”…
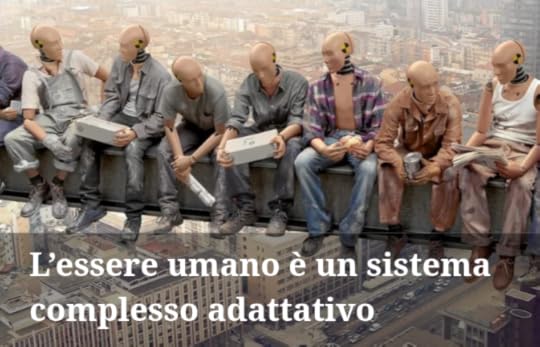 Uomo e Tecnologia
Uomo e Tecnologia
In un precedente post ho scritto che il conflitto arabo-israeliano è un problema “complesso”. Se entrambe quelle realtà sono costituite da esseri umani, e certamente lo sono, allora anche l’essere umano deve essere necessariamente un “sistema complesso” e per giunta “adattativo”.
Sì, l’essere umano può essere considerato un “sistema complesso”. Un sistema complesso è caratterizzato da un insieme di componenti interagenti che generano comportamenti globali emergenti.
L’essere umano è composto da una vasta gamma di elementi interconnessi, tra cui organi, tessuti, cellule, molecole e così via. Questi componenti interagiscono tra loro in modi complessi e dinamici, formando un sistema biologico altamente organizzato. Ci sono diverse caratteristiche dell’essere umano che lo rendono un sistema complesso.
Ad esempio, il cervello umano è un sistema complesso in sé, con miliardi di neuroni che interagiscono tra loro attraverso connessioni sinaptiche. Queste interazioni neuronali generano processi cognitivi, emozioni e comportamenti complessi.
Inoltre, il corpo umano è influenzato da una vasta gamma di fattori interni ed esterni, come l’ambiente, il cibo, lo stile di vita e le relazioni sociali. Questi fattori interagiscono in modo intricato e possono influenzare la salute, il benessere e il comportamento dell’individuo.
Un’altra caratteristica dei sistemi complessi è la capacità di adattarsi e di reagire a cambiamenti interni ed esterni. L’essere umano può adattarsi a varie condizioni ambientali, imparare nuove abilità e reagire a stimoli esterni in modi complessi e flessibili.
L’uomo può essere considerato un sistema complesso a causa delle interazioni dinamiche tra i suoi molteplici componenti, delle proprietà emergenti che ne derivano e della capacità di adattarsi e rispondere a cambiamenti.
Lo studio dei sistemi complessi nel contesto dell’essere umano può contribuire alla comprensione della biologia, della psicologia, della sociologia e di altri campi legati alla complessità dell’esperienza umana.
Ecco alcuni aspetti aggiuntivi da considerare quando si parla dell’essere umano come sistema complesso:
Dinamiche non lineari: i sistemi complessi, inclusi il corpo e la mente umana, spesso mostrano dinamiche non lineari. Ciò significa che piccoli cambiamenti in un componente possono portare a effetti significativi e imprevedibili sull’intero sistema. Ad esempio, una piccola mutazione genetica o un leggero cambiamento nell’attività cerebrale possono avere profonde conseguenze sulla salute o sul comportamento di un individuo.
Auto-organizzazione: i sistemi complessi hanno la capacità di auto-organizzarsi, nel senso che possono formare spontaneamente modelli o strutture senza controllo esterno. Nel corpo umano, l’autorganizzazione è evidente in processi come lo sviluppo embrionale, in cui le cellule si organizzano in tessuti e organi attraverso intricati percorsi di segnalazione.
Cicli di feedback: i cicli di feedback sono una caratteristica essenziale dei sistemi complessi. Implicano lo scambio di informazioni tra diversi componenti del sistema, in cui l’output di un componente influenza il comportamento di un altro. Nel corpo umano, i circuiti di feedback regolano vari processi fisiologici, come il controllo della temperatura, la regolazione ormonale e le risposte immunitarie.
Proprietà emergenti: i sistemi complessi spesso mostrano proprietà emergenti, che sono caratteristiche o comportamenti che derivano dalle interazioni dei componenti del sistema ma che non possono essere direttamente attribuiti a nessun singolo componente. Nel caso degli esseri umani, la coscienza, l’intelligenza e il comportamento sociale sono esempi di proprietà emergenti che derivano dalle complesse interazioni di neuroni, regioni del cervello e reti sociali.
Sensibilità alle condizioni iniziali: i sistemi complessi possono essere sensibili alle loro condizioni iniziali, il che significa che piccole differenze nello stato iniziale del sistema possono portare a risultati significativamente divergenti. Questo viene spesso definito “effetto farfalla”. Nel contesto del comportamento umano, piccoli cambiamenti nelle prime esperienze o nei fattori ambientali possono avere effetti a lungo termine sullo sviluppo e sulle scelte di un individuo.
Adattabilità: i sistemi complessi, compresi gli esseri umani, possiedono adattabilità e la capacità di rispondere ai cambiamenti nel loro ambiente. Il corpo umano può adattarsi a varie condizioni attraverso processi come l’omeostasi, dove mantiene un ambiente interno stabile nonostante le fluttuazioni esterne. Inoltre, gli esseri umani possono adattare i propri comportamenti, convinzioni e abilità in risposta a nuove sfide ed esperienze.
Se le cose stanno cosi, non ci resta che esemplificare nella speranza di rendere i vari sistemi coinvolti comprensibili. Proviamo con l’aforisma. Ecco due aforismi sull’essere umano come sistema complesso: “Un universo in miniatura”, “Un puzzle senza soluzione”. Aveva ragione Amleto: “Essere o non essere. Questo è il problema”.[image error]
October 10, 2023
Il problema arabo-israeliano è un intricato labirinto di complessità
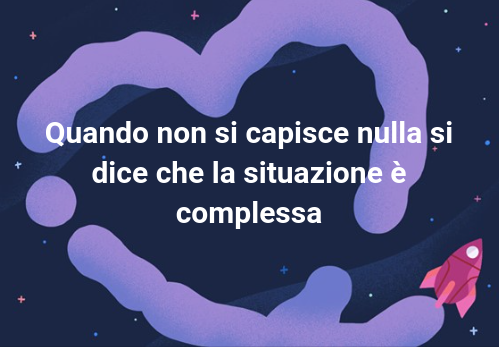 @angallo
@angalloL’etimologia della parola “complessità” può essere rintracciata nel latino “complexus”, che significa “intrecciato” o in inglese “intertwined”. Il termine deriva dal participio passato del verbo “complecti”, che indica l’atto di abbracciare o avvolgere insieme. Quindi, l’origine etimologica della parola “complessità” suggerisce un concetto di intreccio, connessione o interdipendenza tra elementi diversi.
Questo richiama alla mente l’idea che gli aspetti di un sistema complesso siano collegati in modo intricato e che le loro relazioni reciproche contribuiscano alla natura complessa del sistema stesso. Nella vita quotidiana, si possono trovare numerosi esempi di sistemi complessi che mostrano caratteristiche di interconnessione, dinamiche non lineari e comportamenti emergenti. Ecco alcuni esempi:
Il traffico stradale: Il traffico stradale è un esempio di sistema complesso in cui le auto, i pedoni, i semafori e le infrastrutture stradali interagiscono tra loro. Le dinamiche del traffico possono essere imprevedibili, con fenomeni come le onde di congestione che emergono da interazioni complesse tra i veicoli.
Il mercato finanziario: I mercati finanziari sono sistemi complessi in cui gli investitori, le istituzioni finanziarie, le notizie economiche e le dinamiche di mercato si influenzano reciprocamente. Il prezzo delle azioni, ad esempio, può essere influenzato da fattori economici, politici e psicologici, generando comportamenti non lineari e imprevedibili.
Il clima: Il sistema climatico terrestre è estremamente complesso, con interazioni tra l’atmosfera, l’oceano, la biosfera e la geosfera. Il clima è influenzato da fattori come la temperatura, la pressione atmosferica, i venti, le correnti oceaniche e le attività umane. Le previsioni meteorologiche a lungo termine sono difficili a causa delle interazioni complesse all’interno del sistema climatico.
Il cervello umano: Il cervello umano è un sistema complesso che coinvolge miliardi di neuroni interconnessi. Le interazioni tra questi neuroni danno origine a processi cognitivi, emozionali e comportamentali complessi. La comprensione di come funziona il cervello e come emergono la coscienza e la mente rimane una sfida scientifica aperta.
I sistemi ecologici: Gli ecosistemi naturali sono esempi di sistemi complessi in cui gli organismi viventi, le risorse ambientali, il clima e le interazioni tra specie sono intrecciate. I cambiamenti in un componente di un ecosistema possono avere effetti a cascata su tutto il sistema, con conseguenze imprevedibili.
Le reti sociali: Le reti sociali, come ad esempio i social media, sono sistemi complessi in cui le persone si connettono, comunicano e influenzano reciprocamente. Le dinamiche delle reti sociali possono generare fenomeni come la diffusione di informazioni virali, la formazione di comunità online e l’emergere di tendenze culturali.
Questi sono solo alcuni esempi di sistemi complessi che si trovano nella vita quotidiana. In generale, i sistemi complessi sono presenti in molte sfere della nostra esistenza e comprendono una vasta gamma di fenomeni che richiedono un’analisi approfondita e un approccio olistico per comprenderli appieno. Il problema arabo-israeliano è un intricato labirinto di complessità.
Un tema che affligge la regione del Medio Oriente da decenni, generando tensioni politiche, sociali ed economiche che hanno avuto un impatto significativo sulla stabilità della regione. Tuttavia, definire questa questione come semplicemente “complicata” sarebbe un’analisi riduttiva. In realtà, il problema arabo-israeliano è intrinsecamente complesso, caratterizzato da una pluralità di fattori storici, politici, religiosi e culturali che si intrecciano in un intricato labirinto di dinamiche interconnesse.
Complessità storica:
Per comprendere appieno la complessità del problema, è necessario ripercorrere brevemente il contesto storico. Il conflitto tra arabi e israeliani ha le sue radici nel movimento sionista del XIX secolo, che mirava a stabilire uno stato ebraico in Palestina. Questo ha suscitato una serie di reazioni e conflitti con la popolazione araba locale, che si sono intensificati con la dichiarazione di indipendenza di Israele nel 1948 e le successive guerre arabo-israeliane. Da allora, il conflitto si è evoluto in un intricato groviglio di rivendicazioni territoriali, diritti umani, questioni di sicurezza e aspirazioni nazionali.
Complessità politica:
Il problema arabo-israeliano coinvolge numerose parti interessate, tra cui Israele, i palestinesi, gli stati arabi circostanti e la comunità internazionale. Le diverse posizioni e gli interessi contrapposti di queste parti rendono estremamente difficile raggiungere un accordo duraturo. La questione dello status di Gerusalemme, dei confini, dei rifugiati palestinesi e delle colonie israeliane rappresenta solo alcune delle questioni politiche che richiedono una soluzione complessa e delicata.
Complessità religiosa e culturale:
Il conflitto arabo-israeliano ha anche una dimensione profondamente radicata nella religione e nella cultura. Gerusalemme, in particolare, è un luogo sacro per ebrei, cristiani e musulmani, che rivendicano tutti diritti storici e spirituali sulla città. Questa complessità religiosa e culturale si riflette nelle aspettative, nei valori e nelle identità delle diverse comunità coinvolte, rendendo ancora più difficile trovare un terreno comune su cui basare una soluzione.
Complessità socioeconomica:
La situazione socioeconomica nella regione aggiunge un ulteriore strato di complessità al problema. La povertà, la disoccupazione e la mancanza di risorse sono sfide comuni per molti palestinesi e israeliani, alimentando la frustrazione e il dissenso. La necessità di affrontare queste questioni socioeconomiche complesse, insieme alle dinamiche politiche e culturali, richiede soluzioni olistiche e sostenibili.
Il problema arabo-israeliano rappresenta un esempio paradigmatico di complessità. Le sue radici storiche, le dinamiche politiche, religiose, culturali e socioeconomiche si intrecciano in un intricato labirinto di sfide che richiedono un approccio multilaterale e una volontà politica forte per essere affrontate in modo efficace. Ecco alcuni degli ostacoli principali:
Rivendicazioni territoriali: Entrambe le parti hanno forti rivendicazioni territoriali sulla stessa area geografica, in particolare sulla Cisgiordania e sulla Striscia di Gaza. La questione dei confini è estremamente delicata e suscita tensioni significative, poiché entrambe le parti considerano determinate terre come parte integrante del proprio futuro stato nazionale.
Lo status di Gerusalemme: Gerusalemme è una città sacra per ebrei, cristiani e musulmani, e le rivendicazioni su questa città sono una fonte di profonda divisione. Entrambe le parti considerano Gerusalemme come la propria capitale, e la questione dello status di Gerusalemme rimane uno dei principali ostacoli per una soluzione negoziata.
Insediamenti e colonie: La costruzione e l’espansione degli insediamenti israeliani nelle aree occupate della Cisgiordania rappresentano un ostacolo significativo. Molti nella comunità internazionale considerano gli insediamenti illegali secondo il diritto internazionale e li vedono come un impedimento alla creazione di uno stato palestinese indipendente.
Sicurezza e terrorismo: La sicurezza è una preoccupazione fondamentale per entrambe le parti. Israele ha subito attacchi terroristici e si preoccupa della propria protezione nazionale, mentre i palestinesi affrontano restrizioni di movimento e misure di sicurezza che possono limitare la loro libertà di movimento e l’accesso alle risorse. La sfida consiste nel trovare un equilibrio tra la sicurezza di entrambe le parti e il rispetto dei diritti umani dei palestinesi.
Status dei rifugiati palestinesi: La questione dei rifugiati palestinesi, che sono stati sfollati o costretti a lasciare le loro terre durante i conflitti del 1948 e del 1967, è un problema complesso e delicato. Molti palestinesi rivendicano il diritto al ritorno alle loro terre d’origine, mentre Israele teme che un ritorno massiccio dei rifugiati possa minacciare la sua identità e sicurezza come stato ebraico.
#chatGPT[image error]
Mancanza di fiducia reciproca: La mancanza di fiducia reciproca tra le parti rappresenta un ostacolo significativo. Decenni di conflitti, violenze e negoziati falliti hanno minato la fiducia tra arabi e israeliani. La ricostruzione di un clima di fiducia richiede gesti di buona volontà, impegni concreti e una volontà politica forte da entrambe le parti.
October 9, 2023
Difendiamo l’italiano dall’inglese. Una questione di identità.
 Il Giornale
Il Giornale
“Il dominio della lingua inglese può contribuire ad annullare la nostra identità” così ha scritto, a ben ragione, il direttore Vittorio Feltri nella sua stanza quotidiana sul Giornale.
“Può” avere ragione, tra virgolette, se gli Italiani intendono continuare ad avere una propria identità, se sanno il significato di questa parola e se vogliono conservare “l’eredità del nostro passato e della nostra storia”, come si legge nella proposta di legge citata in difesa della lingua italiana.
Chi scrive considera questa lingua, l’inglese, la sua “seconda lingua”, dopo quella materna. Non credo che l’inglese stia “assassinando” l’italiano. Se le cose stessero così, di cadaveri la lingua di Britannia ne avrebbe seminato molti lungo il suo cammino nel tempo e nello spazio.
Le cose stanno diversamente e spero di provarlo in maniera semplice e pratica, lontano da filosofismi o intellettualismi. La verità è che le lingue, tutte le lingue, e ovviamente le loro culture, nel mondo contemporaneo, con l’avvento della IT, Informazione Tecnologica, sono destinate ad avere identità diverse da quelle che le hanno caratterizzato per secoli.
Per alcuni studiosi questa è la quarta rivoluzione non ancora conclusa e completata: la “Infosfera”. Dopo Copernico, Darwin e Freud, questa in corso è destinata a mescolare tutto.
Se penso a come iniziai a studiare la lingua, quella che oggi è sotto processo per tentato “assassinio” soltanto una manciata di anni fa, mi vien da sorridere. Ne ho scritto in diverse occasioni. Quando ero ancora “in cattedra” a scuola, mi sono trovato spesso in conflitto con i docenti di lettere di tutti gli istituti superiori della Scuola italiana.
Ho dovuto litigare con i cari colleghi di latino e greco i quali hanno sempre avuto uno spazio egemone, decisivo e determinante nella formazione culturale degli studenti italiani.
Hanno sempre ritenuto che il latino non fosse una “lingua morta” e le poche ore che fino a pochi anni fa venivano assegnate allo studio delle lingue moderne, in particolare all’inglese, era tempo perso. Parlo di solo pochi decenni, non di secoli fa.
Non si sono mai resi conto che fuori dalle mura della scuola il mondo stava cambiando inesorabilmente. Radio, cinema, televisione, telefono, fino all’arrivo del Commodore 64, agli inizi degli anni ottanta, il primo pc alla portata di tutti, insieme alla diversa visione della cultura diventata improvvisamente un immenso “ipertesto” globale, avrebbe trasformato non solo la comunicazione linguistica, ma gli stessi contenuti culturali.
Adesso scoprono che ci sono troppi termini stranieri nella lingua italiana, troppi anglicismi, forestierismi, barbarismi, deviazioni linguistiche che danno vita a deviazioni mentali e culturali. Non si tratta di voler fare gli americani, ricordando una famosa canzone di Renato Carosone in auge negli anni cinquanta. In effetti il famoso musicista, con la famosa canzone “Tu vuò fà l’americano” anticipava la storia.
Non credete a chi dice, teme e scrive che l’italiano sta prendendo il posto del latino nello status di “lingua morta”. Il latino non è mai morto, nè tanto meno quel possente antico “mostro” del greco antico. Sia l’una che l’altra, sono lingue essenziali e decisive per lo studio delle lingue moderne e per la costruzione di una vera identità europea ed occidentale destinata a confrontarsi dall’interno della cultura greco-latina e mediterranea, non solo con quella anglo-americana, ma con altre ben diverse come la cultura araba e quella orientale.
Quello a cui dobbiamo state attenti quando si parla di anglicismi e di invasione linguistica, per quanto riguarda specialmente noi Italiani, è il travaso dell’inglese nell’italiano. La voglia di fare non solo gli americani, alla Carosone, ma di atteggiarsi ad essere “globish”, parola che sta per “global english”, atteggiarsi e credere di conoscere davvero l’inglese.
Questi anglicismi di cui si parla e si legge nel Parlamento e nel Paese Italia, sono pseudo anglicismi che nessun anglofono comprende davvero. Sono parole inglesi usate quasi sempre in senso diverso. “Ad usum delphini” è il caso di dire, anche se il “delfino” non è morto e non è fesso![image error]
October 8, 2023
L’indicibile: ciò che non si può dire, non si deve dire, non si sa dire.

Dal buio, dal silenzio e dal freddo del nord esce lo scrittore Jon Fosse. Le sue armi sono parole che cercano di narrare l’indicibile. Con una prosa scarna ed essenziale scava nella mente e nell’animo in cerca del senso dell’esistenza. E’ considerato l’erede di Ibsen e di Beckett.
L’indicibile è un concetto che si riferisce a qualcosa che non può essere espresso pienamente o adeguatamente con le parole. È ciò che va oltre i limiti del linguaggio e della comunicazione verbale. L’indicibile spesso si riferisce a esperienze, emozioni o concetti profondamente complessi, intensi o trascendentali che sfuggono alla descrizione verbale precisa.
Nel contesto di uno scrittore, l’indicibile rappresenta ciò che l’autore cerca di comunicare attraverso le sue parole, ma che non può essere completamente espresso o compreso appieno.
È il tentativo di catturare e trasmettere la complessità dell’esistenza umana, delle emozioni profonde, dei misteri della vita e dell’universo che vanno oltre la capacità del linguaggio di rappresentarli completamente.
L’autore utilizza le parole come strumenti per avvicinarsi a questi concetti inesprimibili, cercando di evocarli, suggerirli o farli intuire, anche se non possono essere compresi o spiegati in modo definitivo.
Nel caso dell’autore norvegese menzionato, la sua prosa scarna cerca il senso dell’esistenza e si avvicina a tematiche complesse e profonde. Essendo considerato “l’erede di Ibsen e Beckett”, potrebbe affrontare temi come l’alienazione, l’isolamento, l’assurdità della vita o la ricerca di significato in un mondo apparentemente privo di senso.
L’autore potrebbe utilizzare parole e immagini suggestive per evocare e avvicinarsi a queste tematiche, anche se potrebbero rimanere parzialmente incomprensibili o ineffabili.
L’indicibile rappresenta quindi un elemento di mistero, ambiguità e profondità nella scrittura dell’autore, invitando il lettore a riflettere e a confrontarsi con l’indefinibile e l’incomprensibile.
Nella scrittura, “l’indicibile” si riferisce a ciò che va oltre i limiti del linguaggio e della comunicazione verbale. È ciò che non può essere completamente espresso o compreso appieno con le parole.
L’indicibile riguarda esperienze, emozioni, concetti o realtà profonde, complesse o trascendentali che sfuggono alla descrizione verbale precisa.
Quando si parla dell’indicibile nella scrittura, si fa riferimento alla sfida che gli autori affrontano nel cercare di comunicare concetti o esperienze che sono al di là della portata delle parole.
Gli scrittori possono utilizzare vari strumenti letterari, come metafore, simboli, immagini suggestive o linguaggio evocativo, per avvicinarsi a questi concetti inesprimibili o per suggerirli al lettore.
Tuttavia, l’indicibile rimane, per definizione, qualcosa che non può essere pienamente catturato o spiegato in modo definitivo attraverso il linguaggio.
L’indicibile nella scrittura può includere temi come l’assurdità dell’esistenza, la trascendenza, l’incomprensibilità del mondo, le emozioni profonde, la natura ineffabile dell’amore o della spiritualità, o qualsiasi altra esperienza o idea che superi i confini del linguaggio.
L’obiettivo del cercare di esprimere l’indicibile è spesso quello di invitare il lettore a riflettere, a interrogarsi sulle questioni esistenziali e a confrontarsi con l’indefinibile e l’incomprensibile.
Ci sono molti autori che hanno cercato di esprimere l’indicibile attraverso la loro scrittura. Ecco alcuni esempi notevoli:
Franz Kafka: Kafka è noto per le sue opere che affrontano temi come l’alienazione, l’assurdità e l’incomprensibilità del mondo. Nei suoi romanzi e racconti, come “La metamorfosi” e “Il processo”, Kafka utilizza una prosa intricata e ambigua per rappresentare l’angoscia esistenziale e l’ineluttabilità dell’esistenza umana.
Samuel Beckett: Beckett è considerato uno degli scrittori più importanti del teatro dell’assurdo. Le sue opere, come “Aspettando Godot” e “Finale di partita”, esplorano l’assurdità della condizione umana e l’impossibilità di comunicare e dare un senso alla vita. La sua scrittura spesso sfida le convenzioni linguistiche e mette in evidenza l’inadeguatezza del linguaggio nel rappresentare appieno l’esperienza umana.
Virginia Woolf: Woolf è conosciuta per il suo stile modernista e la sua esplorazione della coscienza e dell’interiorità dei personaggi. Nei suoi romanzi, come “Mrs Dalloway” e “Al faro”, Woolf utilizza una narrazione fluttuante e sperimentale per cercare di catturare le complessità dell’esperienza umana, inclusi i pensieri, le emozioni e le percezioni che spesso sfuggono alle parole.
Jorge Luis Borges: Borges è un autore argentino noto per i suoi racconti brevi che mescolano realtà e finzione, mito e storia. Le sue opere, come “Ficciones” e “L’aleph”, esplorano l’infinità del tempo e dello spazio, sfidando le convenzioni narrative e cercando di rappresentare l’indicibile attraverso un labirinto di parole e concetti.
Per Henrik Ibsen l’indicibile è un tema importante. In “Spettri”, il suo grande dramma, il passato e i segreti che i personaggi cercano di nascondere, emergono e hanno un impatto devastante sulle loro vite. Ibsen esplora la colpa, la vergogna e la responsabilità morale attraverso l’indicibile, mettendo in luce le conseguenze che derivano dal tentativo di nascondere la verità.
Questi sono solo alcuni esempi di autori che hanno affrontato il concetto dell’indicibile nella loro scrittura. Ogni autore ha il proprio stile unico e le proprie sfumature nella ricerca di esprimere ciò che va oltre le parole. Leggete qui di seguito il tema dell’indicibile come è visto in psicologia e psicoterapia.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
L’Indicibile in psicologia e psicoterapiaLa caratteristica fondamentale del Numero Uno, è quella di non rinunciare mai, alla verità, di voler esprimere incessantemente quel flusso di percezioni profonde e sconcertanti che, in modo diretto e vorticoso, freneticamente ruotano dentro ognuno di noi.
Parliamo di indicibile come la massima espressioni di se. Per essere tale, l’ indicibile, ha rigorosamente la necessità di essere verbalizzato, avendo per sua natura una connotazione prevalentemente emotiva ed innanzitutto extra verbale. L’ indicibile è visibile sempre e decisamente nell’ extra verbale.
Tutti vorremmo conoscere le diverse percezioni altrui, i loro pareri e i giudizi sul nostro conto. La diffidenza verso gli altri, nasce dalla atavica paura verso il giudizio, verso il timore che esso possa essere devastante e difforme dalle nostre percezioni ed aspettative.
Quando affermiamo che certe persone sono vere ed autentiche ? Quando esse “parlano schiette, sono dirette, “ parlano in faccia”, affermano e dicono ciò che percepiscono e ciò che pensano, senza alcun filtro o sotterfugio o manipolazione, non inducono a incertezze o a confusioni e non utilizzano retoriche, non adoperano giri di parole, ma sono espressione di chiarezza, se pur alle volte inaccettabili.
Chi si pone nell’ ottica di voler esprimere l’ indicibile, ama la trasparenza, risulta franco, innovativo, propositivo, resiliente e rivoluzionario, reattivo, giusto, ma alle volte veemente, insostenibile, controcorrente, fuori dai valori comuni, ti punta e non perde di vista il tema, il filo e l’ occasione, non è ne rinviante, ne proscrastinante.
L’ indicibile è la casa, è casa nostra, pretende il diritto al libero pensiero, alla parola, alla risposta, alla domanda, alla coerenza, all’ incoerenza e all’ onestà di se. Nelle relazioni ci sono molte variabili e punti vi veduta differenti di ognuno che si intersecano, incomprensibili ad ogni interlocutore e chiaribili solo nell’ ottica dell’ espressione dell’ indicibile.
È molto difficile la comune comprensione, siamo tutti intricati e lontani, rappresentiamo la contraddizione l’ un dell’ altro, diveniamo irraggiungibili, strani e folli, è solo nell’ orientamento di svelare l’ indicibile, che ricreiamo quel ponte di ricongiunzione che potrebbe renderci più collegabili ed affini.
Quando parliamo di indicibile non ci riferiamo a qualcosa che non si può dire, ma al contrario, ci riferiamo al “non detto”, che è più importante ed imponente dell’ evidente. L’ indicibile invece si riferisce al timore di esprimere casa propria, il se autentico, perché appare inopportuno dire e non conforme alla situazione, perché la sua espressione risulterebbe imbarazzante e sconcertante.
L’ indicibile ha coraggio, non rinuncia al proprio tetto, a se, è teso nel combattere le vergogne e gli imbarazzi, le incomprensioni, i conflitti o a crearli li dove sembra tutto andar bene, chiama all’ appello; esso è diretto, non conosce il buono o il cattivo senso, perché persegue il senso, e non conosce la buona o la cattiva educazione, ma percepisce cosa è rispettoso; è ribelle al conformismo, è irriverente, indiscreto, teme, ma osa, non tiene conto dell’ opinione comune, o delle disapprovazioni, ma il suo verbo è, dire, ciò che gli altri direbbero, ma, inibiti, non osano.
L’ indicibile ha una struttura in cemento armato, è un travertino, un ponte in acciaio, ha una marcia in più, parte per primo e se rinunci ad esso ti fai massa, gregge, curva sud, ti globalizzi, ti emargini, diventi un pantano putrido, ti auto confini, ed escludi, accetti lo scontato, rinneghi la dignità del tuo nome, rimani assente, spettatore, rinunci all’ intelligenza differente, rinunci ai tuoi contribuiti, cadi nel mal pensare, diffidi, diventi un orso, un musone taciturno, inciampi nelle tane del pettegolezzo, triangoli. Chi rinuncia all’ indicibile, diventa cinico, sarcastico, tra il detto e il non detto, fa libera professione di aggressività passiva, amico del malumore e delle rimuginazioni, delle interpretazioni e delle perplessità, preda dei soliloqui, delle introversioni, della scontrosità e delle aversioni .
All’ indicibile si oppongono le apparenze del sottaciuto, le elaborazioni, gli espedienti, le scuse, gli escamotage, le menzogne, le retoriche, i giri di parole, tutti quegli atteggiamenti difensivi per non mettersi mai in discussione, come il negare l’ evidenza e il rinviare per non decidere mai.
L’ indicibile è il frutto di una introspezione agita, è la consapevolezza in persona che si fa azione, è il vetro trasparente e la liberazione di se dalle trappole. Esso è l’ evacuazione, la foce, lo sbattere in faccia la verità taciuta che se lungamente trattenuta diviene disagio, rammarico, teatralità protratta, malattia, psicosomatica, nevrosi, disgusto e dispiacere.
La narrazione dell’ indicibile, attraverso la consapevolezza di non voler rinunciare a se, conduce alla riattivazione del benessere, delle sinapsi e della salute, è il riscorrimento delle endorfine, è il respiro, la riscoperta delle anime affini. L’ espressione dell’ indicibile consta nello scovare dove sono le maschere e nel coraggio di toglierle.
La navigazione e la narrazione nel flusso dell’ indicibile, conduce all’ autenticità, al miglioramento o alla chiusura anticipata di certi rapporti, prima che diventino dei falsi consolidati, fino alla riscoperta di altri, speciali.
Ci sono persone che non si conoscono da sempre, se pur si frequentino da tanto, risultano essere tra di loro, estranee. Chi entra nel flusso dell’ indicibile, avverte sincronicità o fa selezione ed esclusione da subito.
Poche volte accade, che nel fracasso nella folla, si percepisce, la presenza di un sottile filo d’oro che collega ad un qualcuno di importante, che si osculta ma non si vede, un impercettibile filo di Arianna, li tiene legati da sempre, da sentir pronunciare piano e poi forte il proprio nome, da riconoscere quel qualcuno, che ricordi, ma mai conosciuto, molto vicino, e prima di quell’ istante, mai visto, intimo più della famiglia ma conosciuto li per li. Questo accade quando si è a casa e in sintonia con se stessi, senza carnevalate e nascondimenti, quando si è sereni, senza maschere, con la propria nudità, si incontrano le meraviglie.
Quanto di quel tempo viene adoperato stando in contatto in relazioni brillanti, ma allo stesso tempo vacue, fagocitanti, confusionarie, fatte tutte di un pezzo, rigide, apparentemente infrangibili e alla minima difficoltà, friabili ? L’ indicibile produce trasparenze e tra due trasparenze, la luce non farebbe fatica ad infrangere l’ incomprensione.
Chi lo decide quando dobbiamo esistere ? Lo decide la nostra anagrafica e il nostro nome, anche se già lo eravamo prima, dal concepimento. Solo quando ci chiamano, reagiamo all’ interno di in un sistema che ci stimola alla risposta, la chiamata del nome è la chiamata all’ appello, alla propria sede, il nome ci ricorda che siamo, nel nome chiamato, si materializza il se. Se non ci chiamano, impariamo a farlo da soli, proviamo quell’ emozione di chiamarci da soli, col proprio nome.
A Nessuno di noi è mai stato insegnato ad ascoltare se stesso, diversamente siamo stati educati ad ascoltare e rispettare gli altri. Ci hanno dato il nome, ci hanno chiamato, ma abbiamo imparato i nomi della storia, le date dei conflitti e degli eventi, ma mai ci hanno indicato di rispettare e ricercare il nome proprio e ad ascoltarlo. Abbiamo spesso sentito chiedere, ascoltami, mai ascoltati, siamo stati educati a rimanere sordi a noi stessi, a finta di nulla, ad ascoltare solo i “rumori” delle voci stridule altrui.
La nostra voce urla dal nostro primo vagito e nasce come l’ altra voce, ogni volta che nasce una nuova voce, nasce la rivoluzione, il contraddittorio, ma parallelamente nasce la volontà e la tentazione di volerla mettere gia a tacere per la sua diversità, per il suo indicibile, per i suoi “capricci”. Ognuno esiste, se riesce a darsi voce, chiamandosi all’ appello.
giorgio burdi
____________
L’indicibile è per coloro che non temono il giudizio, che, sicuri del loro sentire, percorrono la via della sincerità, della realtà, della libertà di essere e di esprimersi. Non tutti sono ingrado di accettare tale schiettezza sbattuta in faccia, a molti non piace la verità, preferiscono la finzione, il buon viso a cattivo gioco. La verità è per pochi. Ma di quale verità parliamo infondo? Non estite un’unica verità, ognuno è condizionato dalle sue esperienze, dalle sue emozioni, la verità è spesso distorta da quello che noi crediamo di vedere o sentire. L’indicibile va oltre la verità, è l’essere autentico, nudo e crudo, senza paura e senza vergogna, perché non ci si deve vergognare di essere se stessi, anzi, bisogna coltivare l’indicibile, bisogna portarlo fuori, esorcizzarlo, renderlo familiare, amico, compagno. Ma ormai credo che bisogna essere se stessi e non pensare di poter piacere a tutti o di trovare un legame con tutti. Ci sono persone che non ti apprezzeranno ma probabilmente sarà anche meglio così. Mostrando l’indicibile sarai apprezzato da chi è come te o da coloro che nel tuo indicibile vedono qualcosa di unico e meraviglioso.
rossella ramundo orlandoSTUDIO BURDI [image error]
October 6, 2023
Le “pratiche inevase” di Primo Levi

La poesia “Le pratiche inevase” di Primo Levi è uno struggente canto di pentimento e rimorso. Arrivati ad una certa età, leggendo questa poesia è possibile ritrovarsi. Mi sono domandato come ha fatto l’autore a scrivere cose di sé che poi sono anche le mie, di tanti, se non di tutti. “Pratiche inevase”, appunto. Solo alla fine del “giorno” ti accorgi di non averle portato a termine. Lecito chiederselo quando ti accorgi che il “giorno” sta per finire.
La giornata terrena, intendo. Il poeta si rivolge a un interlocutore indefinito, che potrebbe essere Dio, la vita, o semplicemente la coscienza stessa. Si scusa per non aver compiuto le sue responsabilità, per aver trascurato gli altri e per aver lasciato irrisolti i suoi progetti.
Il tono della poesia è dimesso e autocritico. Il poeta si rende conto di aver fallito, e si rammarica di non aver potuto fare di più. Si giustifica con l’ignavia e con le difficoltà obiettive, ma sa che queste sono solo scuse. La poesia è costellata di immagini di cose non fatte, di promesse non mantenute, di desideri non realizzati.
Il poeta immagina un libro meraviglioso, che avrebbe potuto cambiare il mondo, ma che è rimasto solo un’idea in un cassetto. Una poesia ricca di significato e di suggestione. Un ritratto commovente dell’uomo, con i suoi limiti e le sue contraddizioni. Anche un invito a riflettere sul valore del tempo e sulla necessità di vivere pienamente la propria vita.
Il tema del pentimento è centrale nella poesia. Il poeta si pente di non aver compiuto le sue responsabilità, di aver trascurato gli altri e di aver lasciato incompiuti i suoi progetti. Questo pentimento è accompagnato da un senso di colpa e di frustrazione. Il tempo è un altro spunto importante nella poesia. Il poeta si rende conto che è prezioso e che non va sprecato. Si rammarica di non aver potuto fare di più con il tempo che gli è stato concesso.
La poesia è anche un invito a riflettere sul valore della vita. Il poeta capisce di aver vissuto in modo superficiale, trascurando le cose importanti. Si propone di cambiare, di vivere la sua vita in modo più pieno e consapevole. Una poesia che ci tocca nel profondo, un invito a riflettere sulla vita, sui nostri limiti e sulle nostre possibilità, a vivere la vita pienamente, senza sprecare il tempo che ci è stato concesso.
Signore, a fare data dal mese prossimo
voglia accettare le mie dimissioni.
E provvedere, se crede, a sostituirmi.
Lascio molto lavoro non compiuto,
Sia per ignavia, sia per difficoltà obiettive.
Dovevo dire qualcosa a qualcuno,
ma non so più che cosa e a chi: l’ho scordato.
Dovevo anche dare qualcosa,
una parola saggia, un dono, un bacio;
ho rimandato da un giorno all’altro. Mi scusi,
Provvederò nel poco tempo che resta.
Ho trascurato, temo, clienti di riguardo.
Dovevo visitare città lontane, isole, terre deserte;
le dovrà depennare dal programma
o affidarle alle cure del successore.
Dovevo piantare alberi e non l’ho fatto;
costruirmi una casa, forse non bella, ma conforme a un disegno.
Principalmente, avevo in animo un libro meraviglioso, caro signore,
che avrebbe rivelato molti segreti, alleviato dolori e paure,
Sciolto dubbi, donato a molta gente
Il beneficio del pianto e del riso.
Ne troverà traccia nel mio cassetto,
in fondo, tra le pratiche inevase;
Non ho avuto tempo per svolgerla.
È peccato, sarebbe stata un’opera fondamentale.
Primo Levi è stato un chimico, scrittore e testimone della Shoah italiano. È nato a Torino il 31 luglio 1919 e morto a Torino il 11 aprile 1987. Autore di numerose opere, tra cui il suo libro più famoso, “Se questo è un uomo”, che racconta la sua esperienza nei campi di concentramento nazisti. Ha scritto anche altri romanzi, saggi e poesie, incentrati sulla Shoah e sulla condizione umana.
Levi ha vissuto in un periodo storico molto complesso e drammatico, che ha segnato profondamente la sua vita e la sua opera. È nato nel 1919, durante il periodo fascista, e ha vissuto la Seconda guerra mondiale, che ha portato alla Shoah. È stato deportato ad Auschwitz nel 1944, dove ha vissuto per un anno e mezzo.
Dopo la guerra è tornato a Torino, dove ha vissuto e lavorato fino alla sua morte. Levi è stato un testimone della Shoah e ha dedicato la sua vita a raccontare la sua esperienza e a combattere contro ogni forma di discriminazione e di violenza. La sua opera è un contributo fondamentale alla comprensione di uno dei periodi più bui della storia dell’umanità.[image error]
October 5, 2023
La riflessione che coglie l’attimo …
Questa fotografia l’ho fatta stamani poco dopo le sette nei pressi del porto di Maiori. Il sole era appena spuntato da dietro il monte de…
October 4, 2023
“Sic Vita” …

Un piacere leggere i “Detti” di Confucio scritti nel VI secolo a. C. Fantastici i suoi silenzi che si manifestavano soprattutto quando i suoi interlocutori volevano convincerlo a discutere del problema della vita dopo la morte. Un giorno, il suo discepolo Zilu gli chiese di parlare della morte. Il Maestro gli disse: “Non conosci la vita, come potresti conoscere la morte?”.
Henry King era figlio di un vescovo anglicano londinese, nacque 1562 e entrò nella carriera ecclesiastica. Fu amico di John Donne, il più grande poeta metafisico inglese. Pubblicò nel 1657 una raccolta di poesie tra le quali quella che propongo qui in una traduzione libera. Una poesia davvero “nuda”, sulla vita, nella sua essenzialità. Una risposta a Confucio.
Sic Vita
Like to the falling of a star,
Or as the flights of eagles are,
Or like the fresh spring’s gaudy hue,
Or silver drops of morning dew,
Or like a wind that chafes the flood,
Or bubbles which on water stood:
Even such is man, whose borrowed light
Is straight called in, and paid to night.
The wind blows out, the bubble dies;
The spring entombed in autumn lies;
The dew dries up, the star is shot;
The flight is past, and man forgot.
— — — — -
Sic Vita
Come la caduta di una stella,
O come il volo delle aquile,
O come il vivace colore della primavera,
O come le gocce d’argento della rugiada mattutina,
O come un vento che agita l’acqua,
O come le bolle che si formano sulla superficie dell’acqua:
Così è l’uomo, la cui luce prestata
Viene subito richiamata e restituita alla notte.
Il vento soffia e la bolla muore;
La primavera è sepolta nell’autunno;
La rugiada si secca, la stella è spenta;
Il volo è finito e l’uomo è dimenticato.
“Così è la vita”. La poesia è una riflessione sulla fugacità della vita umana, che viene paragonata a fenomeni naturali come la caduta di una stella, il volo di un’aquila, il colore della primavera, la rugiada mattutina, il vento e le bolle d’acqua. Il poeta sottolinea che la vita umana è breve e fragile, e che alla fine tutto ciò che resta di noi è il ricordo.
Ma cos’è il ricordo? Il ricordo è una rappresentazione mentale di un evento o di un’esperienza passata. È un processo complesso che coinvolge diversi meccanismi cerebrali, tra cui la percezione, la memoria a breve termine, la memoria a lungo termine e la rievocazione.
I ricordi possono essere di natura sensoriale, emotiva o cognitiva. I ricordi sensoriali sono quelli che riguardano i sensi, come le immagini, i suoni, gli odori, i sapori e le sensazioni tattili.
I ricordi emotivi sono quelli che riguardano le emozioni provate in un determinato momento. I ricordi cognitivi sono quelli che riguardano i pensieri e le idee che si sono avute in un determinato momento.
I ricordi possono essere soggettivi e possono essere influenzati da fattori personali, come le esperienze, le convinzioni e le emozioni. I ricordi possono anche essere distorti o alterati nel tempo. Il ricordo è importante per diversi motivi.
Innanzitutto, ci permette di imparare dal passato e di evitare di commettere gli stessi errori. In secondo luogo, ci permette di costruire la nostra identità e di capire chi siamo. In terzo luogo, ci permette di condividere le nostre esperienze con gli altri e di creare legami sociali.
Il ricordo è un processo fragile e può essere influenzato da diversi fattori, come l’età, le lesioni cerebrali e le malattie neurodegenerative. Tuttavia, ci sono anche diversi modi per migliorare la memoria, come l’esercizio fisico, un’alimentazione sana e l’apprendimento di nuove cose.
Il ricordo è tutto ciò che resta di noi quando moriamo. È la nostra storia, le nostre esperienze, le nostre emozioni. È ciò che ci rende unici e ci collega agli altri.
E’ anche un ponte tra il passato e il presente. Ci permette di ricordare ciò che è stato e di usarlo per costruire il futuro. Lo costruisce il futuro in diversi modi. Innanzitutto, ci permette di imparare dal passato e di evitare di commettere gli stessi errori.
Ad esempio, se ricordiamo le atrocità della seconda guerra mondiale, possiamo essere più propensi a lavorare per la pace nel mondo. Anche se poi le guerre continuano e in Ucraina fanno una guerra infinita …
In secondo luogo, il ricordo ci aiuta a costruire la nostra identità e a capire chi siamo. I ricordi ci raccontano la nostra storia e ci aiutano a definire il nostro posto nel mondo. Anche se poi non sappiamo mai dove stiamo bene …
In terzo luogo, il ricordo ci permette di condividere le nostre esperienze con gli altri e di creare legami sociali. Quando condividiamo i nostri ricordi, ci connettiamo con gli altri a un livello profondo. Anche se poi in questa profondità anneghiamo nella liquidità sociale …
Ecco alcuni esempi concreti di come il ricordo costruisce il futuro:
La memoria storica ci aiuta a costruire società più giuste e inclusive. Quando ricordiamo le ingiustizie del passato, possiamo essere più propensi a lottare per la giustizia nel presente.
Ad esempio, la memoria dell’apartheid in Sudafrica ha contribuito alla lotta per la democrazia e l’uguaglianza nel paese. Ma poi il razzismo nero si sostituisce a quello bianco …
La memoria culturale ci aiuta a preservare la nostra identità e a tramandare le nostre tradizioni. Quando ricordiamo la nostra storia e la nostra cultura, possiamo costruire un futuro più ricco e diversificato.
Ad esempio, la memoria della cultura indigena in America Latina ha contribuito a preservare le tradizioni e le lingue di questi popoli costruendo muri o sterminandoli … La memoria personale ci aiuta a crescere e a maturare.
Quando riflettiamo sui nostri ricordi, possiamo imparare da noi stessi e migliorare come persone. Ad esempio, la memoria di un errore commesso in passato può aiutarci a essere più prudenti in futuro. Anche poi siamo pronti a riconoscere solo gli errori degli altri …
In conclusione, il ricordo è un elemento fondamentale della nostra umanità. È ciò che ci rende unici e ci collega agli altri. Ricordando il passato, possiamo costruire un futuro migliore per tutti, anche se qualcuno ha scritto che i ricordi si interpretano come i sogni …
Forse, come disse Pedro Calderòn de la Barca: “Cos’è la vita? Delirio. Cos’è la vita? Illusione, appena chimera ed ombra, e il massimo bene è un nulla, ché tutta la vita è sogno, e i sogni, sogni sono.”
Shakespeare non fu da meno. Disse che siamo fatti della stessa sostanza dei sogni … “Sic Vita” …[image error]
MEDIUM
- Antonio Gallo's profile
- 52 followers




