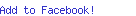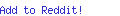Giovanni De Matteo's Blog: Holonomikon, page 26
December 31, 2017
La Lista del 2017
L’invito di Quaderni d’Altri Tempi a partecipare con alcune segnalazioni alla lista degli imperdibili dell’anno che si conclude oggi mi offre il pretesto per condividere con voi una lista più ampia, che abbraccia tutto quello che ho visto e ho letto nel 2017 (sarei stato bravo a leggere tutto, ma ammetto che in alcuni casi si tratta di titoli che avrei voluto/dovuto leggere, ma ancora non sono riuscito a farlo… ma c’è tempo per rimediare!) e che porto con me nell’anno nuovo.
Se volete, nei commenti aggiungete pure le vostre segnalazioni: titolo, autore ed editore, con l’unico vincolo che si tratti di cose uscite nel corso dell’anno solare (prime edizioni o ristampe dopo una lunga assenza). A differenza di Quaderni, separerò le mie segnalazioni per canale. Quindi eccovi i miei consigli, in ordine sparso e del tutto casuale:
Letture
Eymerich risorge, Valerio Evangelisti (Mondandori)
Nottuario, Thomas Ligotti (Il Saggiatore) [ne abbiamo parlato approfonditamente, qui e su Quaderni ]
Le venti giornate di Torino, Giorgio De Maria (Frassinelli) [anche questo recensito]
Autonomous, Annalee Newitz (Fanucci)
La ferrovia sotterranea, Colson Whitehead (Sur)
Ucronia, Elena Di Fazio (Delos Books)
Carnivori, Franci Conforti (Kipple Officina Libraria)
Elysium, Jennifer Marie Brissett (Zona 42)
Laguna, Nnedi Okorafor (Zona 42)
New York 2140, Kim Stanley Robinson (Fanucci) [per ora solo brevemente qui]
Il problema dei tre corpi, Cixin Liu (Mondadori)
Inverso, William Gibson (Mondadori)
Einstein perduto / Nova, Samuel R. Delany (Mondadori)
Domani il mondo cambierà, Michael Swanwick (Mondadori)
Sirene, Laura Pugno (Feltrinelli)
Atlantide e i mondi perduti, Clark Ashton Smith (Mondadori)
Lacerazioni, Anne-Sylvie Salzman (Hypnos)
Entanglement, Vandana Singh (Future Fiction) [per ora solo brevemente qui]
Jerusalem, Alan Moore (Rizzoli)
Il racconto dell’ancella, Margaret Atwood (Ponte alle Grazie)
L’invenzione di Morel, Adolfo Bioy Casares (Sur)
Universi paralleli, Roberto Paura (Cento Autori)
Black Monday di Jonathan Hickman e Tomm Coker (Mondadori) [brevemente qui]
Arcangelo di William Gibson (Magic Press) [brevemente qui]
Nameless di Grant Morrison (Saldapress)
Mio padre la rivoluzione, Davide Orecchio (Minimum Fax)
Schiavi dell’Inferno, Clive Barker (Independent Legions Publishing)
Serie
Taboo, di Tom Hardy, Edward “Chips” Hardy, Steven Knight (Scott Free Productions, Hardy Son & Baker
Legion, di Noah Hawley (Marvel Television, FX Productions, 26 Keys Productions)
Fargo, di Noah Hawley (FX Productions, The Littlefield Company, MGM Television)
Mindhunter, di Joe Penhall (Denver and Delilah, Jen X Productions, Panic Pictures / No. 13)
Twin Peaks – La serie evento, di Mark Frost e David Lynch (Rancho Rosa Partnership Production, Lynch/Frost Productions)
Gomorra, di Giovanni Bianconi, Stefano Bises, Leonardo Fasoli, Ludovica Rampoldi, Roberto Saviano (Sky, Cattleya, Fandango, LA7, Beta Film)
Quarry, di Graham Gordy e Michael D. Fuller (HBO Entertainment, Anonymous Content, Night Sky Productions, One Olive)
The Young Pope, di Paolo Sorrentino (Wildside, Haut et Court TV, Mediapro)
Babylon Berlin, di Henk Handloegten, Tom Tykwer, Achim von Borries (X-Filme Creative Pool, Beta Film, Sky Deutschland, Degeto Film)
Cinema
Arrival, regia di Denis Villeneuve, sceneggiatura di Eric Heisserer da un racconto di Ted Chiang (produzione Lava Bear Films, 21 Laps Entertainment, FilmNation Entertainment)
The War – Il pianeta delle scimmie, regia di Matt Reeves, sceneggiatura di Mark Bomback e Matt Reeves (produzione Chernin Entertainment)
Dunkirk, regia e sceneggiatura di Cristopher Nolan (produzione Syncopy Inc., RatPac-Dune Entertainment, Warner Bros. Pictures)
Blade Runner 2049, regia di Denis Villeneuve, sceneggiatura di Hampton Fancher, Michael Green e Ridley Scott [non accreditato] (produzione Alcon Entertainment, Thunderbird Entertainment, Scott Free Productions) [ne abbiamo parlato diffusamente su Fantascienza.com , su Delos e qui, ma una delle cose migliori che ho letto sul film è apparsa ieri a firma di Luca Giudici]
Avvertenza. Questa lista è inevitabilmente parziale e viziata dalla mia prospettiva distorta: sicuramente ci sono numerosi altri titoli meritevoli di segnalazione che non vengono qui menzionati, perché passati sotto il mio radar oppure semplicemente perché le mie idiosincrasie non mi permettono di pronunciarmi prima di un’occhiata più approfondita. Ma per fortuna abbiamo tutto il futuro per rimediare. Intanto portiamoci questo nel 2018 e cercheremo di recuperare il resto.
Archiviato in:ROSTA Tagged: Alan Moore, Annalee Newitz, Archangel, Arrival, Autonomous, Babylon Berlin, Blade Runner 2049, Christopher Nolan, cinema, Colson Whitehead, David Lynch, Denis Villeneuve, Dunkirk, Elysium, Entanglement, Eymerich, Fargo, fumetti, Giorgio De Maria, Gomorra, Grant Morrison, Il Pianeta delle Scimmie, Jennifer Marie Brissett, Jerusalem, Kim Stanley Robinson, La ferrovia sotterranea, Laura Pugno, Le venti giornate di Torino, lista, Liu Cixin, Margaret Atwood,





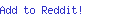

December 16, 2017
La lezione delle tenebre: Ligotti recensito
Dopo anni di semi-clandestinità, Thomas Ligotti ha finalmente guadagnato l’attenzione che gli editori italiani non sembravano disposti a riconoscergli. Scrittore di racconti, nell’arco della sua carriera Ligotti ha saputo esplorare gli abissi oscuri dell’animo umano e gli angoli in penombra del nostro mondo, senza mai discostarsi dalla vocazione per la narrativa breve. La sua produzione annovera centocinquanta racconti, che spaziano dal quadretto d’ambiente (il sogno, i cambiamenti e la condizione umana sono tra i suoi soggetti preferiti, spesso allegoricamente rappresentati nell’atmosfera sospesa e nella malinconia nebbiosa dei panorami autunnali o dell’imbrunire) alle soglie del romanzo breve (My Work Is Not Yet Done, che presta il nome all’omonima raccolta di storie di “corporate horror”, 2002), passando per le riflessioni letterarie di veri e propri saggi sulla scrittura di genere.
In seguito alla pubblicazione de I canti di un sognatore morto (Songs of a Dead Dreamer, 1985) nel 2007 a opera della Perseo Libri, per anni Ligotti è sembrato nuovamente uscire dai radar dell’editoria italiana. Poi nel 2014 il successo mondiale di True Detective ha acceso nuovamente i riflettori sulla sua opera. Insieme a marcati risvolti weird la serie-culto di HBO creata da Nic Pizzolatto presenta anche inconfondibili richiami alla filosofia nichilista e al pessimismo cosmico del Nostro. Così, mentre in America Penguin Classics ne decretava il definitivo sdoganamento critico con una prestigiosa edizione in volume unico delle sue prime due antologie (Songs of a Dead Dreamer and Grimscribe, 2015), in Italia alla sua produzione veniva data ampia visibilità prima da Elara Libri, che raccogliendo il testimone della Perseo dava alle stampe anche Lo scriba macabro (Grimscribe: His Lives and Works, 1991); e poi da Il Saggiatore, con l’antologia Teatro Grottesco (originariamente apparsa in inglese nel 2006) e successivamente con il famoso saggio La cospirazione contro la razza umana (The Conspiracy against the Human Race, 2010).
Nottuario prosegue quest’opera di diffusione. Pubblicata nel 1994 (Noctuary il titolo originale), è la terza raccolta e rappresenta in una certa misura un anello di raccordo tra le prime storie e quelle più recenti, denotate da una prosa sempre precisa e forbita, ma più fluida e cristallina nonostante la ricchezza di dettagli e sfumature che da sempre è il marchio di fabbrica dell’autore di Detroit.
Un orrore sempre più profondo
Sia chiaro: questi racconti macabri e grotteschi, che spesso si addentrano nelle spire della follia ben oltre i confini dell’incubo, pongono delle autentiche sfide ai lettori. Vivono di vita propria, animati da una coscienza malevola decisa a non lasciarsi domare, proprio come le ombre che si muovono al crepuscolo e scivolano intorno ai personaggi, avvolgendoli pagina dopo pagina. E pagina dopo pagina s’incollano addosso al lettore, aderiscono alla sua mente, giocano con la sua memoria in una proliferazione di echi che si propagano da un racconto all’altro.
Con le ombre e i rimandi, si moltiplicano anche gli interrogativi: ogni racconto è un rompicapo, un enigma che innesca domande che richiamano altre domande, in una cascata di dubbi senza fine che non risparmia niente: la vera natura del mondo che ci ospita, il senso delle strutture sociali, il ruolo dell’umanità in tutto questo.
[Continua a leggere su Quaderni d’Altri Tempi .]
Archiviato in:Imaginarium Tagged: corporate horror, Franz Kafka, I canti di un sognatore morto, La cospirazione contro la razza umana, Lo scriba macabro, My Work Is Not Yet Done, Nic Pizzolatto, Nottuario, Teatro Grottesco, Thomas Ligotti, True Detective, weird






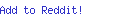

December 8, 2017
Autunnale
E sogniamo sempre il giorno in cui la frenesia dell’estate morirà una volta per tutte, quando ognuno come una foglia arricciata cascherà sul suolo che si raffredda di una terra senza sole, e quando persino i colori dell’autunno si saranno spenti per l’ultima volta, dissolvendosi nella purezza desolata di un eterno inverno.
Tratto da Autunnale, in Nottuario di Thomas Ligotti
(Il Saggiatore, 2017 – traduzione di Luca Fusari, pagg. 209)
Archiviato in:Criptogrammi Tagged: Autumnal, Nottuario, Thomas Ligotti, weird






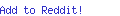

November 29, 2017
A proposito delle venti giornate di Torino
Un’ondata di psicosi collettiva aveva scaraventato Torino nel caos per venti giorni e venti notti, nel cuore di un’estate caldissima. Dieci anni dopo, l’anonimo narratore s’intestardisce a ricostruire gli eventi di quelle folli venti giornate, ma la sua si palesa fin da subito per la sfida impari che è: la reticenza dei suoi concittadini nel rievocare l’accaduto si salda con un clima di paranoia di cui finisce presto per essere vittima egli stesso, mentre sullo sfondo si vanno addensando le nuvole e le ombre di una cospirazione sopravvissuta al tempo, che forse si accinge a colpire di nuovo. Al protagonista non resterà che affidarsi ai suoi ricordi e all’aiuto insperato di un altro testimone, come lui ossessionato dalla reale natura dei fenomeni che ora sembra che tutti pretendano di aver rimosso.
Gli insonni, l’aria irrespirabile, le morti violente rimaste inspiegate, le apparizioni sovrannaturali, le statue che prendevano vita seminando il terrore in città riemergono così dal passato in un turbine di angosce e inquietudini catalizzate, oggi come allora, dal ruolo di quella misteriosa istituzione che solo a nominarla ispira un brivido alla gente di Torino: la Biblioteca.
Si fa presto a perdere il conto dei paragoni illustri scomodati per accompagnare l’encomiabile operazione di riscoperta condotta da Frassinelli: Le venti giornate di Torino, pubblicato nel 1977 dalle edizioni Il Formichiere, passò pressoché inosservato all’uscita, finì fuori circolazione e, malgrado la venerazione di alcuni fortunati lettori che ne fecero un oggetto di culto, fu presto dimenticato, condividendo questo oblio immeritato con il suo autore.
Giorgio De Maria, nato a Torino nel 1924, critico teatrale, pianista (membro del gruppo musicale di avanguardia dei Cantacronache), commediografo (sua la commedia in tre atti Apocalisse su misura, per il Teatro Stabile di Torino), sceneggiatore per la televisione, traduttore e insegnante di lettere, tra le altre cose, nonché autore di altri tre romanzi prima de Le venti giornate di Torino, dopo l’indifferenza riservata a questo libro avrebbe smesso di scrivere, non producendo più nulla fino alla sua morte, avvenuta nel 2009. Il suo nome è tornato inaspettatamente alla ribalta quest’anno, quando la Norton ha annunciato a sorpresa l’edizione in lingua inglese di questo libro che in effetti è un oggetto misterioso, capitato per caso all’attenzione del giornalista australiano Ramon Glazov, rimastone affascinato al punto da spendersi in prima persona per il suo recupero. E nella sua traduzione Norton lo ha proposto in America, facendo di De Maria il secondo autore italiano del suo catalogo dopo Primo Levi.
[Continua a leggere su Quaderni d’Altri Tempi .]
Archiviato in:Imaginarium Tagged: Anni di Piombo, Franz Kafka, Fritz Leiber, Giorgio De Maria, Le venti giornate di Torino, Primo Levi, weird






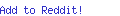

November 25, 2017
Rivelazioni di un essere unico
Suo padre sapeva che nel mondo c’erano posti ai quali il figlio doveva rispondere, anche da bambino, e che lo avrebbero portato a subire una seconda nascita sotto il segno dello Tsalal. Il reverendo Maness sapeva che il borgo di Moxton era uno di quei posti: avanguardie nelle desolate terre di confine del reale. Diceva di avere portato suo figlio in questo borgo perché il bambino imparasse a resistere alla presenza che percepiva qui e in altre parti del mondo. Diceva di avere portato suo figlio nel posto giusto, ma in realtà lo aveva portato in un posto che era completamente sbagliato per l’essere che era. E diceva che suo figlio si sarebbe sempre riempito la testa con le parole di quel libro. Ma queste parole erano facilmente silenziate e usurpate da quelle altre parole in quegli altri libri. Suo padre sembrava indurlo a leggere proprio i libri che non avrebbe dovuto leggere. Presto questi libri stimolarono in Andrew Maness il senso di quella presenza che si poteva manifestare in un posto come il borgo di Moxton. E c’erano altri posti dove sentiva quella stessa presenza. Grazie a intuizioni che con l’età si fecero sempre più chiare, Andrew Maness trovava questi posti, a volte per caso e a volte intenzionalmente.
Magari si imbatteva in una casa abbandonata, sfondata e deforme in un paesaggio isolato: uno scheletro nudo in un cimitero. Ma in questa struttura fatiscente vedeva un sacrario, un tempio eretto lungo la strada in onore della presenza alla quale ambiva unirsi, nonché un ingresso al mondo buio nel quale essa dimorava. Nulla può esprimere le sensazioni, le infinite gradazioni di emozione di quando si avvicinava a un edificio decomposto come quello, il cui profilo sghembo e frastagliato alludeva a un altro ordine di esistenza, all’ordine più alto dell’esistenza, come se i posti simili a questa casa non fossero che ombre tentennanti gettate sulla terra da un lontano e invisibile regno di entità. Là sperimentava il tocco di qualcosa di esterno a lui, qualcosa la cui volontà era confusa con la sua, come in un sogno dove ci sentiamo padroni di un fantastico potere di stabilire quali eventi si manifesteranno e tuttavia ci sentiamo anche incapaci di controllare quel potere, che, attraverso di noi, potrebbe produrre il caos dell’incubo. Questa commistione di padronanza e impotenza era l’ebbrezza oscura che lo sopraffaceva e gli sussurrava il suo scopo nella vita: azionare la grande ruota che gira nel buio, e spezzarcisi.
Tuttavia Andrew Maness sapeva da sempre che la sua ambizione era l’eco di quella concepita tanti anni prima da suo padre e da quegli altri, e che la caccia a questa ambizione era stata coronata con la sua nascita.
Tratto da Lo Tsalal, in Nottuario di Thomas Ligotti
(Il Saggiatore, 2017 – traduzione di Luca Fusari, pagg. 118-119)
Archiviato in:Criptogrammi Tagged: Nottuario, Thomas Ligotti, Tsalal, weird






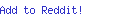

November 12, 2017
Blade Runner 2049: gli androidi sognano ancora pecore elettriche?
Sono trascorsi trentacinque anni dal capolavoro di Ridley Scott che ridefinì la nostra percezione del futuro. Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve non aspira a tanto, ma moltiplica le prospettive di un mondo che ci eravamo illusi di conoscere fin troppo bene.
[image error]Hollywood non ama particolarmente le sfide aperte, preferisce andare sul sicuro. Riportare al cinema un titolo che alla sua uscita lasciò i produttori in cattive acque, per quanto poi col tempo abbia finito per attestarsi come caposaldo imprescindibile, non era di certo quella che può definirsi una scommessa facile. Per questo nel 2011 in molti, tra semplici appassionati e addetti ai lavori, avevamo accolto con un certo scetticismo la notizia che i diritti di Blade Runner erano stati rilevati per una somma imprecisata dalla Alcon Entertainment, in circolazione da una quindicina d’anni e, se si eccettua Insomnia (remake di un film norvegese affidato a un promettente regista anglo-americano, che sarebbe diventato il banco di prova per saggiare le future ambizioni di Christopher Nolan), mai coinvolta fino ad allora in produzioni degne di nota.
D’altronde era risaputo come Ridley Scott avesse sempre tenuto la porta aperta per un eventuale seguito, ma i suoi piani più o meno vaghi si erano andati a scontrare ogni volta contro difficoltà produttive, sovrapposizioni d’impegni e, last but not least, inestricabili nodi legali sui diritti, come nel caso dell’annunciata webseries prequel Purefold, sviluppata con il fratello Tony Scott e poi congelata a tempo indeterminato. È innegabile che la prospettiva di un possibile ritorno all’universo narrativo di Blade Runner abbia sempre solleticato anche la fantasia degli appassionati oltre a quella del suo creatore, ma in pochi sarebbero stati disposti a scommettere qualcosa sui piani di rilancio della Alcon. E invece in questi anni la casa di produzione di Broderick Johnson e Andrew A. Kosove non solo è riuscita ad assemblare una squadra produttiva di prim’ordine, coinvolgendo Columbia Pictures, Thunderbird Films e Scott Free Productions, per raccogliere il budget più alto della sua storia (ben 150 milioni di dollari, che secondo alcune fonti potrebbero invece essere stati addirittura 185), ma con la benedizione di Ridley Scott ha saputo anche assicurarsi il talento di uno dei più apprezzati cineasti in circolazione, il canadese Denis Villeneuve, reduce dal successo di Arrival (2016) e autore di piccoli grandi capolavori come La donna che canta (2010), Prisoners (2013), Enemy (2013) e Sicario (2015).
Con lui la Alcon ha ingaggiato professionisti di prim’ordine, il cui apporto sarebbe stato non meno importante o decisivo nella riuscita dell’operazione. A cominciare dallo sceneggiatore Michael Green (arruolato nel 2013, quando aveva all’attivo solo il copione di Green Lantern, nel frattempo ha visto realizzarsi altre due sceneggiature di un certo prestigio, per l’acclamato ritorno di Wolverine in Logan e per il nuovo adattamento di Assassinio sull’Orient Express firmato da Kenneth Branagh, senza dimenticare il suo ruolo di produttore e showrunner di American Gods, tratto dal romanzo di Neil Gaiman), che è andato ad affiancare Hampton Fancher, l’uomo che per primo colse le potenzialità cinematografiche di un romanzo di fantascienza intitolato Do Androids Dream of Electric Sheep?; per proseguire con Joe Walker (Blackhat, Arrival) al montaggio e Dennis Gassner (recentemente al servizio del nuovo corso di 007) alla scenografia; e per finire con la fotografia di Roger Deakins, plurinominato all’Oscar e punto di riferimento per i fratelli Coen, che è qui già alla terza collaborazione con Villeneuve dopo Prisoners e Sicario. Dell’esito artistico dei relativi contributi abbiamo già parlato diffusamente nella recensione apparsa su queste stesse pagine, quindi non ci dilungheremo oltre.
Il lettore che ha avuto pazienza di arrivare fin qui ci perdonerà di esserci dilungati sui retroscena, ma per un’operazione come questa le vicissitudini produttive non rappresentano un semplice corollario da ridimensionare al rango di curiosità, come d’altro canto insegnano anche le traversie in cui incorse la realizzazione di Blade Runner (si veda a questo proposito l’ottimo libro di Paul M. Sammon Blade Runner. Storia di un mito, purtroppo non più in catalogo, ma sarebbe ora che qualche editore si decidesse a riproporlo ai lettori italiani). Il processo di costruzione di Blade Runner 2049, come dimostra la sua trama stratificata, ricca di rimandi al capolavoro di Ridley Scott, rispecchia la necessità di fare i conti con un rompicapo matematico: riprodurre quel mix di stupore e malinconia, di meraviglia e inquietudine, di speranza e dannazione, di riscatto e castigo, che ha reso Blade Runner un’opera unica nel panorama cinematografico mondiale. Il risultato finale omaggia nella misura giusta il precursore e allo stesso tempo dischiude allo sguardo dello spettatore e dell’appassionato nuovi orizzonti, il tutto con uno sforzo immaginifico che riesce a reinventare l’estetica di Blade Runner tenendosi paradossalmente fedele all’originale.
2019-2049: le cicatrici del futuro
Trent’anni non sono passati invano. Il mondo del 2049 che ci viene presentato appare fin da subito come una credibile derivazione del 2019 impresso indelebilmente nella nostra memoria di spettatori e appassionati, ma è anche il prodotto di una netta discontinuità che, se vogliamo, riprende anche molti dei nostri attuali motivi di preoccupazione.
Il tempo trascorso dal 1982 ha infatti comportato un graduale slittamento della distopia di Ridley Scott nei territori dell’ucronia, o se vogliamo della discronia, aggiungendo straniamento a straniamento: il Giappone non ha soggiogato il mondo e nemmeno la West Coast e, anche se mancano meno di due anni alla data fatale, la robotica comincia sì a muovere i primi passi, così come il dibattito sull’intelligenza artificiale tiene banco sulle pagine dedicate a scienza e tecnologia, e magari la scalata alla frontiera spaziale inizia pure a essere tentata da imprese private disposte ad annunciare lo sbarco su Marte entro il prossimo decennio, ma non c’è purtroppo traccia dei replicanti “più umani dell’umano”, né di colonie spaziali pronte ad accogliere l’esodo dei terrestri in fuga da un pianeta al collasso. Non era insomma esente da rischi l’idea di sviluppare un mondo che in molti avrebbero potuto cogliere come già superato, o comunque contraddetto dai fatti. Ma né i produttori né Denis Villeneuve si sono lasciati scoraggiare e in qualche modo Blade Runner 2049 ha saputo costruire un nuovo futuro sulle fondazioni del vecchio futuro immaginato da Scott.
[Prosegue su Delos SF 192.]
Archiviato in:Imaginarium Tagged: Arrival, Blade Runner, Blade Runner 2049, colonizzazione spaziale, Denis Villeneuve, discronia, Do Androids Dream of Electric Sheep?, Hampton Fancher, intelligenza artificiale, replicanti, Ridley Scott






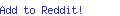

Tutti i seguiti di Blade Runner
[È on line il nuovo numero di Delos Science Fiction, il 192. Tra le altre cose, il direttore Carmine Treanni ha assemblato uno speciale dedicato al film sulla bocca di tutti, che alla fine pare dovrà aspettare l’home video per pareggiare le spese. Oltre all’articolo-recensione di Arturo Fabra, anche due pezzi del vostro bla bla bla. Questo è il primo.]
Forse non lo sapevate, ma Blade Runner 2049 non è la prima volta che vengono ripresi i personaggi e l’ambientazione di Blade Runner. Ecco una veloce panoramica di quello che è successo in questi trentacinque anni.
Blade Runner 2049 non rappresenta il primo e unico tentativo di dare un seguito alle vicende di Rick Deckard, il cacciatore di androidi ideato da Philip K. Dick nel romanzo Ma gli androidi sognano pecore elettriche? e poi entrato nel nostro immaginario collettivo con il volto e i modi spicci di Harrison Ford, protagonista del film che Ridley Scott ne ricavò nel 1982. Prima dell’opera di Denis Villeneuve, si contano almeno quattro tentativi ufficiali, ed è interessante notare che se tre di questi sono dei romanzi, il quarto è un videogioco. Ma procediamo per gradi.
I libri
Nel 1995 K. W. Jeter dà alle stampe Blade Runner 2: The Edge of Human (in italiano Blade Runner 2 per i tipi di Sonzogno, traduzione di Sergio Mancini, ultima edizione 1999): un tentativo di sposare e in qualche modo[image error] risolvere le divergenze tra il romanzo originale e l’adattamento cinematografico, ma che si traduce in realtà in un’esplosione di contraddizioni ancora maggiori. Basti dire che Pris in questo universo non è morta (e anzi, a un certo punto, il romanzo suggerisce che non sia nemmeno una replicante), così come pure J.F. Sebastian, che per di più convive con il suo prototipo letterario J.R. Isidore, addetto in una clinica veterinaria che in realtà aiuta i replicanti fuggiti sulla Terra a costruirsi delle identità di copertura.
La trama vede Deckard tornare in azione per le strade di una Los Angeles devastata da un sisma catastrofico e investita da un’ondata di caldo. Il suo incarico è quello di ritrovare il sesto replicante, ma dietro alla missione si cela una manovra segreta di Sarah Tyrell, nipote del magnate della Tyrell Corporation, ai danni proprio dell’impero costruito da suo zio Eldon. Come se non bastasse, Deckard si ritrova presto di nuovo invischiato in una caccia all’uomo, inseguito dall’originale umano di Roy Batty, uno schizofrenico incapace di provare paura per via di un’alterazione naturale dell’amigdala e deciso a vendicare la morte del suo replicante (resta da spiegare perché un essere umano debba provare una simile affezione per qualcuno/qualcosa che non ha mai visto in vita sua). L’intreccio, sofisticato e in sostanza terribilmente complicato, coinvolge tra gli altri anche il vecchio collega di Deckard Dave Holden, visto nella sequenza di apertura di Blade Runner mentre sottoponeva Leon al Voight-Kampff per poi beccarsi una pallottola in pieno petto. Non si può parlare di un libro memorabile, come si sarà capito, ma Jeter (che oltretutto propone un’inutile etimologia per il termine blade runner, facendolo risalire all’espressione tedesca “bleib ruhig”, ovvero “mantenere la calma”) ha il merito se non altro di introdurre la suggestiva idea della Curva di Wambaugh, “l’indice del disgusto di sé”:
“I cacciatori di replicanti lo raggiungono più malridotti, e più in fretta, degli altri poliziotti. Viene a furia di stare sul campo. […] Alla fine la Curva diventa ripida quanto basta e uno cade”.
Ed è quello che capita al personaggio di Deckard, che nelle mani di Jeter diventa un personaggio decisamente più instabile di quanto già non fosse nella tormentata caratterizzazione di Philip K. Dick.
[image error]In Blade Runner 3: Replicant Night (1996, in Italia dato alle stampe da Fanucci con il titolo Blade Runner. La notte dei replicanti, nella traduzione di Gianni Montanari, ultima edizione 1998), ritroviamo Deckard qualche anno più avanti su Marte, dove è fuggito con Sarah Tyrell dopo i fatti del libro precedente. Il pianeta rosso è una stazione di transito per gli umani che lasciano la Terra diretti alle colonie extra-mondo, e vengono ospitati in rifugi sovrappopolati e malmessi in attesa di ricevere dall’ufficio delle Nazioni Unite il permesso a emigrare. Bloccato in questo limbo, Deckard sbarca il lunario offrendo una consulenza a Urbenton, regista di un film che si propone di ricostruire la notte di caccia raccontata in Blade Runner. Il risultato è molto postmoderno, ma ancora una volta ben lontano da riprodurre lo spessore e il mood sia del romanzo di Dick che del film di Ridley Scott. Tuttavia, ancora una volta Jeter regala al lettore qualche motivo di interesse: in questo caso, Deckard finisce coinvolto in un complotto interplanetario e scoprirà suo malgrado che – per qualche effetto riconducibile ai campi morfogenetici o alla risonanza morfica teorizzata da Rupert Sheldrake – lontano dalla Terra l’umanità ha sviluppato una sterilità che rischia di condannarla all’estinzione, mentre paradossalmente i replicanti hanno acquisito la facoltà di procreare. Un tema che come sappiamo diventerà centrale in Blade Runner 2049.
Nel 2000 esce Blade Runner 4: Eye and Talon, tuttora inedito in Italia, il primo seguito a non mettere in scena Deckard come protagonista, bensì Iris, una delle migliori blade runner del dipartimento di polizia di Los Angeles. Ormai pochi replicanti fuggono clandestinamente sulla Terra e sul dipartimento aleggia il timore di un’imminente riorganizzazione. Iris viene incaricata dal suo superiore, Meyer, di rintracciare un gufo – lo stesso gufo che ha assistito al primo incontro tra Deckard e Rachael presso il quartier generale della Tyrell Corporation.
[Prosegue su Delos SF.]
Archiviato in:Imaginarium Tagged: Blade Runner, Blade Runner 2049, Blade Runner 2: The Edge of Human, Blade Runner 3: Replicant Night, Blade Runner 4: Eye and Talon, Denis Villeneuve, Do Androids Dream of Electric Sheep?, Harrison Ford, K.W. Jeter, Philip K. Dick, replicanti, Rick Deckard, Ridley Scott






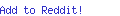

October 31, 2017
When It’s Cold I’d Like To Die
A seconda del mood in cui vi trovate, tre declinazioni di un pezzo di Moby che sembra avere una speciale attinenza con gli universi paralleli, al di là del passaggio suggerito nel titolo.
L’originale.
La vacanza onirica di Tony Soprano dal nostro (dal suo) mondo: una fuga nello spazio delle possibilità e dell’incompiuto.
La risalita dal Sottosopra nel finale di stagione di Stranger Things.
Ce n’è per tutti i gusti. Scegliete pure il vostro.
Archiviato in:Criptogrammi Tagged: Moby, musica, Sottosopra, Stranger Things, The Sopranos, universi paralleli, When It's Cold I'd Like to Die






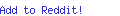

La cerimonia, Laird Barron (The Croning)
Barry Rourke gli aveva detto, una volta, che la degradazione di memoria era un effetto secondario del ritrovarsi esposti all’Oscurità. Mentre si aggirava nei boschi, lacero e traumatizzato, Don poté figurarsi che l’amnesia lacunare fosse in pari misura un meccanismo di autoconservazione. La sua coscienza aveva valutato la minaccia posta da tali affronti alla sua sanità mentale, e poi deciso di abbassare le luci e appendere il cartello con scritto FUORI SERVIZIO.
La cerimonia (The Croning, 2012) è il primo romanzo di Laird Barron, riconosciuto come uno dei migliori autori horror e weird contemporanei, ed è l’opera con cui fa anche il suo esordio in Italia, grazie alle encomiabili Edizioni Hypnos. È un libro che risplende di luce oscura, omaggiando i classici del genere, da Hodgson a Lovecraft passando forse anche da Ligotti, senza mai scadere nella sterile imitazione, anzi con una vitalità terrificante. In queste pagine ipnotiche il weird sconfina nel noir e nella fantascienza, mentre Barron segue l’ottuagenario geologo Donald Miller sulle tracce di un culto antico e terribile, che scoprirà affondare radici profonde ben più vicino a lui di quanto abbia mai osato temere. E incontriamo passaggi folgoranti (nonché familiari a chi ha una certa confidenza con il Solitario di Providence) come questo riportato qui sopra.
È il mio umile consiglio di lettura per questo giorno in cui le ombre sembrano farsi più lunghe e a volte anche animarsi di una volontà che non dovrebbero avere. Un’ottima, inquietante, suggestiva, preparazione a Halloween o, se preferite, a Samhain. Buona festa a tutti.
[image error]
Illustrazione di Dalton Rose.
Archiviato in:Criptogrammi Tagged: Halloween, Hodgson, Laird Barron, Lovecraft, Samhain, The Croning, Thomas Ligotti, weird


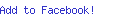



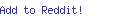

October 29, 2017
Stranger Things
Halloween si avvicina e – come promesso – venerdì scorso Netflix ha messo on-line la seconda, attesissima stagione di Stranger Things. Quale occasione migliore quindi per inframezzare al binge watching in cui vi sarete già calati con alcune riflessioni sparse sulla prima stagione? Quindi, ecco i miei 2 cent sulla serie rivelazione del 2016. Se vi interessa, proseguite; ma se non l’avete ancora vista, lo fate a vostro rischio e pericolo.
Come ormai sanno anche i sassi, Stranger Things è una serie ipercitazionista, che pesca a piene mani dai nostri anni ’80 (ma anche i primi ’90, come anche dalla fine dei ’70): serie TV (Gli acchiappamostri, Twin Peaks e ovviamente X-Files), cinema (I Goonies, E.T., La Cosa, Alien), letteratura (Stephen King su tutti, al punto che il font stesso dei titoli di apertura è una citazione esplicita del carattere usato sulle copertine dei primi libri del Re di Bangor). Ma il bacino degli influssi culturali è molto più ampio e abbraccia Tolkien, Star Wars, i giochi di ruolo (Dungeon & Dragons), i fumetti. Per molti versi mi è sembrata un’operazione nata nello stesso spirito di Super 8 (e, a proposito, è abbastanza facile smascherare anche i punti di contatto con Fringe), ma rispetto alla pellicola di J. J. Abrams, che prendeva una deriva abbastanza inconcludente già verso la sua metà, la serie di Matt e Ross Duffer migliora sulla distanza e rivela una certa specifica, innegabile genuinità.
Interessante l’uso delle musiche, che mescola abilmente partiture originali ricalcate sulle sigle elettroniche di quegli anni (e a proposito, bello il sapore retrò che già avevamo assaggiato con gli analoghi esperimenti delle puntate ’80s di Fringe), hit degli anni ’80 e musiche successive, anche di molto (pensiamo a When It’s Cold I’d Like to Die di Moby, anno di grazia 1995, peraltro già usata a chiusura di quello che forse è il mini-arco narrativo interno più bello dei Soprano: la seconda vita da banale rappresentante vagheggiata da Tony Soprano mentre si trova intubato in fin di vita all’inizio della sesta stagione).
Nel complesso, se tematicamente Stranger Things conserva un’affinità tutt’altro che superficiale con Super 8, esteticamente somiglia molto di più a Donnie Darko, anche per alcune frecciatine politiche buttate lì quasi per caso ma efficaci come non mai (l’insuperabile “È il nostro governo… Sono dalla nostra parte…” probabilmente le batte tutte).
Tutto e solo oro splendente, dunque? Forse c’era qualcosa che andava sviluppato meglio o almeno approfondito. Nella fattispecie il legame tra Eleven (El, resa nel doppiaggio italiano come “Undi“, tanto per urlare vendetta… altro che Hodor!) e quelle che potremmo definire portali o interfacce di carne, la cui origine non è ben spiegata. Così come non è giustificata la presenza nel Sottosopra (concetto per il resto sviluppato in maniera magistrale e reso visivamente benissimo) di un unico Mostro (ma magari la seconda stagione risponderà anche a questo). Una soluzione un po’ arbitraria di cui andava se non altro resa ragione allo spettatore.
L’entourage coagulatosi su Reddit intorno al fantomatico MHE ha smentito solertemente ogni contatto tra la serie Netflix e i racconti delle flesh interfaces (anche in italiano) che hanno catalizzato le attenzioni della rete un paio di primavere fa. Se molti degli spunti comuni (gli esperimenti umani, il progetto MKUltra, la deprivazione sensoriale, l’uso degli allucinogeni, etc.) in effetti sono elementi ormai confluiti nella cultura popolare, divulgati anche nelle opere di King a cui Stranger Things dichiaratamente si ispira, un po’ sospetti restano non una, non due, ma ben tre diverse peculiarità:
la visualizzazione organica dei portali;
l’uso dei bambini per esplorare ciò che c’è al di là (il Sottosopra della serie Netflix);
la tempistica (la serie di racconti creepypasta di MHE è stata portata a termine solo qualche settimana prima dell’esordio di Stranger Things).
Non so – sa distanza di oltre un anno sono ancora dubbioso ed evito di prendere una posizione a riguardo – se pure in questo caso tre indizi bastano a mettere insieme una prova. A ognuno le sue opinioni. Io mi ci sono divertito. E per di più la soddisfazione è andata crescendo man mano che gli episodi scorrevano. E questa forse è un’esperienza che non provavo dalla prima serie di True Detective.
Archiviato in:Imaginarium Tagged: creepypasta, Donnie Darko, Duffer Bros, ESP, fantascienza, flesh interfaces, Fringe, horror, J.J. Abrams, MKUltra, Moby, Netflix, Reddit, serie, Sottosopra, Stephen King, Stranger Things, Super 8, The Sopranos, True Detective, Twin Peaks, universi paralleli, weird, When It's Cold I'd Like to Die