Alessio Brugnoli's Blog, page 129
November 26, 2018
Buon compleanno, Amore
[image error]
Amore, vola da me con l’aeroplano di carta della mia fantasia,
con l’ingegno del tuo sentimento.
Vedrai fiorire terre piene di magia e io sarò la chioma d’albero più alta per darti frescura e riparo.
Fa’ delle due braccia due ali d’angelo e porta anche a me un po’ di pace e il giocattolo del sogno.
Ma prima di dirmi qualcosa guarda il genio in fiore del mio cuore.
Alda Merini
Omero e il rasoio di Occam
[image error]
Qualche giorno fa un tizio ha così commentato le mie critiche alla tesi, assai bislacca, di Omero nel Baltico, che, per chi non la conoscesse, afferma come le vicende narrate nell’Iiade non siano una trasfigurazione poetica di eventi avvenuti in Anatolia nella Tarda età del Bronzo, ma di vicende assai più antiche, ambientate, udite, udite, nella Scandinavia
Le consiglio la lettura di questa seria rivista, forse ripenserà le sue “opinioni”, alcune delle affermazioni da Lei presentate parrebbero non corrispondere a quanto affermato da altri studiosi (accademici e non sognatori):
RIVISTA DI CULTURA
CLASSICA E MEDIOEVALE
Fabrizio Serra editore, Pisa – Roma
Anno LV/2, 2013
Pp. 356
Data che questa rivista è di gran fama e ha un comitato scientifico che la metà basta, sono corso a vedere quali fossero i suoi contenuti, che provvedo a condividervi… Abbiamo, in ordine di apparizione, gli autori e i relativi saggi presenti sono:
Giacomo Tripodi, docente emerito di Botanica generale presso il Dipartimento di Scienze biologiche ed ambientali nell’Università di Messina, autore di
Riflessioni naturalistiche sui versi omerici
Marco Duichin, filosofo, autore di
Il lato oscuro di Odisseo: eroe greco o «sciamano» nordico?
Giovanni Martinotti,psichiatra ed Eleonora Chillemi esperta di psicologia cognitiva, entrambi di chiara fama, autori di
L’Odissea: ovvero la raccolta di icaros sciamanici in trance estasica
Alessandra Giumlia-Mair, grande esperta di metallurgia, autrice di
Baltico e Mediterraneo orientale nel II millennio a.C.
Silvia Peppoloni e Giuseppe Di Capua geologi e vulcanologi, autori di
Uno sguardo d’insieme sugli eventi geologici e climatici che caratterizzano l’Olocene nell’area baltica e mediterranea
William Mullen che immagino non sia il generale, autore di
Odysseus’ Travels after Troy: locations and Symbolic Patterns
Felice Vinci ingegnere nucleare, autore del saggio Omero nel Baltico, che ribadisce e sue tesi in
Evidenze di un’originaria matrice nordica dell’Iliade e dell’Odissea
Carla Del Zotto, docente di Filologia germanica all’Università “La Sapienza” di Roma, autrice di
Il mito di Troia e la migrazione di Odino in Scandinavia
Mark-Kevin Deavin, grande esperto di storia vichinga, autore di
Ulysses in the North? The Yggdrasill Myth re-considered
Maria Stella Bottai, critica d’arte, autrice di
“Prendendo Omero come modello”: l’epica finlandese del Kalevala e l’arte figurativa
Giuliana Bendelli docente di Letteratura inglese nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, autrice di
Ulysses Hibernatus
Arduino Maiuri, docente presso il Liceo “Cornelio Tacito” di Roma, è ricercatore ed esperto di storia delle religioni,autore di
Il Nord nel mondo greco-romano
Ilze Rumniece, docente di filologia classica presso l’università di Riga, autrice
Ancient “curetes” and the Western Baltic tribe of “kuri” (some suggestive parallels)
Tutti persone degnissime, studiosi di chiara fama, che avranno scritto dei saggi di sicuro interesse, ma con un grosso ma… Manca totalmente la presenza di un esperto di archeologia egeo anatolica o di filologia greca. Per fare un esempio concreto è come se chiamassi a progettare un aereo a un gruppo di lavoro costituito da un ingegnere idraulico, da un architetto, da un design, da un noto calciatore, da un musicista e da uno chef di fama: le loro considerazioni potranno anche essere interessanti, ma difficilmente il frutto del loro lavoro riuscirebbe ad alzarsi da terra.
Questa omissione è in fondo, frutto, forse inconsapevole, della volontà di sfuggire al contraddittorio, che mostrerebbe la debolezza della tesi di fondo: per esempio un filologo potrebbe mostrare come molte delle presunte prove di Vinci siano molto simili alle pseudo etimologie che andavano tanto di moda nel Medio Evo.
Oppure l’esperto di archeologia egeo anatolica, forse nel 2013 non avrebbe potuto citare le discusse iscrizioni luvie che accennano a Wilusa o accennare alle nuove ipotesi di rilettura delle tavolette o-ka di Pilo, ma sicuramente avrebbe raccontato dei risultati delle campagne archeologiche compiute nel sito di Troia, con la scoperta della città bassa, del fossato a sua difesa e delle tracce di scontri volenti che sono emerse negli scavi. O discutere dei testi ittiti come la Lettera di Manhapa-Tarhunta, la Lettera di Tawagalawa o Lettera di Millawata, con la loro complessa mitologia. O infine citare le tavolette di Pilo in cui, con le dovute cautele, si parlerebbe di troiani.
Ma questo avrebbe significato privilegiare il dato concreto, rispetto alla chiacchiere retoriche e avere il coraggio di applicare il rasoio di Occam, che ci suggerisce di “eliminare con tagli di lama” tutte le strade più complicate e imboccare quella più immediata e plausibile. Cose sempre meno digeribili, in un’Italia, che come mostrano i no vax, ha sempre più in antipatia la ragione e la scienza.
November 25, 2018
Aveia vestina e Forcona
[image error]
La strada che da Bagno, ora frazione de l’Aquila, ma che sino al 1927 fu comune autonomo, prosegue sino all’altopiano delle Rocche, dove parecchi romani vanno l’inverno a sciare, ai tempi dell’antica Roma, che in epoca preromana, quando questo faceva parte del territorio degli Equi, collegava le due grandi direttrici abruzzesi, quelle che in epoca storica diventeranno la Via Tiburtina -Valeria- Claudia (da Roma per Ostia Aterni, l’odierna Pescara) e la Via Claudia Nova (da Foruli, l’odierna Civitatomassa a Bussi).
Le fonti storiche non ci tramandano il nome di questa strada, che l’archeologo Bunsen nella prima metà del XIX secolo volle chiamare via Claudia. In un lavoro più recente Orsatti ritiene che questa via sia stata un diverticolo della Via Poplica Campana. Una delle prime località incrociate da questa strada era Aveia vestina, la nostra Fossa, di cui ho parlato per la necropoli con i menhir, che per secoli ha goduto della fama di città perduta: solo nel 1773 fu identificata dall’abate archeologo e filosofo Vito Maria Giovenazzi ebbe l’intuizione e il merito di riconoscerne e identificarne i pochi resti evidenti, in particolare un’iscrizione su roccia che attesta il culto di Bacco e Silvano, tracce di mura, l’ara Fossae, in cui sotto una grotta artificiale una lapide attesta il culto del Sole Invitto
[image error]
Nel 1965 è stato scoperto un piccolo acquedotto, mentre nel 2017, a valle della ricostruzione post sisma saltarono fuori grandi basoli calcarei accostati gli uni agli altri con tecnica accurata e raffinata, su cui si vedevano ancora le profonde incisioni dovute all’intenso traffico dei carri: era una strada monumentale,riconducibile all’antica via Claudia Nova, di cui non si avevano finora tracce certe nella conca aquilana.
[image error]
Si trattava di un tratto integro della lunghezza di circa 30 metri e della larghezza stimata di 4-5 metri (la via Appia antica è larga poco più di 4 metri) affiancato da un marciapiede porticato largo oltre 2 metri e dalle adiacenti costruzioni monumentali andate distrutte. E’ così che doveva mostrarsi nel I secolo a.C. il cardo maximus della città di Aveia. La città romana era strutturata su terrazze urbane degradanti sul versante montano e caratterizzata da una città alta, probabilmente monumentale, e da una città bassa che lambiva il corso del fiume Aterno, quella legata alle attività commerciali e di servizio del tratturo. Il percorso della Mura è come accennavo l’unica cosa ancora perfettamente leggibile, con il tratto monumentale meridionale che risale il versante fino al cosiddetto “Torrione” del borgo medievale.
Quando Aveia fu saccheggiata dai goti, per poi scomparire nel VII-VIII secolo d.C., probabilmente per i danni dovuti a catastrofi naturali (allagamenti, frane della montagna o terremoti), il suo posto fu preso, come sede della diocesi ecclesiastica, da un suo vicus, Frustenias, un insediamento dell’Età Tardo repubblicana. Grazie ai numerosi dati epigrafici e ai reperti portati alla luce, a differenza di Aveia abbiamo un quadro abbastanza chiaro dell’area.
Nel centro abitato, tra gli edifici più recenti spiccavano e spiccano tuttora tratti di mura, le strutture romane sottostanti l’antica Cattedrale di San Massimo, i resti di un complesso termale che sono stati inglobati nelle fondazioni dell’edificio cinquecentesco di Villa Oliva, il tempio dedicato a Feronia, rinvenuto e reinterrato negli anni Settanta, oltre a numerose iscrizioni funerarie e dedicatorie, che confermano l’esistenza di un centro abitato d’età romana.



Gli scavi condotti dal 1995 al 2000 hanno contribuito però permesso spero di scoprire la grandiosa opera di monumentalizzazione realizzata dai romani attraverso un intervento programmato sulla pianura posta sul versante settentrionale del Colle Moritola, dove i punti di maggiore pendenza ed instabilità erano stati rafforzati da una complessa struttura in muratura. Il complesso edilizio consisteva in un ampio terrazzamento artificiale che ospita una serie di edifici collegati tra loro, ognuno adibito a funzioni specifiche ed edificato in epoche diverse.
Gli ultimi scavi hanno infatti avvalorato l’ipotesi che la costruzione di questo grande complesso monumentale sia stata sviluppata in fasi successive, come dimostrano le diverse tecniche edilizie usate e lo studio della sequenza stratigrafica: alla fase più antica, che si colloca tra la fine del II e la metà del I sec. a.C., sono datate le strutture murarie in opera poligonale; all’epoca immediatamente successiva, inquadrabile grossomodo all’Età augustea, risale la fase di massima fioritura monumentale dell’area che era stata occupata in precedenza.
E’ in quel periodo che vengono infatti realizzate le strutture di sostegno della collina, sicuramente di grande impatto visivo e scenografico, e gli edifici soprastanti caratterizzati da una grande cura nell’esecuzione del progetto e dalla scelta dei materiali adottati, l’accuratezza delle decorazioni che comprendono pavimenti a mosaico e in opus signinum, affreschi e intonaci, rivestimenti in stucco. Durante l’Età imperiale si assiste ad interventi finalizzati alla modifica, seppure parziale, dell’assetto originario, attraverso la riorganizzazione e il rinnovo di alcuni spazi. Nel periodo tardo-imperiale si giunge all’abbandono volontario del complesso, testimoniato dalla scarsità di reperti, anche d’uso comune, ed il pianoro viene interrato. Tutta l’area resta poi inutilizzata per lungo tempo fino a quando, in Epoca altomedievale, si nota un parziale recupero di alcune delle strutture più antiche. La presenza di canalizzazioni per l’acqua, di ambienti decorati con mosaici e di vasche a livelli e profondità variabili ci narrano di un edificio concepito per la raccolta e l’utilizzo delle acque sorgive, ancora oggi abbondanti in zona.



Per cui, si può ipotizzare, sia per la datazione, sia per la struttura che il complesso fosse un qualcosa di analogo ai grandi santuari a terrazze tardo repubblicani, come quello di Iside all’Esquilino, quello della Fortuna Primigenia a Palestrina, di Ercole Vincitore a Tivoli e di Iuppiter Anxur a Terracina. E per la centralità del ruolo delle acque e delle grotte, poteva essere dedicato alla coppia sacra Feronia, dea della fertilità e delle acque e Soranus, signore del mondo sotterraneo, i cui sacerdoti, chiamati Hirpi Sorani (“Lupi di Soranus”, dalla lingua Sabina hirpus = “lupo”), tra le tante cose celebravano il dio camminando sui carboni ardenti, reggendo le interiora delle capre sacrificate.
Tornando alla storia di Frustenias, sappiamo che un suo vescovo di nome Florio partecipo’ al Concilio ecumenico di Costantinopoli presieduto da papa Agatone nell’anno 680. Con la caduta dell’Impero d’Occidente assistiamo intorno al IV secolo alla nascita della regione Valeria e Furcona vi fu annessa insieme ad Amiterno, Carsoli e Rieti e la città fu chiamata o Civitas Furconiae, nome derivato forse da Forum Conae,a sua volta derivante da laccoma (stagno o lago in latino), ad indicare la posizione nei pressi dei laghi di Bagno, o Civitas S. Maximi, in virtù del fatto che vi venne sepolto il martire Massimo d’Aveia. Questo, secondo la leggenda, nacque intorno all’anno 228 ad Aveia, da una famiglia cristiana. Fu imprigionato durante le persecuzioni di Decio tra l’ottobre 249 e il novembre 251. Condotto dinanzi al prefetto di Aveia, Massimo non abiurò e alla fine fu gettato dalla rupe più alta della città, detta Circolo e Torre del Tempio.
Dopo la guerra greco-gotica (535-553) Civitas Furconiae fu sottoposta all’esarcato di Ravenna per essere poi soggetto ai longobardi, probabilmente intorno al 571-574, divenendo un importante Gastaldato; ne abbiamo notizia in un placito dell’anno 776 del duca Ildeprando in Roma, in cui si cita il gastaldo furconese Majorano. Nell’anno 843, divenne parte della contea dei Marsi (autonoma dal ducato di Spoleto), costituita dalla Marsica e dai Gastaldati di Furcona, Amiterno, Rieti, Valva e Pinna, la quale nel 926 fu divisa in due comitati, uno orientale (con Penne, Teate ed Apruzzo) e l’altro occidentale (con Furcona, Amiterno, Valva, la Marsica e Rieti).




Nell’alto Medioevo il centro visse un nuovo periodo di fioritura sotto il controllo dell’abbazia di Farfa. Ospitò l’imperatore Ottone I di Sassonia e papa Giovanni XIII che, il 10 giugno 957, si recarono in visita ad omaggiare le spoglie di San Massimo.Il papa Niccolò II nell’anno 1059 consacrò san Raniero vescovo di Furcona con l’incarico di costruire la fabbrica della cattedrale di S. Massimo nel luogo della preesistente chiesa. Della costruzione di Raniero, rimangono purtroppo poche rovine: l’abside del Duecento con dentellature, le mura perimetrali, le colonne delle tre navate, le quali sono state recuperate nel VII secolo dalla città romana di Amiternum. Inoltre ci sono pervenute anche la torre campanaria quadrata con dentellature sul tetto con copertura lignea a capanna e le rovine del portico gotico interno con arcate a tutto sesto. Probabilmente, a sentire gli storici locali, la facciata era dominata da un grande rosone.
Nell’anno 1143 i normanni conquistarono la Marsica, annettendovi Furcona , Amiterno e Rieti; in quest’epoca , nell’anno 1158 Furcona era feudo di 1 soldato a cavallo. Forcona prese parte alla fondazione della città dell’Aquila, la sua tassa essendo di 8 once d’oro, ed il suo ‘locale’ era nel Quarto di S. Giorgio. All’edificazione del Duomo dell’Aquila — che accolse le spoglie di San Massimo — la diocesi di Forcona venne trasferita nella nuova sede con la bolla pontificia Purae fidei di papa Alessandro IV del 22 dicembre 1256.Berardo da Padula, già vescovo di Forcona, divenne de facto vesco dell’Aquila.
Come per tutti i centri della zona, la fondazione dell’Aquila provocò il loro progressivi spopolamento: sappiamo ad esempio che Forcona, nel 1508 risultasse abitata da 16 fuochi, pari a 81 persone
La Basilica di Santa Maria Maggiore come non l’avete mai vista
Da Wikipedia
La papale arcibasilica maggiore arcipretale liberiana di Santa Maria Maggiore, conosciuta semplicemente con il nome di “basilica di Santa Maria Maggiore” o “basilica Liberiana” (perché sul suo sito il primo edificio di culto fu fatto erigere da Papa Liberio), è una delle quattro basiliche papali di Roma, situata nel Rione Monti. Collocata sulla sommità del colle Esquilino, è la sola ad aver conservato la primitiva struttura paleocristiana, sia pure arricchita da successive aggiunte.
Edificata durante il pontificato di Papa Liberio (352-366) fu ricostruita o ristrutturata da papa Sisto III (432-40), che la dedicò al culto della Madonna, la cui divina maternità era appena stata riconosciuta dal concilio di Efeso (431)[
La costruzione avvenne su una chiesa precedente, che una diffusa tradizione vuole sia stata la Madonna stessa ad ispirare apparendo in sogno a papa Liberio e al patrizio Giovanni e suggerendo…
View original post 145 altre parole
November 24, 2018
Mercurion
Basilio I il Macedone, uomo dalla vita avventurosa, che dal nulla salì alla porpora imperiale, a differenza di tanti suoi predecessori, non ignorò le regioni occidentali dei suoi domini. Dopo anni di abbandono, sotto il suo regno Bisanzio tornò ad essere protagonista: nell’868 la sua flotta liberò dall’assedio saraceno la città di Ragusa in Dalmazia, le città e le isole della regione vennero unite nel Tema di Dalmazia con capitale Spalato.
Nell’871 venne eliminato l’emirato di Bari con l’aiuto dell’imperatore Ludovico, nell’875 il principe Adelchi di Benevento divenne tributario di Bisanzio, nell’880 per vendicare la caduta di Siracusa nelle mani arabi l’ammiraglio Nasar sconfisse gli arabi alle Lipari e la sua flotta operò nel Tirreno, nell’881 venne riconquistata Taranto e il duca di Salerno diviene tributario dei Bizantini. Nell’883 lo stratego Stefano Massenzio sbarcò in Italia e cominciò a cacciare gli arabi dalla Calabria, con mediocri risultati. tanto nell’885 il suo posto fu preso da Niceforo Foca il Vecchio che alla testa di una legione di Pauliciani convertiti occupò le ultime piazzaforti in Calabria di Santa Severina e Amantea e diviene padrone della costa del golfo di Taranto unendo così i possedimenti della Puglia e della Calabria.
La riconquista bizantina della Calabria, se aumentò di molto l’importanza politica ed economica di Rhegion e della sua chora, che erano sempre rimaste di lingua e cultura greca, ha anche una grande ricaduta nel suo nord. Con la nascita del thema, il territori di Scalea, della valle del Lao, della Calabria nord-occidentale e della Basilicata meridionale, furono soggetti a una sorta di “colonizzazione”, per ripopolare e difendere tale area.
Il diradamento della popolazione non era un fatto recente: al contrario, era un fenomeno che aveva origini remote. Fin dall’antichità la regione aveva conosciuto solo un modello di popolamento sparso. I Brettii, infatti, erano organizzati su base cantonale e di pagì. Nella tarda antichità, a causa della necessità di sostituire le forniture di grano provenienti dall’Egitto, dirottate a Costantinopoli, si svilupparono una serie di villae, il cui tessuto economico e sociale però collassa al seguito della guerra gotica e all’invasione longobarda.
I pochi abitanti rimasti si ritirano nell’interno, sulle colline o sui monti, dove tuttavia non costituiscono grandi centri abitati, ma solo piccoli insediamenti sparsi: si trattava, come spesso accadeva in epoca altomedievale, di piccoli villaggi di capanne di legno con tetto di paglia, difesi dalla natura o fortificati da recinzioni più frequentemente in legno che in pietra. Infatti, in quest’epoca l’unico centro abitato di una certa importanza sembra fosse fortezza di Laino. Per la sua ottima posizione, a dominio dell’alta valle del Lao e del tracciato dell’antica via Popilia, che per secoli era stata l’unico accesso alla Calabria, i Longobardi vi costituirono un gastaldato: nell’atto di divisione del principato di Benevento dell’849, infatti, Laino, Cassano e Cosenza erano gli unici gastaldati attestati per la Calabria.
I Bizantini si trovarono quindi davanti a una sorta di selvaggio west: bisognava lasciarci delle guarnigioni, per evitare che a longobardi e arabi venissero strani grilli, per la testa, che bisognava però nutrire. Per questo era necessario strappare la terra coltivabile alla foresta, costituire nell’interno degli agglomerati urbani e difenderli dalle aggressioni provenienti dal mare, ma anche creare approdi per imbarcazioni di piccole dimensioni per mantenere i contatti con gli altri territori bizantini. Per via di terra, infatti, le comunicazioni con le regioni circostanti erano sempre state difficili. La valle del Lao, separata dal resto della Calabria da alte catene montuose, aveva poche vie di comunicazione con l’esterno ed anche queste spesso erano solo mulattiere pericolose, mentre al contrario, la linea di costa era molto arretrata rispetto ad oggi e il Lao, risultava essere navigabile.
Per cui, Niceforo Foca lasciò che una parte dei suoi veterani (Greci, Armeni, Slavi e forse anche Arabi siriani) colonizzasse le terre di nuova conquista, in modo da creare delle comunità di stratioti,liberi contadini, che in cambio della cessione di un fondo, avrebbero pagato le tasse e fornito un regolare ed ereditario servizio militare.
[image error]
In parallelo a questa colonizzazione laica, arrivò anche quella religiosa: come spesso è accaduto nella storia religiosa, attorno ai primi eremiti, che si erano trasferiti tra i boschi ed i dirupi delle sue montagne in cerca di pace, nascono e si sviluppano una serie di monasteri, che spesso si organizzano in una sorta di federazione, l’eptarchia. Nel caso specifico, abbiamo il Mercurion, che si sviluppò una zona che si può circoscrivere tra Laino, il castello di Mercurio, sito alla confluenza del fiume Lao con l’Argentino, e il borgo di San Nicola dei Greci (corrispondente all’attuale San Nicola Arcella).
Di difficile interpretazione è l’origine del toponimo. Tre sono le ipotesi più accreditate a riguardo. La prima è quella sostenuta dal Binon, il quale farebbe risalire il nome di quest’area al culto di san Mercurio di Cappadocia, professato dai monaci bizantini. Secondo altri studiosi, tra i quali Schluberger, l’origine del nome deriverebbe da un tempio pagano nel quale si adorava il dio Mercurio. Una terza soluzione è stato proposta dal Pandolfi e dal Cappelli. Secondo questi due storici sarebbe il fiume Mercure, che scorre attraverso i territori di Rotonda, Viggianello e Laino, a denominare la zona.
Essendo un’area di frontiera, sia politica, sia ecclesiastica, godeva sia un’enorme autonomia, diventando l’equivalente medioevale del nostro Monte Athos, sia un luogo di enorme fervore spirituale: fu definito nuova Tebaide, e divenne uno dei maggiori centri del misticismo dell’Italia meridionale e della Sicilia, in tale periodo infatti vissero o studiarono, presso i monasteri locali, un gran numero di personalità che saranno venerate come santi dalla chiesa, tra cui: San Fantino il giovane, San Nicodemo da Cirò, San Zaccaria del Mercurion, San Saba del Mercurion, San Luca di Demenna o d’Armento, San Macario Abate e, probabilmente il più importante, San Nilo da Rossano.
Tutto ciò fu cancellato dalla conquista normanna e dal loro tentativo di estirpare ogni traccia di grecità dalla Calabria: i monasteri di rito greco furono assoggettati ad abbazie latine, nello specifico alla Badia di Cava quelli ricadenti in territorio longobardo e alla Badia di Santa Maria della Matina quelli in territorio bizantino, cosa che porò. alla liquidazione dell’eparchia.
Eppure, molte sono le tracce di quel periodo: il santuario di Santuario Madonna della Grotta a Praia a Mare, fondato da Fantino il Giovane, la grotta dell’Angelo a Orsomarso, dove in cui trascorse i suoi anni di eremitaggio e di dura ascesi San Nilo, la grotta di San Ciriaco a Buonvicino, dove il santo si ritirava a pregare, la cappella della Madonna delle Nevi a Verbicaro, un vero gioiello dell’arte bizantina calabrese, la chiesa di Madonna di Mercure a Orsomarso.
November 20, 2018
Mausoleo imperiale di San Vittore al Corpo
[image error]
Nella Mediolanum tardo antica, il suburbio era organizzato in due principali nuclei sepolcrali: il primo, posto accanto alle mura, era il cimitero ad martyres, che sorgeva sull’area oggi identificata tra le vie Nirone, S. Valeria, Lanzone e Piazza Sant’Ambrogio. Cimitero in cui Seguendo sempre la politica polemica di contrapporre potere imperiale a potere vescovile, Ambrogio progettò in quest’area la costruzione della nuova Basilica Apostolorum, la nostra San Nazaro in Brolo, affacciata sulla via porticata, avrebbe poi dovuto accogliere le sue spoglie. Il secondo, invece, situato lungo l’attuale via di San
Vittore, era una necropoli dalla lunga e complessa storia: nata nel I secolo d.C. come ultima dimora dei ricchi milanesi dell’epoca, con la trasformazione della città in capitale imperiale, divenne probabilmente l’area sepolcrale degli equites singolares, le guardie a cavallo dell’imperatore, una sorta di versione meneghina del nostro praedium imperiale Ad Duas Lauros.
[image error]
Già al termine dell’età tetrarchica, però, la necropoli viene progressivamente cristianizzata: all’epoca di Massimiano, padre di Massenzio e collega di Diocleziano, è infatti databile l’iscrizione in greco di Aurelio Frontone, di recente accuratamente riesaminata dal punto di vista filologico e paleografico, riferibile alla tomba di un medico cristiano. Successivamente, in un momento imprecisato tra l’età costantiniana e quella teodosiana, fu costruito il mausoleo imperiale, anche questo dalla vita assai travagliata: trasformato in cappella di San Gregorio nel IX-X secolo e annesso alla chiesa di San Vittore al Corpo, esso fu abbattuto in occasione della ricostruzione tardo-cinquecentesca della fabbrica cristiana, quando quando uno dei progetti di Vincenzo Seregni, che prevedeva di ribaltare l’orientamento della chiesa, costruendo nuova che avrebbe incorporato il mausoleo imperiale, accompagnandolo con una struttura analoga e simmetrica, venne scartato a favore di quello di Galeazzo Alessi, che comportò un
intervento radicale.
[image error]
Il mausoleo, con un’unica stanza, cosa che ne definisce la sua natura cristiana, si ispirava, nella sua concezione ai mausolei costantiniani di Roma e al cosiddetto tempietto di Minerva Medica: si presentavacome un ottagono (lato di 7,5 metri) caratterizzato, all’esterno sugli angoli da lesene a libro e all’interno da otto nicchie rettangolari e semicircolari alternate e divise da colonne. Informazioni sull’alzato
sono desumibili solo da una veduta di un disegnatore olandese, conservato alla Staatsgalerie di Stoccarda, di poco precedente alla demolizione (1570) in cui il mausoleo è rappresentato ancora nella sua posizione presso la chiesa romanica di San Vittore al Corpo, e dalle descrizioni di Jacopo Filippo Besta del XV secolo e di Bonaventura Castiglioni del 1553.
Confrontando il disegno, in cui si evidenzia la presenza di un secondo ordine con arcate cieche, con le descrizioni, possiamo arguire quasi con certezza la presenza all’interno di gallerie superiori. Infine,dell’originario e sontuoso apparato decorativo che caratterizzava l’interno del monumento restano pochissime tracce. I pavimenti erano coperti da opus sectile (lastrine di marmo) e la parte inferiore delle pareti doveva essere rivestita da uno zoccolo in marmo grigio (di cui sono visibili ancora alcuni resti) probabilmente sormontato da tarsie marmoree e vitree, intonaci dipinti, stucchi e mosaici.
Nei pressi del mausoleo, imitando il modello romano definito da Massenzio e Costantino, doveva esserci probabilmente una basilica paleocristiana, che molti ipotizzano essere Portiana. Basilica, il cui nome deriva dal nome di Portius, il laico o chierico che donò un suo terreno per costruire l’edificio, nota per le continue litigate tra Ambrogio e il vescovo ariano Mercurino Aussenzio, su chi ne dovesse avere tra i due la proprietà, che è sorta di mistero archeologico milanese.
Essendosene perse le tracce, molti l’hanno identificato con San Lorenzo, con Sant’Eustorgio o con San Simpliciano, che, per alcune caratteristiche che la rendono simile all’Aula Palatina di Treviri, poteva invece essere l’altrettanto misteriosa Basilica Fausta; tuttavia, numerose fonti medievali l’associano con San Vittore, come ad esempio Liber de situ (X-XI sec.) che,situa la chiesa nel suburbium occidentale, o dai Libri indulgentiarum che specificano come Portiana fosse vicina alla rotonda di S. Gregorio, nome con cui era definito il mausoleo imperiale in epoca medievale: ecclesia Sancti Gregorii et iuxta ecclesiam Portianam. Allo stesso modo il Manipulus Florum menziona il monasterium Sancti Victoris ad corpus in ecclesia Portiana.
La Portiana doveva probabilmente richiamare nella forma le grandi basiliche romane, con tre navate divise da filari di colonne, di cui la centrale chiusa da un’abside semicircolare. L’edificio, coperto da travi a vista, era orientato a est e con l’ingresso forse proceduto da un quadriportico. La presenza della basilica e del mausoleo, trasformò la necropoli in un cimitero di lusso: vi furono seppelliti ad esempio i primi vescovi milanesi Mirocle (313-314) e Protasio (343-344). Tra il materiale epigrafico dell’epoca si distingue l’epitaffio dell’ottantenne Probus, rinvenuto sulla sua sepoltura accanto al mausoleo
imperiale, in una posizione di evidente prestigio. Sposato per trent’anni e sepolto nel 368, come si deduce dall’indicazione del consolato, egli si qualifica “presbyter”, una carica ecclesiastica appena inferiore a quella di vescovo. Commovente invece è l’epitaffio, sempre risalente a quel periodo, della rimpianta Adtica Lea, morta a ventiquattro anni, paragonata a una pianta che cade lasciando frutti immaturi.
[image error]
Prima del VI secolo, la necropoli fu protetta da un recinto ottagonale costriuto in modo da avere il mausoleo in uno dei suoi fuochi, lungo internamente 132 e largo 100 metri, aveva lati lunghi 42/44 metri ed era dotato di torri semicircolari ai vertici. L’alzato, con paramenti laterizi e nucleo di mattoni e ciottoli alternati a strati, era sorretto da fondazioni in conglomerato di malta e ciottoli. Il tratto di muro nordoccidentale, l’unico conservato in elevato, presentava all’interno nicchie affiancate da semicolonne. L’ingresso monumentale era collocato a sud-est e ancheggiato da due torri. Il recinto dovette avere lunga vita: in una pianta del 1814, infatti, tre dei suoi lati costituivano ancora confini di proprietà.
Detto questo, il mausoleo imperiale a chi era destinato? Non certo a Massimiano, che a differenza del figlio, era un convinto pagano: probabilmente accolse le tombe della famiglia dei Valentiniani, da Graziano a Valentiniano II. Quest’ultimo, morto prematuramente a Vienne in Gallia nel maggio del 392, a causa degli intrighi del magister militum Arbogaste e trasportato a Milano, avrebbe avuto qui sepoltura, in un sarcofago di porfido. Il vescovo di Milano Ambrogio, nel discorso funebre pronunciato per il giovane imperatore, ricorda che la salma restò in una chiesa in attesa della sepoltura avvenuta solamente in settembre. Sarcofago che tra l’altro, fu donato a Pandolfo Malatesta che se le portò a Rimini…
20 novembre 2018 “Stella Rossa sul Futuro” alla Libreria Pagina 2
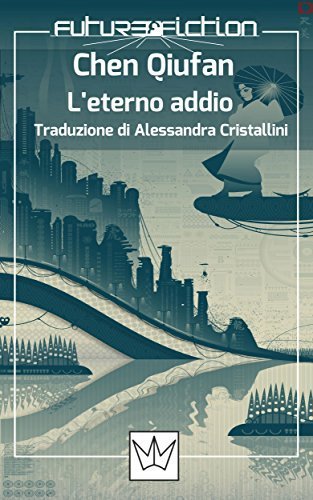
Martedì 20 novembre, alle ore 19, incontro in libreria dal titolo Stella Rossa sul Futuro: tendenze e tensioni della Science Fiction cinese
Interverranno:
CHEN QIUFAN (noto anche come Stanley Chan), autore di narrativa di speculazione, traduttore e produttore creativo, vincitore del premio Dragon Fantasy di Taiwan, del Milky Way per la Science Fiction, il Nebula cinese per la fantascienza e il premio Science Fiction & Fantasy per la traduzione insieme a Ken Liu.
FRANCESCO VERSO, scrittore di genere ed editor del progetto multiculturale Future Fiction, specializzato nello scouting e nella traduzione dei migliori scrittori di Science Fiction provenienti da tutto il mondo, autore di numerosi romanzi e racconti, vincitore del premio Odissea e premio Italia 2014 e co-vincitore premio Urania 2015.
SIMONE PIERANNI, giornalista de Il Manifesto, scrittore, fondatore di China Files, esperto conoscitore di cina, è co-autore del podcast sulla Cina Risciò.
Libreria Pagina 2
View original post 11 altre parole
November 19, 2018
I micenei odiavano le epigrafi…
[image error]
Facendo i conti della serva, sui 6.000 testi in lineare B che abbiamo attualmente trovato, il 99% è inciso su documenti d’argilla o dipinto su vasi, mentre uno o due documenti sono incisi su pietra, uno lo è su un ostrakon uno su un sigillo e uno su un pendente d’ambra.
Ora dato che la pietra, come materiale, dovrebbe essere assai meno deperibile dell’argilla, statisticamente il rapporto dovrebbe essere molto diverso: per cui dobbiamo arguire come i micenei non la utilizzassero. Il che a dire il vero, è testimoniato dal fatto che, come d’altra parte i minoici, non avevano alcun interesse, a differenza dei greci dell’antichità classica, dei romani e delle civiltà vicino orientali loro contemporanee, per una scrittura come dire, “monumentale”.
Insomma, i micenei odiavano scrivere epigrafi: problemi loro, risponderebbe il buon Li er barista… In realtà questa assenza rappresenta un indizio di una visione del mondo peculiare: da una parte si scrive su pietra non per se stessi, ma per i posteri, tracciando delle informazioni, connesse a un documento pubblico oppure qualcosa di privato ma estremamente standardizzato, per esempio le lapidi tombali, che si vogliono conservare per sempre.
Scrivere epigrafi significa fissare dei punti fermi nel fluire del Tempo. Affermazione banale, che presuppone almeno tre concetti, che noi moderni diamo per scontati:
L’esistenza del Mutamento, ossia che non tutto ciò che esisterà è esistito o esiste attualmente, che può essere associato a un divenire lineare, il nostro Futuro o a uno ciclico.
Senza il concetto di Mutamento è possibile la mera ‘reazione’ ma non l”azione’, in quanto l’agire richiede la capacità di anticipare il mutamento, Le immagini del mutamento (fini, obiettivi, intenzioni, speranze, paure, aspirazioni) rientrano tra le cause dell’azione presente.
Per cui, è possibile che i minoici e micenei avessero una concezione del Tempo ben diversa dalla nostra, da quella dei popoli anatolici e mesopotamici e dell’età classica, non legata al chronos, a ciò il cui cambiamento è misurabile e determinabile, ma alla dialettica tra quello che gli elleni definivano Kairos, il momento indeterminato nel quale “qualcosa” di speciale accade e l’Aion, l’eternità. Come in tanti popoli primitivi, esisteva una sorta di lungo presente, specchio ed epifania dell’Eterno, che si concretizzava tramite le dimensioni del Sacro e del Mito e il rito, di cui erano garanti le élites palaziali.
Dall’altra, l’epigrafe è nelle società del Vicino Oriente e dell’età Classica il principale canale di comunicazione fra Stato e Cittadini. Si potrebbe azzardare un paragone tra le epigrafi antiche e i nostri mezzi di comunicazione di massa, mutatis mutandis, ossia il modo primario in cui il Potere costruisce la sua immagine
A differenza di altre forme antiche di comunicazione, le iscrizioni non costituiscono una categoria esclusiva per pochi eletti, ma sono potenzialmente rivolte a tutti: i destinatari sono infatti non solo tutte le persone alfabetizzate, in grado di leggere e decodificare il messaggio scritto, ma anche i semianalfabeti, che potevano avvalersi di “esegeti” o “letterati” per la lettura, la spiegazione o il riassunto dei testi.
L’epigrafe, citando un saggio di Susini, come medium, implica almeno tre effetti specifici sui suoi destinatari
la persuasione dell’importanza della scrittura, che impegna il suoestensore e tutti i protagonisti che vi sono evocati (una gens, una respublica, una collettività) alla veridicità di quanto vi si legge ed alla fedeltà ai valori espliciti od impliciti nel testo, anche in correlazione agli apparati figurativi e monumentali che eventualmente corredano il supporto;
di conseguenza, il senso di sicurezza che promana dal monimentum e dalla sua scrittura, proprio perché concettualmente imperituri: la gente sa di ritrovare in quell’orizzonte quella scrittura, che diviene con ciò un luogo comune dell’esperienza, cioè del quotidiano, e della memoria;
infine, una scrittura su materiale durevole impegna il committente, l’estensore, lo scriba o scriptor, nonché il lapicida ad un prodotto “di riguardo”, consentaneo quindi ai sentimenti di garanzia che la scrittura suscita nel lettore: costui ne è anche il controllore ed il censore, e tutto deve quindi compiersi perché la scrittura risulti gradevole, perspicua, corretta, quindi ammirabile.
La rinuncia a questo medium da parte dei wanax e dei lugal, oltre a evidenziare la scarsissima alfabetizzazione della società micenea, in cui la scrittura aveva una funzione burocratica e contabile, tanto da scomparire al seguito del collasso del sistema palaziale in cui era integrata, implica da una parte il primato dell’oralità, con la centralità del ruolo dell’aedo nel tramandare la Storia e il Sapere, riscrivendoli rendendoli atemporali, dall’altra l’utilizzo, in maniere analoga a tante altre società primitive, del Rito e dell’Economia del dono come strumento di comunicazione e di raccolta del consenso.
Comportamenti ben diversi dai loro vicini Ittiti e Luvi, fissati per le epigrafi monumentali… E lo iato culturale tra le due diverse visioni del mondo, che, in aggiunta ai contrasti geopolitici, furono alla base dei tanti equivoci e malintesi che appaiono nelle tavolette di Hattusa…
November 18, 2018
Amiternum



Può sembrare strano, ma nei pressi de l’Aquila, a una decina di chilometri dalla città, vi era una delle principali città sabine, seconda per importanza soltanto a Rieti; si tratta di Amiternum, il cui nome deriva dal fiume Aterno che scorre vicino, o come ricorda Strabone attraversava l’abitato (V 4,2) e Varrone (De ling. Lat. V 28) ricorda che “gli Atermini sono chiamati così perché abitano intorno all’Aterno”. Catone (citato da Dionigi d’Alicarnasso, II 49) afferma che “il più antico insediamento sabino, Testruna, sarebbe stato in prossimità di Amiterno”.
Sempre secondo Dionigi d’Alicarnasso, gli amiternini vinsero una guerra contro gli aborigeni al tempo di Romolo (fine dell’VIII secolo a.C.), conquistando le loro città più importanti, Lista e Cutiliae, in un attacco notturno e furono la popolazione che dominò l’alta valle dell’Aterno fino al VI secolo a.C. Probabilmente, all’epoca, in maniera simile alla Roma dei primordi, vi era un vicus principale, situato sul colle di San Vittorio, a cui, per legami gentilizi e sacrali, facevano riferimento una serie di pagi circostanti, suddivisi da questo da pascoli e campi coltivati. Pagi che dovrebbero, in linea di massima,
corrispondere ai nostri Scoppito, Pizzoli, Preturo, Coppito.
Amiternum fu conquistata dai romani, guidati da Manio Curio Dentato nel 293 a.C. durante la terza guerra sannitica (Livio, X 39, 2-4); in quell’occasione avrebbero stati uccisi 2800 uomini e catturati 4270. Nel 290, con il definitivo assoggettamento della Sabina il centro entrò a far parte dello stato romano ottenendo la cittadinanza sine suffragio (senza diritto di voto), mentre nel nel 268 a.C. gli fu concessa la cittadinanza ottimo iure, che dava la possibilità agli amiternini di contare politicamente in tutto lo stato romano, con l’inclusione in due nuove tribù, la Quirina e la Velina.
Nel 211 si salvò per puro caso dalla furia di Annibale e sino ad Augusto la città restò semplice prefettura governata da octoviri e solo allora dovette accedere a statuto di municipio anche se, recentemente, la scoperta dell’iscrizione con la menzione di duoviri fa pensare all’esistenza di una colonia anteriore alla costituzione del municipio. Il culto imperiale era amministrato da tresviri augustales invece che dai seviri, anche questo segno di un’amministrazione municipale non del tutto sviluppata. La città diede i natali al celebre storico Sallustio nell’86 a.C.. Tra i più noti culti locali ricordiamo quelli di ferocia, di Ercole e di Fortuna il cui tempio fu ricostruito dopo un incendio come ci attesta un’iscrizione di epoca imperiale (CIL IX 4181).
In ogni caso, sotto il dominio di Roma la città crebbe e diventò un grande centro urbano con decine di migliaia di abitanti, inserita nella IV Regione (Sabina et Samnium) che corrispondeva all’attuale Abruzzo e Molise, dato il suo essere un importante nodo stradale: situata lungo l’antica Via Cecilia che arrivava fino ad Hatria, da essa si snodavano la Via Claudia Nova e due diramazioni della Via Salaria, il che la rendeva uno dei principali luoghi di transito tra il Tirreno e l’Adriatico. A questo si aggiungeva la prosperità fondata soprattutto sull’allevamento del bestiame che poteva finalmente praticare la transumanza protetta da precise leggi di Roma che legavano l’Abruzzo alle terre Pugliesi
Secondo una leggenda, ad Amiternum, nacque, in età augustea Ponzio Pilato. Per dare maggiore credito a tale diceria, nel Seicento un erudito locale si inventò questa simpatica storiella
“Amiternum. Anno 1580, 25 marzo. Il martellamento ritmico dei picconi degli spagnoli proveniente dalle rovine di Amiternum riecheggiava tra le ancora innevate colline che corollano la valle dell’Aterno. L’antichissima e nobile città sabina era stata razziata di ogni cosa trasportabile, compreso gli imponenti leoni in marmo dei templi ed il famoso calendario amiternino. Un tonfo sordo del ferro incuriosìuno degli uomini. Dal terreno di Amiternum gli spagnoli estrassero uno scrigno. Le urla di giubilo degli scavatori ruppero la quiete della valle.
Il singolare rinvenimento, fece pensare subito ad un tesoro, a monete d’oro sonante, a preziosi gioielli custoditi da secoli all’interno del forziere. Come scatole cinesi, una volta rotto avidamente l’involucro in pietra, spuntarono fuori una cassetta in ferro, poi una di marmo. Al loro interno, per la delusione degli spagnoli, solo alcuni rotoli di pergamene scritte in ebraico. Quando poi, tra i rotoli, si riscontrò che uno conteneva la sentenza di condanna di morte emessa da Ponzio Pilato lo sbigottimento fu immenso. Si pensò allo scherzo al punto che la pergamena fu detta apocrifa.”
Invece risalgono al III secolo le cosiddette tabulae patronatus: iscrizioni in bronzo, che parlano patronato della famiglia Sallii sulla città e menzionane il nome del primo acquedotto Aquae Arentani, ricordandone da il restauro datato 325 d.C., la sistemazione delle terme ad opera di C. Sallio Sofronio Pompeiano, della curia Septimiana Augustea (curia della città) e del teatro. La seconda iscrizione menziona l’altro acquedotto denominato aqua Augusta di età tiberina, e le terme costruite da un certo L. Iulius Pompilius Betulenus Apronianus vengono menzionate da una terza iscrizione (CIL IX 4196).
Nel 346-47 la città fu colpita da un terremoto, ma che probabilmente non causò danni poiché l’epicentro era abbastanza lontano dalla città, e nel corso del IV secolo fu devastata dalla guerra gotica. ‘inizio del declino risale al V secolo quando, ormai caduto l’Impero romano d’Occidente, gli abitanti della città dovettero rifugiarsi in luoghi più facilmente difendibili sulle alture: il centro abitato iniziò a spostarsi nell’attuale San Vittorino.Proprio in quegli anni il vescovo della città Quodvultdeus, di origini africane, ristrutturò e potenziò le catacombe realizzando un mausoleo paleocristiano. Nel
554 i territori di Amiternum, Aveia e Forcona furono sottoposti all’autorità civile e militare dell’esarca di Ravenna. Fu un periodo di privazioni e sofferenze per la popolazione amiternina che subiva un esasperato fiscalismo dai funzionari bizantini. Pochi anni dopo, tra il 571 ed il 574, i Longobardi arrivarono in queste terre.
Il clima di insicurezza dell’epoca si percepisce dal clima di ristrutturazione urbana finalizzate a realizzare un castrum, come suggeriscono delle abitazioni di legno nella zona del teatro.Le strutture pubbliche e molte abitazioni vennero smontate al fine di rinforzare le strutture difensive della città e abbondanti porzioni dell’abitato furono abbandonate. Negli anni 970-974 fu visitata dall’imperatore Ottone I accompagnato da Teodorico, vescovo di Metez, per raccogliere reliquie di santi: ai loro occhi si presentò uno spettacolo di desolazione e di distruzione dell’antica città.
Come distretto territoriale laico (per l’omonimo Contado) e religioso (come capitale di Diocesi) Amiterno è attestata dalle fonti sicuramente fino al 1069 (anno in cui il Vescovo Lodoico o Lodovico prende parte al Concilio Romano), ma venne successivamente unita alla diocesi di Rieti. Recenti scavi archeologici hanno però dimostrato come tra il 1100 e il 1200 inoltrato ci fu un periodo di relativa floridezza della cittadina, che fu abbandonata nel 1300 inoltrata sia come conseguenza dello sviluppo urbano de L’Aquila, sia per i distruttivi terremoti che la flagellarono nel 1293, 1298, 1315, 1328 e l’ultimo, più
distruttivo, del 1349.
Ma come era la città, nel suo momento di gloria ? Grazie ai rilievi magnetici del 2008, ne abbiamo finalmente un’idea di massima: il teatro si trovava nei limiti settentrionali del centro, che si sviluppa verso nord per altri 50 metri circa, mentre verso sud sono presenti edifici per almeno un chilometro. L’asse nord-sud era la Via Cecilia, bordata nella parte meridionale da piccoli abitazioni e botteghe di dimensioni ridotte. La Cecilia passava ad ovest dell’anfiteatro, dove è stata riportata alla luce una parte lastricata, e ad est del teatro, attraversando l’Aterno su un ponte i cui resti sono andati distrutti Dei
muri di contenimento delle acque fluviali sono ancora visibili e ciò fa pensare che il corso del fiume non sia cambiato.
La città aveva un piano ortogonale ed erano presenti molte strade perpendicolari all’asse principale nella parte meridionale. Ad est dell’anfiteatro, sulla Cecilia, era situato un tempio di 50×40 metri circa, a nord di questo un’ampia area termale e a sud un’area densamente edificata, probabilmente un mercato. A sud dell’anfiteatro erano presenti un altro piccolo tempio, dei giardini e un grande edificio domestico; subito a nord del fiume c’era probabilmente il Foro e nella sua parte occidentale era presente una basilica o un sacellum e subito a nord di queste un ampio complesso commerciale. A nord del
Foro, vicino al teatro, l’acquedotto entrava in città e a sud- est del teatro c’era una serie di grandi domus.
[image error]
Di tutto questo ben di Dio, quale sono le cose più importanti da vedere ? La prima è l’Anfiteatro, dichiarato monumento nazionale nel 1902, forse costruito nel I secolo d.C., che i staglia all’estremità meridionale della città, lontano dal Foro. La cavea, che si eleva sulla via Amiternina tra il colle San Marco e il fiume Aterno, ha diametri di 68 e 53 metri misurati rispettivamente sulle direttrici est-ovest (lato parallelo alla scena del teatro) e nord-sud. Le arcate sono 48 e reggevano le gradinate, oggi praticamente scomparse, originariamente disposte su due piani e rivestite in laterizio; si stima che la capienza complessiva fosse di 6.000 persone. Dell’anfiteatro è oggi ancora visibile l’intero corridoio esterno con il colonnato a mattoncini sagomati e la struttura della cavea con muratura a sacco e rivestimento in laterizio. L’ingresso all’arena avviene dall’entrata situata sull’asse maggiore est-ovest, detta Porta Triumphalis.
L’unica notizia sugli spettacoli che si svolgevano viene da un’iscrizione rinvenuta nei pressi dell’anfiteatro, che specifica spettacoli gladiatori offerti da Caius Sallius Proculus, con l’aiuto di suo padre. La struttura, che come è accennato è in opera a sacco con cortina laterizia, è di ottima fattura. La pietra da taglio riguarda solo il rivestimento del muro del podio, in lastre di calcare squadrate, alcune di reimpiego, nonché le soglie e gli stipiti dei vari ingressi all’arena, nonché le gradinate della cavea. Il monumento si presume sia stato rinnovato nel secolo successivo alla sua costruzione ed abbandonato
in seguito alla decadenza di Amiternum. La cavea è rimasta sempre in vista e ne è testimoniata la presenza negli archivi catastali ma l’intera struttura è tornata alla luce solo con gli scavi archeologici del 1880, mentre i lavori di consolidamento e restauro risalgono al 1996.
Nei suoi pressi, gli scavi hanno rivelato la presenza di un edificio tardo-romano a funzione pubblica, ricco di mosaici ed affreschi, che si sviluppava intorno ad una corte centrale, dotata di portico, da cui prendeva aria e luce. Le strutture relative all’edificio absidato documentano diverse fasi di costruzione che si concludono con un incendio: della fase del II sec. d.c. restano le pavimentazioni che offrono una variegata esemplificazione di mosaici geometrici in bianco e nero. Di questo edificio sono stati indagati tre importanti settori: l’atrium (ingresso), l’impluvium (il bacino per la raccolta dell’acqua piovana) ed il tablinium (il vano di rappresentanza).
Il ricco impluvium è realizzato con pregiato marmo di Porta Santa, cavato nell’isola greca di Chios e così detto perché di questo materiale sono fatti gli stipiti della Porta Santa in Vaticano. Su di esso sono visibili i segni di un terremoto del tempo di Costantino (306-337). Sulla pavimentazione a mosaico del tablinium spiccano i resti di una statua di marmo pario, databile al I secolo a.c., rappresentante un personaggio con una spada coperta da fodera e clamide (mantello corto) assicurata sulla spalla con una fibula.
[image error]
Sempre parlando di edifici dedicati agli spettacoli, è degno di ammirazione anche il teatro romano, risalente all’età augustea, come si evince dai rivestimenti delle murature realizzati con la tecnica edilizia dell’opera reticolata ancora oggi ben visibile. Era situato nella cosiddetta Ara di Saturno, a poca distanza dal Foro corrispondente al centro della città. La cavea, che si sviluppa sulle pendici del colle San Vittorino, ha un diametro massimo di 80 metri ed era originariamente strutturata su due livelli con precintio, vale a dire con corridoio intermedio semianulare che separava i due settori denominati ima e
media cavea, si stima che la capienza complessiva fosse di 2.000 persone. La parte inferiore, articolata in 18 file cui si accedeva da 3 scale radiali, è stata oggi parzialmente scoperta ed è in grado di ospitare circa 400 persone. Frontale alla cavea, e separata da essa da un canale in cui scorreva il sipario, sono i resti della scena di quasi 60 metri di lunghezza e strutturata su due diversi segmenti. Abbandonato dopo il IV secolo d.c. venne successivamente utilizzato come necropoli.



Più tarde sono la chiesa di San Michele e la catacomba di San Vittorino, dedicate al primo vescovo di Amiternum che fu martirizzato nel 96 d.C. presso Aquae Cutiliae, dove, secondo la leggenda, fu legato e lasciato sospeso a testa in giù su di una sorgente di acqua sulfurea morendo avvelenato tre giorni dopo.
Furono proprio gli abitanti di Amiternum ad edificare in suo onore un santuario la cui presenza, sotto il nome di ecclesia sancti Victorini, è attestata già dall’anno 763 in un documento dell’abbazia di Farfa. Tracce della chiesa di origine altomedievale sono visibili nei resti rinvenuti sotto l’abside e nella zona della cosiddetta chiesa vecchia posta a nord dell’attuale[3], databili tra l’VIII e il IX secolo, periodo in cui fu dedicata all’arcangelo Michele. Nel XII secolo il monumento venne ricostruito in stile romanico e nuovamente consacrato al martire san Vittorino il 24 luglio 1170, come si legge
nell’iscrizione posta nella parete destra della navata.
Mentre le catacombe furono fondate nel V secolo intorno alla tomba del santo, sviluppandosi come un’ampia galleria che si articola perpendicolarmente all’asse della chiesa e su cui si aprono tre vani collegati ad altre tre grotte. Subito dopo l’ingresso, vi è un ambiente rettangolare a volta a botte, rivestito con le tecniche dellʾopera reticolata o dellʾopera incerta, che ospita il presunto sepolcro di san Vittorino ricomposto con i restauri del 1940. Il monumento, datato al V secolo, è composto da lastre di marmo decorate scandite da quattro pilastri con sorretta un tabula che attribuisce il merito della
realizzazione del sepolcro al vescovo Quodvultdeu
IVBENTE DEO CRISTO NOSTRO SANCTO MARTYRI VICTORINO QVODVVL(t)DEVS EPIS(copus) DE SVO FECIT
Accanto a questi resti, si possono ammirare i resti delle terme e di un acquedotto dell’epoca augustea o tiberiana. Rintracciati anche i resti della strada principale, la via Caecilia, che da Roma, diramandosi dalla Salaria, raggiungeva l’Adriatico. Sulla via, forse, doveva affacciarsi anche un tempio, perchè se è rinvenuta la soglia monumentale. Sulla piazza principale di Amiternum è stata portata alla luce parte della basilica, nei pressi della quale è la curia. Sulla parete di fondo della basilica si sono riconosciute l’abside ed il podio di una statua, sono stati trovati il panneggio di un mantello, un’iscrizione ed
alcune modanature tra le quali una con rappresentazione di un’aquila.
[image error]
E tra le varie statue e iscrizioni ritrovate, spicca senza dubbio il cosiddetto Calendario Amiternino, la cui natura è specificata dal nome: il calendario riporta le maggiori ricorrenze religiose e pagane dell’epoca. Datato al 20 d.C., era inciso probabilmente su due tavole di marmo. Della prima resta un frammento dal 18 al 28 del mese di maggio e di giugno; della seconda tavola si conserva la registrazione dei primi venti giorni di ogni mese, da luglio a dicembre. Accanto ad ogni giorno sono riportate delle sigle che definiscono la qualità giuridica del giorno (i giorni in cui si poteva amministrare la giustizia, i giorni dei comizi, i giorni in cui alcune ore erano riservate agli dei, i giorni dedicati ai ludi per alcune divinità…). Queste annotazioni così precise, legate ai momenti più significativi della vita quotidiana, mostrano come il calendario fosse divenuto un mezzo potente di propaganda della Roma imperiale.
Immagini e filmati della festa del 10 novembre 2018 all’Acquario Romano
Alcune immagini e alcuni filmati della bella giornata passata sabato 10 novembre presso l’Acquario Romano – Casa dell’Architettura durante la quale le associazioni e i comitati del Rione Esquilino hanno incontrato residenti e cittadini nell’ambito dell’evento “L’Esquilino s’incontra all’Acquario” mostrando i contributi e le attività che svolgono nel territorio.
La festa
Alcuni filmati delle esibizioni della Banda dei Vigili Urbani di Roma Capitale e delle Danze di Piazza Vittorio
Le postazioni delle associazioni e dei comitati del Rione Esquilino all’interno dell’Acquario Romano
Alcuni degli interventi dei partecipanti
La presentazione dell’Associazione Abitanti via Giolitti Esquilino
Alessio Brugnoli's Blog




