Alessio Brugnoli's Blog, page 37
March 17, 2021
Il Bastione Ardeatino

Il cardinale Alessandro Farnese aveva sempre proposto al papa di turno di modernizzare le difese dell’Urbe, con la scusa di voler impedire a Carlo V, in qualche accesso d’ira, di replicare il sacco di Roma del 1527.
Questa era la motivazione ufficiale: la realtà, nota a tutta la Curia, era legata al suo essere smodatamente superstizioso e alla sua passione per l’astronomia, che mantenne anche dopo la sua elezione al soglio di Pietro, tanto che tra i suoi cortigiani vi erano uno sproposito di maghi e veggenti,che consultava di sovente per ogni piccola cosa, per esempio per decidere l’ora di una partenza o la data di un concistoro.
A quanto pare un astrologo, che per darsi un tono si spacciava di origine armene e che campava a sbafo dei Farnese dopo un’epocale sbronza gli aveva predetto che, se il Papa non avesse costruito le nuove mura cittadine, i turchi avrebbero messo a ferro e fuoco Roma.
Dato che la predizione sembrava campata in aria e poco credibile, che con Carlo V si era raggiunto un modus vivendi accettabile e che, per colpa a della Fabbrica di San Pietro, le finanze pontificie erano in perenne rosso, questa proposta era gentilmente respinta. Per cui, i romani anche nel caso che Alessandro fosse prima o poi eletto papa, davano per scontato che non se ne facesse mai nulla.
Le cose cambiarono per colpa di una donna bellissima, Giulia Gonzaga, contessa di Fondi, donna di grande bellezza, cultura e intelligenza, così descritta dall’Ariosto
Iulia Gonzaga, che dovunque il piede
volge, e dovunque i sereni occhi gira,
non pur ogni altra di beltà le cede,
ma, come scesa dal ciel dea, l’ammira
La sua fama era giunta Khayr al-Dīn, il Barbarossa, sì, il coprotagonista del fumetto Dago, signore di Tunisi, di Algeri e grand’ammiraglio della flotta turca, che per ottenere uno sconto sulle tasse da parte del sultano Solimano il Magnifico, aveva deciso di donargli come favorita dell’harem proprio la nostra Giulia.
Per far questo, dopo avere saccheggiato le coste della Calabria, nella notte tra l’8 e il 9 agosto 1534, conquistò la città di Fondi: Giulia però si salvò dal rapimento con una fuga avventurosa compiuta in abiti discinti a Campodimele. Per consolarsi, il Barbarossa saccheggiò la cittadina e la vicina Sperlonga, ma fu poi respinto dalla strenua resistenza degli abitanti di Itri.
Dato che Fondi tanto distante dall’Urbe non è, al romano medio cominciò a venire il dubbio che forse, l’astrologo dei Farnese, tutto questo torto non lo avesse. Per cui, appena eletto nel conclave del novembre 1534, Alessandro, che prese il nome di Paolo III, dichiarò subito l’intenzione di provvedere alla costruzione delle nuove mura di Roma affidando l’incarico ad Antonio di Sangallo il Giovane, che oltre a cercare di venire a capo a quel manicomio che era diventato il cantiere di San Pietro, era anche uno dei massimi architetti militari dell’epoca.
Antonio ci si mise di buona lena e presentò un progetto che prevedeva la demolizione delle mura Aureliane e la sostituzione con 18 bastioni alla moderna; il problema era però la cronica carenza di fondi dello Stato Pontificio. O si rinunciava alla costruzione di San Pietro, o alle nuove mura e Paolo III non era disposto a nessuno dei due sacrifici. Per cui, per prima cosa, cercò di appioppare i costi di costruzione dei bastioni al Comune di Roma, ma i Conservatori risposero picche appellandosi a una clausola in piccolo di una decreto dei tempi di Niccolò V.
Poi, decise a malincuore, di aumentare le tasse, con nuove gabelle su sale, farina e vino. Trovati i fondi, sorse però il problema di dove iniziare con la nuova costruzione. Visti i procedenti, era probabile che l’attacco turco, se mai si fosse verificato, sarebbe venuto da sud, per cui, si decise di costruire il nuovo bastione tra porta San Sebastiano e Porta San Paolo. Sangallo stimò un preventivo di 44.000 ducati per l’esecuzione dei e nel 1537 fece demolire 400 metri delle mura Aureliane,8 torri – dalla XIV alla XXII – e la porta Ardeatina vera e propria.
Subito, dopo cominciarono i lavori: Antonio aveva concepito un progetto d’avanguardia, un vero capolavoro dell’architettura militare dell’epoca. Il bastione era dotato di due fianchi arretrati, di batterie superiori e inferiori, cioè di due piani sovrapposti di artiglierie, di pozzi di controcava, di un pozzo per il rifornimento autonomo, di casamatte di fiancheggiamento alle quali si sparava con le armi leggere e che fungevano anche da ricovero per le munizioni. Otto camere ottagonali sotterranee, situate sotto le facce salienti del bastione, erano destinate ad eventuali azioni di contromina, grazie a cunicoli che permettevano di uscire all’esterno e di prendere gli assalitori alle spalle. Un imponente stemma di Paolo III, affiancato da quelli del Senato Romano e della Camera Apostolica, fu messo a coronare l’angolo del Bastione.
Tutto ciò fece però lievitare i costi: per di più, durante i lavori di realizzazione del nuovo Bastione, Paolo III affidò a Sangallo anche il rafforzamento difensivo della Città Leonina. Tale decisione fece sì che i lavori sulle Mura Aureliane rallentarono, fino ad essere completamente abbandonati intorno al 1539, per non essere mai più ripresi. Così si salvarono le antiche mura…
March 16, 2021
Atene contro Siracusa (Parte IX)

Ovviamente, a Siracusa, tutto lo spiegamento di forze ateniese non passò inosservato: per cui si riunì l’assemblea cittadina, sia per chiarirsi assieme le idee sulle intenzioni attiche, sia per decidere il da farsi. Paradossalmente, le posizioni dell’ecclesia siracusana, erano simmetriche e opposte a quelli presenti nel suo equivalente ateniese.
I popolari, che ad Atene erano rappresentati sia da Alcibiade, sia da una pletora di demagoghi, a Siracusa mantenevano una posizione più cauta, simile a quella di Nicia: ritenevano difficile che la polis greca si impegnasse in una guerra dall’esito incerto e lontana dai suoi obiettivi immediati. La dimostrazione di forza serviva soltanto a ottenere migliori condizioni a favore dei suoi alleati in un’eventuale trattativa.
I conservatori, invece, avevano una posizione simile ad Alcibiade, convinti come l’imperialismo fosse una necessità vitale per lo stato ateniese. Per cui, la polis attica, per mantenere la sua potenza, dovesse per forza avere mire sulla Sicilia.
Posizione che fu espressa da un politico che avrà un’importanza crescente negli eventi successivi, Ermocrate, il cui discorso è riportato, più o meno fedelmente, da Tucidide
Inverosimili forse, come già è toccato ad altri, potranno suonarvi le indicazioni che sto per rivelare sulla concreta e prossima minaccia di un’offensiva ateniese. Mi rendo conto: chi dà una notizia o riferisce un evento che non pare credibile, oltre a non convincere, si guadagna anche la reputazione di persona senza criterio. Ma non sarà questa paura a serrarmi la bocca: la patria corre pericolo, ed io sono convinto di avere notizie più fidate di chiunque da annunciare. Atene prende di mira proprio noi, e voi fate quell’aria stupita! Un’armata immensa, di navi e fanterie: formalmente per onorare l’alleanza con Segesta e restituire a quelli di Leontini la loro sede, ma il movente originale è la passione per la Sicilia, in particolare per la nostra città, poiché s’aspettano, se la riducono sotto di sé, d’aver via libera per nuove conquiste.
Badate che spunteranno in un lampo: disponete di mezzi, si provveda al loro migliore impiego, per respingerli con efficacia più energica. Non fate che per il vostro disprezzo il nemico vi sorprenda indifesi, o che l’incredulità v’induca a lasciar troppo correre. Se poi la verità si fa strada, non ispiri sgomento il loro passo temerario, con quella grandiosa macchina da guerra. Poiché ci infliggeranno qualche perdita, ma intanto si dovranno esporre a un’uguale tempesta di colpi; né la circostanza che ci assalgano con un poderoso apparato costituisce per noi un punto a sfavore, anzi ripensando alla lega con gli altri della Sicilia, questo particolare ci tornerà utile (l’improvviso turbamento farà più risoluti gli alleati a prestar man forte alla nostra reazione).
Con una profonda lucidità strategica, Ermocrate rassicurò la cittadinanza, probabilmente qualcuno nell’assemblea spaventato, proponeva la resa, evidenziando, proprio con l’esempio delle Guerre Persiane, il perché, l’ampiezza dello sforzo bellico nemico potesse essere la principale causa della sua possibile sconfitta: da una parte, un esercito così numeroso, rendendo esplicita l’ambizione di dominio ateniese, invece di dividere il fronte dei potenziali nemici, lo cementava. Dall’altra, come successe con Serse, avrebbe avuto difficoltà confrontarsi con il nemico più insidioso e tenace: la logistica e la necessità di sfamare tutte le truppe.
Poi sia che ci riesca d’eliminare fino all’ultimo uomo il nemico, o di rigettarlo in mare, umiliando tutte le sue ambizioni (nessuno, son sicuro, nessuno dei gloriosi programmi ateniesi coglierà nel segno) sarà la nostra vittoria più splendida, e dal profondo dell’anima mia la presento con fiduciosa certezza. Nella storia greca o del mondo barbaro è rarissimo il caso di un’offensiva numerosa che, giunta a gran distanza dai propri porti, abbia felicemente coronato la missione. Poiché gli aggressori non possono soverchiare in numero le genti del luogo e i loro confinanti (l’allarme è un efficacissimo cemento per i popoli). E se la loro potenza si spegne per la difficoltà di rifornirsi in territori ostili, essi lasciano ai paesi aggrediti un’eredità di gloria, anche se l’origine del disastro si deve addebitare principalmente ai loro stessi errori. Non fu proprio il caso degli Ateniesi il cui nome echeggiò celebre nel mondo quando l’offensiva dei Persiani, che aveva scelto a bersaglio pareva, precisamente Atene, crollò sotto quell’insperata catena di disfatte. Chi ci proibisce di sperare in un successo altrettanto lieto?
Ma nel concreto, come impedire che Atene possa imporre la sua supremazia tattica, trasformando una rapida campagna di conquista in una guerra d’attrito. Per prima cosa con un’iniziata diplomatica in grande stile, per creare un’ampia coalizione, che comprenda i Siculi, proprio per creare terra bruciata dinanzi al nemico, le altri polis siciliane e della Magna Grecia, altri possibili obiettivi ateniesi e le popolazioni italiche, fonte inesauribile di mercenari.
Poi, stupendo molti dei presenti, data l’antica rivalità con i punici, propose anche di ricercare l’alleanza con Cartagine. Da una parte, il politico siracusano era consapevole del principio
Il nemico del mio nemico è mio amico
e che probabilmente il successivo obiettivo dell’espansionismo ateniese, in caso di successo sarebbe stata la stessa metropoli africana. Dall’altra, sapeva bene come la politica punica in Sicilia non era orientata alla conquista delle polis greche, ma all’indirect rule e alla difesa dei suoi interessi commerciali: obiettivi che sarebbero stati probabilmente messi in crisi dall’imperialismo ateniese. Infine, nella campagna diplomatica si sarebbe dovuta coinvolgere anche la Lega Peloponnesiaca, in modo da scatenare la guerra in Grecia, danneggiando gli interessi più immediati degli ateniesi e costringendoli così alla smobilitazione, per difendere il cortile di casa
Peccato che Ermocrate avesse fatto i conti senza l’oste. Siculi e polis magnogreche temevano più un imperialismo vicino, quello siracusano, che uno lontano, per cui, per quanto possibile, si mantennero neutrali. I mercenari italici applicavano il motto
dove non c’è guadagno la remissione è certa
per cui corsero in massa ad arruolarsi sotto le bandiere di chi pagava di più, ossia gli ateniesi. Infine, Cartagine si mantenne alla finestra, neutrale, facendo un ragionamento assai cinico: nel caso di vittoria ateniese, la polis greca, per il principio della coperta troppo corta, avrebbe avuto difficoltà a combattere contemporaneamente contro le truppe puniche, gli spartani e persiani, per cui, nel caso i suoi opliti avessero cercato di marciare sull’Epicrazia, sarebbe stati ributtati in mare e la metropoli africana avrebbe imposto facilmente il suo dominio sulla Sicilia.
Lo stesso sarebbe avvenuto in caso di vittoria siracusana, dato che la polis siciliana sarebbe stata così indebolita da non poter contrastare una nuova offensiva cartaginese. Cosa che avvenne regolarmente ai tempi della guerra di Imilcone, scatenata proprio dalle ambizioni dello stesso Ermocrate
Infine, gli spartani, piuttosto che combattere in Grecia, preferirono mandare aiuti militari in Sicilia..
Animo dunque, e provvediamo alla difesa della città. Intanto si ricorra ai Siculi: con questi rinnoviamo più saldi legame d’intesa, con quelli si tentino le strade per un accordo di solidarietà e d’alleanza. Spediamo ambascerie in tutti gli altri centri della Sicilia, ammonendo che si corre tutti l’identico rischio, e verso l’Italia, con l’intento di farcela amica, o almeno ostile ad Atene. A mio giudizio sarebbe utile anche un appello ai Cartaginesi. Non li coglieremo impreparati vivono costantemente all’erta tesi al momento in cui Atene sferrerà l’attacco alla loro città. Sicché potrebbe accadere questo: nel dubbio, se lasceranno al destino il corso degli eventi quaggiù, che la rovina si ripercuota poi a loro danno, prevarrà il consiglio di fornirci, in segreto o a viso aperto, in un modo o nell’altro, qualche soccorso. Di questi tempi dispongono dei mezzi più cospicui del mondo per farlo, se acconsentono: possiedono riserve auree e d’argento illimitate, con cui si ha in pugno la sorte della guerra, e di qualunque altra operazione. Facciamoci vivi anche a Sparta, a Corinto, con la proposta di aiuti rapidi in Sicilia e di una ripresa intensa della lotta in Grecia.
In parallelo a questa offensiva diplomatica, Ermocrate proponeva una condotta di guerra audace, basata sul principio del
Chi mena per primo, mena due volte.
In pratica suggeriva di attaccare con un audace raid la flotta ateniese mentre traversava lo Ionio. Nel caso fosse andata bene, il nemico sarebbe stato distrutto. Nel caso lo scontro non fosse stato decisivo, la flotta siracusana si sarebbe rifuggiata a Taranto, dove, con’applicazione ante litteram della dottrina della fleet in being, avrebbe impedito lo sbarco ateniese sulle coste pugliesi.
Dato che il tempo avrebbe aumentato i costi di una spedizione bloccata a Corcira, gli ateniesi, dopo l’inverno, se ne sarebbero tornati al Pireo con la coda tra le gambe
E passo a illustrarvi un’iniziativa che personal mente ritengo del più sicuro effetto strategico, ma che per certo s’insabbierà, senza scuotervi, nella vostra inerzia ordinaria. Se noi tutti, gente di Sicilia, in massa o altrimenti prendendo con noi quanti più armati possibile posta in assetto fino all’ultima nave attualmente nei nostri arsenali, con riserve di vettovaglie per due mesi, ci risolvessimo ad avanzare incontro agli Ateniesi fino a Taranto e al promontorio Iapigio per ficcar loro in testa che prima di contenderci la Sicilia, dovranno sudar sangue per passare lo Ionio, sarà per loro un avvertimento terribile e li sforzeremo a riflettere che la nostra cintura di protezione ha salde basi su una sponda amica (Taranto di sicuro ci accoglie), mentre davanti a tutti i loro convogli e alla flotta s’apre una traversata immensa, al largo, durante la quale, prolungandosi la navigazione senza scalo, diventa penoso conservare l’ordine di combattimento. Per noi invece sarà un gioco trafiggere le unità isolate, mentre il grosso s’accosta lento lento, a brevi strappi. Poniamo il caso che si alleggeriscano e che ci si rovescino addosso con le unità veloci in formazione serrata: si faranno sotto a forza di remi, e quando piomberemo su di loro li coglieremo sfiniti.
Se poi la mossa non ci parrà conveniente, saremo sempre in tempo a ripiegare su Taranto, mentre il nemico, preso il largo con vettovaglie limitate, in vista di uno scontro diretto, dovrebbe trovarsi in pessime acque circondato da coste spopolate e ostili: quindi o si arresterà subendo il blocco o, nel tentativo di costeggiare, si vedrà costretto a rompere i contatti con il resto della spedizione, mentre il suo spirito di fiducia vacillerà nel sospetto che i centri costieri si rifiuteranno di aprire i propri porti. Sicché personalmente credo che frenati da queste logiche previsioni non leveranno nemmeno gli ormeggi da Corcira, ma dopo aver ponderato a lungo e a fondo, dopo essersi fatti una idea con accurate ricognizioni di che mezzi disponiamo e a che altezza siam giunti, ci si sarà spinti ormai nel mese invernale; o attoniti per la nostra sorprendente reazione lasceranno cadere ogni proposito offensivo, soprattutto poiché, a quanto affermano le mie fonti, il loro stratego di maggiore esperienza ha ricevuto contro voglia il comando, e sarà ben felice di prendere a volo il pretesto, se si noteranno sul nostro fronte movimenti difensivi degni di rispetto. So bene che li raggiungerebbero notizie esagerate sul nostro armamento: e i sentimenti degli uomini, e le loro opinioni si plasmano sul sentito dire. È un formidabile vantaggio assumere con piglio risoluto l’iniziativa o, in caso di aggressione lasciar intender chiaro che si è pronti a respingere chiunque: ci si crea il credito di gente pari al rischio. E sarà questa l’impressione da noi istillata agli Ateniesi.
Il loro assalto si fonda su una presunzione, che noi non prenderemo le nostre misure. Costoro hanno motivi validi per sottovalutarci, poiché non abbiamo fatto lega con Sparta per distruggerli. Ma se osservano in noi questo temperamento insospettabile, più della nostra reale potenza d’urto li sconcerterebbe la reazione imprevista. Datemi fiducia dunque: soprattutto realizzate con audacia il mio disegno. Altrimenti urge fornire al più presto ogni altro preparativo di guerra. E stia in ciascuno incrollabile la certezza che il senso di superiorità sugli aggressori si conferma nello slancio operoso di resistenza. In questi momenti la mossa che può riuscire più opportuna è l’azione regolata dal sentimento di una minacciosa presenza, nella consapevolezza che gli apparati difensivi più responsabili e franchi sono quelli accompagnati dalla tensione costante per un pericolo atteso. E l’offensiva nemica è già in moto, lo so bene, già a vele spiegate e solca le nostre acque.
Come spesso accadrà in futuro, Ermocrate, a differenza del suo allievo Dioniso, sottovalutava i mezzi necessari per realizzare nel concreto le sue grandi ambizioni. Qualcuno nell’assemblea gli fece notare come la flotta ateniese era senza dubbio, per qualità e quantità, superiore a quella siracusana, per cui un’improbabile battaglia navale nello Ionio, si sarebbe conclusa con una batosta dei siciliani. Dinanzi alla sconfitta siracusana, Taranto, anche a malincuore, si sarebbe schierata dalla parte del più forte, Atene, per evitare problemi. Nell’improbabile caso che ciò non fosse avvenisse, gli ateniesi avrebbe sicuramente ottenuto l’alleanza di Messapi e Lucani, sempre desiderosi di espandere i loro domini ai danni dei greci. Per cui, l’audace piano rischiava di fare vincere gli ateniesi ancor prima che sbarcassero sulle spiagge siciliane…
March 15, 2021
Le Idi di Marzo

Il buon Svetonio, il padre spirituale del mio Io,Druso racconta così tutti i prodigi, che secondo lui, annunciarono l’assassinio di Cesare, nelle Idi di Marzo, di cui oggi si celebra l’anniversario
Ma la morte imminente fu annunciata a Cesare da chiari prodigi. Pochi mesi prima, i coloni condotti a Capua, in virtù della legge Giulia, stavano demolendo antiche tombe per costruirvi sopra case di campagna. Lavoravano con tanto ardore che scoprirono, esplorando le tombe, una gran quantità di vasi di antica fattura e in un sepolcro trovarono una tavoletta di bronzo nella quale si diceva che vi era sepolto Capi, il fondatore di Capua. La tavola recava la scritta in lingua e caratteri greci, il cui senso era questo: «Quando saranno scoperte le ossa di Capi, un discendente di Iulo morrà per mano di consanguinei e ben presto sarà vendicato da terribili disastri dell’Italia.» Di questo episodio, perché qualcuno non lo consideri fantasioso o inventato, ha reso testimonianza Cornelio Balbo, intimo amico di Cesare. Negli ultimi giorni Cesare venne a sapere che le mandrie di cavalli che aveva consacrato, quando attraversò il Rubicone, al dio del fiume, e lasciava libere di correre, senza guardiano, si rifiutavano di nutrirsi e piangevano continuamente. Per di più, mentre faceva un sacrificio, l’aruspice Spurinna lo ammonì di «fare attenzione al pericolo che non si sarebbe protratto oltre le idi di marzo».
Il giorno prima delle idi un piccolo uccello, con un ramoscello di lauro nel becco, volava verso la curia di Pompeo, quando volatili di genere diverso, levatisi dal bosco vicino, lo raggiunsero e lo fecero a pezzi sul luogo stesso. Nella notte che precedette il giorno della morte, Cesare stesso sognò di volare al di sopra delle nubi e di stringere la mano di Giove; la moglie Calpurnia sognò invece che crollava la sommità della casa e che suo marito veniva ucciso tra le sue braccia; poi, d’un tratto, le porte della camera da letto si aprirono da sole. In seguito a questi presagi, ma anche per il cattivo stato della sua salute, rimase a lungo indeciso se restare in casa e differire gli affari che si era proposto di trattare davanti al Senato; alla fine, poiché Decimo Bruto lo esortava a non privare della sua presenza i senatori accorsi in gran numero che lo stavano aspettando da un po’, verso la quinta ora uscì. Camminando, prese dalle mani di uno che gli era venuto incontro un biglietto che denunciava il complotto, ma lo mise insieme con gli altri, come se volesse leggerlo più tardi. Dopo aver fatto quindi molti sacrifici, senza ottenere presagi favorevoli, entrò in curia, passando sopra ogni scrupolo religioso, e si prese gioco di Spurinna, accusandolo di dire il falso, perché le idi erano arrivate senza danno per lui. Spurinna, però, gli rispose che erano arrivate, ma non erano ancora passate.
Svetonio, da buon romano, molto più superstizioso di noi, sicuramente credeva alla veridicità di tali segni e ai modi strani con cui gli Dei e il Fato parlano a noi uomini. Per noi moderni, invece il suo racconto assume un significato ben differente. Qualcuno, più o meno vicino ai congiurati, fu spaventato dall’enormità del gesto e dalle sue potenziali conseguenze e cercò di fare la spia, provando al contempo a non tradire Bruto e Cassio. Ma Cesare, nonostante tutto, decise di andare incontro al suo Destino.
Mentre prendeva posto a sedere, i congiurati lo circondarono con il pretesto di rendergli onore e subito Cimbro Tillio, che si era assunto l’incarico di dare il segnale, gli si fece più vicino, come per chiedergli un favore. Cesare però si rifiutò di ascoltarlo e con un gesto gli fece capire di rimandare la cosa a un altro momento; allora Tillio gli afferrò la toga alle spalle e mentre Cesare gridava: “Ma questa è violenza bell’e buona!” uno dei due Casca lo ferì, colpendolo poco sotto la gola. Cesare, afferrato il braccio di Casca, lo colpì con lo stilo, poi tentò di buttarsi in avanti, ma fu fermato da un’altra ferita. Quando si accorse che lo aggredivano da tutte le parti con i pugnali nelle mani, si avvolse la toga attorno al capo e con la sinistra ne fece scivolare l’orlo fino alle ginocchia, per morire più decorosamente, con anche la parte inferiore del corpo coperta.
Così fu trafitto da ventitré pugnalate, con un solo gemito, emesso sussurrando dopo il primo colpo; secondo alcuni avrebbe gridato a Marco Bruto, che si precipitava contro di lui: “Anche tu, figlio?”. Rimase lì per un po’ di tempo, privo di vita, mentre tutti fuggivano, finché, caricato su una lettiga, con il braccio che pendeva fuori, fu portato a casa da tre schiavi.
Secondo quanto riferì il medico Antistio, di tante ferite nessuna fu mortale ad eccezione di quella che aveva ricevuto per seconda in pieno petto. I congiurati avrebbero voluto gettare il corpo dell’ucciso nel Tevere, confiscare i suoi beni e annullare tutti i suoi atti, ma rinunciarono al proposito per paura del console Marco Antonio e del comandante della cavalleria Lepido
Sul perché di questa scelta, da parte di Cesare, si interrogano da secoli decine di storici. Persino Svetonio, per una volta, smette di dedicarsi ai suoi amati pettegolezzi e improvvisa un’analisi psicologica
Ad alcuni suoi amici Cesare lasciò il sospetto che non volesse vivere più a lungo e che non si preoccupasse del declinare della sua salute. Per questo non si curò né di quello che annunciavano i prodigi né di ciò che gli riferivano gli amici. Alcuni credono che, facendo eccessivo affidamento nell’ultimo decreto del Senato e nel giuramento dei Senatori, abbia congedato le guardie spagnole che lo scortavano armate di gladio. Secondo altri, al contrario, preferiva cadere vittima una volta per sempre delle insidie che lo minacciavano da ogni parte, piuttosto che doversi guardare continuamente. Dicono che fosse solito ripetere che non tanto a lui, quanto allo Stato dovesse importare la sua salvezza; per quanto lo riguardava già da tempo aveva conseguito molta potenza e molta gloria; se gli fosse capitato qualcosa, la Repubblica non sarebbe certo stata tranquilla e in ben più tristi condizioni avrebbe subito un’altra guerra civile.
Su una cosa tutti furono d’accordo, che in un certo senso aveva incontrato la morte che aveva desiderato. Infatti una volta, avendo letto in Senofonte che Ciro, durante la sua ultima malattia, aveva dato alcune disposizioni per il suo funerale, manifestò la sua ripugnanza per un genere di morte così lento e se ne augurò uno rapido. Il giorno prima di morire, a cena da Marco Lepido, si venne a discutere sul genere di morte migliore ed egli disse di preferire quello improvviso e inaspettato.
Forse, Cesare doveva lottare contro il nemico più subdolo e difficile, il cupio dissolvi, la stanchezza di vivere, che dal timore di non potere compiere imprese più grandi di quelle già compiute e di doversi confrontare con una lunga e lenta decadenza, per ridursi all’ombra di se stessi. Non avendo il coraggio di combattere quest’ultima battaglia, lasciò campo libero ai congiurati. Per citare Cioran, aveva raggiunto i confini dell’inutilità.
Né Davide Del Popolo Riolo, con De Bello Alieno, né il sottoscritto, con Io,Druso abbiamo narrato la nostra versione peplumpunk delle Idi di Marzo, perché i nostri romanzi, vuoi o non vuoi, sono ambientati in un periodo differente… Però, in un brano del mio romanzo, i protagonisti ricordano il funerale del divo Giulio
“Claudio, pensa che un paio di volte ho avuto la fortuna di incrociare il biografo di Aullio, Giovanni di Tiberiade, uomo assai piacevole. Comunque, tanto per tornare al mio racconto, che voi due screanzati vi ostinate a ignorare, la sera del funerale di Cesare, trascinato dalla folla, mi ritrovai nel Foro, davanti al lussuoso ustrinum , eretto da Giulia, la sua amata figlia, vedova inconsolabile di Marco Licinio Crasso, dove incrociai un certo siriano, che si riempiva le tasche vendendo ai gonzi presunte pezze della toga dell’illustre defunto”.
Demetrio attaccò a ridere.
“Non facevo nulla di male! Offrivo, anche a prezzo alquanto abbordabile, ciò che più volevano, le illusioni. Poi, citando il grande Aristotele, maestro di coloro che sanno
Uno sciocco e il suo denaro son presto separati”.
Fu una delle rare volte, che vidi sorridere Cingetorige.
“Vecchio farabutto, provasti a truffare anche me”.
Demetrio gli fece il segno delle fiche.
“No, amico mio, ho solo saggiato la tua intelligenza. Mi sarei vergognato, di avere come compagno, qualcuno assai meno sagace del sottoscritto”.
Così il mio liberto siriano si prese un buffetto in testa dal suo degno compare. Dopo avere sorriso, Cingetorige riprese il suo racconto.
“Ce l’ho ancora davanti agli occhi, quell’ustrinum, di una ricchezza e di un lusso mai visti sino ad allora a Roma. Di fronte alle tribune, in cui si accalcavano senatori e membri dell’ordine equestre, vi era una replica in legno dorato del tempio di Venere Genitrice, che Cesare aveva fatto erigere con grande sfarzo, per celebrare le antiche origini della sua stirpe.
All’interno vi era un letto d’avorio, ricoperto con oro e porpora e con all’estremità un trofeo con la veste che indossava quando fu ucciso, il che dà la misura dell’intelligenza di Demetrio.
Tuo nonno Marco Aurelio, vestito per una volta in maniera dignitosa e Lucio Pinario Scarpo pronunciarono gli elogi funebri: il fatto che per una volta quei due, sempre pronti, con la testardaggine di un mulo, a piccarsi tra loro, non si misero a litigare fu un evento degno di nota, a perenne testimonianza della gravità del momento.
Terminati i loro discorsi, in cui si celebrava il ruolo fondamentale di Cesare nella nascita diffusione delle Res Novae e nell’epica vittoria contro i Tripodi, tutti e due presero le torce, dando fuoco all’enorme pira. Immediatamente la turba circostante accumulò rametti secchi, sgabelli e qualunque altra cosa adatta ad alimentare le fiamme; in seguito i flautisti e gli attori buttarono nelle fiamme le loro vesti, e le legioni dei soldati veterani, che avevano combattuto agli ordini di Pompeo contro i nemici provenienti da Marte, gettarono le armi con cui si erano adornati per la solennità del funerale. Nell’estremo lutto pubblico la moltitudine dei popoli stranieri a gruppi pianse lì intorno secondo il proprio costume, soprattutto gli ebrei, che addirittura per due continue notti frequentano il rogo, dato che il Machinarum Magister li aveva favoriti sopra ogni cosa.
Finita la cerimonia, tornai a casa, dove i miei padroni continuavano ancora a battibeccare”.
Inoltre, Davide, ha trattato proprio queste vicende, quando vinse il Premio Kipple, nel suo romanzo Non ci sono Dei oltre il Tempo…
March 14, 2021
La vittoria di Imilcone su Siracusa

L’obiettivo successivo dell’offensiva cartaginese era proprio Gela, dove Dioniso aveva messo le basi della sua ascesa al potere: Imilcone, dopo tutto quello che aveva patito ad Akragas e dato che aveva approfittato del periodo invernale per rimpinguare le salmerie, voleva evitare un lungo assedio della città, in modo da risparmiare tempo e risorse in vista dell’obiettivo principale della sua campagna, Siracusa.
Per cui, pose il campo presso il mare ad ovest della città, fortificandolo con una trincea ed una palizzata e diede ordine di saccheggiare le campagne, come strumento di pressione psicologica per i geloi. I quali, avevano inizialmente deciso di trasferire donne e bambini a Siracusa: secondo Diodoro Siculo, le donne insistettero per restare in città, ma probabilmente Dioniso, visti i precedenti problemi con i profughi di Akragas, si rifiutò di appoggiare tale ipotesi.
Alla fine fu deciso di non costringere nessuno a evacuare la città, ed i greci misero in atto una difesa attiva, attaccando i cartaginesi quando foraggiavano, in una sorta di guerriglia. Imilcone, che come dicevo, voleva chiudere la pratica Gela quanto prima, decise di prendere d’assalto la città prima dell’arrivo degli eventuali soccorsi siracusani.
Nonostante la resistenza di Gela, i cartaginesi riuscirono a portare arieti contro le mura occidentali e ad aprire alcune brecce. Tuttavia i difensori riuscirono a tenere a bada gli attaccanti nel corso del giorno ed a riparare le brecce di notte, l’aiuto delle donne nel riparare le brecce era inestimabile, quindi i cartaginesi ogni mattino dovevano ricominciare da capo, in una sorta di tela di Penelope.
Come racconta Diodoro Siculo
Mentre quanti per l’età aveano vigore e robustezza, stavano continuamente in armi, e combattevano l’inimico: tutto il resto della bisogna facendosi con grande zelo dalla moltitudine. E con tanto spirito e valore resistevasi all’impeto degli assedianti, che quantunque la città non fosse fortificata, e non s’avesse alcun ajuto degli alleati, ed anzi le mura fossero già in parecchi tratti aperte, il timore del pericolo presente non avviliva que’ prodi.
Questa resistenza disperata non aveva alternative, per il semplice motivo che Dioniso, impegnato a consolidare il suo potere a Siracusa, se la stava oggettivamente prendendo comoda: alla fine, riuscì a organizzare alle meno peggio un esercito formato da greci siciliani e mercenari italici, che contava almeno 30000 opliti, 4000 cavalieri e una flotta di 50 triremi, che con tutta calma, marciò su Gela. Nonostante queste tempistiche alquanto dilatate, l’azione ruppe le uove nel paniere a Imilcome, che non volendo essere preso tra l’incudine dei difensori di Gela e il martello dell’esercito siracusano, interruppe l’assalto e si dedicò a fortificare ulteriormente il suo campo.
I greci si accamparono alla foce del fiume Gela sulla riva occidentale di fronte alla città e dall’altro lato rispetto al campo cartaginese, abbastanza vicino al mare per poter dirigere sia le operazioni terrestri sia quelle navali: Dioniso, memore di quanto accaduto ad Akragas, decise di impegnarsi in una guerra di attrito e logoramento.
Per tre settimane tormentò i cartaginesi con le truppe leggere e tagliò loro i rifornimenti con la flotta: il problema però è che i forzieri e le dispense dei cartaginesi erano pieni, quelli dei greci no, per cui, alla lunga, ci avrebbero rimesso le truppe di Dioniso. In più, più tempo perdeva a Gela, più possibilità avrebbero avuto i suoi nemici a Siracusa di organizzarsi, per defenestrarlo.
Per cui, Dioniso decise di correre il rischio di una battaglia campale, con il problema che i cartaginesi, come numero, erano di gran lunga superiore ai greci. Per ovviare al problema, Dioniso ideò un contorto e ,come dire, genialode piano, che prevedeva un attacco su tre colonne contro l’accampamento cartaginese.
Questa scelta, alquanto bizzarra, derivava da un’osservazione di Dioniso, che si era accorto come cavalleria cartaginese era accampata sul lato verso terra, mentre i mercenari erano sul lato verso mare, con gli africani nella parte centrale entro il campo. Dionigi, osservando che una forza trasportata via mare poteva attaccare il campo da sud, pensò che tenendo occupate le truppe cartaginesi con un’azione diversiva, i mercenari, presi di sorpresa e travolti: in questo modo, il grosso dell’esercito di Imilcone sarebbe stato accerchiato e preso tra i due fuochi.
Così stabilì un piano che prevedeva come gruppo di poche migliaia di truppe leggere fosse sbarcato sulla spiaggia a sud del campo cartaginese al comando di suo fratello Leptine ed avrebbe attaccato l’estremità meridionale da ovest, impegnando le forze cartaginesi; altri 4000 opliti italici avrebbero marciato lungo la costa ed avrebbero attaccato da est la stessa parte del campo. Nello stesso momento, la cavalleria greca, appoggiata da 8000 opliti, avrebbe impegnato i cartaginesi nella parte settentrionale del campo.
Infine, a completare il quadro, Dionigi, con la riserva e gli opliti di Gela, avrebbe effettuato una sortita dalla porta occidentale della città ed avrebbe attaccato il campo una volta che i cartaginesi fossero stati fortemente impegnati ai fianchi.
Tutto questo complicato accrocco poteva funzionare solo se tutti i movimenti fossero stati sincronizzati al secondo, altrimenti i cartaginesi avrebbero potuto sconfiggere una per volta e senza troppa fatica, le singole colonne greche. Ovviamente, per la legge di Murphy, tutto quello che poteva andare storto, lo fece.
Così racconta il manicomio che si scatenò Diodoro Siculo
Mentre ognuno eseguisce questi ordini, i Cartaginesi accorrendo specialmente a quella parte nella quale verso il lido il loro campo non era fortificato, si fanno solleciti di difenderlo, e d’impedire lo sbarco al nemico. In quello stesso momento gl’Itali, avendo già scorso tutto lo spazio fra il mare, e l’accampamento de’ Peni, entrano in questo; e vi fanno man bassa, avendo trovato che la più parte della gente era ita a tener lontano le navi: ond’è, che volti in fuga quelli che doveano ivi far difesa, poterono entrare negli steccati. Presto però ritornarono a quella volta i Cartaginesi colla massima parte dell’esercito; ed a stento dopo lungo combattimento cacciarono quello squadrone, che era già passato oltre il fosso: e gl’Itali obbligati a dar luogo a tanta moltitudine de’ Barbari si ritrassero in una certa angusta estremità de’ trinceramenti, aspettando d’essere soccorsi dai loro. I Siculi, avendo avuto a fare una troppo lunga strada per la campagna, non potevano trovarsi presto a quel luogo; e i soldati mercenarj di Dionigi, dovendo perdere tempo nello scorrere pei vicoli della città, non potevano giungere solleciti quanto volevano. Que’ di Gela invero, come più vicini, erano usciti fuori per ajutare gl’Itali in quel luogo precipitoso, in cui s’eran posti; ma temendo, che intanto le mura venissero a mancare del debito presidio, sospesero la loro corsa a quella parte. Da ciò venne, che gl’Iberi, e i Campani, ausiliari de’ Cartaginesi, dando aspramente addosso ai Greci d’Italia, ne ammazzarono più di mille: perchè però quelli, che erano sulle navi colle saette e dardi li tenevan lontani, gli altri poterono ripararsi entro le mura della città. Da altra parte intanto i Siculi abbaruffati coi Peni, combatterono con tanto valore, che fecero d’essi non mediocre strage, e gli altri inseguirono sino agli accampamenti; ma come poi Iberi, Campani, e Cartaginesi si avanzarono a sostenere gli Africani, perduti mille de’ loro, si ritirarono in città anch’essi; e così fece la cavalleria, quando vide i suoi soccombere, massimamente che da ogni parte era investita dai nemici; e in città parimente si ritirò Dionigi, poichè seppe, che i suoi erano stati messi in fuga.
In pratica, le truppe trasportate via mare al comando di Leptine ottennero una sorpresa totale e con gli opliti che attaccavano lungo la costa irruppero nell’accampamento cartaginese. Mentre questo gruppo combatteva contro i sanniti e gli iberici, il gruppo settentrionale ritardò il suo arrivo e non riuscì a lanciare il suo attacco in tempo utile. Questo fatto diede ai cartaginesi il tempo di sconfiggere prima i greci che attaccavano da sud, dove Leptine perse 1000 uomini prima di ritirarsi e furono fermati dalle bordate di frecce scagliate dagli arcieri posti sulle navi greche, cosa che permise a Leptine di organizzare una ritirata dignitosa, evitando la rotta . Alcuni soldati gelani aiutarono i greci, ma la maggior parte rimase in città perché temevano di lasciare le mura indifese, visto il casino a cui stavano assistendo
Nel frattempo la colonna settentrionale aveva attaccato il campo, ed aveva respinto i punici, usciti per opporsi ad essi, entro il campo stesso. A questo punto Imilcone ordinò il contrattacco generale, mettendo in rotta la colonna settentrionale dell’attacco, con la perdita di altri 600 greci. La forza al comando di Dionigi rimase chiusa entro le vie strette della città e la popolazione, e non entrò neppure in azione. La cavalleria greca non fu impegnata ed i cartaginesi respinsero i greci entro la città. Al termine del combattimento Imilcone aveva vinto la battaglia, a costo però di gravi perdite.
Però, il morale dell’esercito greco era a terra: il cibo e il denaro cominciava a scarseggiare e Dionisio aveva scoperto che a Siracusa si stava organizzando un golpe ai suoi danni. Per cui, il generale greco, dopo avere ottenuto una tregua per seppellire i caduti, organizzò l’evacuazione generale di Gela.
A notte fonda scivolò via con tutto l’esercito e la popolazione, lasciando insepolti i morti. Un gruppo di 2000 uomini armati alla leggera rimase in indietro, per accendere grandi fuochi nel campo così da spingere i cartaginesi a credere che i greci erano ancora nel campo stesso. Di primo mattino anche queste truppe lasciarono Gela, ed il giorno successivo i cartaginesi entrarono e saccheggiarono la città pressoché deserta. Le spoglie saccheggiate a Gela comprendevano anche una famosa statua di Apollo, inviata a Tiro, come ex voto per la vittoria.
La carovana greca, a marce forzate, arrivò a Camarina: Dioniso, sia resosi conto che la polis era poco difendibile, sia perché le notizie di Siracusa fossero sempre più allarmanti, ordinò di evacuare anche questa polis. Sempre secondo Diodoro Siculo
Dionigi intanto giunto a Camarina, obbligò gli abitanti di quella città a trasferirsi colle donne e i figli a Siracusa; e perchè la paura non permetteva dilazione, parte d’essi insaccò l’argento e l’oro, ch’eran facili a trasportare; parte senza badare alla roba, non pensò che a fuggire co’ genitori e co’ figli di tenera età; e alcuni gravi per vecchiezza, o malattia, furono dai parenti e dagli amici abbandonati: parendo a tutti, che i Cartaginesi ad ogni momento fossero loro addosso. Perciocchè la ruina di Selinunte, d’ Imera, e d’Agrigento, avea gettato negli animi di tutti tanto spasimo, che ognuno nella immaginazione sua non vedeva più che l’atroce crudeltà di que’ Barbari, e il non perdonare a nissun prigioniero, il non sentir pietà di nessun infelice, il mettere in croce gli uni, il tormentar gli altri con insopportabili con tumelìe, ed ogni più misera calamità simile.
Imilcone, che stava tallonando l’esercito greco, giunse a Camarina il giorno successivo: dopo avere occupato la città senza colpo ferire e saccheggiata adeguatamente, stipulò un accordo con una alcune truppe sbandate di Dioniso, sia greche, sia sannite, e gli affidò il controllo della città.
Intanto la posizione di Dioniso era sempre più complicata: parte dei suoi soldati si lamentava del fatto che, nonostante le sue vanterie, non avesse ottenuto risultati migliori dei precedenti generali. In più, a torto, molti si sospettavano che fosse stato corrotto da Imilcone. Per cui, gli oligarchi siracusani decisero di tentare il tutto per tutto, per defenestrarlo.
Parte della cavalleria dell’esercito greco, che era d’accordo con i congiurati tornò di corsa a Siracusa e tentò di prendere il controllo della città. Il loro tentativo fu goffo, in quanto Dionisio, raggiungendo la polis, trovò le porte chiuse, ma non custodite. Per cui fu un gioco da ragazzi farvi infiltrare i suoi uomini, aprirle e irrompere a Siracusa, prendendo di sorpresa gli oppositori e uccidendone buona parte. Chi riuscì a salvarsi, fuggì nella città siceliota di Etna, quella rifondata da Gelone, e, con un voltafaccia, si alleò con i Cartaginesi.
I profughi di Gela e Camarina, visto il manicomio e prevendendo un prossimo assedio di Siracusa, presero armi e bagagli e raggiunsero i profughi di Akragas a Leontini. Furono facili profeti: dopo meno di una settimana, l’esercito punico, in pompa magna, si accampò fuori delle mura della polis, incominciando l’assedio.
Imilcone aveva tutti i vantaggi: viveri e denaro in abbondanza e un nemico demoralizzato e diviso: gli bastava attendere con pazienza e Siracusa sarebbe caduta ai suoi piedi, come un frutto maturo. Ma gli dei erano favorevoli a Dionisio. Nel campo cartaginese, si scatenò l’ennesima epidemia: memore di Akragas, Imilcone, il cui obiettivo stategico non era conquistare Siracusa, ma trasformarla in un junior partner e rafforzare l’indirect rule e il predominio commerciale cartaginese in Sicilia, decise di trattare con Dioniso, imponendogli un trattato umiliante
Ai cartaginesi andava il dominio, oltre che sugli antichi coloni, anche sugli Elimi e sui Sicani; alle popolazioni di Selinunte, Akragas, Himera, Gela e Camarina, era concesso di abitare nelle loro città ma senza cinta muraria, ed era imposto di pagare tributi a Cartagine; Leontinoi, Messàna e i Sicelioti restavano liberi con le loro leggi; Siracusa era sottoposta a Dionisio; le due parti si restituivano i prigionieri e le navi catturate
March 13, 2021
L’Osservatorio astronomico di Palermo

Quando parlai di Piazzi e della sua scoperta di Cerere, accennai all’esistenza dell’Osservatorio Astronomico di Palermo, posto a Palazzo dei Normanni, proprio alla sommità dell’antica Torre Pisana. Osservatorio che è ancora vivo e vegeto e che prosegue una straordinaria attività di ricerca scientifica: alla sede tradizionale, ha affiancato quella distaccata di via G.F. Ingrassia 31, a Sant’Erasmo,che ospita i laboratori, le officine e le macchine per il calcolo ad alte prestazioni.
L’origine dell’Osservatorio risale al 1789 quando Giuseppe Piazzi, deciso a fondare la nuova specola, si fece mettere in mezzo da Giuseppe Venanzio Marvuglia, il quale tra le tante stranezza, millantava anche di essere esperto di astronomia.
Per cui, il povero Piazzi, fu costretto a un faticoso tour per tutte le soffitte e i tetti di Palermo, finché, più per stanchezza, che per effettiva convinzione, si orientò alla vecchia torre del Palazzo dei Normanni. Stabilito che questa era la sede più opportuna per solidità ed elevazione, ma soprattutto per la possibilità che offriva di portare a termine i lavori in un tempo relativamente breve e risparmiando sui costi, i Borboni erano più prodighi di incoraggiamenti che di soldi, grazie all’appoggio del Viceré Principe di Caramanico, che autorizzò la nascita dell’osservatorio in data 1° luglio 1790.
Il vicerè non che fosse un grande appassionato di astronomia, ma si era reso conto come l’Osservatorio era necessario alla realizzazione del progetto di triangolazione della Sicilia, necessario per l’aggiornamento delle mappe catastali e per costringere la riottosa nobiltà locale a pagare le tasse.
Sia perchè Piazzi badava più al concreto che alle forme, sia per risparmiare tempo e denaro, la pianta del’Osservatorio era ridotta all’essenziale: comprendeva due sale, una per il Cerchio azimutale, che tanta fatica era costato, per farlo spostare da Londra ed una per lo Strumento dei Passaggi, collegate da una galleria per gli strumenti mobili. Unica concessione al lusso fu un piccolo tempio circolare in marmo che circonda il Cerchio di Ramsden eseguito su disegno di Venanzio Marvuglia e le vetrine in cui erano costoditi gli strumenti più piccolo, che furono disegnate dal grande architetto neoclassico Léon Dufourny. Ridendo e scherzando, a Palermo ci sono più sue opere, che a Parigi.
Grazie alla scoperta di Cerere, a Piazzi fu assegnato in premio una medaglia d’oro che egli rifiutò perché il premio fosse utilizzato per l’acquisto di altri strumenti, tra i quali un equatoriale di Troughton che collocò nella seconda cupola dell’osservatorio, ma che fu una mezza sola: non fu mai in condizioni di funzionare appropriatamente perché giunse a Palermo, nel 1804, gravemente danneggiato.
Quando nel 1817 Piazzi si trasferì a Napoli per completare la costruzione dell’osservatorio di Capodimonte, lasciò la direzione dell’Osservatorio di Palermo al suo braccio destro Niccolò Cacciatore, il che non è che fosse una cima come scienziato, anche se si tolse le sue soddisfazioni, scoprì un paio di stelle della Costellazione del Delfino, Sualocin e Rotanev, nient’altro che, a lettere invertite, la versione latinizzata del suo nome, Nicolaus Venator e l’ammasso globulare NGC 6541, ma che era un eccellente organizzatore.
Inoltre, a differenza di Piazzi, Niccolò aveva una straordinaria passione per la metereologia, tanto che fece costruire un sismoscopio ed un anemometro di sua invenzione, fece sistemare il pluviometro ed acquisto’ un igrometro di Daniell e regolarmente, pubblicava le previsioni sul tempo, che attaccava alle porte della Cattedrale… Il leggerle e il commentarle era uno dei passatempi preferiti del palermitano dell’epoca.
Alla sua morte, il 27 gennaio 1841, la direzione fu assunta per incarico dal figlio secondogenito Gaetano (1814-1889) che nel 1835, appena ventunenne, era stato nominato secondo assistente alla Specola e, nel 1839, primo assistente. Nel 1843 Gaetano Cacciatore ottenne la nomina definitiva alla direzione dell’Osservatorio. Gaetano era ancora meno cima del padre, però, in compenso, era un ottimo divulgatore, tanto da organizzare, cosa all’avanguardia per l’epoca, delle visite guidate per le scolaresche e per i curiosi dell’epoca e promosse la pubblicazione di un “Annuario astronomico”, che era leggibilissimo anche per i non addetti ai lavori.
Gaetano, però, era appassionato di politica e nel 1848, si schierò a favore dell’indipendenza siciliana: di conseguenza fu epurato e sostituito da Domenico Ragona, che era filoborbonico. Al di là delle sue idee politiche, che fecero allentare i cordoni della borsa al governo di Napoli, tanto da ordinare due nuovissimi ed eccellenti strumenti, un cerchio meridiano delle officine Pistor e Martins di Berlino da 13 cm di apertura in sostituzione dell’ormai obsoleto strumento dei passaggi di Ramsden, ed un telescopio equatoriale da 25 cm di apertura della ditta Merz di Monaco in sostituzione del famigerato equatoriale di Troughton, a differenza dei Cacciatore, Domenico era un eccellente scienziato.
La sua idea era di sfruttare la posizione geografica di Palermo per costituire, non appena messi in opera i nuovi strumenti, un ampio Catalogo di stelle australi non osservabili dagli osservatori del Nord Europa. Contemporaneamente egli si dedicò alla riorganizzazione ed implementazione delle osservazioni meteorologiche, che rimanevano il principale motivi per cui l’Osservatorio era noto al palermitano medio.
Con l’arrivo dei Mille nel 1860, tutti questi buoni propositi finiscono a ramengo: Domenico viene cacciato a pedate Gaetano Cacciatore venne quindi reintegrato, con decreto del 14 luglio 1860 a firma di Giuseppe Garibaldi, nella sua carica di Direttore dell’Osservatorio di Palermo. Il problema è che gli intellettuali siciliani dell’epoca, si erano resi conto della pochezza di Gaetano, che per di più, poverino, stava avendo gravi problemi alla vista: per cui, a cominciare dal grande arabista Michele Amari, provarono a convincere Schiaparelli, il tizio dei canali di Marte, a prendere la direzione dell’Osservatorio, senza però riuscirci.
A peggiorare il tutto, Domenico aveva fatto ricorso al Ministero dell’Istruzione contro la sua epurazione: il ministro Francesco de Sanctis, sì, il critico autore della Storia della Letteratura Italiana, risolse il tutto con compromesso. Domenico fu nominato direttore dell’osservatorio di Modena, al posto di Pietro Tacchini, che fu nominato direttore operativo dell’Osservatorio di Palermo, lasciando a Gaetano Cacciatore le incombenze amministrative e didattiche.
Il primo compito di Francesco fu montare e collocare l’equatoriale di Merz da 25 cm, ordinato da Ragona, che per le vicende degli anni precedenti, era stato abbandonato a se stesso. Grazie alle sua formazione da ingegnere, egli seppe abilmente dirigere i lavori per la sistemazione della stanza e della cupola del grande strumento. Seguendo le istruzioni dello stesso costruttore, egli riuscì quindi a mettere in funzione l’equatoriale, che fu inaugurato il 30 aprile del 1865 e che sancì l’inizio del nuovo corso dell’Osservatorio di Palermo
Lo strumento di Palermo era gemello dell’equatoriale utilizzato da p. Angelo Secchi al Collegio Romano per i suoi celebri studi di fisica solare. Tacchini pensò bene dunque di dedicarsi con esso allo studio del sole, osservando facole e macchie solari, ed intervenendo nel dibattito scientifico internazionale sulla natura e struttura della fotosfera solare e fondare quella disciplina che nei decenni successivi, avrà un’importanza sempre maggiore, la spettroscopia.
Dopo aver messo in funzione l’equatoriale di Merz, Tacchini si occupò di revisionare il cerchio meridiano di Pistor & Martins, col quale, tra il 1867 ed il 1869, determinò le coordinate di 1001 stelle australi. Tra le altre attività scientifiche del periodo vanno ricordati gli studi di Tacchini sulle Leonidi e le Perseidi, sulle osservazioni di aurore boreali ed il perfezionamento o la progettazione di alcuni strumenti secondari. Grande impulso ricevettero anche gli studi di meteorologia, con l’acquisto di numerosi strumenti, il più importante dei quali fu un meteorografo Secchi, uno dei più spettacolari e sofisticati strumenti per il rilevamento automatico dei parametri meteorologici mai costruito. L’attività in questo campo venne incentivata quando, con la costituzione dell’Ufficio Centrale di Meteorologia a Roma nel 1879, alla cui direzione fu chiamato Tacchini, si provvedette ad organizzare e coordinare una rete meteorologica nazionale, con la creazione di numerose stazioni, tra le quali, a Palermo nel 1880, quella di Valverde, sita nei locali della villa Ventimiglia in Corso Calatafimi, che costituì la sezione staccata per la meteorologia dell’Osservatorio di Palermo.
Il trasferimento a Roma di Pietro, però scatenò nell’Osservatorio una confusa lotta per la successione, complicata sia dal taglio dei fondi, sia dal fatto che l’Amministrazione della Real Casa, sempre in carenza di spazi per gli uffici amministrativi, aveva preso di mira l’ultimo piano della Torre Pisana. Per cui, stava brigando in ogni modo per sfrattare gli astronomi.
E tanto fece l’Amministrazione della Real Casa, che il Ministero della Pubblica Istruzione dovette istituire una Commissione tecnica per cercare di salvare capra e cavoli. La Commissione, istituita nel 1888 e presieduta dal senatore Emanuele Paternò, Rettore dell’Università di Palermo, stabilì che i locali dell’ Osservatorio non si potevano abbandonare, ma che contemporaneamente era opportuna la costruzione di una succursale dove collocare due nuovi strumenti e precisamente un cerchio meridiano da 20 cm di apertura ed un rifrattore equatoriale da 60 cm, strumenti da destinarsi entrambi all’astronomia di posizione. Il sito individuato per il nuovo Osservatorio era il monte Consono nei pressi di Bagheria, ed Ernesto Basile fu incaricato di redigerne il progetto. Ovviamente, si erano fatti i conti senza l’oste, mancando i fondi e non solo il progetto cadde nel dimenticatoio, ma ebbe anche l’effetto collaterale di congelare tutti gli investimenti nell’Osservatorio.
Nel 1889 alla morte di Gaetano Cacciatore la direzione dell’Osservatorio veniva affidata ad Annibale Riccò. Questi tuttavia ebbe appena il tempo di completare le formalità burocratiche relative alla consegna dei locali e della suppellettile strumentale e libraria e venne chiamato, meno di un anno dopo (1890) a ricoprire la prima cattedra di Astrofisica creata in Italia presso l’Università di Catania, ed a dirigere l’appena terminato Osservatorio di quella città, nonche’ la sede dell’Etna e il suo posto venne preso a Temistocle Zona, noto per avere scoperto una cometa.
A lui si deve, nel 1893, la creazione di una stazione astronomico-meteorologica (“vedetta meteorico-alpina”) al pizzo eremita, su Monte Cuccio, poco fuori Palermo, dove trovò condizioni di cielo più favorevoli per le sue osservazioni. Nella piccola stazione, Zona collocò la montatura equatoriale appositamente realizzata per il telescopio Merz già appartenuto al Principe di Lampedusa, insieme ad alcuni strumenti meteorologici. Tra il 1899 ed il 1903, tuttavia, dei fulmini colpirono per ben due volte la capanna, distruggendo gli strumenti meteorologici e danneggiando la montatura equatoriale. La stazione fu quindi abbandonata.
Però, proprio per la mancanza di fondi, nonostante gli sforzi erculei del successivo direttore, Filippo Angelitti, che quasi di tasca propria, acquistò un Cannocchiale Zenitale di Wanschaff da 8 cm di apertura, che fece installare al posto dell’antico Cerchio di Ramsden ormai assolutamente inservibile, un regolatore astronomico di Frodsham, un pendolo di Riefler e numerosi altri strumenti minori, l’Osservatorio entrò in una fase discendente, tanto che divenne una sorta di discarica per astronomi in disgrazia, che facevano carte false per darsela a gambe. Un vero peccato, perchè, mio nonno, il cui interesse per l’astronomia era prossimo a zero, che per caso era riuscito a visitarlo, ne fu affascinato.
I problemi si acuirono durante e dopo la seconda guerra mondiale, quando l’osservatorio fu vicino alla chiusura, privato di alcuni locali, dopo esser anche rimasto privo, nel 1939, dell’unico strumento di osservazione moderno di cui era dotato, il modello di telescopio zenitale sviluppato da Julius Wanschaff a Berlino. Nel 1952, per cercare di uscire dal tunnel, fu tentato un accordo internazione con l’osservatorio di Amburgo.
Nel corso dell’anno successivo (1953) altri tre Osservatori, e precisamente quelli di Bologna, Teramo e Catania si “aggregarono” al progetto “Palermo-Amburgo” nella speranza di potere anche loro risolvere i problemi, analoghi a quelli dell’Osservatorio di Palermo, in cui si dibattevano. L’accordo raggiunto dai quattro Osservatori italiani ed inviato all’ufficio del Piano ERP del Ministero della Pubblica Istruzione prevedeva che i singoli Osservatori rinunciassero alle loro precedenti richieste sui fondi appositamente stanziati (Piano MPA-203) per concentrare una ragguardevole somma nell’acquisto in comune di un unico strumento potente e moderno da collocare nella regione più favorita dalla natura, vale a dire la Sicilia. Lo strumento scelto era un riflettore Schmidt costruito dalla Askania-Werke uguale a quello in funzione presso l’Osservatorio di Bonn ed il cui costo era di 27,5 milioni. In sostanza la Regione Siciliana avrebbe dovuto stanziare i fondi, circa 30 milioni, per costruire la nuova stazione astronomica, il Ministero della Pubblica Istruzione avrebbe dovuto assegnare ai quattro Osservatori i fondi per l’acquisto di uno strumento e l’Osservatorio di Amburgo avrebbe dovuto provvedere agli altri telescopi.
Il progetto, tranne che per la scelta della località individuata nella zona tra Piana dei Greci, Misilmeri e Bagheria, era sensato ed andava nella direzione giusta, che è poi quella che si segue modernamente, di non distribuire somme a pioggia per l’acquisto di piccoli strumenti, ma di ottenere un unico grande strumento dividendo il tempo di osservazione fra gli Enti partecipanti alle spese. Non sappiamo quali siano stati gli intralci che lo fecero fallire. Di certo la Regione non stanziò mai i fondi richiesti limitandosi ad assegnare, sugli esercizi finanziari 53/54 e 54/55 un contributo annuo di 5.500.000 lire quale concorso nelle spese di riordinamento e di ricostruzione del patrimonio scientifico (librario e strumentale).
Con tali fondi furono sostituite le tre cupole della Specola sotto le quali giacevano gli storici strumenti che, in un estremo quanto inutile tentativo di riutilizzo furono sottoposti ad una radicale revisione da parte delle Officine Salvadori di Firenze, revisione che ebbe solo l’effetto disastroso di danneggiarne irreparabilmente alcune parti.
Cupole che però erano realizzate in ferro, troppo pesanti e pericolose per la struttura normanna. Per cui, anni dopo, furono sostituite con altre in rame, più leggere. C’è da aggiungere inoltre che fin dal 1953 l’Assemblea Regionale sottrasse all’Osservatorio gran parte dei locali che da sempre erano stati di sua pertinenza. Tali sottrazioni, in parte ampiamente giustificate da esigenze di restauro delle fabbriche normanne, ed in parte largamente arbitrarie, comportarono, fra l’altro, l’ammassarsi indiscriminato dell’ingente patrimonio librario e di strumenti che si era accumulato nel corso dei due secoli di vita.
Fortuna che a salvare il tutto, venne Giuseppe Salvatore Vaiana ( 1935-1991) che nel 1976 assunse la direzione dell’Osservatorio, che fece un lavoro straordinario, per rilanciare l’Osservatorio al livello internazionale.
Associato all’Osservatorio, vi è il cosiddetto Museo della Specola, che conserva tutti gli strumenti astronomici storici, compresi quelli del Principe di Lampedusa, compreso il telescopio prestato a Luchino Visconti per il set del celebre film Il Gattopardo. Tra le sale spicca quella della Meridiana, un piccolo gioiello di architettura in stile neogotico progettata e decorata da Giovanni Battisti Filippo Basile: qui è custodito un telescopio adoperato per osservare i passaggi degli astri alla massima altezza sull’orizzonte durante il loro passaggio in meridiano, attraverso una piccola fessura: questa stanza è rimasta quasi intatta, caratterizzata dal contrasto del legno con le pareti rosse. Un luogo intimo in cui è facile immaginare gli astronomi dell’epoca alle prese con le osservazioni astronomiche. Del resto in ognuna delle Cupole dell’Osservatorio si viene catapultati nel passato
Infine, nella sala del Rifrattore è presente il famigerato telescopio equatoriale Merz, risalente alla metà dell’Ottocento e di recente restauro, è celebre in quanto con esso Pietro Tacchini, tra i primi astronomi in Italia, eseguì importanti studi spettroscopici sul sole. A completare la collezione della galleria, ci pensano bellissimi ritratti di astronomi, alcuni dei quali eseguiti da Giuseppe Velasco ai primi dell’Ottocento.
Oltre al Museo della Specola, all’Osservatorio è associata anche la Biblioteca Storica, che trae origini dal lascito testamentario della biblioteca personale di Giuseppe Piazzi e comprende le pubblicazioni necessarie per svolgere le attività accademiche e di ricerca per l’Osservatorio, ma anche quelle che riguardano gli interessi personali di Piazzi, della sua formazione e cultura.
Il lascito di Piazzi è costituito da circa 400 opere, divise in 1650 volumi, dei secoli XVI-XIX: gli argomenti sono prevalentemente di carattere scientifico, spaziando tra periodici, atlanti stellari e mappe geografiche; sono presenti anche enciclopedie, classici latini, grammatiche, dizionari e opere a carattere religioso e filosofico.
Ora la biblioteca, in costante aggiornamento, possiede circa 10.000 monografie, 1.200 testate di periodici, 6.000 opuscoli ed è organizzata in due sezioni. La sezione storica, principalmente di supporto alle ricerche di storia dell’astronomia e della scienza in generale, comprende circa 1650 volumi antichi, monografie pubblicate sino agli anni ’50-’60 del XX secolo e oltre mille periodici. A questa sezione afferisce anche l’archivio storico. La sezione moderna, di supporto alle attuali attività di ricerca astrofisica, comprende oltre 6000 monografie e periodici correnti e gestisce anche le pubblicazioni in formato elettronico.
March 12, 2021
L’urbanistica di Cuma

L’urbanistica dell’antica città di Cuma, vuoi o non vuoi, è stata fortemente condizionata dalla peculiare orografia dei suo territorio, frutto dell’attività vulcanica dei Campi Flegrei: di conseguenza, la polis fu ripartita in due zone, l’acropoli e la città bassa, disposta lungo la linea di costa.
L’acropoli sorgeva su quello che viene oggi definito come monte di Cuma, ossia un antico cratere, alto circa ottanta metri, dotato di pareti scoscese in tufo e quindi praticamente inattaccabile, accessibile solo dal lato meridionale; fu su questa zona che si sviluppò il primo nucleo della città, attraversato da una strada, chiamata Via Sacra, che conduceva ai principali templi, fino a raggiungere la sommità del monte: la strada aveva inizio con due torri, di cui una crollata insieme a parte del costone della collina e l’altra restaurata in epoca bizantina e di cui sono visibili i ruderi
La parte bassa invece si sviluppò a partire dall’epoca sannitica ed in maggior misura durante l’età romana, nella zona circostante l’acropoli e si estendeva dal monte Grillo alla costa: era caratterizzata da tipici edifici romani, come il Foro e le Terme.
Sul versante nord dell’Acropoli si conservano alcuni tratti delle poderose mura che cingevano la città e la monumentale Porta Mediana. La parte più antica delle mura risalirebbe alla fine del VII sec. a.C., ma se ne conserva una porzione esigua non perfettamente leggibile, mentre in seguito nella prima metà del VI sec. a.C. le mura sono meglio conservate e costituite da una doppia cortina edificata in grossi blocchi di tufo squadrati riempita di terreno e scaglie di tufo, della larghezza totale di circa 5 metri. Le mura più antiche subiscono ristrutturazioni alla fine del VI sec. a.C. e nel V secolo a.C. vengono costruite due “ali” in corrispondenza dell’apertura della porta, che monumentalizzano il varco.
Sotto le mura passava una grandissima fogna per lo smaltimento delle acque e questo ci fa capire che la città anche nelle sue fasi di vita più antiche aveva già una strutturazione molto complessa con grandi opere, come le fognature e le mura fortificate, insomma una città molto ricca e potente. Appena fuori dalle mura è stato ritrovato un deposito in cui era deposta una gran quantità di ossa di cavalli, che presentavano ferite provocate da frecce e spade. Si tratta dunque di una fossa dove probabilmente furono seppelliti i cavalli morti durante una grande battaglia e forse una delle grandi battaglie avvenute in quel periodo a Cuma, quella del 524 a.C. contro gli Etruschi, nella quale si distinse il giovanissimo Aristodemo, futuro tiranno della città.
Nel III sec. a.C. la cortina è oggetto di un poderoso potenziamento: viene costruita una ulteriore cortina che si aggiunge a nord di quella esistente insieme ad un rafforzamento fatto di setti murari in blocchi di tufo posizionati perpendicolarmente alle due grandi cortine, e il tutto riempito con terreno e scaglie di tufo. Nel II sec. a.C. con l’ingresso nell’egida romana viene meno l’esigenza di fortificare e difendere militarmente la città: così alle mura si addossano le gradinate di uno stadio.
Le mura e la Porta Mediana continuano a vivere fino al VI sec. d.C., svolgendo un ruolo fondamentale durante l’assedio bizantino, con continui rialzamenti del piano pavimentale e ristrutturazioni, dovuti probabilmente alle alluvioni che dal III sec. d.C. in poi si verificano nella piana della città bassa.
L’ingresso monumentale della città era l’Arco Felice, costruito nel 95 d.C. per consentire il passaggio della via Domitiana attraverso il monte Grillo. Ai ipotizza che per la sua edificazione sia stato necessario ampliare il taglio nel monte che, forse, già esisteva in epoca greca: il monumento veniva, così, ad acquisire sia la funzione di contenimento per eventuali frane e smottamenti del terreno sia di viadotto per il collegamento fra le due parti della cresta del monte Grillo.
L’arco venne progettato per essere contemporaneamente porta urbana ed arco trionfale, oltre che parte del sistema difensivo; alto circa 20 metri, si presenta, ancora oggi, a fornice unico sormontato da un altro arco a tutto sesto e sostenuto da due pilastri laterali con nicchie, le quali dovevano presumibilmente ospitare delle statue.
Grazie ad incisioni del XVII e XVIII secolo è possibile sapere qual’era l’aspetto originario: sormontato, all’origine, da un attico con la targa per ospitare l’iscrizione e nicchie ai lati in corrispondenza delle sottostanti. Inoltre due torrette a pianta quadrangolare sormontavano lo stesso attico e l’intero arco era rivestito con marmi e stucchi. La facciata ovest è oggi quella meglio conservata e dell’originaria struttura romana sono oggi visibili solo l’intradosso e parte della facciata occidentale.

La particolare orografia della zona costrinse gli architetti del tempo a realizzare numerose opere ingegneristiche, per lo più gallerie, in modo tale da collegare le diverse zone della città: oltre alla Grotta, Cocceio probabilmente realizzò anche la cosiddetta Crypta Romana, una galleria scavata interamente nel tufo che attraversa la collina dell’acropoli e collega il Foro della città antica con il mare. Viene realizzata ad opera di Agrippa, generale di Ottaviano Augusto durante la guerra civile (44-31 a.C.) a scopo difensivo; fa parte infatti di un sistema di gallerie che dal litorale cumano conducevano fino al porto di Augusto (Portus Iulius) nel bacino del Lucrino.
Con la pax augustea la Crypta cessa la sua funzione militare per diventare semplice collegamento tra l’area portuale e il cuore della città, e più tardi in età domizianea viene arricchita con un ingresso monumentale in opera reticolata con nicchie, dove dovevano trovare posto delle statue oggi perdute. In età tardo-antica la galleria diventa in alcuni tratti luogo di sepoltura e nella parte centrale, quella corrispondente alle cisterne, diventa luogo di culto con l’edificazione di una piccola basilica rupestre, della quale restano poche tracce: resti di una scaletta ricavata sulla parete meridionale, i simboli cristiani della corona e della spiga graffiti sulla sommità della volta e una croce apicata sulla parete nord.
La galleria non segue un percorso rettilineo, perché intercetta alcune strutture preesistenti, la cosiddetta Cava Greca e le grandi cisterne situate al centro del percorso sotterraneo, che vengono inglobate per garantire una riserva d’acqua al servizio della galleria stessa.
Il primo tratto, costituito da un corridoio d’ingresso originariamente lungo circa m. 30 (come si può desumere da un piedritto ancora in sito appartenente all’arco occidentale), è coperto da una volta a botte, su cui sono ancora visibili le tracce dell’armatura lignea usata per la messa in opera. Le pareti, di roccia tufacea, presentano un paramento in opera reticolata con ammorsature in tufelli. La ghiera del fornice orientale, a blocchetti di tufo, è sormontata da due file di cubilia.
Superato questo corridoio si accede a un grande vestibolo a pianta rettangolare (lung. m. 26 ca.), il cui pavimento originario doveva essere ad un livello più alto dell’attuale. La parete a sinistra, in opera vittata, presenta quattro grandi nicchie in opera reticolata, destinate a ospitare statue, ma anche funzionali a scaricare il peso della muratura; la parete di destra reca tracce di numerosi restauri. La volta si impostava a una quota superiore rispetto a quella dell’ingresso. In prossimità dell’ingresso, sulla volta tufacea, furono scolpiti gli strumenti utilizzati dagli scavatori: piccone, maglio, bipenne e cunei. Da qui il percorso si snoda sotto il Monte di Cuma, piegando poi a gomito verso la città bassa.
L’illuminazione della galleria era assicurata da una serie di pozzi aperti nella volta. Nell’ultimo tratto sulla destra, furono ricavate due grosse cisterne con gradinate per la decantazione dell’acqua: i paramenti, in opera reticolata, sono rivestiti da uno spesso strato di cocciopesto per tre metri di altezza; successivamente due tagli praticati nelle gradinate le misero in comunicazione con la galleria.
Nel V sec. d.C., quando la città bassa fu abbandonata sulla spinta delle pressioni barbariche, la crypta perse la sua funzione di collegamento. Successivamente, durante la guerra greco-gotica (VI sec. d.C.), il generale Narsete, per espugnare la città, fece scavare una serie di cunicoli nella volta, provocandone il crollo, allo scopo di far franare la soprastante torre posta a guardia dell’ingresso dell’acropoli.. Da allora la Crypta andò progressivamente a interrarsi.
Non si conoscono notizie certa sulla posizione del porto di Cuma; alcuni hanno ipotizzato che un primitivo porto, quello greco, fosse posizionato in una insenatura ai piedi dell’acropoli, la quale a quel tempo si affacciava direttamente sul mare: tale ipotesi è confermata dal ritrovamento in zona di numerose ceramiche greche. È inoltre possibile che in tale periodo la città avesse due porti, probabilmente all’interno del lago di Licola, ora prosciugato, in quanto Dionigi di Alicarnasso afferma che Aristodemo sostò con la sua flotta nei porti di Cuma. A seguito della conquista sannita nel 421 a.C. il porto conobbe un periodo di decadenza, tanto che con l’arrivo dei Romani, Marco Vipsanio Agrippa ne dovette costruire uno nuovo, collegato tramite un canale al lago Fusaro, il quale disponeva anche di una chiusa, utilizzata per le operazioni di dissabbiamento: nei pressi dell’uscita della Crypta sono state rinvenuti banchine, un bacino di carenaggio, un blocco in tufo in opera reticolata, alto circa otto metri ed un lungo muro con degli speroni, probabilmente un faro, anche se non è stato possibile fare ulteriori indagini a causa dello sfruttamento agricolo della zona. Il porto di Cuma venne sicuramente abbandonato a seguito della concorrenza dei porti di Miseno e Pozzuoli, nel periodo dopo le guerre civili.
Il quartiere a nord delle terme del Foro fin dalla fondazione della città greca ha assunto una funzione residenziale e conserva assi stradali perpendicolari, i cui tracciati non si modificano nel tempo, ma restano sempre gli stessi e continuano ad essere ristrutturati ed utilizzati a partire almeno dal VI sec. a.C. fino al III d.C. Qui allora è possibile comprendere come cambiano le tecniche costruttive e le tipologie di abitazione nel corso dei secoli, seguendo un’ideale linea del tempo che va dalla fondazione della città greca alla piena età romana.
Le case di VIII e VII sec. a.C. sono costruite in blocchetti di tufo non squadrati e un impasto di argilla cruda e paglia molto resistente; hanno uno o più vani e ampi spazi esterni utilizzati anche per attività produttive. In seguito dal VI al III secolo a.C. si diffonde l’uso di costruire in grossi blocchi di tufo ben squadrati e le case, della tipologia a corte, cominciano a disporsi una vicino all’altra formando un quartiere segnato dagli assi stradali. Con i Romani, a partire dal II sec. a.C. si costruisce in muratura e il quartiere residenziale si riempie di case e botteghe per la vendita, fino a quando nel II sec. d.C. tutte le abitazioni che presumibilmente appartenevano a nuclei separati vengono unite da un solo proprietario che trasforma il quartiere in un’unica grande domus che ingloba parte dell’asse stradale orientale e occupa tutto l’isolato. Questa ha la tipica struttura della domus urbana con atrio centrale colonnato e gli ambienti che vi si dispongono intorno.
March 11, 2021
La coppa di Nestore

Come accennato in un altro post, il primo stanziamento storicamente noto dei coloni greci in Italia è nell’isola di Ischia. Paradossalmente, benché ne parlassero Strabone
Pithekoussai fu un tempo abitata da Eretriesi e anche da Calcidesi i quali, pur avendo ivi prosperato grazie alla feracità del suolo e alla lavorazione dell’oro, abbandonarono l’isola in seguito ad una disputa; più tardi essi furono spinti fuori dell’isola da terremoti ed eruzioni di fuoco, mare e acque bollenti … E anche Timeo dice che gli antichi raccontano molte cose meravigliose a proposito di Pithekoussai, e che solo poco prima del suo tempo, l’altura chiamata Epopeus (l’attuale Monte Epomeo), al centro dell’isola, scossa da terremoti, emise fuoco e respinse la parte tra sé e il mare nel mare aperto; e la parte di terra che era stata ridotta in cenere, dopo essere stata sollevata alta nel cielo, piombò giù di nuovo sull’isola come un turbine; e il mare si ritrasse per tre stadi, ma non molto dopo essersi ritirato, tornò indietro e con la corrente di ritorno allagò l’isola; e di conseguenza il fuoco sull’isola fu estinto, ma il frastuono fu tale che la gente sulla terraferma fuggì dalle coste entro la Campania. Le sorgenti dell’isola hanno fama di curare chi soffre di calcoli
e Tito Livio
La città di Palaepolis era non lontana dall’attuale sito di Neapolis. Entrambi i luoghi erano abitati dalla stessa gente, che era venuta originariamente da Cuma, mentre i Cumani fanno risalire la loro origine da Calcide in Eubea. Grazie alla flotta che li aveva portati dalla loro città natia, essi esercitarono notevole influenza lungo la costa del mare sulla quale vivevano, essendo prima sbarcati sulle isole di Aenaria e Pithekoussai, ed essendosi poi avventurati a trasferire la loro base sulla terraferma.
gli studiosi per secoli erano molto scettici su tale testimonianza. Le cose cambiarono quando, nel 1949, il poco più che trentenne archeologo tedesco Giorgio Buchner (1914 – 2005), già profondo conoscitore dell’isola (i genitori si erano stabiliti definitivamente a Ischia, in località Sant’Alessandro, nel 1943) ottenne la delega della soprintendenza per iniziare gli scavi in località San Montano, nel comune di Lacco Ameno.
Buchner, infatti, trovò le prove concrete della colonizzazione ai tempi della Grecia a Pithecusa, letteralmente l’isola delle scimmie. Il perché di questo strano nome, già nell’Antichità aveva scatenato una ridda di ipotesi: l’erudito alessandrino Xenagora (intorno al 90 a.C.) faceva derivare Pithekoussai da pithekos, in greco “scimmia” e metteva in relazione tale derivazione con la leggenda della presenza a Ischia di Ercole e di quelle simpatiche canaglie dei Cercopi e della loro metamorfosi.
Ipotesi che stranamente, negli ultimi anni sta ritornando in voga, grazie a un frammento di un cratere di fabbricazione locale risalente al Geometrico Recente, famoso per l’ con la iscrizione retrograda dipinta “… inos m’epoiese” (” … inos mi fece”), che è la più antica firma di vasaio che sia mai stata trovata nel mondo greco. Nella decorazione appare una figura, che era stata interpretata come una sfinge o un’arpia: di recente, invece sta andando di voga la sua rilettura, come la rappresentazione di una bertuccia.
Per cui, con un volo di fantasia, ha fatto immaginare ad alcuni come in epoca protostorica esistesse a Ischia una colonia di queste scimmiette, analoga a quella di Gibilterra e che questa colpisse la fantasia dei primi esploratori greci. Il problema è che resti ossei di questa presunta colonia, non sono mai stati ritrovati…
La seconda ipotesi, la formulò Plinio il Vecchio, in un suo momento di lucidità intellettuale: sostenne come il nome dell’isola non avesse nulla a che vedere con le bertucce (non a simiarum multitudine), ma derivasse invece dai dolii (a figlinis doliorum), in greco pithoi, in relazione sia alla produzione ceramica locale, sia all’esportazione di vino e olio prodotti da Ischia… I resti archeologici sembrerebbero propendere verso tale direzione. Infine c’è sempre l’ipotesi del falso somigliante, ossia che i greci si siano limitati a un calco fonetico del nome che i locali davano all’isola.
L’archeologia, arricchendo le scoperte di Giorgio Buchner, ci sta dando un’idea abbastanza precisa della storia arcaica di Ischia. Per prima cosa, la presenza sia di ceramica della cultura appenninica, sia micenea, ha reso evidente come l’isola fosse integrata nella rete commerciale che aveva come fulcro l’emporio di Vivara: probabilmente, nella tarda età del bronzo, l’economia locale era incentrata sulla produzione e l’esportazione del vino.
Poi, abbiamo potuto datare, grazie ai ritrovamenti di Punta Chiarito, ad anticipare la prima colonizzazione greca poco prima dell’800 a.C. Questa non era orientata alla creazione di una polis, ma al popolamento diffuso, data la presenza di fattorie indipendenti, che in qualche modo, si integravano con l’economia delle popolazioni locali. A queste, doveva essere associato un emporium, per favorire l’esportazione dei prodotti agricoli e il commercio con l’Etruria. Ad esempio, a Pithecusa si lavorava anche il ferro, come dimostrato dal rinvenimento di uno scarto di fibula e scorie, probabilmente provenienti dall’Isola d’Elba e dalle colline metallifere della Toscana, attestate in località Mazzola
Emporium che doveva essere nei pressi diLacco Ameno e che doveva essere multietnico: oltre agli etruschi, vi era una forte presenza di commercianti fenici, che non solo monopolizzavano i commerci con la Siria e l’Egitto, ma avevano avviato la produzione di ceramica di imitazione orientale, che veniva rivenduta nel Sud Italia e nel Latium Vetus.
A riprova di questa presenza, è un’anfora da trasporto importata, di una fabbrica greca non ancora individuata con precisione in una tomba del Tardo Geometrico I, che reca incisi diversi graffiti. Questi si riferiscono in parte all’uso dell’anfora come contenitore commerciale: in lettere fenicie vi è scritta la parola Kpln, che significa “il doppio”, mentre su una delle anse si trovano dei segni numerali che sono stati interpretati come la cifra “200”. Queste indicazioni sulla capacità del contenitore devono, con tutta probabilità, essere state incise dal mittente, e fanno presupporre che il destinatario pitecusano fosse in grado di comprenderle. All’utilizzazione della stessa anfora quale tomba di neonato fa invece riferimento un segno triangolare, identificabile con un plurivalente simbolo religioso semitico, ben noto in cimiteri fenici e punici. E’ quindi evidente che almeno uno dei genitori dell’infante seppellito nell’anfora era di origine orientale.
Commerci che aumentarono notevolmente la prosperità dell’isola, come testimoniato dalla cosiddetta Coppa di Nestore, una delle più antiche testimonianze della lingua greca. La coppa è una kotyle, ossia una tazza piccola, larga non più di 10 cm, di uso quotidiano, decorata a motivi geometrici. Fu importata nella colonia greca di Pithekoussai, l’odierna Ischia, da Rodi, secondo alcuni insieme a una partita di vasi contenenti preziosi unguenti orientali, che tra il 720 e il 710, insieme con altri 26 vasi, tra cui 4 crateri, fu gettata sul rogo di un ragazzo di 10-14 anni, per poi accompagnarlo nella tomba, che fu portata alla luce nel 1955 dagli archeologi Giorgio Buchner e Carlo Ferdinando Russo.
La coppa è un reperto straordinario perchè reca inciso su di un lato in alfabeto euboico in direzione retrograda, ossia da destra verso sinistra, come nella consuetudine fenicia, un epigramma formato da tre versi, il primo con metro giambico e il secondo e terzo perfetti esametri dattilici, che allude alla famosa coppa descritta nell’Iliade di Omero, tanto grande che occorrevano quattro persone per spostarla:
Poesia che cosi dice
Io sono la bella coppa di Nestore,
chi berrà da questa coppa
subito lo prenderà il desiderio di Afrodite dalla bella corona
Se l’alfabeto greco nasce intorno al 770 a.C. come adattamento di quello fenicio, mediata dalla presenza di comunità di commercianti e artigiani immigrati, presenti non solo a Ischia, a Cipro, a Rodi, ma anche nell’Eubea e nella Grecia continentale, sin da subito un utilizzo ben più ampio di quello contabile della Lineare B.
Inoltre, in quella che al greco medio dell’epoca doveva apparire come l’estremo confine del mondo conosciuto, c’era un ricco commerciante o agricoltore che conosceva l’esistenza di Nestore e che aveva forse ascoltato un aedo recitare il corpus di canti che secondo la tradizione erano stati raccolti e formalizzati una generazione prima, intorno al 760 a.C. e che al contempo, sapesse leggere, scrivere e avesse un’idea chiara della metrica dell’epoca e che in un’epoca cosi arcaica, si dedicassero al Simposio.
E me lo immagino, tra le case di Pithecusa, banchettare brindando e spettegolando, improvvisando canti e poesie e non disdegnavano nemmeno di cimentarsi in danze ed acrobazie, di certo, a causa dei fumi dell’alcol, non impeccabili, con gli amici che battono il ritmo con ramoscelli, di alloro o di mirto, gli àisakoi.
Perchè, come scriveva Alceo
Beviamo.
Perché aspettare le lucerne?
Breve il tempo.
O amato fanciullo, prendi le grandi tazze variopinte,
perché il figlio di Zeus e di Sèmele
diede agli uomini il vino
per dimenticare i dolori.
Versa due parti d’acqua e una di vino;
e colma le tazze fino all’orlo:
e una segua subito l’altra
March 10, 2021
La Posterula Ardeatina

E’ assai probabile che al romano medio, il nome di Posterula Ardeatina, dica ben poco: per una volta, non è che gli si possa dare tutte queste colpe. Rispetto ad altre porte delle Mura Aureliana, si nota ben poco, per la sua posizione, intermedia tra la Porta Appia e la Porta San Paolo, nelle vicinanze dei moderni fornici aperti per il passaggio della via Cristoforo Colombo, sia perché, oggettivamente, non è che abbia un aspetto così imponente e monumentale, essendo, a prima vista, un’uscita secondaria dalla città.
Priva di torri di difesa, si ovviò a tale carenza realizzando una sporgenza del muro che, in tal modo, poteva fungere da piccolo bastione; l’unica sua evidenza monumentale, sono poi i suoi stipiti decorati in travertino.
L’archeologia però, ci racconta, come sempre, una storia lievemente differente: gli scavi hanno mostrato come la struttura esistesse ben prima delle mura Aureliane. La sua prima fase costruttiva risale infatti al I secolo a.C. e consisteva in un casello daziario, dove si pagava la tassa per entrare nell’Urbe, il cui aspetto doveva essere simile a quello che ritroviamo ad Ostia nell’ingresso ad un “centro commerciale” dell’epoca, gli horrea epagathiana.
Che tale casello fosse particolarmente trafficato, è testimoniato da tre elementi: il primo è la presenza, sia all’esterno che all’interno delle Mure, di un tratto di strada lastricata di epoca romana, in cui sono visibili i segni lasciati dal traffico dei carri, che doveva essere notevole. Il secondo, l’ulteriore monumentalizzazione risalente all’epoca antonina, quando il dazio fu arricchito di un arco realizzato con marmi policromi.
Il terzo, l’elevato numero di mausolei, tombe a fossa e di colombari posti nelle sue vicinanze, che implicava la presenza di un importante e vasto sepolcreto: il più importante, era proprio adiacente al casello daziario ed era un mausoleo ad ara, che viene fatto risalire alla seconda metà del I° secolo a.C., di conseguenza, immediatamente successivo alla costruzione della prima versione della Posterula Ardeatina.
Mausoleo ancora visibile: al fianco della Posterula Ardeatina, nella parte interna delle Mura, infatti, si vede ancora un arco in cementizio con dei grossi blocchi di travertino ai lati. Da una porticina chiusa da un cancello si intravedono dei scalini che portano alla torre ed un’apertura che permette di entrare proprio nel in questo sepolcro, che misura m.3×4 circa.
Nella cripta ci sono su una parete di fronte all’entrata tre nicchie in laterizio con quella al centro più grande e con tracce di intonaco antico, e, sopra le nicchie, un grande arcosolio. Sulla parete nord, dove c’è l’ingresso, c’è una nicchia e sopra un arcosolio. Da un buco nel muro esterno, si intravede una parte della parete originaria del mausoleo, ormai coperta alla vista dal muro della torre, con visibile una parte di una tabella dove potrebbero esserci i nomi dei defunti.
Dato che quest’area faceva parte degli Horti Serviliani, ovviamente appartenente alla famiglia dei Servilii a cui apparteneva Marco Giunio Bruto uno degli uccisori di Cesare, suicida a sua volta a Filippi nel 42 d.C., è probabile che fosse il mausoleo fosse associato a tale gens. Ed è probabile che Un rilievo funebre dei Servilii, custodito oggi nei giardini della Villa Wolkonski all’Esquilino, provenisse proprio da questo mausoleo.
Per cui, quale era la strada su cui si doveva pagare il dazio? Non certo l’Ardeatina che, in età romana passava per le attuali località di Tor Marancia (un tempo parte degli Horti flaviani, di proprietà della famiglia di Vespasiano) e Cecchignola fino a raggiungere la Solfarata, all’epoca una pozza di acque sulfuree fredde a 15 miglia romane dalla città. Da qui procedeva verso Ardea con un tracciato identico a quello moderno e a 4 miglia e mezza dall’arrivo, attraversava il Numicius, probabile nome antico del Rio Torto.
Via che iniziava dalla Porta Naevia delle Mura Serviane, ora scomparsa, che si trovava probabilmente in corrispondenza dell’attuale largo Fioritto e nei pressi della basilica di Santa Balbina. Della porta Naevia si trova una sola citazione in Livio, una in Varrone che ne fa derivare il nome dalla sua posizione ai margini o all’interno dei “boschi Nevii”, e una terza nei Cataloghi delle Regiones in cui Augusto aveva suddiviso la città, nei quali si precisa come la porta fosse raggiungibile dal vicus portae Naeviae, che la collegava alla Piscina Publica, un bacino idrico che serviva sia per la distribuzione dell’acqua, sia ad attività sportive, sito dove adesso sono le terme di Caracalla.
L’Ardeatina attraversava le Mura Aureliane in una distinta porta, ovviamente chiamata Porta Ardeatina, a un unico fornice: nei disegni del Sangallo è indicata la presenza di una porta che venne distrutta assieme ad un tratto delle mura Aureliane durante la realizzazione del bastione Ardeatino nel 1538.
Se non era l’Ardeatina, che strada passava lungo il casello daziario ? Facciamo un esperimento: se ci poniamo fuori porta sul rettifilo della via Appia, ad esempio sul dosso che supera la strada al II miliario, rivolti verso la città, si può notare come la strada non punti su Porta San Sebastiano, ma proprio alla Posterula Ardeatina, per cui è ovvio che fosse una diramazione della Regina Viarum.
Questa sorta di Appia bis, dove portava ? Grazie sia agli scavi archeologici, sia all’analisi della topografia alto medievale, numerosi studiosi hanno ipotizzato che la sua destinazione finale fosse il santuario di Diana sull’Aventino, posto dove adesso sorge la chiesa di Sant’Alessio, fatto costruire da Servio Tullo, come un santuario federale dei Latini da Servio Tullio, in sostituzione di quello di Diana Aricina, sede dell’antica Lega Latina, e per ribadire il predominio di Roma sul Latium Vetus.
L’Appia stessa, con la sua diramazione, traduceva ideologicamente e sul piano urbanistico tale sostituzione. Il carattere federale del culto e le relative cerimonie, ovviamente, impattava sul traffico di tale diramazione, aumentandone l’importanza. Il tempio di Diana, in cui cercarono inutilmente rifugio in questo tempio Gaio Sempronio Gracco e i suoi sostenitori, durante la fuga da Roma, si trattava di un grande tempio ottastilo con due ordini di colonne lungo i lati ed era era circondato da un portico a due ordini di colonne. Il suo aspetto era simile a quello di altri santuari di Artemide-Diana, in particolare l’Artemision di Efeso, mentre la statua di culto arcaico assomigliava a quella trovata all’Artemision di Marsiglia, che doveva derivare pure dal modello efesino.
Nell’età antonina, l’importanza dell’area adiacente al tempio crebbe esponenzialmente, dato vi era la Privata Traiani Domus, ossia la casa dove abitava Traiano prima di diventare imperatore: così, il quartiere, tradizionalmente abitato da plebei, si gentrificò. Così la monumentalizzazione della zona, come detto, influenzò la ristrutturazione del casello daziario.
Nel III secolo d.C. nonostante la perdita d’importanza del tempio di Diana e la trasformazione in terme della Privata Traiani Domus, l’Aventino mantenne la sua importanza come quartiere signorile: per cui, Aureliano, dovette mantenere il collegamento diretto con l’Appia. Di conseguenza, il presunto mausoleo dei Servili e il casello daziario furono in parte demoliti, in parte inglobati nelle nuove mura: il precedente arco fu privato dei marmi e ampliato in profondità, in modo da trasformarsi in una porta urbica vera e propria.
Se i lavori di Massenzio non impattarono sulla Posterula Ardeatina, è probabile che fosse in qualche modo ristrutturata ai tempi di Onorio. Secondo una testimonianza dell’umanista e storico Poggio Bracciolini, anche sulla su di essa era affissa la solita lapide commemorativa che ricordava il restauro finanziato da tale imperatore.
Con lo spopolamento alto medievale dell’Aventino, la diramazione dell’Appia fu progressivamente abbandonata, tanto che la Posterula fu murata in epoca longobarda: già nell’VIII secolo non viene più citata e fu abbandonata sino alla moderna risistemazione e riapertura ad opera di Carlo Pietrangeli durante gli scavi del 1940.
March 9, 2021
Pippo Spano
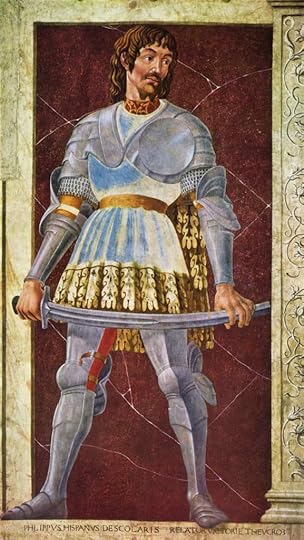
Parlando delle guerre hussite, ho accennato di sfuggita a una figura, che sicuramente, meriterebbe maggior fama e certo la sua vita non sfigurerebbe in una serie su Netflix: si tratta di Filippo Buondelmonti degli Scolari, meglio noto come Pippo Spano.
Pippo nacque nel 1369 a Tizzano, nei dintorni di Firenze, da Stefano e da una Antonia di cui si conosce solo il nome, da una famiglia di mercanti, alquanto prospera: per essere pronto a prendere in carico le attività di famiglia, a tredici anni divenne apprendista del mercante fiorentino Luca del Pecchia, che si stava arricchendo con il commercio con l’Ungheria.
Per cui, Pippo si trasferì a Buda, dove si fece ben volere dalla locale colonia toscana, tanto che, a valle della chiusura delle attività di del Pecchia in Ungheria, si fecero in quattro per trovargli un nuovo lavoro: grazie a loro nel 1385 entrò al servizio dell’arcivescovo di Esztergom, Demeter Kaniszai, lavorando come impiegato che oggi definiremmo ufficio acquisti della diocesi. Onesto e incorruttibile, gli fu affidato il compito di raccogliere il denaro per combattere i turchi che minacciano il Danubio.
In tale occasione fece amicizia con il funzionario regio Miklós Kanizsai, l’equivalente del nostro capo dell’Agenzia delle Entrate, tanto che nel 1389, alla morte di Demeter, lo raccomandò al fratello János, nuovo arcivescovo di Eszetergom e soprattutto gran cancelliere del regno d’Ungheria.
János nominò Pippo suo capo contabile; bazzicando la corte, nel 1390, accadde un evento imprevisto che gli cambiò la vita. Pippo era Doboj, in Bosnia, all’epoca possesso ungherese, dove era stato spedito da János a indagare sulla contabilità cittadina, dato che il gran cancelliere era convinto su come i magnati locali stessero barando sulle entrate e sulle uscite, intascandosi parte delle tasse di spettanza regia. Pippo esaminò con attenzione i libri contabili e non solo si accorse della malversazione, ma scoprì, per puro caso, come questa servisse a finanziare una rivolta contro il re Sigismondo d’Ungheria. Avvertita la corte di Buda, organizzò anche la trappola che permise di catturare i trentadue congiurati, che furono ammazzati a coltellate, due alla volta, nel castello di Ozora.
Con quell’azione Pippo conquistò anche la fiducia del re, cosa che diede il via alla sua carriera. Sempre come capo della contabilità e revisore dei conti economici, accompagnò nel 1396 Sigismondo alla battaglia di Nicopoli contro i Turchi: rendendosi conto di come le cose si stessero mettendo pessimamente per la coalizione crociata, ebbe la prontezza di spirito di impadronirsi di una barca, di farci salire, quasi a forza, Sigismondo, il cardinale Kaniszai e il conte Ermanno di Cilla e di fuggire a fuggire verso la foce del Danubio, spacciandosi per poveri pescatori, dove furono portati in salvo dalle galee veneziane.
Come premio, nel 1397, Pippo ottenne il privilegio di amministrare il castello di Simontornya. Con l’acquisizione di questa residenza divenne nobile di fatto, entrando così nella ristretta cerchia della classe dirigente magiara; ma formalmente la sua nobilitazione si concretizzò con l’accordo matrimoniale con Borbála Ozorai, figlia di un ricco proprietario terriero, che aveva conosciuto durante la sventata congiura di Doboj. Già all’epoca, l’aveva chiesta in sposa, ma il padre aveva rifiutato la sua richiesta, visto che riteneva disonorevole avere come genero un impiegato: ora, invece, le cose erano cambiate.
Nella circostanza, Borbála ottenne dal re (2 giugno 1398) il diritto di primogenitura, ossia il privilegio di ereditare i beni paterni come fosse il figlio maschio maggiore. Il 5 novembre 1399, Pippo ottenne anche due privilegi: il diritto di tenere mercato settimanale a Ozora e quello di esercitare lo ius gladii «pro extirpandis furibus et latronibus», ossia la responsabilità di comandare la milizia locale e di amministrare la giustizia L’ex apprendista mercante aveva in tal modo ottenuto il pieno possesso del villaggio di Ozora (da cui derivò il nome di Ozorai Pipo con cui è ancor oggi conosciuto in Ungheria).
Nel 1400, Pippo scoprì una nuova congiura contro Sigismondo, capitanata dal barone magiaro Stefano Lackfi, che voleva porre sul trono di Buda il re di Napoli Ladislao d’Angiò. Sigismondo d’Ungheria si disse disposto a un compromesso, tanto da convocare un’assemblea di nobili a cui fu invitato anche Stefano Lackfi, a cui fu consegnato un salvacondotto, a prendervi parte con i suoi fautori. In realtà era una trappola, organizzata dallo stesso Pippo. Appena giunsero in presenza del re i ribelli furono catturati, disarmati e uccisi su due piedi. Gli immensi possessi dei Lackfi, comprensivi di otto fortezze e di duecentocinquanta villaggi, furono divisi tra il re ed i suoi fedeli. Ovviamente, una parte fu incamerata anche da Pippo, che ottenne il titolo di governatore della Camera del sale della Transilvania, che gestiva l’estrazione e il commercio del salgemma e che fruttava proventi favolosi.
Il 28 aprile 1401, il suo vecchio protettore, János l’arcivescovo e il conte palatino Detre Bebek organizzarono una congiura contro il re, che fallì anche per l’intervento di Pippo, che fece da scudo umano a Sigismondo. Lo ritroviamo assieme al sovrano a Pozsony, l’odierna Bratislava, il 21 settembe 1402, in occasione della stipula del contratto che designava l’arciduca d’Austria, Alberto IV, erede di Sigismondo al trono magiaro. Nonostante il suo modesto incarico di conte camerario, Scolari figurava già allora tra i grandi del regno: era il quarantottesimo tra i centodieci praelati, barones, nobiles, proceres che avevano accompagnato il re a Pozsony.
Pippo trasse ulteriore giovamento per la sua carriera dalla seconda congiura ordita contro il sovrano all’inizio del 1403. Anche questo nuovo complotto era pianificato per portare sul trono d’Ungheria il re di Napoli Ladislao d’Angiò-Durazzo: ora, Pippo, che sino a quel momento non era nulla più che un burocrate di successo, si improvvisò militare. Arruolò 700 cavalieri e scoprì un’inaspettato talento militare, stupendo i suoi avversari per la sua brutalità spietatezza delle sue condotte di guerra: era noto per tagliare la mano destra dei prigionieri da lui rilasciati, per impedire che potessero riprendere le armi in futuro. In tale campagna, conquistò il castello di Visprino e contrasta i ribelli che sconfisse sul fiume Raab. Attaccò a Esztergom dove si era fortificato il cardinale Kaniszai, mettendola a ferro e fuoco per poi costringere l’esercito angoino a reimbarcarsi per Napoli.
Come premio, ricevette dal re il castello di Temesvár (oggi Timisoara in Romania) e la contea di Temes con l’ambito titolo di ispán, cioè governatore, da cui derivò il suo soprannome di ‘Spano’, entrando così nella cerchia dei maggiori signori territoriali forniti di banderium del Regno d’Ungheria. La carica di governatore di Temes era una delle maggiori del regno, data anche la crescente importanza assunta da questa contea dopo che gli Ottomani si erano fatti sempre più minacciosi ai confini meridionali dello Stato magiaro.
Scolari esercitò la giurisdizione anche sulle contee di Csanád (Cenad), Arad, Krassó (Caraş), Keve (Kovin), Csongrád e Zaránd (Zarand). Inoltre, tra il 1409 e il 1413, fu anche governatore della contea di Fejér. Non possedeva la facoltà di legiferare nei propri domini, ma aveva la delega del sovrano a presiedere le assemblee locali e poteva elargire donazioni; come governatore di contea era investito anche di funzioni giudiziarie; infine, in qualità di giudice partecipava alle sessioni del tribunale presieduto dal conte palatino, il quale rappresentava il sovrano nella gestione degli affari giudiziari. Rivestì inoltre la carica di sommo tesoriere dal 21 aprile 1407 al 10 luglio 1408.
Nel frattempo, combattè contro i Turchi, lanciando la moda di impalare i prigionieri, e sconfisse Tvartko II di Bosnia. Nel luglio del 1409, Ladislao d’Angiò-Durazzo re di Napoli e rivale di Sigismondo nella contesa del trono d’Ungheria, per 100.000 ducati vendette la città di Zara a Venezia. Tale cessione comportò un immediato deterioramento dei rapporti diplomatici tra la Serenissima e la corona ungherese, fino ad allora rimasti sostanzialmente buoni. Sigismondo infatti, eletto nel 1410 anche imperatore di Germania e dei Romani, era vivamente interessato a quei territori della Dalmazia che, insieme a quelli del Friuli, fungevano da importanti luoghi di passaggio e di collegamento tra i due suoi domini.
Per cui, incaricò Pippo di trovare un accomodamento diplomatico con i veneti e un’alleanza contro Ladislao. Nel 1410 organizzò con grande pompa la sua ambasceria, si fa accompagnare da numerosi gentiluomini e da una scorta di 300 cavalli. Nel suo viaggio italiano, fece tappa a Firenze, fermandosi per quaranta giorni in un palazzo posto all’angolo tra il Canto dei Giraldi ed il borgo degli Albizzi fatto costruire dal fratello Matteo con il suo denaro, soggiorno che, come vedremo, colpì la fantasia dei suoi concittadini. Fu accolto a Ferrara da Niccolò d’Este; ad agosto si incontra a Bologna con l’antipapa Giovanni XXIII.
Visto che i veneziano rifiutavano qualsiasi accordo, Pippo appoggiò la causa di Brunoro della Scala e di Marsilio da Carrara, rispettivamente pretendenti delle signorie di Verona e di Padova, ospitandoli presso di sé una volta cacciati dal governo veneziano nel 1404, anno in cui inizia la grande espansione veneziana nell’entroterra veneto.
Così, nel 1411 scoppià la guerra tra Venezia e l’Ungheria: Pippo, alla testa di 16.000 ungheresi e boemi, invase il Friuli, prendendo e saccheggiando Monfalcone, Marano, Portogruaro, Ceneda, Serravalle, Belluno, Feltre, il Trevisano, il Veronese ed il Padovano (dove sperava nell’insurrezione antiveneziana a favore degli spodestati Carraresi, Scaligeri e da Camino).
Pippo, assieme a Sigismondo ed alla testa di 6.000 cavalieri, entrò a Udine il 28 settembre 1411, dopo che la città aveva chiesto invano protezione al duca d’Austria Ernesto “Il Ferreo” d’Asburgo; Udine fu costretta a pagare un alto prezzo per evitare il saccheggio; il 30 settembre cadde anche Cividale.
Anche i veneziani invasero il Friuli causando stragi e saccheggi: il nobile friulano Tristano Savorgnan, dopo essere stato assediato quattro mesi nel proprio castello di Povoletto, fece atto di sottomissione alla Serenissima e riparò subito a Venezia dove fu nominato provveditore. Proprio Tristano Savorgnan si rese protagonista di un’azione ardita: con 400 cavalieri, numerosi fanti e innalzando false insegne ungheresi ingannò la guarnigione che presidiava le mura cittadine e riuscì ad entrare a Udine, ma venne scoperto e subito cacciato (28 marzo 1412). Carlo I Malatesta, al soldo di Venezia, con 8.000 cavalieri e 6.000 fanti saccheggiò anche i territori di Enrico IV conte di Gorizia (maggio-giugno 1412).
Neppure l’Istria fu risparmiata dal conflitto: Venezia occupò Buie, Portole, Rozzo e Colmo, mentre gli ungheresi occuparono il castello di Montona credendolo di Venezia, scoprendo invece che era presidiato da milizie patriarcali. I due contendenti si affrontarono per il controllo dei territori appena occupati; Venezia realizzò 22 miglia di fossi e terrapieni lungo il Livenza, che fu pattugliato da una flottiglia munita d’artiglierie; Filippo Scolari con 3.000 cavalieri e truppe raccolte nelle guarnigioni (boemi, tedeschi, ungheresi ed alcuni feudatari friulani) attaccò di sorpresa all’alba il campo veneziano a Motta di Livenza (24 agosto 1412).
Carlo Malatesta venne ferito tre volte negli scontri e Taddeo del Verme (anch’egli ferito nello scontro) furono alla fine soccorsi da un contingente di cavalleria condotta da Ruggero “Cane” Ranieri e Crasso da Venosa, i quali riuscirono a respingere gli attaccanti che lasciarono sul campo più di 1.300 tra caduti e feriti. Guglielmo da Prata ed altri tre capitani furono fatti prigionieri, e cinque delle sei bandiere furono perse. Passati all’offensiva, i Veneziani posero l’assedio a Udine (15 ottobre 1412), riuscendo a sconfiggere Filippo Scolari, solo per venire cacciati dall’esercito guidato da Sigismondo, divenuto frattanto re di Germania, che fu accolto in città il 13 dicembre 1412. Venezia occupò tuttavia i porti della Dalmazia ed assoldò Pandolfo III Malatesta signore di Fano, Brescia e Bergamo, ma nessuno raggiunse un successo decisivo, tanto che si raggiunse una pace di compromesso.
Dopo la guerra con Venezia, Pippo prese le armi, con mediocri risultati, più però per colpa di Sigismondo che sua, contro gli hussiti, e, con più successo, contro i Turchi. Quest’ultimi, alla notizia della sua presunta morte, nel 1422, invasero la Va. Su richiesta del despota di Serbia Stefano Lazarevic e del nipote di questi Giorgio Brankovic mosse contro gli avversari alla testa di 5000 cavalli e di 10000 uomini. Giunse a Golombaz e vincs in battaglia campale i turchi che subirono la perdita di 20000 uomini: non ebbe però il tempo di assaporare il frutto della vittoria. Assistette al combattimento da una portantina, essendo gravemente ammalato di gotta e al termine dello scontro, gli venne un collasso per gli strapazzi sopportati e perdette quasi la parola. Aggravatosi a Várad, fu portato a Lippa (Lipova), dove si spense il 27 dicembre 1426. Fu seppellito in una cappella a Székesfehérvár, da lui fatta costruire nel 1425, accanto a quella dei re d’Ungheria.
Pippo non fu solo un guerriero spietato: fu un amante dei libri e della cultura, amico degli umanisti cardinale Branda Castiglione e Poggio Bracciolini e un mecenate, prodigo elemosiniere e finanziatore di opere civili e religiose. Fece costruire a Ozora, oltre al castello, un monastero di osservanti francescani, abitato dal 1423 e un un acquedotto che avrebbe dovuto portare l’acqua dal lago Balaton a Ozora. A Lippa, finanziò la costruzione dell’ospedale di S. Elisabetta.

Fu anche un amante dell’arte e molto probabilmente fu lui a chiamare in Ungheria Masolino da Panicale, che stava lavorando insieme a Masaccio agli affreschi della Cappella Brancacci, per far dipingere la sua cappella a Székesfehérvá. Alla sua morte nel 1426 lasciò 5.000 fiorini d’oro all’Arte dei Mercatanti di Calimala, per far costruire una chiesa camaldolese, dedicata alla Vergine e ai dodici Apostoli, che fu commissionata al Brunelleschi, la famigerata Rotonda di Santa Maria degli Angeli.
Opera che tra l’altro, non fu mai completata, perché la Repubblica fiorentina requisì il lascito per sopperire alle spese della guerra contro Lucca (dal 1437), rimase il rudere alto circa sette metri, che fu poi chiamato dal popolo il Castellaccio. Esso era inserito nel muro di confine dell’orto del monastero, finché non venne coperto con un tetto nel XVII secolo. Nel XIX secolo si costruirono sopra alcune stanze e il locale servì come studio allo scultore Enrico Pazzi. Fu ristrutturata da Rodolfo Sabatini solo nel 1937 seguendo il disegno del suo ideatore ma senza riuscire a dare un aspetto unitario all’edificio, che rimane comunque diviso in parte bassa con i tipici costoloni in pietra serena, e parte alta senza decorazioni. La scelta operata dal progettista fu quella di completare le strutture rinascimentali con una nuova porzione dal linguaggio asciutto e più legato alla contemporaneità – coprendo l’aula in assoluta autonomia, così da non turbare l’architettura brunelleschiana con eccessivi contrasti. ha ospitato a lungo le aule del Centro linguistico d’Ateneo, oggi spostate in via degli Alfani, ed oggi appartiene ancora all’Università di Firenze, sebbene non venga utilizzato.
La rotonda di Santa Maria degli Angeli è l’unico edificio a pianta centrale progettato da Brunelleschi senza doversi misurare con strutture continue. Dell’assetto originario resta, tra le varie testimonianze, un disegno abbastanza fedele di Giuliano da Sangallo, che mostra un impianto a simmetria raggiata con asse verticale, ispirata all’edificio esquilino del tempio di Minerva Medica.
La pianta è ottagonale e su ciascun lato si apre una cappella, circondata attorno all’aula centrale da arcate e lesene in pietra serena. L’altare doveva trovarsi probabilmente al centro, coperto da una cupola. Ciascuna cappella, di forma quadrata con due nicchie ai lati che la facevano sembrare ellittica, aveva una parete piana verso l’esterno, mentre negli spazi dei pilastri erano tagliate nicchie esterne forse destinate ad essere decorate da statue. Le nicchie interne dovevano essere in comunicazione l’una con l’altra, in modo da generare un andamento circolare dello spazio.
Come detto, sia il per il lusso del suo soggiorno fiorentino, sia per la sua storia di self made man, colpì la fantasia dei suoi concittadini. Compare infatti nella Novella del Grasso legnaiolo, racconto di una celebre beffa ordita da Brunelleschi, che, nonostante il ritratto serioso che gli danno i libri di Storia dell’Arte, non avrebbe sfigurato tra i protagonisti di Amici Miei, ai danni dell’ebanista Manetto Ammanatini, detto Il Grasso.
Brunelleschi fece credere a Manetto di essere un’altra persona, un certo Matteo Mannini, fannullone che viveva alle spalle dei parenti. Con la complicità di un gran numero di persone, la beffa riuscì al punto di far dubitare alla vittima della propria stessa identità. Se vi ricorda la storia di Gasperino er Carbonaro del Marchese del Grillo, avete ragione, è una delle sue fonti di ispirazioni. Comunque alla fine della vicenda per evitare il ridicolo il povero legnaiolo è costretto a trasferirsi in Ungheria al seguito di Pippo Spano, dove peraltro farà fortuna.
Pippo è anche protagonista del Ciclo degli uomini e donne illustri affrescato da Andrea del Castagno, realizzato tra il 1448 e il 1451 nella villa Carducci di Legnaia presso Firenze, per il gonfaloniere di Giustizia Filippo Carducci.
Filippo Carducci fece decorare ad Andrea del Castagno la loggia della villa, che successivamente venne trasformata in salone. Il ciclo, ispirato da esempi padani, celebra il valore delle virtù morali degli uomini, che venivano innalzati a una dimensione eroica. Se fino ad allora i personaggi erano spesso tratti dalla Bibbia e dalla mitologia, quindi modelli astratti e fuori dal tempo; nel ciclo di Legnaia, a parte le figure femminili, vennero scelti personaggi del passato prossimo di Firenze, ancora vivi nella memoria. Questa particolare iconografia si ispirò a Boccaccio, ma anche a Plutarco, il cui Mulierum virtutes era stato tradotto dal latino entro il 1495 da Alamanno Rinuccini, cugino di Andrea Carducci e nipote di Filippo.
Questa decorazione è costituita da singole immagini, quasi in finto rilievo, in nicchie rettangolari, allineate su una lunga parete: tre uomini d’arme, Pippo Spano, Farinata degli Uberti e Niccolò Acciaioli; tre letterati, Dante, Petrarca e il Boccaccio; e tre figure femminili, la Sibilla Cumana, la regina Ester, la regina Tomiri; inoltre, sopra una porta, una Madonna col Bambino tra angeli a mezzo busto, sotto un padiglione (iconologia imitata più tardi da Piero della Francesca nella Madonna del parto, a Monterchi); ai lati della porta sono riapparse in restauri (1949) le figure di Adamo ed Eva e il Crocefisso.
Andrea del Castagno assolve il suo compito senza rinunziare al suo dinamismo e al suo plasticismo (che, anzi, appare, dal pretesto stesso della finta scultura, singolarmente accentuato); rende in modo virtuosistico e realistico la qualità della materia (anche nei finti marmi delle nicchie) e si dimostra perfettamente al corrente dei tentativi di epigrafia classicheggiante nelle stupende iscrizioni che commentano le raffigurazioni degli eroi e delle eroine.
March 8, 2021
Atene contro Siracusa (Parte VIII)

Mentre il manicomio dello scandalo delle Erme, i preparativi ad Atene per la spedizione in Sicilia procedevano a vele spiegate, tanto che il contingente fu pronto a partire in occasione delle Adonie, che quell’anno cadavano a metà giugno.
Feste che ad Atene celebravano il dolore per la scomparsa di Adone e la gioia per il suo ritorno; sotto certi aspetti, erano una sorta di carnevale, dato che non erano feste pubbliche. Lo lo scoliaste al v. 389 della Lisistrata di Aristofane precisa che la città non le finanziava né le organizzava; si svolgevano tra profumi, vino e pranzi nelle abitazioni private. Il commediografo greco Difilo definisce le Adonie un autentico bordello e della loro licenziosità ci informa anche Menandro.
Tutto questo rese ancora più rovente l’atmosfera della partenza, che così descrive il nostro Tucidide, dipingendo un ritratto sublime della psiche umana
Per conto loro, invece, gli Ateniesi e alcuni alleati presenti in città discesero con l’aurora del giorno stabilito al Pireo, e montarono sulle navi pronti a puntare al largo. Era sceso in loro compagnia anche il resto della gente d’Atene, si può dire in massa: cittadini e forestieri. Quelli del posto accompagnavano per un saluto ciascuno i propri cari: quello un amico, l’altro un parente, l’altro ancora un figliolo. Camminavano, e ad ogni passo si fondeva alla speranza una nota di pianto: negli occhi il quadro superbo della conquista, ma dentro l’angoscia di non rivedere i volti amati, fantasticando su quelle tappe sconfinate di mare che separavano dalla patria la loro meta.
Ed ecco fu l’ora, e in procinto di separarsi verso un futuro denso di minacce, sentivano insinuarsi nei cuori uno sgomento più forte di quando decretarono in assemblea la campagna oltremarina: pure era una consolazione accompagnare con l’occhio la generosità spiegata in ogni particolare, e cogliere il senso di forza che dall’ordinato complesso spirava. I forestieri e l’altra moltitudine erano accorsi curiosi, nel presentimento d’assistere a un’esperienza di singolare interesse, a un progetto che pareva chimerico.
Tra l’altro Tucidide, nella sua saggezza, oltre a riecheggiare il concetto eschileo dell’hybris, l’orgogliosa tracotanza che porta l’uomo a presumere della propria potenza e fortuna e a ribellarsi contro l’ordine costituito, sia divino che umano, immancabilmente seguita dalla vendetta o punizione divina, evidenzia il problema di fondo di una spedizione di questo genere, nata più per motivi di prestigio, che per effettive esigenze strategiche: l’enorme costo imposto sia al tesoro statale, sia ai singoli ricchi ateniesi. Se fosse andata male, la casse vuote della città, avrebbero portato a un crollo dell’impegno militare attico e reso molto più difficile il controllo dell’impero e la riscossione dei tributo, dando il la a una spirale recessiva.
Poiché fu questo il primo armamento varato con le proprie forze da un’unica città con equipaggi interamente greci, il più largo di mezzi e il più magnifico tra quanti, fino a quei tempi, s’erano mai allestiti. Per numero di unità navali e di fanterie anche la campagna di Pericle contro Epidauro, poi condotta da Agnone contro Potidea, non era riuscita inferiore: all’offensiva navale partecipavano allora quattromila opliti cittadini, trecento cavalieri e cento triremi, oltre a cinquanta provenienti da Lesbo e da Chio. Al seguito, naturalmente, una folla varia di alleati. Ma l’azione in quella circostanza si protendeva per breve raggio, allestita con uno spiegamento di forze ordinario. Quest’ultima flotta, invece, salpava per una campagna che si presagiva di lunga durata, forte di un duplice armamento per affrontare, ove si presentasse l’urgenza uno scontro sia sui mari che di fanterie.
La squadra navale esigeva un impegno poderoso da parte dei trierarchi e dell’economia statale. Il tesoro pubblico passava ai marinai una dracma giornaliera di soldo a testa: aveva inoltre fornito gli scafi di sessanta vascelli da combattimento, quaranta di navi per trasporto truppe, con ai remi ciurme selezionate. I trierarchi s’erano assunti spontaneamente l’obbligo di versare alla classe dei traniti e al personale specializzato di bordo un soprassoldo sulla paga corrisposta di denaro statale, provvedendo inoltre ai fregi e alle preziose suppellettili di ogni bastimento; e ogni trierarca aveva profuso energie e capitali senza risparmio, purché il proprio vascello spiccasse per il lusso degli ornamenti e la scorrevolezza sul mare.
Nell’armata terrestre militavano, tratti da leve meticolose, elementi scelti, in mezzo ai quali s’era accesa una rivalità appassionata tra chi sfoggiasse le armi migliori e l’equipaggiamento più efficiente. Si trovò che non solo in seno all’armata dominava lo spirito d’emulazione, a seconda del servizio cui ciascuno era stato assegnato, ma che l’operazione nel suo complesso si poteva intendere più come una parata dimostrativa della potenza e grandezza ateniesi agli occhi degli altri Greci, che un reale armamento ai danni dei nemici. Se infatti si fosse tenuto calcolo dello sforzo finanziario sostenuto dall’erario pubblico e delle somme che i partenti recavano via con sé; delle spese già versate dallo stato e dei fondi consegnati agli strateghi in partenza; delle cifre elargite dai singoli per attrezzarsi e da ogni trierarca per armare la propria nave, oltre a quelle tenute con se di riserva, in vista d’impegni futuri e inoltre, senza contare il soldo governativo, di tutto quanto era prevedibile che ciascuno si rifornisse per far fronte ad ogni evenienza di viaggio, presagendo un lungo periodo di campagna; e con l’aggiunta del liquido che per ragioni di traffico ognuno, armato o mercante, portava con sé all’imbarco l’importo in talenti delle fortune che uscivano da Atene toccava, nell’insieme, una quota ragguardevole. E questa spedizione rimase celebre non meno per lo spettacoloso ardimento e il fulgido quadro che offriva all’occhio, che per la supremazia strategica sul nemico che si andava ad attaccare; perché inoltre, era l’offensiva transmarina inferta agli obiettivi più remoti che mai in passato dalle proprie basi, e l’impresa scortata dalle speranze più liete per l’avvenire, nate ammirando le disponibilità presenti.
Ormai le truppe gremivano le navi e s’era già tutta stivata l’attrezzatura che avrebbero portato via con sé, quando uno squillo di tromba segnalò il silenzio. E gli equipaggi, non da ogni singolo vascello, ma ad una voce, guidati dall’araldo, ripeterono le preghiere di rito prima del distacco; e in ogni angolo della flotta, attingendo dai crateri colmi di vino con coppe d’oro e d’argento tutti, truppa e ufficiali, libarono. Si fondeva alla preghiera anche la voce dell’altra gente stipata sui moli: cittadini e quanti, per sentimento d’amicizia, s’erano raccolti laggiù. Poi s’intonò il peana e conclusa la cerimonia le navi si staccarono, uscendo dapprima in lunga fila dalla rada, poi sfidandosi subito in velocità fino ad Egina. Allora gli Ateniesi misero senz’altro le prue su Corcira, meta di raccolta di tutte le altre squadre in arrivo dai porti amici.
Arrivati a Corcira, la nostra Corfù, che ricordiamolo, era stata uno dei casus belli della guerra del Peloponneso e raggiunto lo scopo dimostrativo nei confronti dei nemici, che da una parte rimasero certo atterriti dal mostrare i muscoli di Atene, dall’altra tirarono un sospiro di sollievo, in fondo era meglio che sprecassero le loro risorse in terre lontane, piuttosto che utilizzarle ai loor danni, decisero di riorganizzare il contingente, per semplificarne il comando e la logistica e probabilmente su suggerimento di Nicia, mandarono un’avanguarda, sia per saggiare le potenziali alleanze e comprendere dove sbarcare in Sicilia, sia per capire l’effettivo stato delle finanze di Segesta, sulla cui ricchezza, lo stratega ateniese aveva, giustamente, parecchi dubbi
Gli Ateniesi frattanto con tutti gli alleati stazionavano già nel mare di Corcira. Come misura preliminare gli strateghi passarono in rivista l’armata assegnandole la disposizione da conservare sia nella fase di ormeggio che nelle operazioni d’alloggio a terra. Ripartirono l’esercito in tre settori, poi sorteggiati uno per stratego: ad evitare che accostando compatti si incontrassero difficoltà di rifornimento d’acqua, negli attracchi ai moli e nel reperire vettovaglie nei porti. Tra l’altro, la disciplina di marcia si assicurava meglio con questa regola, e il comando diveniva più agile, direttamente agli ordini, divisione per divisione, del proprio stratego. In un secondo momento, gli strateghi mandarono tre navi avanti, in Italia e in Sicilia, per accertare quali città avrebbero loro offerto accoglienza. S’era data istruzione, al ritorno, di farsi incontro alla flotta, allo scopo di conoscere in anticipo i punti precisi di sbarco.
Così Tucidide ne approfitta per dare il dimensionamento effettivo del contingente di invasione ateniese
Concluse queste operazioni iniziali, gli Ateniesi sciogliendo ormai le vele da Corcira iniziavano la traversata alla Sicilia con i mezzi seguenti. Disponevano in tutto di centotrentaquattro triremi, oltre a due navi di Rodi a cinquanta remi (tra esse cento erano attiche, di cui sessanta unità veloci; il rimanente per trasporto truppe; il resto della flotta apparteneva a Chio e agli altri alleati). In tutto gli opliti erano cinquemilacento (tra cui millecento ateniesi forniti dalle classi di leva cittadine, settecento erano teti imbarcati come combattenti sulle navi; gli altri partecipavano in qualità di alleati: parte tributari, parte Argivi, cinquecento, parte milizie di Mantinea, che con le truppe mercenarie assommavano a duecentocinquanta). Complessivamente gli arcieri erano quattrocentottanta (tra cui ottanta provenienti da Creta); c’erano poi settecento frombolieri di Rodi, centoventi fuoriusciti di Megara con armatura agile. Seguiva da ultimo un solo bastimento per trasporto di truppe a cavallo, con trenta cavalieri a bordo. Erano dunque tali le proporzioni del primo contingente di spedizione che varcava il mare alla guerra con in coda un convoglio di trenta vascelli da carico, in cui era stivato tutto l’occorrente in vettovaglie, con a bordo fornai, muratori, carpentieri e un’attrezzatura completa per opere di fortificazione e d’assedio. Di fianco al convoglio veleggiava un centinaio di battelli da carico requisiti: liberamente s’era invece aggregato un nutrito gruppo di legni mercantili e altri bastimenti, per ragioni di traffico
Dall’elenco fornito da Tucidide saltano agli occhi due cose. La prima, il grosso errore tattico, dovuto alla scarsa presenza della cavalleria nella spedizione. Tra l’altro, ad Atene, i contigenti dei cavalieri, pur non uguagliando in qualità e quantità quelli tessali, erano di gran lunga superiori a quelli delle altre polis.
Il cavaliere ateniese indossava il petasos, una corazza anatomica, stivaletti, chitone, una clamide nera, ed era provvisto di 2 giavellotti e una sciabola. Ad esso veniva conferito un assegno giornaliero per l’acquisto del foraggio, un contributo per l’acquisto del cavallo, che annualmente veniva sottoposto a controllo come stabilito dalla Bulé, in occasione della dokimasia. Il contingente era suddiviso in Philè di 100 hippikon comandati da un filarca. Ciascuna ala di cavalleria, composta da 5 philai veniva comandata da un hipparca con carica annuale. Ciascuna philè conferiva all’hipparchia 5 prodromoi, cavalieri con compiti di esplorazione e recapito messaggi.
Di fatto, la loro tattica era abbastanza semplice: si avvicinavano alla falange oplitica avversaria, lanciavano i giavellotti, per infastidirla, poi caricavano i fuggitivi. Ben diversa, la cavalleria nell’esercito siracusano, molto più numerosa, meglio corazzata e armata: era dotata di una lancia più pesante e lunga dello xiston macedone e la spada monofilare makhaira. Con la carica scompaginavano la fanteria nemica, per poi farsi largo a spadate nella mischia. E proprio questa differenza di numeri e di tattiche, fu causa di diversi problemi per gli ateniesi.
La seconda, l’enorme costo operativo della spedizione. Facciamoci i conti della serva. Dai resoconti riguardo alla battaglia di Potidea (433 a.C.) si conosce che un oplita prendeva 2 oboli al giorno. Successivamente però, la paga di ogni singolo soldati salì a 4 oboli quotidiani cioè 20 dracme d’argento al mese; durante la spedizione ateniese il salario toccò le 30 dracme mensili. Con un esercito di 5100 opliti si sarebbe spesi teoricamente per i due anni di spedizione circa 600 talenti (30 dracme × 24 mesi × 5100 opliti). Considerando le perdite e gli opliti di rinforzo la cifra si avvicina ai 1000 talenti.
Il costo medio dei marinai era di 3 oboli al giorno durante il periodo di Pericle, quello di una trireme era di 200 dracme al giorno, ovvero 12 talenti l’anno.La flotta di 134 triremi sarebbe quindi costata teoricamente oltre 3200 talenti per i due anni della spedizione (1 talento mensile × 24 mesi × 134 triremi). Le prime perdite significative si fecero sentire solo dopo il primo anno di spedizione: in totale quindi, comprendendo perdite e rinforzi, Atene dovette pagare almeno 3000 talenti. I cavalieri costavano circa 12 oboli al giorno. La loro paga sarebbe in totale costata ad Atene circa 5 talenti.
Le 700 unità leggere costarono dai 35 ai 58 talenti. I 480 arcieri richiesero circa 38 talenti, visto che la loro paga era di 4 oboli al giorno, ovvero 20 dracme al mese (20 dracme × 24 mesi × 480 arcieri = 230 400 dracme ≈ 38 talenti). Simile era la paga dei frombolieri che costarono circa 45 talenti.
Per cui, complessivamente, 4146 talenti. Ogni talento attico equivale a 26 kg di argento puro. Di conseguenza, 107.796 kg di argento ossia, al prezzo medio di 700 euro a kg, il totale di 75.547.200 euro, che vanno raddoppiati, considerando i costi di varo della flotta. Con 150.000.000 di euro, anche in caso di vittoria, l’economia ateniese ne sarebbe stata comunque prostrata.
Alessio Brugnoli's Blog



