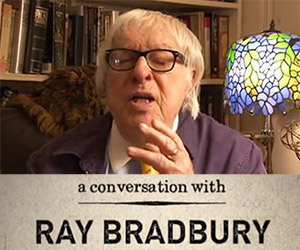Alessio Brugnoli's Blog, page 183
September 5, 2017
Star Wars: il divertente corto animato di 40 secondi dedicato a C1-P8
C1-P8 (originariamente noto come R2–D2) è probabilmente, insieme al suo inseparabile amico d’avventura D-3BO (C-3PO), il robot più famoso non solo di Star Wars, ma di tutto il panorama cinematografico SCI-FI. Sul canale Twitter ufficiale di Star Wars è stato di recente pubblicato un cortometraggio brevissimo a lui dedicato, ovvero The droid the droids are looking for, in cui non mancano di apparire nemmeno altre facce – o forse sarebbe meglio dire: ingranaggi – ben noti ai tanti fan della saga. Segue il filmato animato. Buona visione!
The droid the droids are looking for. #StarWarsBlipspic.twitter.com/H00dgppDvR
— Star Wars (@starwars) September 3, 2017


ROMA: CON LA GUIDA DI REPUBBLICA IL PREMIO AL MIGLIOR GELATO
Il premio Latte Sano per il miglior gelato è stato consegnato da Simone Aiuti ad Andrea Fassi del Palazzo del Freddo di Giovanni Fassi all’interno della nostra nuova Guida ai sapori e ai piaceri di Roma e del Lazio. Il volume, con un grande racconto e centinaia di consigli sul bello e sul buono della città e della regione, è disponibile in edicola, nelle librerie e online su Amazon, Ibs e sul nostro store al link bit.ly/GuideRepubblica


September 4, 2017
Vivarium ?
[image error]
Udite, udite, oggi Manu, dopo una lunga battaglia burocratica, è riuscita a cominciare la fisioterapia: si è stancata, senza dubbio alcuno, ma in compenso non ha provato dolore al ginocchio. Per di più, i progressi dovute alla ginnastica, nel piegare l’articolazione, sono apparsi a vista d’occhio… Vedremo come andrà domani…
Per festeggiare, mi diverto a citare un brano della Guerra Gotica di Procopio di Cesarea, anche per onorare l’Urania collezione di Agosto, ambientato proprio in quel periodo.
Ma Bessa e Peranio convocarono Belisario, perché Vitige li stava pressando con grande vigore presso il Vivarium. Ed egli, essendo preoccupato per quella parte del muro (in quanto, com’è stato detto, lì era molto facilmente aggredibile), giunse egli stesso in soccorso, in tutta fretta, lasciando uno dei suoi fidi a Porta Salaria. E scoprendo che i soldati nel Vivarium erano sgomenti per l’attacco del nemico, il quale stava pressando con grande vigore ed in grande numero, ordinò loro di disprezzare il nemico e in tal modo fece loro riguadagnare coraggio.
Il terreno lì era molto piatto, pertanto il luogo si prestava agli attacchi degli assalitori. E per caso il muro in quel punto aveva in buona parte ceduto, al punto che i mattoni non si tenevano più bene uniti. All’esterno del primo muro, gli antichi Romani ne avevano costruito un altro più modesto che lo circondava, non per motivi di sicurezza (in quanto non era fortificato con torri, né aveva merlatura sulla sommità, né alcun altro dispositivo che avrebbe reso possibile respingere l’assalto di un nemico dalle fortificazioni), ma per assolvere ad una funzione di un lusso inopportuno, cioè per potervi imprigionare e tenere leoni ed altri animali selvatici. Ed è per tale motivo che questo luogo è stato chiamato il Vivarium; in quanto è così che i Romani chiamano un luogo dove vengono tenuti gli animali selvatici.
Un brano che nasconde un piccolo, grande mistero archeologico dell’Esquilino, ossia dove fosse quest’edificio, un ampio spazio recintato in cui si trovavano le gabbie per gli animali feroci e campi di pascolo per le bestie selvatiche utilizzate negli spettacoli circensi.
Da quanto racconta Procopio, si trovava nei pressi delle Porte Prenestina e Labicana (l’attuale Porta Maggiore) ed era stato inglobato da Aureliano nella cinta difensiva della città; il problema è che questa struttura pare sia scomparsa nel nulla: un paio di secoli di saggi archeologici non ne hanno rilevato traccia. Inoltre, sembra strano come possa essere esistito un simile edificio, visto che sarebbe stato un doppione di uno già esistente, vicino alla domus di San Giovanni e Paolo sul Celio, connesso al Colosseo con uno stretto passaggio sotterraneo.
L’unica ipotesi è che questa struttura fosse relativa all’Anfiteatro Castrense, ma sembra strano che fosse utilizzata sino alla tarda antichità, visto come l’anfiteatro avesse smesso di funzionare dai tempi di Aureliano.
Il buon Adriano La Regina, però, ha notato come la descrizione di Procopio, che evidenzia la mancanza di torri e merli, coincida con quanto sappiamo dell’Anfiteatro stesso: è probabile che lo storico bizantino, poco avvezzo al latino, abbia confuso Vivarium con Viridarium, dato che l’arena sembra aver svolto a quei tempi il ruolo di giardino del Palazzo imperiale del Sessoriano.


September 3, 2017
Gli affreschi perduti di Gentile e Pisanello










Oggi, grande risultato per Manu: mi ha accompagnato al supermercato, per fare la spesa, senza neppure affaticarsi troppo ! Il che mi riempie di speranza per il futuro, visto che non si arrende e che ogni giorno compie un piccolo passo…
Così, mi ritrovo a parlare di un episodio dell’arte italiana, tanto influente, tanto poco noto: gli affreschi perduti di Gentile e di Pisanello in San Giovanni in Laterano, distrutto durante il rifacimento della Basilica compiuto nel 1650 da Borromini. Lo stesso Borromini ne curò la parziale riproduzione in disegno che oggi si trova a Berlino presso la Kunstbibliothek.
Il promotore di quest’opera fu Papa Martino V, parente alla lontana dei protagonisti dei miei romanzi, che sin da quando fu eletto papa nel 1417 a Costanza, mostra un grande interesse per la politica balcanica: ricevette subito l’ambasciatore bizantino Nicola Euadaimonoiannes che in cambio dell’appoggio del basileus per la riunificazione della chiesa d’Oriente e d’Occidente, chiede fondi per la manutenzione dell’Hexamilion, la muraglia che nello stretto di Corinto difendeva la Morea dalle incursioni turche.
Ambasciatore che accompagna Martino V nel suo lento scendere Roma e che probabilmente è presente all’incontro del Papa con Gentile da Fabriano nel 1419 a Brescia, quando il pittore era impegnato nella decorazione del Broletto commissionata da Pandolfo III Malatesta, colpendone l’immaginario e arricchendo le suggestioni bizantine, che forse aveva acquisito lavorando agli affreschi del Palazzo Ducale a Venezia.
Nel settembre 1420, Martino V è a Firenze dove dove entra in contatto con l’ambiente artistico locale, ordina arredi sacri a Ghiberti e si porta dietro Gentile,visto che è documentato nella città toscana dal 6 agosto di quell’anno.
Poco dopo, a dicembre, il Papa coglie il successo con il matrimonio di Cleofe Malatesta con Teodoro Paleologo, che dovrebbe essere la base dell’alleanza tra le signorie italiane , Costantinopoli e i vari despotati greci contro i turchi: proprio in quest’ottica si impegna in una straordinaria attività diplomatica, con il senno di poi fallimentare, ma che nel 1423 lo porta a proclamare il giubileo un giubileo per celebrare la rinascita cittadina, evento per il quale è commissionata la Pala Colonna a Santa Maria Maggiore, che dovrebbe essere quindi la prima opera in cui Masolino e Masaccio collaborano assieme, il che spiegherebbe molte incertezze stilistiche.
[image error]
[image error]
Ora perché una commissione così prestigiosa fosse data a due illustri sconosciuti, Masaccio si era iscritto all’arte dei medici e speziali nel 1422, mentre Masaccio lo aveva fatto a inizio 1423, è poco chiaro: probabilmente i due soci furono raccomandati da Ghiberti, loro amico, e dal loro protettore Paolo Carnesecchi, Console delle arti per i medici e gli speziali e con cui Martino V aveva parecchi debiti.
Intanto, nel 1424, Pisanello che stava completando gli affreschi di Gentile al Palazzo Ducale di Venezia, è incaricato di affrescare il Castello di Pavia con scene di caccia, in previsione dell’arrivo di Giovanni VIII di Bisanzio. Pisanello accetta e all’improvviso, si ritrova circondato da decine di funzionari bizantini, rimanendo affascinato dai loro vestiti, usi e costumi. Pisanello,che è un disegnatore compulsivo, rappresenta di tutto, da opere romane antiche a dipinti di Giotto e Altichiero e opere all’epoca d’avanguardia come quello l’Angelico, Fra Filippo Lippi, Donatello, Luca della Robbia, li comincia a ritrarre; non lo avesse mai fatto ! In men che non si dica, si ritrova a svolgere il ruolo di pittore ufficiale dei Paleologhi.
Nel 1427, Martino V riesce a convincere Gentile da Fabriano a venire da Roma: il pittore si impegna in un’attività forsennata, realizzando l’affresco della Sacra famiglia, ammirato da Michelangelo, per la basilica dei Santi Cosma e Damiano, la tavola con Martino V e dieci cardinali , dove è ipotizzabile la nascita dell’iconografia protocollare, con la prima rappresentazione della cerimonialità curiale, proseguita nei decenni successivi con Jean Fouquet e l’Angelico, fino ai capolavori di Melozzo e Raffaello e la commissione più prestigiosa, la decorazione della basilica Lateranense, in cui nell’ottica di affermare la dimensione atemporale dell’Ecclesia, ricollegandosi alle sue radici paleocristiane, recupera la tradizione figurativa delle basiliche maggiori.
Modello di riferimento dell’impianto decorativo, diviso in registri con figure monumentali e riquadri narrativi, era la primitiva navata paleocristiana di San Pietro, ancora in opera in quegli anni, ribadito da Pietro Cavallini alla fine del Duecento sia in quella ostiense sia nell’altra trasteverina di Santa Cecilia negli anni del primo giubileo.
Per cui Gentile imposta una struttura decorativa a due livelli: in basso, le scene della vita di Gesù e del Battista e in Battista e più in alto tra le finestre, a chiaroscuro, ritratti di profeti, degli evangelisti e di altri apostoli, di dottori della Chiesa; immagini queste, che colpiranno la fantasia dei fratelli Van Eyck, durante il loro pellegrinaggio a Roma e che saranno citate nel Polittico dell’Agnello Mistico.
[image error]
September 2, 2017
Palermo Ebraica
[image error]
Oggi giornata transitoria: Manu non ha fatto un granché, tranne sperimentare Netflix e io ho lavorato all’allegato tecnico in inglese per una nuova gara. La buona notizia è che sto venendo a capo del manicomio della fisioterapia e che, forse, dalla prossima settimana Manu potrà cominciare a farla…
Per cui, per ammazzare il tempo, torno a parlare di Palermo, affrontando un tema assai particolare: la sua comunità ebraica.
La prima testimonianza della sua presenza, risale al 598: un vescovo di Panormos, per zelo religioso o per riempirsi le tasche, occupò le sinagoghe, gli ospizi e le case degli ebrei locali e per evitare di restituirle ai loro legittimi proprietari, le aveva consacrate. Gli ebrei, non sapendo a chi appellarsi, scrissero a papa Gregorio I, che dopo aver fatto una solenne lavata di capo al vescovo, gli ordinò di risarcirli e di restituire i libri e gli ornamenti appartenenti alle sinagoghe.
Poi, il nulla, sino al 878, in cui si citano, tra i prigionieri catturati dagli arabi, alcuni di religione ebraica: inizialmente, data il caos dovute alle guerre civili tra musulmani e le lotte con i bizantini, probabilmente gli ebrei locali non se la passarono molto bene, però con il tempo, furono tra coloro che trassero beneficio dal boom economico di Balarm.
Cosa che sappiamo da una fonte molto particolare, una ghenizah, parte della sinagoga destinata a servire da deposito, delle opere che trattino argomenti religiosi redatti in ebraico, divenuti inutilizzabili, in attesa che esse siano sotterrate in un cimitero, dal momento che è proibito categoricamente gettare documenti scritti in cui compaia uno dei sette Nomi sacri di Dio, ivi comprese le lettere personali e i contratti legali che – allo stesso modo dell’Islam che prevede l’abbondante uso della basmala – si aprono con un’invocazione a Dio. In pratica le ghenizah contengono anche documenti profani, che abbiano o meno la formula d’invocazione tanto usata, come pure i documenti redatti in altre lingue che non siano l’ebraico, ma che utilizzino l’alfabeto ebraico.
E la ghenizah che ci interessa è ben lontana da Balarm: è infatti quella annessa alla Sinagoga di Ezra di Fustat, il nostro Cairo, edificata nell’882 sul luogo dove si ergeva in antico una chiesa dedicata all’arcangelo Michele, sopravvissuta fino alla conquista persiana sasanide dell’Egitto da parte dello Scià Cosroe nel 616, riscoperta nel 1864 da Jacob Saphir; tra le migliaia di documenti che vi sono stati trovati, vi sono una serie di lettere che rivelano come vi fossero itinerari, utilizzati ogni giorni, che collegavano la Sicilia e la Palestina e che esisteva un trasferimento di fondi per il mantenimento della comunità ebraica a Gerusalemme, ma parlano anche di uno schiavo affrancato, del traffico ebraico della seta e della vendita di libri della sinagoga.
E tanti contratti, a testimonianza della prosperità della comunità, relativi al commercio di tessuti e capi di abbigliamento, lino e seta, miele, olio, cereali, spezie, pietre preziose e gioielli, zucchero, altri prodotti alimentari.
Essendo, oltre la proibizione di portare armi e l’obbligo di indossare un segno identificativo, gli ebrei, come i cristiani, dovevano pagare due tributi speciali: la gisia sulle persone e il kharag sui beni immobili. In più, ai tempi della repubblica islamica di Balarm, che a differenza dell’emirato Kalbita, applicava una politica economica protezionista, fu imposto loro il’ushr, imposta sulle importazioni.
Secondo una lettera della ghenizah indirizzata nel 1056 da un ebreo palermitano a Nehorai b. Nissim di Fustat, gli ebrei cercarono di evitare l’imposta: le autorità usarono spie, reclutate spesso tra le file dello stesso gruppo ebraico, per scoprire i trasgressori e imposero l’ushr anche ai residenti. La vicenda si concluse con l’arresto di numerosi ebrei palermitani, ma la lotta contro l’ushr continuò durante gli ultimi anni della dominazione musulmana.
E si può ipotizzare come, in analogia all’organizzazione comunale di Balarm, la comunità si cominciò ad amministrare tramite un consiglio generale, che era formato principalmente dai capifamiglia e che costituiva la base elettiva di un consiglio di maggiorenti, e un organo esecutivo costituito dai prothi, il cui mandato durava un trimestre.
Ovviamente, dinanzi alla minaccia normanna, la tassa fu abolita: in più a seguito del colpo di stato di Muhammad Ibn al-Ba‘bā‘, che abbatté la repubblica islamica, fu nominato naghid degli ebrei siciliani Zakkār b. Ammār al-Madīnī, che apparteneva ad una prestigiosa famiglia di mercanti, che venne integrato in questa sorta di signoria, sino alla conquista
Data la pessima fama che avevano i normanni, vi fu una sorta di fuggi fuggi generale in direzione Gerusalemme e Nord Africa da parte degli ebrei locali: però i normanni, che era molto più pragmatici della media dei loro contemporanei, cercò di tutelarli in ogni modo.
Riqualificò il rabat, diviso in due parti, Harat-abu-Himaz (Meschita vera e propria ) e Horat-al-Jahudin (Guzzetta, una sorta di espansione commerciale e industriale), in cui si giungeva attraverso la porta di Ferro, o porta Judaica, comunicante con il Cassero, dove vivevano la maggior parte delle famiglie ebraiche, compreso il Ponticello, la Via Calderai e la via del Giardinaccio, che a causa del torrente Kemonia, finiva spesso a mollo. Consegnò loro la moschea di Ibn Siqlab, definita dal mercante e viaggiatori di Baghdad Ibn Hawqal, una delle più grandi e belle della città, in modo che potessero fondare una nuova sinagoga, da cui prese il nome il quartiere, Meschita, e gli assegnò la responsabilità del tiraz, la fabbrica statale di tessuti di seta, annessa al palazzo dell’Emiro. In più ottennero il privilegio del monopolio della vendita dell’henné di Partinico.
Nel 1147 re Ruggero II conquistò Corfù, Cefalonia, Tebe e Corinto e il resto della costa bizantina fino a Malvasia (Monembasia) e gli ebrei di quelle terre furono deportati in Sicilia, principalmente per favorirne lo sviluppo economico: circa un secolo dopo la conquista normanna, così, secondo il racconto di viaggio di Beniamino da Tutela del 1165, Palermo contava 1500 famiglie ebraiche.
Così, il quartiere della Meschita si sviluppò nel tempo, tra alti e bassi, anche se sospetto che a Palermo gli ebrei se la passassero meglio che nella Roma Pontificia: accanto alla sinagoga, che doveva essere dove vi è il complesso del convento di San Nicolò da Tolentino, oggi in gran parte adibito ad archivio comunale, sorse la corte rabbinica, la scuola, l’ospedale per poveri e forestieri, che nell’Ottocento divenne un conservatorio per fanciulle e infine il miqweh, il bagno rituale obbligatorio sempre al di sotto del piano stradale e colmo d’acqua pura: di sorgente o di fiume o anche piovana — purché non fosse stata raccolta da mano umana con un recipiente — dove le donne si immergevano per purificarsi dopo il ciclo mestruale o il parto.
Il miqweh palermitano è stato identificato nel complesso di Casa Professa, sotto l’atrio di Palazzo Marchesi, in un luogo sempre attraversato dalle acque del fiume Kemonia. Il tutto circondato da case caratterizzate dallo sviluppo in altezza, per aggiunte successive, e la “gheniza”, in pratica un’incavatura nella porta d’ingresso, all’altezza dello stipite, in cui si conservava un piccolo rotolo con un passo della Bibbia.
Importante era anche il cimitero, dove i corpi venivano seppelliti nella nuda terra avvolti in un sudario: a Palermo il cimitero ebraico era fuori porta Termini, a metà dell’attuale via Lincoln.
Il rabbi Obadiah Yare ben Abraham, grande erudito e viaggiatore, che morì a Gerusalemme, così descrive la comunità ebraica nel Quattrocento, che riteneva la più grande d’Italia
Palermo è la più grande e principale città del reame di Sicilia. Vi sono 850 famiglie incirca, tutti raccolti in un solo quartiere, il migliore del paese. Sono poveri ed artigiani, fabbri in rame e ferro, facchini e lavoratori della terra. Sono disprezzati dai Gentili, perché sono vestiti in stracci e sono sporchi. Devono portare sul seno un segno di stoffa rossa, largo una moneta d’oro. I lavori forzati del re pesano su loro, perché sono costretti di fare tali lavori quantunque vengono chiamati per tirare a terra le barche, costruire dighe, e simili. Gli ebrei devono giustiziare i condannati a morte, e punire e torturare i condannati alla frusta e alla tortura. Vi sono molti informatori tra gli ebrei. Questo delitto è diventato lecito fra loro; informano l’uno sull’altro spesso, senza reticenza….
La sinagoga a Palermo è senza paragone nel paese e tra i popoli, e viene lodato da tutti. Nel cortile crescono le viti su pilastri di pietra. Non hanno pari: ho misurato una vite che aveva uno spessore di cinque palmi. Di là una scala porta alla corte di fronte alla sinagoga, circondato da tre lati da un portico, fornito di sedie per quelli che non vogliono entrare alla sinagoga per un motivo o l’altro. V’è un pozzo, distinto e bello. Sul quarto lato v’è il portale della sinagoga. L’oratorio è quadrato, quaranta su quaranta braccia. In oriente v’è un santuario. Una struttura bella di pietra come una cappella, perché non vogliono mettere i rotoli della Legge in un Aron. Ne mettono invece nel santuario, su una piattaforma di legno, con i loro astucci e corone su di loro, ed le pome d’argento e cristallo sullecolonne. Mi hanno detto che i ricami di argento, cristallo ed oro nel santuario avessero un valore di 4,000 pezzi d’oro. Il santuario è fornito di due uscite, al sud ed al nord. Due fiduciari, membri della comunità, curano le porte. In mezzo alla sinagoga v’è una torre di legno; li i hazzanim ascendono ad un desco per recitare le preghiere. La comunità ha assunto cinque hazzanim. Recitano il sabato e le feste con voci e melodie dolci. Non ho visto cose simili tra gli ebrei da nessuna parte. I giorni feriali pochi frequentano la sinagoga, un ragazzo può contarli. Vi sono molti vani intorno alla sinagoga, come p.e. l’ospizio con letto per gli ammalati ed i vagabondi forastieri da parti lontane; il miqweh; la grande e bella sala dei funzionari; dove amministrano giustizia e deliberano su affari pubbliche..
Però, come un fulmine a ciel sereno, giunse il 31 marzo del 1492 l’editto di Granada di vittoriosi Ferdinando ed Isabella di Spagna che espelleva degli ebrei da tutti i loro domini, compresa la Sicilia. La notizia costernò tutti i palermitani, qualunque fosse la loro religione.
Il 20 giugno 1492 gli ufficiali e i principali banchieri del Regno presentarono un memoriale a re Ferdinando, enumerando i danni all’economia siciliana, che la cacciata degli ebrei portava. Essi, pur dichiarando fedeltà al re, ritenevano loro dovere avvisarlo al tempo stesso delle gravi conseguenze che la partenza di un così importante elemento della popolazione dal punto di vista economico avrebbe potuto comportare. Secondo i loro calcoli la perdita per il giro d’affari della Sicilia sarebbe stata di addirittura un milione di fiorini all’anno, considerando anche che gli ebrei avevano un ruolo come artigiani, commercianti, professionisti e così via e che ci sarebbe stata altresì la perdita di tasse ed altre entrate di loro spettanza. Gli ufficiali chiedevano, dunque, almeno una proroga della data fissata per la partenza e il memoriale fu firmato da undici persone, tra cui il secreto ed il mastro portulano di Palero ed il mastro racionale della Sicilia, che compirono così un atto eccezionale e molto coraggioso, se contestualizzato nell’ “assolutismo” della Spagna medievale.
Ma nonostante proteste e petizioni, i cattolicissimi sovrani iberici non vollero sentire ragioni: allora il mastro portulano di Palero ed il mastro racionale della Sicilia, provarono a buttarla sul pietoso, dicendo che così avrebbero fatto morie di fame tanti poveri. Poi, mentendo spudoratamente, affermarono che in caso di sospensione del bando, tutti gli ebrei palermitani si sarebbero convertiti con entusiasmo al cristianesimo.
Neanche questo servì: di 35000 ebrei circa 9000 decidono di rimanere, mentre 26000 s’imbarcano alla volta di Napoli per prendere residenza a Istanbul, Salonicco Patrasso e Gerusalemme, dove già molte famiglie si erano trasferite in passato.
Al momento di andare via alcune famiglie erano debitrici di grosse somme di denaro alla nobile Cristina Di Salvo e, poiché non era possibile risolvere il debito in contanti, fu applicato un bando col quale si autorizzava a vendere i beni dei Giudei per soddisfare i creditori. Si concordò allora che trenta Ebrei, nominati dai loro capi e rappresentanti la Nazione Giudaica, cedessero alla nobildonna il cortile delle case, chiamato “Cortiglio della Meschita”, comprese le botteghe, situate nella zona tra la Via Calderai e la via Giardinaccio.
Dopo la loro partenza, la Meschita subì una sorta di damnatio memoriae: gli orti e i giardini furono soggetti nel tempo a una forte speculazione edilizia, che cambiò l’aspetto della zona. Nel 1600 la realizzazione della via Maqueda mutò l’aspetto civico della parte occidentale, a levante un altro taglio, praticato per la realizzazione della via Roma, nel 1922, distrusse la continuità interrompendo diverse strade che da monte portavano verso valle…
Così, alla fine, di tutto non rimangono che rari frammenti, che, come fantasmi, appaino all’improvviso passeggiando nel centro storico di Palermo


Una conversazione con Ray Bradbury: l’intervista integrale
Ray Bradbury, grazie ad opere come Fahrenheit 451 (edito in Italia col titolo Gli anni della fenice) e The Martian Chronicles (Cronache marziane), si è affermato nel tempo come uno dei più grandi autori di fantascienza della storia. Oggi vi presentiamo un’intervista del 2008 con Lawrence Bridges, considerata una delle migliori interviste mai fatte all’autore statunitense, dove si parla soprattutto di scrittura. Buona visione!


September 1, 2017
Anfiteatro Castrense
[image error]
Oggi Manu ha ottenuto un piccolo, grande risultato: è riuscita, con tutte le stampelle, ad andare dal parrucchiere. Può sembrare una sciocchezza, però, una settimana fa, sarebbe stato impossibile.
Mi riempie di gioia vedere come ogni giorno migliori, superando i suoi limiti: appena riusciremo a risolvere il problema della fisioterapia, mi ritornerà come nuova.
Così, per festeggiare, continuo a parlare del palazzo imperiale che era nella zona di Santa Croce in Gerusalemme. L’architetto che progettò il Sessoriano, dovendo soddisfare la richiesta di Settimio Severo di replicare in piccolo l’area del Palatino, dovette progettare anche un mini Colosseo,di pianta ellittica (metri 88 x 75,80).
Dato che l’imperatore era un committente tanto irritabile, quanto impaziente, l’architetto, per affrettare i tempi,fece costruire tutto in mattoni, tranne pochi elementi in travertino. Originariamente questo piccolo anfiteatro aveva due ordini di arcate tra pilastri: nel primo i fornici erano inquadrati da semicolonne corinzie, con il capitello in mattoni, mentre nel secondo i fornici erano affiancati da paraste. Il terzo, ricostruibile da disegni rinascimentali, era costituito da un muro pieno, nel quale si aprivano finestre e vi erano inserite alcune mensole sulle quali poggiavano le travi che sostenevano il velario, al pari del Colosseo.
Dall’anfiteatro aveva inizio un grandioso corridoio coperto, lungo più di 300 metri e largo 14,50, che sfiorava la grande sala più tardi trasformata nella chiesa di S.Croce in Gerusalemme e si spingeva fino al Circo Variano: resti di questo corridoio e del circo sono visibili in vari punti nella zona retrostante la basilica.
Eliogabalo, personaggio ambiguo, ma straordinariamente intelligente, la sua intuizione di basare il Potere sul Sacro è stata messa in pratica per secolo dal Papato, essendo appassionato di religione più che di ludi gladiatori, lo impiegò per la rappresentazione di noiosissimi drammi sacri, a cui doveva assistere tutta la corte. La quale, per vendicarsi, oltre a renderlo vittima di un colpo di Stato, ne infangò la memoria, trasformando un riformatore religioso in un dissoluto gaudente.
Dopo l’eliminazione di di Eliogabalo, l’Anfiteatro fu riportato al suo uso originale, finché non giunse il momento di costruire le Mura Aureliane. Per risparmiare tempo e denaro, l’Anfiteatro fu inglobato nel perimetro difensivo: Una metà dell’ellisse fu inclusa nelle mura, chiudendo le arcate del piano inferiore e alzando il piano superiore con un attico merlato. Al tempo stesso, affinché questa struttura risultasse più alta, fu abbassato il livello esterno di circa 2 metri.
Così, divenuta sede di una guarnigione degli equites singulares, una sorta di scorta a cavallo di mille uomini che accompagnavano in battaglia gli imperatori e a Roma ne garantivano la sicurezza.
Una delle loro due caserme, i Castra Nova, è sepolta sotto il pavimento della navata centrale di San Giovanni in Laterano, mentre l’altra, i Castra Priora, è sepolta sotto via Tasso.
Tra l’altro avevano la necropoli nell’area della proprietà imperiale “ad duas lauros” lungo la Via Labicana, l’attuale Villa De Sanctis, dove collaboro nell’organizzazione di Amarte.
Necropoli utilizzata sino IV secolo, quando il corpo fu sciolto da Costantino, dopo la battaglia di Ponte Milvio, essendosi gli equites schierati dalla parte di Massenzio; su questa, Costantino fece erigere la basilica di San Marcellino e il Mausoleo di Elena, la nostra Torpignattara.
Tornando a noi, proprio per la presenza di questa guarnigione, l’anfiteatro assunse il nome di Castrense, da Castrum.
L’Anfiteatro Castrense, ben conservato fino al terzo ordine fino alla metà del XVI secolo, fu ridotto al solo primo piano, per non essere un facile bersaglio per le artiglierei: un’arcata del secondo ordine è oggi visibile in via Nola, mentre della cavea non resta quasi nulla.
Intorno alla metà del Settecento, i resti dell’Anfiteatro furono utilizzati per la costruzione di nuovi edifici: sotto Benedetto XIV, fu demolito quanto rimaneva delle gradinate e il materiale ottenuto fu utilizzato per la costruzione delle facciate di Santa Maria Maggiore e di Santa Croce in Gerusalemme e alla ricostruzione della chiesa di San Marcellino e Pietro in Laterano.
Attualmente, dentro l’Anfiteatro, vi è lo splendido orto di Santa Croce in Gerusalemme


A Lavinium, sulle tracce di Enea
Ecco una proposta per “camminare nella storia” nei dintorni di Roma. Si tratta di una breve passeggiata – tra storia e mitologia – a Lavinium, sulle tracce di Enea.
Il lungo viaggio di Enea
 Memoria del bimillenario virgiliano
Memoria del bimillenario virgiliano
Virgilio compose il poema epico Eneide nel primo secolo avanti Cristo rielaborando antiche tradizioni letterarie e “riscrivendo” la storia di Roma. L’eroe Enea fugge da Troia, fonda una nuova città, Lavinium, considerata “metropoli” (città madre) dei Latini, dove custodisce gli déi portati da Troia e la memoria di nobili antenati da cui discendono la stirpe albana e la stessa Roma (non è casuale che anche la Storia di Roma di Tito Livio abbia inizio con lo sbarco di Enea nel territorio laziale). Il viaggio che porterà Enea da Troia al Lazio durerà ben sette anni. La prima tappa è in Tracia. Poi nell’isola di Delo…
View original post 804 altre parole


August 31, 2017
Circo Variano
[image error]
Oggi grande risultato! Manu è scesa al bar sotto casa per fare colazione… Cosa che una settimana fa, pareva impossibile…
Per festeggiare, continuo a parlare del Palazzo Sessoriano… Ora, a noi moderni può sembrare strano, ma le corse nel Circo avevano, oltre a una dimensione sportiva e ludica, anche una sacrale.
La corsa, infatti, rappresentava, nella visione cosmologica dell’epoca, il giro dei pianeti e della sfera delle stelle fisse attorno alla Terra… E il Magistrato o l’Imperatore che supervisionava i giochi diventava garante dell’ordine cosmico.
Così il Circo non era solo un spazio architettonico, ma anche uno dei simboli dell’Imperium: per cui, l’architetto a cui Settimio Severo diede l’incarico di progettare il suo buon retiro ad Spem Veterem dovette fare i salti mortali per costruire nell’area l’equivalente del Circo Massimo, il Variano, dal nome della famiglia di Eliogabalo.
Circo, completato da Caligola, grande appassionato di corse, che era addirittura più grande dell’originale ed orientato lungo l’asse est/ovest, con il lato curvo ad est ed i carceres, da dover partivano i carri, ad ovest.
La parte occidentale del circo, il lato della partenza dove si trovavano i carceres, è stato ritrovato all’interno delle mura, in pratica sotto il museo dei granatieri, mentre il lato orientale incurvato si trovava all’altezza di via Alcamo; il lato settentrionale del circo ha fornito poi il sostegno per l’ultimo tratto dell’Acquedotto Felice (1585-1589) che, nel tratto extraurbano fino alla congiunzione delle attuali via Ozieri e via Nuoro.
Eliogabalo, travolto dalle manie religiose, cambiò funzione al Circo, da luogo di corse di carri a sede di processioni. Ciò impatto anche sulla struttura architettonica del complesso: fu ridotta , rispetto al progetto originario, l’estensione del circo verso ovest arretrando i carceres e caratterizzandoli con due torri alle estremità, secondo la tipologia introdotta in quel periodo nel Circo Massimo. In questa fase, il circo aveva una lunghezza di m 547 circa.
In più, l’obelisco di Antinoo, quello del Pincio, per capirci, fatto trasportare dall’Egitto da Adriano ed eretto sulla via Labicana in onore dell’amante dell’imperatore che Settimio Severo aveva fatto spostare in modo che decorasse la spina del circo fu spostato fuori dalla struttura, o per significati simbolici, un richiamo al dio solare di Emesa di cui Eliogabalo era sommo sacerdote, o per fungere da decorazione dell’ingresso.
Dopo il colpo di stato contro Eliogabalo, il circo fu sfruttato per parate militari, finchè venne tagliato a metà, con la costruzione delle mura Aureliane, che lo rese inutilizzabile.
La cose cambiarono con la ristrutturazione di Massenzio e Costantino che riempirono il circo con ambienti di servizio, di collegamento e forse di residenza della servitù della corte imperiale. Poi, dopo la pestilenza del 590 d.C. fu tutto abbandonato, per essere ridotto nel Medio Evo a vigna del convento di Santa Croce in Gerusalemme, famosa per il vino, fornitrice della corte papale al Laterano


August 30, 2017
Sessoriano
[image error]
Oggi prima giornata di lavoro, meno traumatica del previsto, dato che i giorni scorsi, nonostante le ferie, mi ero portato avanti con la gare che stavo seguendo, per avere più tempo da dedicare a Manu.
Manu, che a quanto pare, grazie alla fascia elastica che le ha consigliato l’ortopedico, pare rinata… Così, per stasera, posso senza troppi problemi, parlare dell’estrema propaggine dell’Esquilino, la cosiddetta Spei Veneris, dal tempio edificato nel 477 a.C. per celebrare la vittoria della Repubblica Romana su Veio. Zona che coincide con la nostra Porta Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme. Sì ipotizza che fosse ben poco urbanizzata e che la speculazione edilizia promossa da Mecenate la impattasse in maniera molto limitata. La cosa cambio con Settimio Severo che decise di erigervi una dimora imperiale, una sorta di buen retiro per quando si era stancato degli affari del Palatino, acquistando la proprietà da Sesto Vario Marcello, padre di Eliogabalo.
Da quanto si riesce a capire dai bolli laterizi, la struttura severiana era costituita da una sala di rappresentanza, che poi diverrà Santa Croce in Gerusalemme, da un paio di padiglioni privati, da un portico dalle terme, forse ad uso pubblico, terminate poi da Alessandro Severo e dal Circo Variano, lungo 630 m e largo 125 m, più grande del Circo Massimo, completato da Caracalla, grande appassionato di corse di carri.
Quando salì al trono Eliogabalo, per ovvi motivi sentimentali, il complesso fu totalmente ristrutturato: ampliò i padiglioni privati, modificò il circo variano, accorciandolo e adattandolo a scenario per le processioni religiose di cui era grande appassionato, costruì l’anfiteatro castrense e raddoppiò le aule di rappresentanza, creando il cosiddetto Tempio di Venere e Cupido.
Tutto il palazzo si sviluppava per circa 12.000 mq. Il collegamento e l’unificazione tra i vari nuclei monumentali e residenziali e tra questi ed il parco era offerto da una lunga carrabile coperta, elemento caratteristico del giardino romano imperiale. L’inedita formulazione dell’associazione circo-palazzo proposta negli Horti Spei Veteris sarà ripresa più tardi nella Villa di Massenzio ed in seguito diventerà una costante dei palazzi imperiali tardo antichi, come testimoniato dai complessi palaziali di Antiochia, Milano, Tessalonica, Treviri e Costantinopoli.
Qui, secondo l’Historia Augusta, avvenne l’ammutinamento della guardia pretoriana, quando Eliogabalo ordinò l’assassinio di Alessandro Severo: ammutinamento che portò alla morte dell’imperatore.
Il palazzo, pur rimanendo di proprietà imperiale, fu trascurato nel III secolo, tanto che la sua struttura architettonica fu impattata dalle mura aureliane, che inglobarono l’Anfiteatro Castrense e il perimetro degli appartamenti privati dell’Imperatore e divisero a metà il circo variano.
Il tutto cambiò con Massenzio che decise di integrare in un unico complesso architettonico il palatium liciniani e lo spei veteris, lanciando una ristrutturazione globale dell’area, dando così origine al Sessorianum.
Nome dall’incerta origine: secondo alcuni proviene da “sedes” soggiorno, secondo altri dalle sfrenate attività sessuali degli imperatori, secondo altri ancora, deriverebbe da Sus sorianum, ovvero porco siriano, il soprannome dato ad Eliogabalo, nato in Siria, di cui Cassio Dione Cocceiano narrò
riservò una stanza nel palazzo e lì commetteva le sue indecenze, standosene sempre nudo sulla porta della camera, come fanno le prostitute, e scuotendo le tende che pendevano da anelli d’oro, mentre con voce dolce e melliflua sollecitava i passanti
Secondo ulteriori studiosi il nome deriva dal sessorium, un pupazzo su cui i gladiatori si allenavano nel vicino anfiteatro Castrense, oppure da consessus o palatium consessorianum, il luogo in cui si tenevano le riunioni plenarie, che dovrebbe coincidere con la nostra Santa Croce in Gerusalemme
Costantino, dopo la vittoria su Massenzio continuò i lavori, dando poi il palazzo in appannaggio alla madre Elena, che non voleva trasferirsi a Costantinopoli, la quale, oltre a commissionare una nuova decorazione dei padiglioni privati, simile a quella degli affreschi della domus faustae, ristrutturò le terme e trasformò una della aule di rappresentanza nell’Ecclesia Hierusalem , con una parte aperta al pubblico e una parte invece dedicata al culto privato della cappella imperiale.
Con la morte di Elena, il palazzo continuò a essere utilizzato: è probabile che vi abitasse Valentiniano III, che lo volle come sede del Sinodo convocato nel 433 da Sisto III, fosse sede del governatore ostrogoto, data che vi avvenne l’esecuzione di Odoino nel 500 e il concilio tenuto da papa Simmaco nel 510.
Con la conquista bizantina e il trasferimento della sede del dux nel Palatino, il palazzo fu però abbandonato: nella memoria collettiva rimase soltanto la valenza religiosa voluta da Elena


Alessio Brugnoli's Blog