Alessio Brugnoli's Blog, page 167
December 11, 2017
A la Renella
Era il 1960. Mio papà, all’epoca poco più che ragazzo, lavorava come muratore nell’impresa di famiglia. Dopo una lunga giornata di lavoro, dedicata alla calce, ai blocchetti e ai foratini, era andato a farsi un’onesta mangiata all’osteria. All’improvviso, tra un piatto di matriciana e un quartino di vino, sente una voce, in lontananza, intonare Chitarra Romana. Gli amici alzano le spalle, tanto è una delle solite serenate, pensano… Oggi desterebbero curiosità, ma all’epoca non facevano né caldo, né freddo… Mio papà però fa cenno di tacere
Il cantante non fa in tempo a finire la prima strofa
Sotto un mondo di stelle,
Roma bella mi appare,
Solitario il mio cuor,
Disilluso d’amor, vuol nell’ombra cantar.
Che tutta quell’orda di caciaroni si azzittisce… La canzone non fa in tempo ad arrivare a
O chitarra romana, accompagnami tu
che tutti quanti abbandonano coltelli e forchette e per mio papà, ancora più buona forchetta del sottoscritto, è stato un evento memorabile, e si fiondano a vedere la serenata. Due o trecento metri e si trovano davanti un ragazzotto di una ventina d’anni, che sotto la finestra di una prossima sposa, attaccava a memoria, senza alcuna incertezza e con tanta passione e voce, tutte le canzoni di Romolo Balzani.
Attaccano con gli applausi e poi, quasi con timidezza, chiedono a uno dei presenti
“Ma questo chi è”
“E’ ‘n’amico de Nino er Biondo. Lavora ai Mercati Generali. Se chiama Leopoldo”.
Fu il primo contatto tra la mia famiglia e Lando Fiorini. Da quel momento ci ha sempre fatto compagnia e gli associo tanti bei ricordi da quelli dell’infanzia, quando alle sagre di paese, con tutta la famiglia, nonni, zii, cugini d’ogni genere e risma, ci faceva compagnia con i suoi concerti in attesa della lotteria con una Fiat 126 come primo premio (e ogni anno era sempre la stessa… secondo me certe Pro Loco la facevano vincere a un biglietto falso, campandoci di rendita per anni). O quando, giuro, per sbaglio, mi imbucai ignobilmente dentro al Puff, con una tizia francese che aveva rimorchiato un mio amico (e lui rimase fuori). Lando mi sgamò, vide la mia espressione imbarazzata e si fece ‘na risata e invece di cacciarci a pedate, ci fece godere lo spettacolo….
Oppure le serate in trasferta, in cui mi faceva compagnia nei momenti di solitudine… Insomma, con lui se ne è andato un pezzo della mia vita e della Roma folle, contraddittoria, che nascondeva la malinconia dietro il suo ridere di tutti e di tutti, burbera, ma dal cuore grande.
E sarò scemo, non lo nego, ma mi sento dentro un poco più vuoto…


December 10, 2017
Rosellini, lo studioso
[image error]
L’Italia a inizio Ottocento, non esportava in Egitto solo grandi e affascinanti avventurieri, ma anche straordinari studiosi, il più famoso dei quali è stato Ippolito Rosellini.
Ippolito, Primogenito di Giovambattista, commerciante originario di Pescia, e di Angiola Biagetti, nacque a Pisa il 13 agosto 1800.
Il papà, per dare lustro alla famiglia e per fare contento uno zio arciprete, voleva avviarlo alla carriera ecclesiastica: per cui lo spedì prima a studiare presso i padri Serviti, a Pisa e Firenze, per poi iscriverlo nel 1817 a Teologia presso l’università di Pisa. Ippolito, più per senso per dovere che per passione, era uno studente diligente, finché cominciò a seguire le lezioni di Cesare Malanima, uno dei principali ebraisti dell’epoca: da quel momento in poi, nacque la sua passione per le lingue orientali
Millantando al papà di volere fare il missionario, dopo aver ottenuto la laurea in teologia (5 giugno 1821), si trasferì a Bologna per perfezionarvi lo studio delle lingue orientali con il celebre poliglotta Giuseppe Gaspare Mezzofanti.
Mezzofanti era un cardinale per caso: per le sue idee di sinistra era repubblicano, favorevole all’abolizione dello stato della Chiesa e dell’Unità d’Italia, sostenitore del divorzio e del diritto di sciopero, era considerato da Napoleone un pericoloso giacobino. In altre occasioni, il Papa Re lo avrebbe spedito a cacciare i sorci a Castel Sant’Angelo, ma Mezzofanti, oltre a una memoria degna di Pico della Mirandola, era un genio nell’apprendere le lingue.
Mezzofanti arrivò a scrivere e parlare pressoché perfettamente 38 lingue, tra le quali figurano l’ebraico, l’arabo, il neo-aramaico-caldeo, il copto, l’armeno antico e il moderno, il persiano, il turco, l’albanese, il maltese, il greco antico e moderno, il latino, lo spagnolo, il portoghese, il francese, il tedesco, lo svedese, l’inglese, il russo, il polacco, il ceco, l’ungherese, il cinese, il siriaco, il ge’ez, l’amarico, l’hindi, il gujarati, il basco, il rumeno. Possedeva con minor sicurezza un’altra quarantina di lingue (oltre a un numero imprecisato di dialetti), per un totale di 78 idiomi. E tra i suoi rimpianti figurava il
sanscrito, il malese, il tibetano, l’islandese, il lappone, il ruteno, il frisone, il lettone, il cornico, il quechua, il bambara: era in grado solo di leggerli, non di parlarli.
Insomma, dinanzi a un tale fenomeno, il Papa Re decise di fare finta di nulla sulle sue esternazioni politiche e di sfruttarlo sia come insegnante, sia come responsabile del Propaganda Fide. Conoscendo tale cardinale e il suo circolo di rivoluzionari da salotto (il fisico ed etruscologo Francesco Orioli, l’incisore Francesco Rosaspina, il barnabita Luigi Ungarelli) Ippolito, oltre ad acquisire simpatie progressiste e approfondire la sua conoscenza delle lingue del Vicino Oriente, capì che della vita ecclesiastica poco gli importava. Anche perché, a sempre a Bologna, scoprì la grande passione della sua
vita: le donne. L’aspirante arciprete, grazie anche al suo bell’aspetto, al suo eloquio affascinante e la suo fascino romantico da intellettuale, divenne uno dei principali don Giovanni della città felsinea.
In questo bailamme, a Mezzofanti capitò tra le mani un mattone, Mémoire sur les hiéroglyphes phonétiques, scritto da un certo Jean-François Champollion: gli diede una scorta, si grattò il capo, se ne uscì con un soccmel e chiamò Ippolito
Ragazuol leggi qui
Ippolito fece finta di ascoltarlo, per poi tornare a correre dietro alle panterone locali
Però, nel 1823 gli capitò tra le mani una traduzione del tomo di Champollion, fatta da Domenico Valeriani nell’Antologia di Firenze e di lì a poco l’articolo critico dello stesso Valeriani. Incuriosito, anche per non fare brutta figura con Mezzofanti, che nel frattempo era impegnato a convincere la famiglia Rosellini che è meglio avere in casa un buon professore, che un cattivo prete, cominciò a leggerlo, per arrivare a dare ragione al suo professore: quel diavolo di francese aveva risolto il mistero dei geroglifici.
Terminati gli studi, Ippolito rientrò a Pisa nel 1824, dove fu nominato, grazie all’intervento di Mezzofanti, professore, a soli ventiquattro anni, dapprima di lingue e letterature orientali, poi, dall’autunno 1825, anche di egittologia: i corsi, di taglio comparativo e appassionata eloquenza, attraevano un uditorio numeroso.
A tempo perso, visitava i magazzini del porto di Livorno, che, grazie a Belzoni e Drovetti, erano pieni di antichità egiziane: così, tra una sfinge e un canopo, concepì il sogno di recarsi nella terra dei Faraoni. Nel frattempo, si dedicò all’attività di pubblicista sul Nuovo Giornale dei letterati, nel quale non di rado espresse opinioni liberali, affrontando temi cari al Risorgimento, e sull’Antologia, polemizzando aspramente con chi non era convinto delle ipotesi di Champollion.
Inoltre scrisse anche un bignami, per dare massima diffusione delle idee del francese: alla fine del 1825, uscì sul “Nuovo Giornale dei Letterati” il suo libello Il sistema geroglifico del Signor Cavaliere Champollion il minore, dichiarato ed esposto alla intelligenza di tutti insomma, una sorta di geroglifico for dummy…
Libello che attirò l’attenzione dello stesso Champollion, che un pizzico di bonaria ironia lo recensì così
l’Italia aveva bisogno di questo per capirvi qualcosa. La pigrizia natia gli impedisce di leggere un grosso volume…!
Così, per curiosità, lo studioso francese, che era in Italia per visitare le collezioni egizie locali, decise di conoscere questo suo accanito fan: l’occasione fu la trattativa per l’acquisto della collezione Salt, conservata provvisoriamente a Livorno.
I due studiosi diventarono amici e Ippolito ottenne il permesso di accompagnare Champollion in giro per l’Italia: il francese insegnò il copto al toscano e questi, al contrario, lo rese edotto della lingua ebraica. Tra una sosta e l’altra, Ippolito parlò a Champollion del suo sogno di un viaggio in Egitto. Allo studioso francese, che era stato un sostenitore di Bonaparte, lo aveva anche incontrato nel 1810, brillarono gli occhi: così, entrambi decisero di convincere il proprio governo a replicare le imprese della commissione napoleonica
Idea che fece rizzare i capelli al fratello di Champollion che la commentò
Andare a cercare pietre in Egitto è faccenda dei Caillaud e dell’altra gente con gambe buone e stomaco buono
Il piano della spedizione, elaborato in comune dai due studiosi e presentato nel 1827 ai rispettivi governi, fu subito approvato in Toscana, inducendo così il riluttante Carlo X ad accordare a sua volta il proprio finanziamento. Per caldeggiare l’impresa, Ippolito se ne andò a Parigi, dove accadde un imprevisto: l’uomo pronto a infiammarsi per mille donne , così lo definiva Champollion, si innamorò di nella figlia del celebre compositore Luigi Cherubini, Zenobia, di cinque anni più giovane di lui.
Superando l’opposizione del suocero, a cui era arrivata la fama di donnaiolo di Ippolito, grazie all’appoggio della madre di Zenobia e di Gioacchino Rossini, i due giovani si sposano a Parigi il 30 ottobre del 1827. E contro ogni fosca previsione, la loro unione fu felice, con Ippolito che si trasformò in un perfetto marito e padre di famiglia.
La spedizione franco-toscana, partita con tredici membri da Tolone il 31 luglio 1828: degli italiani, oltre Ippolito, vi facevano parte suo zio l’ingegnere Gaetano Rosellini, addetto ai rilievi architettonici, il senese Alessandro Ricci, medico, dotato di gran talento artistico, già sperimentato negli anni di viaggio trascorsi in Egitto, Sinai, Nubia e Sennar, Giuseppe Angelelli,botanico, che aveva già partecipato a una spedizione toscana in Amazzonia, Felice Galastri… E Salvador Cherubini, cognato di Ippolito, che all’inizio fungeva da imbucato di turno, per diventare strada facendo il disegnatore ufficiale della spedizione
La spedizione trattenutasi in Egitto e Nubia fino all’autunno del 1829, gettò le basi della moderna egittologia: furono documentati centinaia di monumenti, testi, scene, che rappresentano oggi la testimonianza preziosa di ciò che allora era visibile e non sempre si è conservato. Il solo materiale della Commissione toscana, oggi conservato nella Biblioteca universitaria di Pisa, comprende circa 1400 disegni originali dei suoi pittori e 14 volumi manoscritti di osservazioni, copie di testi e appunti vari di Rosellini, in parte ancora inediti. Due distinte collezioni di antichità furono inoltre messe insieme, una per il Louvre (102 pezzi) e una per la Toscana (1878 pezzi), oggi nel Museo egizio di Firenze.
Dalla spedizione africana Rosellini, fortemente interessato anche agli aspetti antropologici ed ai problemi umanitari del continente, condusse con sé a Firenze anche una ragazzina nubiana, acquistata presso un mercato di schiavi al fine di liberarla, ribattezzata dal medesimo Nadezhda, ovvero Speranza, ed attualmente sepolta presso il Cimitero degli inglesi della città.
I due egittologi avevano concordato di pubblicare in comune l’opera, suddividendosi l’amplissima materia, ma il progetto non andò in porto: il 4 marzo 1832 Champollion morì e sulle spalle di Ippolito, rimasto suo unico continuatore ed erede spirituale, ricadde il peso dell’intero lavoro. Nonostante il dolore profondo per la morte dell’amico e la schiacciante responsabilità, Ippolito condusse a termine l’opera in dodici anni: i Monumenti dell’Egitto e della Nubia comprendevano 9 volumi in ottavo e 3 atlanti in folio massimo. L’ultimo volume apparve postumo.
E la stesura del lavoro, fu un dramma per Ippolito: da una parte vi era l’invidia e l’ostilità dei colleghi, dall’altra i problemi legati al suo impegno politico: entrò in contatto con Filippo Buonarroti e divenne probabilmente uno dei capi della Carboneria toscana. Anche se i suoi tentativi come rivoluzionario furono alquanto velleitari, Ippolito non si vergognò mai delle sue idee liberali: manifestò per le idee liberali. Un suo articolo di geografia, che toccava la questione a lui cara dell’Unità d’Italia, pubblicato nel giornale L’educatore del povero (poi chiuso d’autorità nel 1833 dal granduca, su pressione dell’Austria), era incorso nella censura governativa. Allo stesso modo, non mancò mai di offrire il suo sostegno agli esuli politici, come mostra la corrispondenza con l’amico Orioli o con Alessandro Poerio.
Durante uno dei tanti viaggi di studio in Egitto, contrasse una forma di malaria incurabile. Morì prematuramente il 4 giugno del 1843 a Pisa, dove venne sepolto presso il Camposanto monumentale del Duomo, che accoglie le spoglie di molti altri docenti del prestigioso ateneo cittadino.
Gaetano Rosellini donò una piccola parte della collezione privata del nipote a Carlo Lasinio il quale allestì nel cimitero monumentale del Duomo un vero e proprio al museo a cielo aperta. Questi reperti nel 1986 furono trasferiti nell’appena fondato museo del Duomo. Un’altra parte della collezione venne lasciata in eredità alla nipote Laura Birga che la donò all’università di Pisa e andò a costituire il primo nucleo delle collezioni egittologiche dell’Università, visitabili ancora oggi in via Freddiani 12


December 9, 2017
Il simpatico neutrino
[image error]
Per l’angolo della fisica per scrittori di fantascienza, oggi parliamo di una particella tanto anarchica quanto antipatica ai grillini: il buon vecchio neutrino, che ogni tanto, per la sua mania di protagonismo e l’insipienza di giornalisti e politici italiani, fa capolino nei titoloni dei giornali.
Come forse sapete, la teoria quantistica dei campi è descritta tramite il cosiddetto modello standard, un accrocco tanto complicato, contiene infatti ben 19 parametri liberi, come le masse delle particelle e le costanti di accoppiamento, che devono essere determinati sperimentalmente, ma le masse non possono essere calcolate indipendentemente l’una dall’altra, segno che sono legate da una qualche relazione non prevista dal modello, quanto efficace nelle previsioni, che ci beccano quasi sempre.
Il quasi ahimè è legato al nostro neutrino: secondo il modello standard, infatti, non dovrebbe avere massa, ma lui, fregandosene altamente delle nostre teorie, ce l’ha. La questione è legata alla strana abitudine di questa particella di cambiare identità: ne esistono infatti tre varietà, gli elettronici, i muonici e i tauonici. Le differenza il modo in cui il neutrino interagisce con gli atomi dei rivelatori: a seconda che emetta un elettrone, un mesone e un tauone (questi due sono i cugini più pesanti degli elettroni) avremo un diverso sapore.
Una quindicina di anni fa i fisici scoprirono che, propagandosi nello spazio, un neutrino poteva cambiare sapore: uno che partiva in un modo, poteva mutare in maniera casuale in un altro. A quanto pare questa particella è costituita, invece che di uno, come tutte le altre particelle, di ben tre diversi possibili stati di massa, che viaggiano nello spazio a velocità diverse: a secondo dell’ordine in cui arrivano all’osservatore, avremmo uno dei tre diversi sapori.
Beh, come sono questi “stati di massa” ? Ci sono due ipotesi: la prima che viene definita gerarchia normale, prevede due stati di massa leggeri e uno pesante. L’altra, che con molta fantasia viene chiamata inversa, ne prevede due pesanti e uno leggero. Embè, che cambia ? Il modo in cui i neutrini mutano di sapore.
Appurato che i neutrini abbiano massa, il problema è come la ottengano, visto il loro rapporto conflittuale con il buon bosone di Higgs. Ora, particelle normali la ottengono interagendo con il campo di Higgs: però questo funziona solo con le particelle di cui esistono una versione destrorsa e sinistrorsa, cosa che non ha nulla a che vedere con la politica, ma dal modo in cui è orientato il loro spin rispetto alla direzione di movimento.
Ahimè, i neutrini, e ti pareva, sono solo sinistorsi: per cui, nell’ipotesi che esistano anche i destrorsi, questi sono degli asociali che non vogliono interagire con tutte le altre forze e particelle dell’universo, cosa che ai fisici pare poco probabile. Al contempo, se i neutrini ottenessero la massa dal campo di Higgs, la loro massa dovrebbe essere molto più elevata di quella attualmente stimata.
Per cui, vi sono due possibilità: o i neutrini ottengono la massa dall’interazione da un altro campo, connesso a un bosone diverso da quello di Higgs, ancora da identificare, oppure il neutrino è una particella di Majorana, in cui una particella coincide con la sua antiparticella.
Questo perché il neutrino è elettricamente neutro: la carica elettrica è infatti il principale attributo che distingue la particella dall’antiparticella. Per esempio, l’elettrone ha carica negativa, mentre il positrone, la sua antiparticella, l’ha positiva.
Per cui, il neutrini avrebbe un’ulteriore oscillazione di “identità”, passando da antineutrino a neutrino. Gli antineutrini sarebbero quindi dotati di una massa molto grande, ma allo stesso tempo instabile a tal punto da trasformarsi rapidissimamente in una massa minuscola, il neutrino. Le due particelle sarebbero dunque in una sorta d’altalena tra masse e forze che porta sempre la massa più piccola in alto, ovvero ad emergere.
E questa prevalenza, spiegherebbe il perchè vi sia in giro più materia che antimateria, dato che questa oscillazione può essera avvenuta ai tempi del Big Bang. Il problema è come verificarlo ? O si verifica il realizzarsi di un particolare fenomeno, il doppio decadimento beta senza neutrini, un nucleo atomico decade in un altro con stesso numero di massa, senza emettere neutrini, che può avvenire solo nel caso di neutrino di Majorana, oppure si verifica l’esistenza degli asociali neutrini destrorsi, il che potrebbero essere a loro volta pesanti e la cui esistenza, renderebbe ridondante tale ipotesi
E l’esperimento SOX ha proprio questo scopo… Così l’ignoranza e la demagogia grillina sta ostacolando l’umanità nella comprensione dei misteri dell’Universo..


Alita: Angelo della battaglia, il primo trailer in italiano del nuovo film di Robert Rodriguez
Alita: Angelo della battaglia (Alita: Battle Angel) è uno dei film di fantascienza più attesi del 2018. Il film del regista Robert Rodriguez, con la produzione di James Cameron, è l’adattamento del popolarissimo manga di Yukito Kishiro. Alita è un cyborg che, non avendo alcuna memoria del suo passato, dovrà capire chi è e qual è il suo obiettivo.Alita: Angelo della battaglia sarà distribuito dalla 20th Century Fox nelle sale americane a partire dal 20 luglio 2018.


December 8, 2017
Contro il tribalismo romano
[image error]
Come sapete, nei mesi scorsi sono stato in prima fila nella difesa del progetto del Campidoglio di sostituire le lampade al sodio ad alta pressione con i Led. Progetto ideato da Marino e portato avanti dalla Raggi, che, specie nel I Municipio, ha avuto un’opposizione tanto rumorosa, quanto poco consistente in termini di numeri e di argomenti, che andavano da opinabili considerazioni storico estetiche, a quanto pare vi è una sorta di amnesia collettiva sull’illuminazione a Roma a inizio anni Ottanta, a complottismo di bassa lega, a interessi personali, l’apparire sui media per raccattare qualche voto alle prossime elezioni municipali.
L’esperienza mi ha reso consapevole di quanto sia difficile, per qualsiasi problema che tocca la vita dell’Urbe, discutere in maniera razionale, specie se questi riguardano la tecnologia: da una parte, come diceva il buon Asimov, vi è, specie in ambito grillino
la falsa nozione che la democrazia significhi che la mia ignoranza vale quanto la tua conoscenza
Il che, specie nel campo nella polemica sui Led, ma potrei anche parlare della questione smart city, ha portato a porre sullo stesso piano un distributore di gazebo, che tra l’altro fa anche il distributore di lampade a induzione magnetica, insomma con un piccolo conflitto di interessi, e un professore universitario di illuminotecnica.
Dall’altra l’idea che la tecnologia non sia un qualcosa di neutrale, da valutare in un’ottica di costi e benefici, ma come un qualcosa che mina in profondità la loro visione del mondo, la loro ideologia. Perché, purtroppo, come conseguenza dell’americanizzazione della politica voluta da Berlusconi, viviamo in una società, in cui vi è un’ampia maggioranza silenziosa e abulica e minoranze fortemente polarizzate.
E la polarizzazione implica tribalismo, un’adesione irriflessa e indiscussa ai dogmi imposti dalla parte politica a cui si simpatizza. Tribalismo che domina soprattutto suoi social media: faccio un esempio, relativo a un’altra polemica in cui sono invischiato.
Se la Raggi fa costruire una pista ciclabile, per un aborigeno grillino deve essere fatta bene a prescindere: se qualcuno vive il territorio ed evidenzia i problemi di quanto realizzato, è assoldato dal PD. Se poi i fatti danno ragione a chi si lamente, beh, allora la colpa è del sabotaggio eseguito dal Municipio
In una situazione del genere, il metodo tradizionalmente utilizzato nella comunicazione tecnica e scientifica, il deficit model, dite i fatti e questi basteranno a convincere l’interlocutore, non serve più. Bisognerebbe distinguere tra maggioranza silenziosa, che vorrebbe capire perché è stata adottata una soluzione invece di un’altra e come procedere, dai tribalisti.
Per la prima, bisognerebbe capire quali sono i loro valori, le loro paure, la loro storia, per individuare il tipo di linguaggio più adatto per rendersi comprensibili, spiegando vantaggi, svantaggi e impatti. Con i tribalisti, cambia tutto: loro reagiscono in maniera emotiva, perché temono per la loro identità. Se qualcuno mette in dubbio la sua posizione, è una minaccia. Bisogna affrontarli a muso duro, sbattendogli in faccia la loro ignoranza, non per convincerli, tanto è fiato sprecato, ma per mostrare agli altri che vi sono risposte ai loro dubbi…


December 7, 2017
Haring in Rome
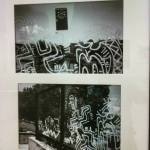


Come spesso evidenziato in questo blog, sono sempre preoccupato dall’ideologia del decorismo, specie quando a nutrirla è un’abissale ignoranza. Un caso emblematico, che dovrebbe rimanere nel cervello degli amministratori capitolini, ma che spesso cade nel dimenticatoio, riguarda le vicende dei graffiti dei Keith Hating.
L’artista newyorchese ha realizzato diverse opere in Italia: il murale monumentale Tuttomondo a Pisa, la decorazione del negozio di Elio Fiorucci a Milano, un intervento su un cartellone pubblicitario a San Babila, forse il murale alla Casa dello Studente a via del Laghetto…
E ben due interventi a Roma: un murale al Palazzo delle Esposizioni e uno sul ponte Pietro Nenni della Metro A. Inoltre, leggenda metropolitana vuole, ma non ha alcun fondamento, che abbia dipinto un muro a via Giolitti….
Il primo murale, realizzato a Via Milano, era dipinto in rosso vivo, per ricordare come ogni civiltà sia basata sul dolore e sul sangue. Il secondo, in acrilico bianco, una metafora del travertino con cui è costruita Roma, che si logora, ma persiste nel tempo, come questa folle e caotica città.
Ebbene, che fine hanno fatto queste opere ? Sono finite al Macro o vendute a qualche ricco collezionista ? Nulla di tutto ciò. L’opera a Palazzo delle Esposizioni fu cancellata in occasione della visita del presidente russo Gorbaciov a Roma nel 1992, come se poi gliene fosse importato qualcosa, mentre quella sulla metro A fu fatta cancellare addirittura nel 2000, quando Haring era già strafamoso, perché occultava la vista del Tevere.
Per cui, alcuni retakers o la Campanini, non nascono dal nulla… Sono figli di una mentalità piccolo borghese, con un’idea ristretta del Bello e della legalità, che alberga nella burocrazia e nell’amministrazione capitolina e che genera dei nuovi barbari, impegnati a distruggere, per un ipocrita senso del decoro, la memoria comune


December 6, 2017
Tornando a San Polieucto
[image error]
Premesso che sono un sostenitore dell’ipotesi tradizionale, ossia che la decorazione di San Polieucto sia made in Costantinopoli, anche perché altrimenti non si spiegherebbero i motivi decorativi di ispirazione sasanide, approfittando del ritrovamento a Venezia di un altro pezzo di tale chiesa, torno a parlare dell’ipotesi di Kalemin, che invece afferma una sua origine romana, in particolare, da un’officina di lapicidi con sede al Sessoriano, ossia all’Esquilino.
Una delle obiezioni più sensate a questa ipotesi è la seguente: come è possibile che una bottega di artisti attiva all’incirca dall’età teodoriciana fino a Gregorio Magno, abbia lasciato tracce solo a Costantinopoli e non in zona ?
Kalemin, reinterpretando in maniera creativa le ricerche di Eugenio Russo, si è messo di buzzo buono, per trovare nel nostro rione queste benedette tracce… E secondo lui, le avrebbe trovate. ll primo argomento che porta a favore della sua tesi, sono i capitelli del ciborio e le transenne dell’altare che il presbitero Mercurio, che divenuto papa, fu il primo a cambiare nome, assumendo quello di Giovanni, fece erigere in S. Clemente a Roma al tempo di papa Ormisda.
Entrambi decoravano la chiesa sotterranea: quando questa fu abbandonata, dopo il sacco normanno, furono riutilizzati. Il capitello, in cui si legge l’epigrafe MERCVRIVS PB SCE ECclesiae romanae servuS DNI, servì per decorare il monumento funebre del ricchissimo cardinale Antonio Jacopo Venier (tra l’altro titolare anche di San Vito e Modesto), scolpito da un seguace di Mino da Fiesole.
[image error]
La transenna, con l’iscrizione ALTARE TIBI DEVS SALVO HORMISDA PAPA MERCVRIVS PRESBYTER CVM SOCIIS OF(fert) fu invece utilizzato come materiale di costruzione dell’ambone. Dalle analisi e ricerche di Kalemin, sembrerebbe come entrambi gli elementi scultorei siano stati realizzati nel marmo di Luni, invece che in quello del Procanneso, per cui non possono essere stati realizzati a Costantinopoli. Inoltre, la loro datazione dovrebbe coincidere con il 522 d.C. Ora, se diamo per buona la data del 524 d.C. per l’inizio dei lavori di ricostruzione da parte di Anicia Giuliania della basilica di San Polieucto, la decorazione di San Clemente potrebbe considerarsi una sorta di prova generale del magnus opus costantinopolitano.
Kalemin, poi prosegue la sua analisi, paragonando i plutei e i pilastrini fatti realizzare sempre dal buon Mercurio, appena eletto nominato nel 535 d.C., caratterizzati dalla presenza del monogramma di Giovanni II rispetto alla Croce, a quelli coevi fatti scolpire da Giustiniano per Santa Sofia.
Dal loro confronto, ritiene come la decorazione della basilica romana sia indipendente dal modello bizantino, avendo come base la rivisitazione dei monumenti classici dell’Urbe, piuttosto che l’influenza stilistica siriana; in più ha ipotizzato come le stesse maestranze abbiano lavorato sia a San Cosma e Damiano, sia un pulvino conservato nella catacomba dei Santi Marcellino e Pietro, ricavato da un blocco di reimpiego d’un’iscrizione monumentale.
Catacomba, che ricordiamo, dipendeva dal titulus Eusebii e che quindi aveva sempre a che fare con l’Esquilino… Quindi il buon Kalemin ha ragione ? Il fatto è che, come testimoniato dal relitto di Marzamemi, che proveniva da Costantinopoli e trasportava materiali recuperato di una basilica tardo antica (ventotto basi di colonne, ventisette capitelli corinzi e colonne monolitiche di marmo proconnesio) e ad un ambone (in marmo cosiddetto “verde antico”, proveniente dalle cave greche di Larissa in Tessaglia), all’epoca di Giustiniano il commercio da Oriente a Occidente di marmi semilavorati fosse molto diffuso.
E nulla vieta che a destinazione, vi fossero degli scalpellini, più o meno abili, capaci di dare il tocco finale… Questo poteva valere anche per Roma… Ipotizzare il contrario, però, ossia un commercio da Occidente a Oriente, è ancora poco fondato


December 5, 2017
Cadorna
[image error]
In questi giorni, per il centenario di Caporetto, si è tornato a parlare di Cadorna: come sempre succede in Italia, in cui tutti sono commissari tecnici, ministri e grandi generali, ci si divide tra chi lo disprezza a prescindere, la maggior parte, e qualcuno che lo difende a spada tratta. La realtà, come sempre, è nel mezzo, con le sue luci e ombre e probabilmente la maggior parte degli strateghi da tavolino di questi giorni, messe nelle stesse condizioni, non avrebbe fatto di meglio.
Cadorna era un uomo dell’Ottocento, testardo come un mulo, poco diplomatico, incorruttibile e dal grande sangue freddo: cosa che molti ignorano, era cultura smisurata in tutti i campi compresa la storia dell’arte, aiutato anche da una memoria fuori del comune (recitava la Divina Commedia a memoria); parlava il francese come l’italiano. Amava la montagna e conosceva tutta la linea del fronte che aveva anche dipinto in vari acquerelli.
Quando fu nominato al posto di Pollio, era alla soglia dei sessantuno anni, non aveva ancora ricevuto alcun comando operativo su teatro di guerra. Così, provo di esperienza, si trovò catapultato nel mezzo della Grande Guerra.
Il primo problema che dovette affrontare fu la Politica: a differenza della Francia, della Russia e della Germania, in cui le sue ragioni erano subordinate a quelle dei generali, cosa che fece precipitare gli eventi nel 1914, in Italia accadeva il contrario. Cadorna sapeva che avrebbe dovuto combattere, ma non contro chi e quando. Così, lui che dal 1912, quando era stato messo a capo della seconda armata, di stanza a Genova, si era dedicato all’approntamento delle fortificazioni della frontiera con la Francia e allo studio della cooperazione tra fanteria e artiglieria, che gli appariva necessaria per lo sfondamento delle difese nemiche, in pochi mesi dovette ridisegnare da zero tutti i piani di guerra.
In particolare, i negoziati con l’Intesa, avviati il 4 marzo, i negoziati si protrassero sino al 26 aprile, mentre l’incertezza che regnava allora nei circoli politico-diplomatici, conseguenza di una condotta improntata a simili criteri opportunistici, determinò un significativo ritardo nell’emanazione dei primi ordini di mobilitazione
Dopo le prime disposizioni per una mobilitazione parziale e puramente cautelativa, soltanto il 5 maggio Cadorna venne esplicitamente informato da Salandra della necessità di una mobilitazione generale, nella prospettiva di scendere in guerra contro l’Austria-Ungheria entro il giorno 26 dello stesso mese.
L’articolo 2 del Patto di Londra, firmato da Salandra (ma garante il Re) all’insaputa di Cadorna, obbligava l’Italia a tenere impegnati gli austriaci con tutte le proprie risorse. Di fatto poneva quindi l’esercito italiano alle dipendenze del comando alleato che ne richiese l’impegno ogni volta che i tedeschi attaccavano il fronte francese, il che limitava di molto la libertà operativa di Cadorna, come successe in occasione di Caporetto.
Il secondo problema era tattico-organizzativo: l’approccio prussiano di Pollio, con le sue manovre avvolgenti e a tenaglia, presupponeva un elevato livello di addestramento dei soldati e dei sottufficiali, ufficiali di notevole preparazione e un terreno adatto: per la cronica mancanza di fondi, i primi due requisiti non erano mai stati soddisfatti, portando a meschine figure in Libia. Per la seconda, le Alpi e il Carso non permettevano la stessa mobilità e flessibilità tattica delle pianure polacche e del nord della Francia.
Per trovare un’alternativa, serviva del genio: Cadorna, nonostante i suoi guizzi di creatività, non ne aveva, come d’altra parte Joffre, Haig e Nivelle. Le sue idee erano differenti da quelle dei generali suoi contemporanei: dalla dottrina francese incentrata essenzialmente sull’elan, sino alla massima austriaca del «Vorwärts bis in den Feind» (“Sempre e in ogni caso avanti fino al nemico”).
Cadorna nel suo “libretto rosso” si diceva convinto che un movimento offensivo si sarebbe sempre risolto in un attacco frontale, reso costosissimo dalle moderne armi se non ben preparato e condotto; riteneva però che il coordinamento delle varie armi, lo sfruttamento del terreno da parte delle catene di tiratori avanzanti e una fredda determinazione del comandante avrebbero permesso di effettuare con successo anche un attacco frontale. Erano però necessari comandanti autorevoli, quadri affiatati, truppe disciplinate: e appunto all’istruzione dei reparti era dedicata l’ultima parte, in cui si
raccomandavano esercitazioni di quadri a partiti contrapposti sul terreno e sulla carta.
Le stesse conclusioni a cui erano arrivati i generali tedeschi: solo che loro queste cose le avevano, noi no. Per averle, Cadorna cominciò dalle cose più facili: conoscendo i suoi polli e memori delle figure da cioccolatai compiute negli anni precedenti a causa di generali impegnati nel battibeccare tra loro, accentrò su di sé il comando; in più, non avendo questo grande carisma, si convinse che il modo migliore per non fare cadere nel caos le sue truppe, era imporre una disciplina ferrea.
E la situazione oggettiva non lo aiutava: Pollio gli aveva lasciato nelle mani un esercito da operetta, sulla carta moderno ed efficiente, nella pratica un manicomio: la mancata istruzione delle reclute di terza categoria obbligava al richiamo di ben 13 classi di leva per reperire gli organici di soldati da inviare in prima linea, con un aggravio di tempi tutto a favore del nemico; la milizia mobile, prevista nell’ordinamento dell’Esercito, non era neppure stata costituita; l’artiglieria da fortezza non era in numero sufficiente per armare tutte le opere terminate e dichiarate operative; in caso di mobilitazione
generale solo alcuni Corpi d’armata avevano aggiornato la lista dei quadrupedi da precettare; dei 36 reggimenti di artiglieria da campagna previsti sulla carta, 5 non erano ancora costituiti e 5 erano in fase di completamento; delle 86 batterie di cannoni da 75mm modello 1911 – Deport – di cui era prevista l’entrata in servizio già nel 1913, solo 12 erano costituite nel 1914; per le batterie da montagna non era stato ancora previsto il materiale, mentre i reggimenti pesanti campali avevano gli obici ma non i cannoni.
Per il tipo di guerra che si andava delineando, era grave anche la situazione delle sezioni di mitragliatrici: la dotazione sulla carta era di una sezione di mitragliatrici per battaglione di fanteria dell’Esercito permanente, una per ogni Reggimento di milizia mobile e per ciascun Reggimento di cavalleria, e due avrebbero dovuto essere pure le sezioni per ogni battaglione alpino; in realtà in caso di mobilitazione si poteva contare solo su 150 sezioni di mitragliatrici per tutto l’Esercito.
Anche l’istruzione militare era carente per la scarsità di poligoni e campi di addestramento, che rendeva difficoltoso il richiamo per istruzione di soldati già congedati. Ciliegina sulla torta, visto che per la Triplice Alleanza dovevamo fare la guerra alla Francia, le carte geografiche del territorio austriaco erano vecchie e di scala molto grande, e non ne esistevano di particolareggiate. In più, mancavano collegamenti ferroviari dedicati alle tradotte militari e nelle stazioni di confine era inadeguato il numero di binari per la sosta dei treni in arrivo e partenza
Cadorna, con un inaspettato talento organizzativo, riusci a rendere questo bordello un dignitoso strumento bellico. E fece questo con un’energia implacabile, facendo pulizia, esonerando 206 generali e 255 colonnelli, organizzando una logistica dignitosa, e ampliando l’organico: i 548 battaglioni di fanteria del 1915 diventavano 867 nel 1917, con un armamento immensamente superiore, con 3.000 pezzi di medio calibro invece di 246 e 5.000 di piccolo calibro invece di 1.772.
Il terzo problema era strategico e qui Cadorna poteva fare ben poco: le Alpi sono quelle che sono e nonostante la buona volontà del Duca d’Abruzzi, la marina non poteva garantire la superiorità sul nemico, né l’esercito era attrezzato per gli sbarchi in grande stile. L’unica possibilità era l’Isonzo.
In parallelo, scontrandosi sia con la politica italiana, ancorata a un’ottica risorgimentale e ai comandi alleati, che non riuscivano a guardare oltre le Fiandre, aveva ottica globale del conflitto. Avrebbe voluto ridurre le forze italiane in Libia e Albania e accrescerle in Macedonia, dove potevano rappresentare un reale pericolo per il nemico. Era pure favorevole al più stretto coordinamento con gli eserciti alleati, cercando nel 1915 l’appoggio dei Russi e dei Serbi, scatenando più di una offensiva concordata con gli Anglo-francesi, proponendo nel 1917 il concentramento degli sforzi dell’Intesa contro l’Austria-Ungheria, punto debole della coalizione nemica.
Cadorna, a differenza di quanto si dice, era uno dei pochi generali della I Guerra Mondiale ad avere capito la guerra moderna, la Materialschlacht, naturale conseguenza della guerra di logoramento indotta dall’avvento delle trincee. Anche in questo caso il ragionamento sotteso alle decisioni di Cadorna seguiva una semplice logica quantitativa (in relazione alla qualità delle truppe, alle caratteristiche del terreno, alla situazione logistica ed alle alleanze), basata sull’approccio che prevedeva maggiore potenza di fuoco per scalzare trinceramenti sempre più estesi e profondi.
Strategia che però, per essere implementata efficacemente, aveva necessità di una base industriale che l’Italia non aveva: dovendo fare le nozze con i fichi secchi, all’inizio dovette basarsi con cinismo sulla massa umana, contando nella maggiore capacità italiana di sopportare le perdite.
Con il tempo, come già detto, fu progressivamente sostituita dalla potenza di fuoco: questo approccio stava portando l’Austria-Ungheria alla disfatta in virtù della semplice disparità delle forze in gioco: già all’epoca della conquista di Gorizia, Cadorna aveva appena cominciato a intaccare le proprie riserve umane, mentre gli austro-ungarici dovettero in quel momento fronteggiare la prima seria crisi dall’inizio delle operazioni.
All’indomani dell’undicesima battaglia dell’Isonzo la situazione austriaca si era fatta disperata, con il solo monte Ermada rimasto ormai a sbarrare il passo all’avanzata italiana attraverso il Carso in direzione di Trieste: la resistenza era giunta a un punto di rottura, e proprio tale evidenza indusse l’Alto Comando tedesco a concedere infine gli agognati rinforzi che portarono alla costituzione della XIV Armata in vista di quella programmata offensiva di alleggerimento.
Di fatto Caporetto fu l’inaspettata conseguenza della sua visione strategica…


Liquid Television: tutti i cartoni MTV degli anni ’90 disponibili gratis online
Liquid Television ha segnato una generazione: i suoi programmi trasmessi su MTV fra il 1991 e il 1994 – Beavis and Butt-head così come cartoni Sci-Fi rivoluzionari fra cui Æon Flux, diventato poi anche un film con Charlize Theron – sono diventati dei classici. Ora, per il piacere dei nostalgici, tutti i programmi di Liquid Television sono disponibili gratuitamente su Internet Archive. La pagina del download si può raggiungere cliccando qui. Buon divertimento!


December 4, 2017
Modello Elladico
[image error]
Gli scavi compiuti a Santorini da parte del grande archeologo Spyridon Marinatos hanno portato, nel corso degli anni a definire quello che è stato definito, scherzando, il modello standard elladico.
Modello che dice presappoco così: la pacifica civiltà minoica dominava i commerci del Mediterraneo Orientale, protetta dalla sua flotta dagli invidiosi e rozzi micenei. All’improvviso, però, scoppiò il vulcano di Thera, che distrusse tutte le navi cretesi e mise in crisi la civiltà neopalaziale. Di questo che approfittarono i Micenei, che conquistarono Creta, civilizzandosi.
Grazie a una serie di complicati calcoli basati sulla cronologia egiziana, fu stimato come tale eruzione avvenisse intorno al 1450 a.C. Il che pareva confermato anche da una serie di dati storici e archeologici: il fatto che le tombe della necropoli dei guerrieri cominciassero ad essere scavate e utilizzate intorno al 1430 a.C. (che data la somiglianza con quelle a tholos del Peloponneso, faceva ipotizzare che fossero utilizzate da invasori provenienti dalla Grecia), la datazione delle tavolette in lineare B della sala dei carri a Cnosso, risalenti al 1400 a.C., che faceva pensare come all’epoca non fosse più utilizzata la lineare A e si parlasse miceneo, invece che la lingua locale, e le vicende, narrate nelle tavolette ittite, di Attarsiyya di Ahhiyawa che, avendo conquistato Cipro nel 1420 a.C., implicava come le talassocrazia minoica fosse sostituita da quella micenea.
Chi provava a proporre un’interpretazione alternativa, magari facendo notare come i defunti del circolo B e A di Micene non sembrassero così rozzi e povere, ma dei leader potenti, in contatto con l’Egitto, l’Anatolia e il Medio Oriente, veniva guardato con sufficienza.
Però, questo modello, che era semplice e sintetico, è andato progressivamente in crisi, a causa proprio dell’archeologia. Il primo, pesante attacco è venuto dalla datazione dell’eruzione: a seconda che si prenda come riferimento il radiocarbonio, la dendrocronologia e la datazione delle ceramiche cipriote, questa varia tra il 1650 a.C., il 1627 a.C. e il 1570 a.C. Date, tranne l’ultima, compatibili con la crisi minoica che porta al passaggio dal Protopalaziale al Neopalaziale, ma di certo molto precedenti alla presunta invasione micenea.
Inoltre, analizzando i resti ossei dei defunti della necropoli dei guerrieri, sia dal punto di vista genetico, sia da quello degli isotopi, è risultato come questi non fossero di origine greca, ma minoico doc. Il che ha portato a reinterpretare i corredi funebri non in termini di discontinuità, ma in quelli di evoluzione della tradizione locale.
Poi, rileggendo le tavolette delle sala dei carri, sono apparsi una serie di “errori e peculiarità” che inizialmente hanno fatto pensare come potessero essere riferite a una sorta di scuola: però, stonava il fatto, che per insegnare la lineare B si usassero dei complessi esercizi contabili. Così, nel corso degli anni, si è ipotizzato come gli scribi usassero il miceneo come seconda lingua, in cui ribaltavano alcune caratteristiche della madre lingua minoica.
Elementi che hanno reso sempre più difficile parlare di un’invasione, dato che più che una sostituzione di un ceto dominante con uno proveniente dall’esterno, sembrava come se élites locali avessero gradualmente innestato sulla loro cultura stimoli e suggestioni provenienti dall’esterno. Questo scenario, con gli anni, si è arricchito di ulteriori elementi: gli scavi di Chania hanno mostrato come la lineare A continuasse ad essere usata sino al 1330 a.C. e come i sacrifici umani, peculiarità della religione locale, fossero praticati sino al 1280 a.C., ossia sino a una cinquantina di anni prima rispetto al collasso dello stato miceneo.
Al contempo, dagli scavi di Iraklia, è apparso come intorno al 1450 a.C. i micenei possedessero già una flotta efficiente e dalla tomba del grifone, come gli scambi culturali con il mondo minoico fossero assai vivaci. Inoltre dagli scavi di Tebe, sembra evidente come fosse adottata in Grecia una versione della religione minoica, depurata forse degli aspetti più sanguinosi, che più tardi darà origine ai misteri eleusini.
Il che evidenza come questa circolazione culturale fosse bidirezionale, con i minoici che si micenizzavano e viceversa i micenei che si minoicizzavano, in un processo di integrazione bidirezionale, capace di avvicinare civiltà differenti, creando una sorta di Commonwealth, della cui organizzazione sappiamo poco, ma che è stato capace di configurarsi come una delle principali potenze politiche e militari della tarda età del bronzo..


Alessio Brugnoli's Blog






