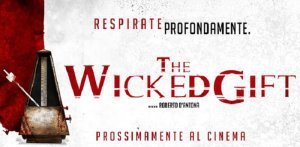Alessio Brugnoli's Blog, page 169
November 27, 2017
Buon compleanno, tesoro
Per oggi, niente chiacchiere, polemiche o discussioni… Voglio solo scrivere due righe, per fare gli auguri di buon compleanno a mia moglie, la donna tanto dolce e tosta che mi sopporta ogni giorno e che mi asseconda in tutte le mie imprese…
Sono stato fortunato ad averti incontrato, tesoro mio, e grazie di condividere la tua vita con me !
Mille di questi giorni, cucciola !


Disponibile per il download gratuito l’intervista ad Amedeo Balbi
È disponibile gratuitamente su tutti i portali ebook e, naturalmente, sul sito Kipple, l’intervista con fumetto ad Amedeo Balbi, nata da un’idea di Roberto Bommarito e Alessandro  Napolitano; l’incontro è stato organizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Electric Sheep Comics, mentre le tavole e i disegni interni sono di Marzio Mereggia. Il lettering è di Claudio Fallani e la copertina è di Ksenja Laginja.
Napolitano; l’incontro è stato organizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Electric Sheep Comics, mentre le tavole e i disegni interni sono di Marzio Mereggia. Il lettering è di Claudio Fallani e la copertina è di Ksenja Laginja.
Il tema dell’intervista verte sul ruolo dell’uomo nell’universo e vira su altre suggestioni aliene e astrofisiche tenute insieme dalla passione per la Fantascienza e la Scienza, passando per gli argomenti che interessano l’umanità sul procinto di una possibile Singolarità Tecnologica.
Amedeo Balbi è nato a Roma nel 1971, è professore associato di astronomia e astrofisica al Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. È autore di oltre 90 pubblicazioni scientifiche, i suoi interessi di ricerca spaziano dall’origine dell’universo…
View original post 99 altre parole


November 26, 2017
Drovetti, console d’Egitto
[image error]
Ogni eroe, per essere tale, deve confrontarsi con un avversario alla sua altezza: altrimenti, se vince facile, perde molto del suo fascino. Così, Belzoni, senza l’arcinemico Drovetti, sarebbe assai meno fascinoso.
Anche perché il buon Bernardino Michele Maria Drovetti, nato il 4 gennaio 1776 a Barbania, un ridente paesino del Canavese, figlio del notaio Giorgio Francesco e della contessa Anna Vittoria Vacca, ha tanto da dire di suo.
A 15 anni fu spedito a studiare a Torino, dove si laureò in Legge l’1 aprile 1795 e di certo, senza la Rivoluzione Francese, sarebbe stato uno dei tanti notai di provincia: invece, si trovò coinvolto nell’epopea napoleonica, come Avitabile e Ventura.
Solo che, a differenza del suo conterraneo Solaroli, beh, Bernardino il soldato lo fece seriamente, arruolandosi nel 1796 (27 legère) come soldato semplice. Presente all’assedio di Mantova, è promosso sergente maggiore, quindi sottotenente (1° ag. 1797). Nel governo provvisorio (dicembre 1798-aprile 1799) diventa segretario del Comitato di sicurezza generale durante le ultime settimane, più che altro perché tutti gli altri possibili candidati alla posizione, si erano dati dalla macchia.
Con l’arrivo dei russi, Bernardino scappa di corsa in Francia, ma invece di starsene buono, buono, con la ripresa delle ostilità nel ’99, si presenta volontario e viene nominato capitano nella 1ademi-brigade piemontese dal generale J.-E. Championnet; passa poi allo stato maggiore della cavalleria dell’armata di Riserva come aiutante di campo e prendere parte alla mitica battaglia di Marengo e, nell’agosto dello stesso anno, divenne comandante di squadrone negli ussari piemontesi.
Marengo, dove, tra l’altro, si comporta da vero eroe: salva la vita a Gioacchino Murat facendogli scudo con il suo corpo e perdendo alcune dita di una mano. Nel febbraio 1801 il generale Colli, noto voltagabbana lo vuole come capo di stato maggiore della divisione piemontese dell’Armata d’Italia; però Bernardino, stanco della vita militare, canticchiando
Non più andrai farfallone amoroso
Da le dimissioni dall’esercito, vista anche la sua invalidità. Il problema, è che fare per riempirsi lo stomaco: il Colli, lo fa nominare giudice posto di giudice presso il tribunale criminale di Torino, ma lo stipendio arriva una volta ogni tre. Per cui, bisogna inventarsi un altro mestiere. Bernardino scrive così a Murat, che in debito di riconoscenza, rompe le scatole a Napoleone, il quale, per toglierselo dalle scatole, nomina Drovetti sottocommissario alle relazioni commerciali ad Alessandria d’Egitto, promettendo come tale carica sia provvisoria e che presto arriverà un incarico di prestigio a Parigi.
Così, pieno di fiducia nella parola del Primo Console, si imbarca assieme a De Lesseps, il console generale in Egitto. Però, De Lesseps, più scafato di Bernardino sui complessi meccanismi della burocrazia francesce, capisce subito come tale altisonante incarico sia una sola cosmica, per cui, millantando un non ben precisato malessere, se ne ritorna, nel 1804 a Parigi, nominando Drovetti console generale al suo posto.
Bernardino, che è un bell’uomo, atletico, colto e brillante, amante del buon vino e insofferente “alle mode ridicole” dei suoi tempi, vorrebbe anche lui tornarsene a casa, ma ahimè, per dirla alla francese, la femme ci mette lo zampino.
In quell’anno conosce l’amore della sua vita Rose Rey Bathalon. Si racconta che fosse un tipetto molto accorto, parsimonioso e semi-analfabeta. Certo è che fosse sposata con un marsigliese, dal quale ebbe quattro figli! La passione però prende il sopravvento, magari spinta dal clima ardente e dall’ ambiente esotico… Ed è così che Rose chiese il divorzio… Solo che questi benedetti documenti, anche per colpa di Tallyerand, non arrivano… E senza questi, appena si sbarca in Europa, si finisce al gabbio per bigamia…
Per cui, Bernardino è costretto a rimanere in Egitto, in cui a questi dettagli di burocrazia matrimoniale si fa poco caso: per sua fortuna, diventa grande amico del pascià d’Egitto Mohammed Alì. Nel 1807 addirittura, salvò il trono al pascià: gli inglesi, preoccupati dalla politica ambiziosa di Mohammed Alì, avevano mandato in Egitto una spedizione militare, guidata dal generale Mackenzie Fraser, per spodestarlo, con l’aiuto dei bey mamelucchi..
Mackenzie Fraser, sbarcato ad Alessandria, tenta di arrestare Bernardino, che si becca anche un paio di pistolettate, ma il buon Drovetti, travestito da cammelliere, riesce a sfuggire, raggiunge il Cairo, dove si mette a capo di un esercito improvvisato, sconfigge gli inglesi che tentano di conquistare con un colpo di mano la città. In più, manda un messaggero Mohammed Alì che stava combattendo contro dei ribelli al sud del paese.
Mohammed, capita l’antifona, prende armi e bagagli e marcia a Nord, per prendere a randellate inglesi e ribelli. Al momento della resa di Fraser, Bernardino, con molta fatica, riesce a convincere il suo amico pascià che non è una prassi accettata dalla diplomazia europea l’impalamento dei generali avversari…. Proprio questo gesto di generosità, gli permette, alla caduta di Napoleone di barcamenarsi alla meno peggio.
Nel 1811 giunge poi in Egitto, in missione segreta, il colonnello. Boutin, con l’incarico di studiarvi la situazione militare nell’eventualità di una nuova invasione francese. Bernardino, dato il suo ruolo, lo accompagna nell’Alto Egitto, facendo il doppio gioco, informando Mohammed e convincendo Boutin che è meglio avere un alleato che un nemico in più. In più scopre che tutte le anticaglie faraoniche possono essere piazzate a peso d’oro presso i ricconi europei.
Scoperta che viene poi confermata durante il viaggio di De Cherville, linguista francese, con cui, vestito da beduino, esegue un censimento delle lingue parlate lungo il Nilo. La caduta del regime napoleonico trasforma Bernardino in un disoccupato.; non essendo ancora giunto il suo successore, Roussel, durante i Cento giorni Bernardino rialza il tricolore sulla legazione francese e, nel giugno 1815, si dichiara ancora fedele al Murat, suo antico protettore. Ovviamente, dopo Waterloo, Bernardino è cacciato a pedate dal consolato: il problema è come diavolo campare. Muhammad Pascià, pur chiedendo continuamente consigli, non vuole assumerlo… A un certo punto, Bernardino ha un’idea: visto che sono tanto richieste, diventerà un commerciante di anticaglie.
Nei primi mesi del 1816,così Bernardino compie il suo primo vero e proprio viaggio di esplorazione in Alto Egitto, arrivando sino alla seconda cataratta, dove tenta, senza successo, di convincere gli indigeni, seguaci del motto
Tu pagare cammello, tu vedere cammello
ad aiutarlo nei lavori necessari per portare alla luce il tempio di Abu-Simbel. In più, per dare evidenza al suo nuovo business, Bernardino si costruisce casa in cima uno dei piloni del tempio di Karnak.
Nel frattempo, durante la sua assenza, è giunto ad Alessandria il nuovo console generale inglese H. Salt, destinato ad essere per un lungo periodo (il Salt morì in Egitto nel 1827) il suo maggior rivale sia nell’attività politica. In più dal giugno 1815 operava in Egitto il buon Belzoni, che comincia a fargli concorrenza.
Nel 1816 Drovetti avvista un obelisco sull’isola nilotica di File e si accorda con l’aga del villaggio, dietro congrua mancia, perché glielo conservi. Due anni dopo viene a sapere che l’obelisco è in viaggio per l’Inghilterra, mittente Belzoni, che pare abbia compensato il capo locale con un orologio d’oro. E quando pochi mesi dopo avviene un contatto ravvicinato tra le due squadre di «cacciatori», gli uomini del piemontese assalgono quelli del padovano, e a un certo punto dalla pistola di Drovetti parte un colpo di pistola. Dopo quell’episodio Belzoni lascerà l’Egitto per non farvi mai più ritorno.
Nel febbraio 1819 Bernardino, alla ricerca di nuove possibili antichità, parte assieme al viaggiatore francese F. Caillaud, per il suo secondo giro di esplorazione alle oasi di Dakel e di Kharga; in più nel marzo 1820 viene incaricato da Mohammed Alì di sottomettere le tribù beduine che infestano la zona dell’oasi di Siwah: compito che con un contingente di 2000 uomini e qualche cannone, porta al termine senza grossi problemi, trovando il tempo, oltre che per arraffare qualche reperto archeologico, anche di classificare le specie botaniche della zona e di compilare un piccolo vocabolario della lingua locale.
el corso di questi anni Bernardino, a gratis, perché, come detto, non ricopriva alcun incarico ufficiale, non aveva mai abbandonato il suo ruolo di abile consigliere del pascià, il quale, praticamente sovrano indipendente del paese, aveva dato inizio ad un vasto programma di riforme e ammodernamento dell’Egitto; in particolare Bernardino . aveva seguito il lavoro di riorganizzazione delle finanze egiziane e della Zecca, e aveva caldeggiato la rimessa in opera dell’antico canale Mahmoudieh, che mette in comunicazione Alessandria con il Nilo e quindi con Il Cairo (compiuto nel 1819).
A Parigi si rendono conto di questo ruolo e quindi, dati i crescenti interessi per il Nord Africa, decidono di approfittarne: nel 1821, all’improvviso, Bernardino si ritrova di nuovo non solo console per i francesi, ma a seguito di una serie di liti tra Zar e Sultano, anche per i Russi. Se da una parte continua ad affiancare l’amico pascià nella sua opera di riforma, lo convince ad imporre l’obbligo della vaccinazione antivaiolosa, al contempo deve smettere di dedicarsi al commercio di antichità.
Solo che lo stipendio, dalla Francia, arriva ogni morte di papa: per cui, per mantenersi, decide di vendere al migliore offerente la sua collezione privata, che comprende 169 papiri. 102 mummie, 95 statue di grande valore. Tra i papiri spicca il Canone Reale, che è alla base della cronologia egiziana, mentre tra le statue, vi figurano veri capolavori, come quella di Ramesse II.
La sua intenzione è di vendere la collezione alla Francia, ma il prezzo richiesto è troppo alto e non se ne fa niente. Intanto nella vicenda interviene un altro viaggiatore piemontese, Carlo Vidua, che si prodiga affinché i reperti, ammassati in un magazzino di Livorno , non prendano la via di Parigi:
«Questo affare mi sta moltissimo a cuore»
scrive a un amico.
«Desidero che i forestieri non possano più dire: “Turin est une ville fort jolie et régulière, mais il n’y a presque rien à voir”».
Brillante intuizione della possibile vocazione turistica della città, a cui il re Carlo Felice aderisce acquistando nel 1823 la collezione per una cifra enorme: 400 mila lire, pari a circa 700 milioni di euro. Niente male per un piccolo Stato militare come era il Regno di Sardegna.
A Torino i reperti – ottomila pezzi, tra i quali grandi statue, sarcofagi di pietra, papiri, mummie, amuleti, tutti oggetti di primaria importanza, da cui si svilupperà la moderna egittologia – giungono sotto la neve, accolti nella Reale Accademia delle Scienze che diventa il primo museo al mondo interamente dedicato all’antico Egitto. Dopo lunghi mesi di studi e catalogazione, l’apertura al pubblico, l’8 novembre 1824.
E subito a Torino accorre Jean-François Champollion, che ha appena decifrato la stele di Rosetta e vuole mettere alla prova la sua scoperta.
Nel 1825, nell’ambito dei provvedimenti relativi allo sviluppo agricolo dell’Egitto, Bernardino suggerisce di incrementare la coltivazione cotone e grazie alle sue relazioni piemontesi in particolare con Michele Benso marchese di Cavour, presidente della Società pastorale e papà del più noto Camillo, fa importare un gregge di pecore merinos introducendone l’allevamento nel paese.
Per ricambiare questo gesto, Mohammed Alì regala al Piemonte un elefante indiano di 27 anni chiamato Fritz, che diventerà una della attrazioni della Palazzina di Caccia di Stupinigi. Nel 1828, intanto, Bernardino compie il capolavoro diplomatico della sua vita: riesce a convincere Mohammed Alì a ritirarsi dalla Morea, permettendo così l’indipendenza della Grecia. In più, con l’arrivo in Egitto della spedizione di di Champollion e Rossellini, capisce che la sua epoca è finita. Così dopo aver piazzato al Louvre un’altra collezione, per 150.000 franchi, pagabili in cinque comode rate, nel 1829 si ritira a vita privata.
Passa gli ultimi anni viaggiando per l’Europa e facendo il consulente sia in ambito agricolo, sia in quello geopolitico. Il 3 marzo 1852 è ricoverato nell’ospedale di San Salvario, dove muore il 9 alle 21, per problemi causati da idropisia e disturbi neurologici.
L’11 marzo si svolgono i funerali Nel testamento, scritto il 23 febbraio, lascia disposizioni per l’autopsia sul suo corpo: voleva avere la certezza di essere morto davvero per non rischiare di essere seppellito vivo (terrore molto diffuso all’epoca)! Indica come suoi eredi i poveri di Torino e Versailles. E’ sepolto al Monumentale.
Il suo monumento funebre è del 1855 e si trova in una nicchia un po’ nascosta: un busto opera dell’Albertoni lo raffigura con lunghi capelli e folti favoriti, baffi e pizzetto puntuto, l’espressione decisa (una copia della scultura si trova in Piazza Umberto I a Barbania). E’ posto su un grosso piedistallo decorato in cima da un simbolo egizio sotto cui sono incise queste frasi:
Qui giace Bernardino Drovetti F. di Giorgio, insignito di molti ordini e ascritto a molte accademie d’Europa
Nato a Barbania il 7 gennaio 1776, morto in Torino il 9 marzo 1852
Fu dottore in ambe leggi, reggente il Ministero di Guerra, uffiziale e console generale di Napoleone I in Egitto
Promosse colà il progresso e vi raccolse preziosi monumenti onde si creò il Museo Egizio, precipuo ornamento di questa città
Morì qual visse: benefico, chiamando i poveri a suoi eredi.
C. Cagnon e C. Mosca senatori del Regno, amici ed esecutori testamentari di lui posero questa memoria 1855


Santa Bibiana superstar nella mostra dedicata al Bernini alla Galleria Borghese
Questo è il post pubblicato su Facebook da CBC, la Società Cooperativa che si sta occupando del restauro della statua di Santa Bibiana in queste settimane esposta alla mostra su G.L. Bernini allestita presso la Galleria Borghese.
Le fotografie testimoniano l’ammirazione del pubblico verso questo capolavoro sconosciuto ai più. Ci auguriamo che lo stesso interesse dimostrato in questa occasione non smetta quando la statua ritornerà nella sua collocazione originale presso la chiesa omonima e che Santa Bibiana diventi un luogo non solo di culto per i parrocchiani ma anche meta di turisti e amanti dell’arte richiamati dalla statua, dall’architettura del Bernini e dagli affreschi di Pietro da Cortona.
Sempre che le autorità competenti per il territorio si ricordino che via Giolitti non è solo una via del Centro Storico di Roma ma un vero e proprio scrigno di tesori dell’arte e dell’archeologia e non merita di essere trattata come è…
View original post 25 altre parole


November 25, 2017
Il sepolcro del fornaio
[image error]
Uno dei sepolcri più affascinanti e singolari della Roma augustea è proprio ai confini dell’Esquilino: è la tomba di Marco Virgilio Eurisace e di sua moglie Atistia, il cosidetto sepolcro del fornaio,
Ma il buon Eurisace era qualcosa di più del precursore dei nostri Roscioli o Panella. Per prima cosa, era un immigrato, di origine greca, e un liberto, un ex schiavo di un membro della gens di origine etrusca Vegilia Esquilina, che dopo avere fornito una quantità industriale di politici arruffoni e mediocri generali alla Res Publica, si era dedicata con successo all’attività imprenditoriale.
Gens che come dice il nome, aveva case e opifici nel nostro rione. Per cui non è peregrino pensare che anche Eurisace abitasse in zona, forse proprio nella Graecula, la sezione del rione, nei pressi di Sant’Eusebio, compresa tra gli Horti Calyclani e i Cycladiani, che pullulava di immigrati ellenici, che, dato che non vi è nulla di nuovo sotto il sole, facevano storcere la bocca con le loro strane abitudini ai radical chic dell’epoca, che si erano comprati casa nelle vicinanze.
Eurisace come dicevo non era solo un valente panettiere: era appaltatore di pubbliche forniture ed “apparitore“, cioè aiutante di un sacerdote o di un qualche eminente magistrato. Egli, infatti, sfruttando la norma che consentiva la liberazione (o meglio il riscatto per affrancazione) agli schiavi che svolgessero – a salario ridotto e senza limiti orari – il lavoro di panificatori, aveva organizzato, grazie alle loro fatiche, quella che oggi sarebbe definita una fiorente industria del pane, tanto da diventare fornitore ufficiale di Augusto e di parecchie legioni, che pranzavano con le sue gallette.
In più, aveva organizzato e guidato con pugno di ferro il collegia, l’associazione di categoria dei panettieri; sappiamo che, grazie a un paio di scioperi e qualche manifestazione dinanzi al Palatino e alla Curia, era riuscito a ottenere diversi benefici fiscali ai suoi associati.
In vecchiaia, decise di celebrare il suo successo con il suo monumento funebre. Per prima cosa, scelse per costruirlo una zona che, pur essendo fuori le mura, fosse vicino casa: essendo ricco sfondato, comprò il lotto migliore, in mezzo all’incrocio tra via Labicana e Prenestina, in modo che nessun viandante potesse ignorarlo. Infine, per celebrare le origini della sua ricchezza, fece costruire, intorno al 20 a.C. su un basamento in tufo dell’Aniene e travertino sormontato da una muratura in opera a sacco rivestita da blocchi di travertino, il suo sepolcro, decorato con elementi caratteristici di un forno, come sacchi e bocche di doli e dalla forma dei recipienti in cui veniva impastata la farina; il tutto sovrastato, per rispettare la moda dell’epoca, da una bella piramide, attualmente perduta, ma i cui resti furono identificati dal Canina.
In più, per ribadire il concetto, aveva fatto decorare il tutto con l’iscrizione, ripetuta su tutti i lati
Est hoc monimentum Marcei Vergilei Eurysacis pistoris, redemptoris, apparet[oris]
ossia
“Questo sepolcro appartiene a Marco Virgilio Eurisace, fornaio, appaltatore, apparitore” e verrebbe da aggiungere, un guai a voi se non l’avete capito, e con un fregio dove sono rappresentate le varie fasi della panificazione alla sua presenza e di funzionari dello Stato: satura e molitura del grano, setacciatura della farina, preparazione dell’impasto, pezzatura e infornata del pane
Sul lato orientale, ora perduto, in direzione delle domus dei radical chic esquilini, che lo guardavano dall’altro in basso e tante volte a mezza bocca, si era lamentati degli stranieri che rubavano lavoro ai romani. vi era il rilievo che lo rappresentava accanto alla moglie, ora ai Musei capitolini.
Per finire le ceneri di Eurisace e Atistia erano conservate in un’urna a forma di madia o di panarium, il canestrello che fungeva da porta pane romano. Allo stato attuale, è stata ritrovata solo quella di Atistia, per cui non è da escludere che Eurisace riposi ancora nella sua tomba.
Ai tempi della costruzione delle mura aureliane, il sepolcro si salvò pelo pelo, forse perché, per legge non poteva essere demolito: Onorio, però, che aveva meno scrupoli legali, lo utilizzò come basamento delle torri difensive circolari costruite a difesa di Porta Maggiore. Proprio queste torri lo nascosero sino al 1838, quando papa Gregorio XVI diede ordine demolirle, per ripristinare il prospetto originale delle mura..,


The Wicked Gift: il trailer e la data d’uscita dell’attesissimo film horror di Roberto D’Antona
The Wicked Gift, l’attesissimo film horror italiano diretto dal giovane regista emergente Roberto D’Antona, sbarcherà nelle sale il 6 dicembre. C’è molta attesa per questa pellicola, prodotta da Movie Planet in collaborazione con L/D Production, specialmente dopo il successo ottenuto al Fantafestival 2017. “Siamo veramente felici e soddisfatti del nostro film – commenta Annamaria Lorusso, coprotagonista e produttrice insieme a Roberto D’Antona – soprattutto perché si tratta di una pellicola indipendente, nata dal basso e totalmente finanziata e prodotta da MoviePlanet Group in collaborazione con L/D Production. Un traguardo fondamentale per il cinema di genere italiano, visto che credo sia la prima volta in cui un progetto 100% indipendente riesce ad ottenere una distribuzione legata prevalentemente alle pellicole mainstream“.
Seguono sinossi e trailer del film.
“Ethan è un giovane designer, timido e piuttosto riservato che da anni è afflitto da insonnia a causa di terribili incubi…
View original post 53 altre parole
[image error]

November 24, 2017
Trofei di Mario
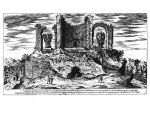

Uno dei luoghi più noti e forse meno valorizzati dell’Equilino è il Nymphaeum divi Alexandri, meglio conosciuto come i Trofei di Mario: questo nome , appare per la prima volta in una guida per pellegrini del 1140, i Mirabilia Urbis Romae, e deriva da due grandi sculture marmoree che hanno decorato il monumento fino al 1590 , quando papa Sisto V le ha fatte togliere e collocare sulla balaustrata del Campidoglio, dove si trovano ancora.
Sculture che tra l’altro hanno la strana abitudine a traslocare ogni tot secoli: non risalgono all’epoca severiana, ma a quella di Domiziano. Forse decoravano il famigerato arco quadrifonte che questo imperatore, convinto di aver vinto di Daci e i Catti, si era fatto erigere sul luogo della Porta Triumphalis, nei pressi dell’area sacra di Sant’Omobono, e che era sovrastato da ben due ben due quadrighe condotte da elefanti, una condotta da Domiziano stesso, l’altra, forse, dal padre Vespasiano. Tito, invece, nonostante l’antipatia esistente tra fratelli, era celebrato nelle imagines clipeatae, che ne esaltavano il valore militare.
Quest’arco, dopo la damnatio memoriae subita da Domiziano, pur sopravvivendo, fu utilizzato come fornitore di materiale scultoreo a basso prezzo per altri monumenti: Alessandro Severo, per la decorazione del sua fontana monumentale e un castello di distribuzione dell’acqua, non fece altro che applicare questo principio di riciclo architettonico.
Fontana monumentale a piana trapezoidale, dovuta confluenza della via Tiburtina o della via Collatina con la via Labicana, che, dopo una serie di studi altimetrici, è possibile attribuire all’acquedotto Claudio e dell’Anio Novus. Tale elemento attribuisce forse un nuovo significato al toponimo forma Claudiana attestato nella zona dall’ Itinerario di Einsiedeln.
Grazie a Frontino, che, tra l’altro viveva nel nostro rione, abbiamo idee abbastanza chiare sulla portata dei due acquedotti: delle 3.498 quinariae che raggiungevano la città, 816 erano destinate alla casa imperiale e 1.567 ai privati. Per la pubblica utilità ne restavano 1.115, così suddivise, sempre secondo Frontino: 149 quinarie ai 9 castra, 374 per i 18 servizi pubblici, 107 per le 12 fontane monumentali (munera ) e 226 per le fontane di quartiere (lacus).
Sappiamo che le due acque – già miscelate – raggiungevano a Roma presso “ad Spem Veterem“, ossia Santa Croce in Gerusalemme, dove i Severi avevano il loro palazzo imperiale, e che una quota notevole della Claudia era stata deviata da Nerone sugli arcus caelemontani aquae Claudiae, mentre un altro ramo, probabilmente derivato dal castellum ” post hortos Pallantianos “, i giardini del corruttibilissimo liberto dell’Imperatore Claudio, sempre in zona Esquilino, alimentava forse la cisterna delle Sette Sale destinata alle terme di Traiano; le due acque – indistinte – raggiungevano tutte le XIV regioni augustee con 92 castella secondari distribuiti all’interno della città.
Per cui, all’alimentazione della fontana, era dedicata una minima parte di tutta quest’acqua, proveniente dal castellum principale presso le mura, su archi di epoca severiana, di cui si vedono i resti a via Turati, nei pressi del Nuovo Mercato Esquilino.
La monumentale struttura (volume 4000 m³ circa; larghezza alla base 25 m) occupa la parte più alta dell’Esquilino ed è tutta in opera laterizia originariamente rivestita in marmo, come indicano i numerosi fori per grappe distribuiti sull’intero alzato. Si articola su tre livelli, con diversi ambienti e canalizzazioni ancora visibili. L’acqua veniva immessa al terzo piano sul lato posteriore destro della struttura a considerevole altezza da terra (9,85 m); dopo aver aggirato un massiccio centrale semicircolare, si divideva in due parti ed era quindi convogliata da cinque canali rivestiti di cocciopesto in una vasca oggi non più esistente posta sul lato anteriore della fontana.
Da qui, attraverso tubi sistemati all’interno delle pareti, l’acqua si raccoglieva in una seconda vasca rivestita di cocciopesto e articolata in nicchie alternativamente rettangolari e arcuate. Una terza vasca di attingimento, parzialmente conservata, raccoglieva nuovamente l’acqua al piano inferiore per l’approvvigionamento delle zone altimetricamente più basse della città.


Grazie alle monete dell’epoca, abbiamo una buona idea di come dovesse essere la sua decorazione: la fontana era coronata da una quadriga, con delle vittorie ai lati, per celebrare i probabili successi sui Sasanidi, l’archeologia sembra aver confermato la versione della Storia Augusta, secondo cui Alessandro Severo fece passare un brutto quarto d’ora ad Ardashir e da un’iscrizione dedicatoria.
Al di sotto si apriva una grande nicchia centrale semicircolare, coperta da una semicupola a cassettoni, in cui vi erano due statue (forse di Alessandro Severo e di sua madre Giulia Mamea), mentre due archi laterali ospitavano i due trofei militari.
In basso vi era un bacino d’acqua pensile, con al centro una statua di oceano sdraiata, che reggeva una cornucopia, da cui usciva l’acqua, l’Oceani solium citato nella Historia Augusta. Ai fianchi, sotto i trofei, vi erano due fontane, decorate con statue.
[image error]
Gli scavi tardo ottocenteschi per la sistemazione dell’angolo settentrionale di piazza Vittorio Emanuele II fece seguito un importante restauro dell’edificio, le cui fondazioni erano rimaste esposte, condotto da Rodolfo Lanciani fra il 1878 ed il 1885. Nella prima redazione progettuale il monumento doveva trovarsi al centro della nuova piazza intitolata al fondatore della Patria, in modo da sottolineare la sua funzione di crocicchio monumentale posto al bivio fra due importanti assi viari
Prevalsero, invece, gli interessi delle compagnie fondiarie private ed il rudere, pur salvatosi dalle demolizioni cui andarono incontro molti altri monumenti della zona (primo fra tutti il monumento funerario noto come “Casa Tonda“), fu ridotto a mero ornamento periferico e relegato in un angolo della piazza, in modo da non sacrificare lo sviluppo delle aree edificabili.
In occasione del restauro di Lanciani, ad ogni modo, furono espropriate e demolite le abitazioni private sorte a partire dal XVII secolo in addosso alla struttura.
[image error]
Gli scavi compiuti tra il 1982 e il 1988 hanno poi dimostrato come questa fontana, sia realtà siano una “versione 2.0”. Sono sono saltati fuori resti risalenti all’epoca augustea, in opus reticulatum. Probabilmente Mecenate, per aumentare l’appetibilità della sua speculazione edilizia, aveva pensato alla realizzazione di un ninfeo, probabilmente più piccolo di quello dell’età severiana.
Alla sua decorazione è forse associabile il rilievo Il rilievo raffigura una Menade neoattica, risalente all’età augustea e ispirata a un modello ideato da Callimaco che balla in preda all’ebbrezza dionisiaca, trovato a inizio Ottocento nei pressi di Vigna Magnani (ossia tra il monumento ai caduti e Piazza Cimbra, l’attuale sagrato di Sant’Eusebio).
La donna è vestita da un mantello mosso dall’impetuosa danza e da una tunica che lascia scoperti entrambi i seni; nella mano sinistra tiene un coltello con il quale ha appena sacrificato il capretto che stringe nella mano sinistra. La lastra, leggermente ricurva, doveva poggiare su una base rotonda e quindi doveva utilizzata come decorazione laterale della precedente fontana monumentale…
[image error]

November 23, 2017
Iklania
E’ interessante notare come la tomba del Grifone non sia un unicum, ma sia una tante tracce che del legame che legano la Messenia al mondo minoico; la maggior parte di queste provengono dal villaggio di Iklania, a circa a 4 Km a sud di Pilo. Sino a una decina di anni fa, era considerato un sito miceneo secondario, corrispondente probabilmente a uno dei nove capoluoghi di distretto della cosiddetta Provincia Citeriore del regno miceneo, l’ a-pu2[-we].
Nel 2006 la missione archeologica della University of Missouri St. Louis, invece scoprì una realtà ben diversa: in un’epoca antecedente alla fondazione del megaron di Pilo e corrispondente all’orizzonte temporale della tomba del grifone, Iklania era uno dei centri elladici più importanti del Peloponneso, capace di rivaleggiare con Micene.
Sono stati identificati, in questi undici anni di scavo un santuario all’aria aperta, che potrebbe anche identificarsi con pa-ki-ja-ne citato nelle tavolette di Pilo, che fungeva oltre che da centro religioso, da sito di produzione e ridistribuzione di beni di lusso, un sistema di drenaggio delle acque sorprendentemente avanzato, con fogne in pietra ed un sistema di erogazione dell’acqua attraverso un elaborato percorso di tubi di argilla, analogo a quelli identificati nei palazzi cretesi e una struttura che gli archeologi hanno battezzato terrazza ciclopica, che domina l’intero sito ed è composta da massi di calcare lavorato assemblati tra loro con l’aiuto di blocchi più piccoli.
La terrazza ciclopica sosteneva un megaron di circa due o tre piani andato, purtroppo, distrutto. Alcune stanze del complesso edilizio sono sopravvissute sull’altopiano a sud ed attraverso di esse si può avere un’idea della datazione e della funzione di questo complesso monumentale, che fu abbandonato all’epoca della costruzione del palazzo di Pilo.
[image error]
In particolare, tra le rovine di tale megaron sono stati trovati frammenti di affreschi che, come quelli di Tebe, di poco precedenti, rappresentano una processione femminile, il che fa pensare come alcune pratiche della complessa religione cretese fossero state adottate in ambito elladico e soprattutto navi, il che implica come la Messenia già all’epoca fosse integrata nel commercio minoico.
[image error]
Ma la scoperta più importante è una tavoletta in Lineare B, forse la più antica, date tutte le polemiche sul ciottolo di Kafkania, che risalirebbe al 1430 a.C. Tavoletta, che come le successive, reca iscrizioni su entrambi i lati e svolge un ruolo burocratico e amministrativo: da un verso vi è un elenco di nomi maschili accompagnati da numeri; sull’altro verso vi è un elenco di prodotti di cui si è conservata solo l’intestazione che recita “fabbricato” o “montato”.
Ora, dato il ruolo manifatturiero dei santuari micenei, è probabile tale tavoletta fosse una sorta di rendiconto, di quanto prodotto e dei beni da consegnare come pagamento agli artigiani su libro paga. Questo tipo di dati veniva conservato in genere solo per un anno fiscale, quindi la tavoletta non era stata creata perché durasse a lungo.
Per cui, era lasciata essiccare al al sole, ed era quindi fragile e facilmente deperibile. La fortuna degli archeologi è che tavoletta fu buttata in un pozzo insieme all’immondizia che per motivi igienici fu successivamente bruciata. Col il fuoco la indurì, permettendole di arrivare ai nostri giorni.
Tavoletta che pemette da una parte di anticipare il processo di nascita della Lineare B, evidenziando il ruolo di mediazione culturale svolto dalla Messenia: il che renderebbe più difficile interpretare la tomba del Grifone come quella di un predone di ricchezze cretesi.
Dall’altra, come lo sviluppo della complessa e per noi moderni poco comprensibile macchina burocratica e amministrativa elladica, fosse ben più precoce di quanto immaginato…
[image error]

November 22, 2017
Critickets
Mettiamola così: nella mia vita, ho visitato un numero spropositato di mostre, anche per lavoro quando collaboravo con Equilibri Arte o con Quaz Art.
La maggior parte di queste erano di alto livello; in alcuni casi, mi sono trovato davanti a dei veri gioielli, che avevano l’unico difetto di non essere pubblicizzate abbastanza. In rarissimi casi, ho preso delle sole clamorose.
Questo perché andavo alla cieca, fidandomi del nome, della sede e di qualche recensione, magari a pagamento, pubblicata sulle riviste specializzate. Però, più invecchio, meno ho voglia di farmi menare per il naso. Per cui sentivo più la necessità di un portale di community, capace di dare voce all’esperienza diretta dei visitatori, per condividere esperienze, evidenziare punti di forza e di debolezza degli eventi d’arte, consigliare e se necessario stroncare.
Uno strumento semplice, aperto a tutti, non solo ai professionisti del settore e che implementasse dei meccanismi tali da evitare alcune distorsioni e furbate, ad esempio presenti su TripAdvisor.
In questi giorni, grazie a Manuela Morgia, che, tra l’altro, è stata anche la fotografa del mio matrimonio (e la consiglio a tutti), ho scoperto che questa mia richiesta ha avuto finalmente una risposta Critickets, un portale che permette di
Tramite un motore di ricerca identificare la mostra che si vuole visitare, visualizzandone la descrizione, le informazioni principali, i pareri di chi l’ha già visitata e suggerimenti per eventi d’arte simili
Inserire nuovi eventi d’arte, funzione assai utile per curatori e addetti stampa.
Per cui, mi raccomando, partecipate alla community, recensendo e aggiungendo eventi, perchè questo è uno dei casi emblematici della Legge di Metcalfe
Il valore di una rete cresce esponenzialmente all’aumentare del numero dei suoi utenti
Ossia più informazioni vi sono, più si scambiano opinioni, più diviene utile per noi amanti del Bello.


November 21, 2017
Chiacchiere fantastiche
Ogni tanto, anche se di rado, mi ricordo che scrivo narrativa fantastica e che dovrei anche parlare di questi argomenti… Oggi è uno di questi rari momenti: come sapete, mesi fa ho lanciato l’idea di organizzare una convention di fantascienza all’Esquilino.
E’ anche senza pompa magna, in maniera anarchica e bottom-up, qualcosa si sta muovendo: gli incontri dedicata a Leiber, a Pincio e ad Effe Cinicola, sono uniti da un filo rosso: grazie all’ospitalità del Palazzo del Freddo, si sono aperte delle finestre sulla letteratura di genere, che spero possano continuare anche nei prossimo mesi.
Sempre parlando del futuro, c’è molto fermento in ambito steampunk: come forse sapete, Vaporosamente, una delle più importanti manifestazioni italiane del settore, organizzata dall’instancabile Roberto Cera, in cui si incontrano scrittori, artisti e appassionati del genere, che era diventato un appuntamento tradizionale di Torino, quest’anno è saltato.
Lo scrittore Davide del Popolo Riolo, lo stesso che ha suggerito l’idea della convention all’Esquilino, ha proposto di spostare la sede dell’evento a Cuneo. Ora non citerò Totò, sarebbe scontato, ma è un’idea che mi affascina, perché ho sempre trovato un qualcosa di vittoriano, in quella città. Per cui auguro di riuscire nell’impresa.
Nel frattempo, a Colleferro che, scherzando, dovrebbe ambire al titolo di una della capitali della fantascienza italiana, perché sede della fabbrica Avio in cui vengono costruite componenti dei vettori Ariane 5 e Vega C, si terrà il 26 maggio un evento steampunk con i fiocchi…
[image error]
E forse il suo scenario sarà l’ex Zuccherificio, che è all’origine della città e che, sembra strano, potrebbe essere all’origine del suo gemellaggio con la manifestazione piemontese Nel 1898, infatti è costituita la Società Valsacco per la lavorazione delle barbabietole, che apre la sua fabbrica davanti alla stazione ferroviaria di Segni-Paliano. Molte famiglie di operai si trasferiscono nei dintorni dello stabilimento,specialmente lungo la via Carpinetana antica, che costeggia il perimetro della fabbrica. A questo sviluppo edilizio spontaneo segue quello “pianificato” della Società Valsacco che su una altura poco lontana dallo Zuccherificio costruisce un piccolo villaggio, costituito da edifici bi – quadrifamiliari e dalla chiesa di S. Gioacchino.
Sviluppo che continua, senza troppo entusiasmo, perché lo zuccherificio non ha poi questo successo, sino al 1912 quando lo Stabilimento Valsacco viene rilevato dalla Società B.P.D. che lo trasforma fabbrica di esplosivi, in cui lavoreranno tanti operai provenienti proprio dal Piemonte…
E così la manifestazione steampunk di Colleferro è anche l’occasione per celebrare le origini dell’industrializzazione italiana..
[image error]

Alessio Brugnoli's Blog