Alessio Brugnoli's Blog, page 150
May 11, 2018
Il Mitreo dei Marmi Colorati
[image error]
E’ assai complesso descrivere l’origine del Mitraismo, anche perché tra il Mithra dei persiani, quello adorato in Asia Minore nel II secolo a.C. e quello presente nell’Impero Romano, vi è ben poco in comune, oltre il nome.
Probabilmente, il substrato originale indoiranico subì nel tempo da una parte una complessa elaborazione teologica, dall’altra fu soggetto a una serie di sincretismi con altre divinità: però, nonostante la sua natura misterica e la complessità del simbolismo che vi era associato il Mitraismo godette però di una vasta fortuna, oltre che nell’esercito, soprattutto tra le classi più modeste della società: schiavi, liberti, operai, artigiani e piccoli commercianti.
Una prova di tale successo la abbiamo anche a Ostia: nella città, estesa nel III secolo per circa 130 ettari e con una popolazione stimata di circa 60000 abitanti, vi erano almeno 15 mitrei. Uno dei più singolari, per la sua storia complessa e affascinante, è quello situato nel quartiere di Porta Marina, il cosiddetto Mitreo dei Marmi Colorati.

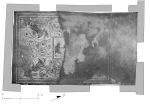
Come raccontato altre volte, il quartiere di Porta Marina era una sorta di “San Lorenzo” dell’Ostia dell’epoca, pieno di taverne e trattorie. In età severiana, uno di questi locali, una piccola caupona, di poche pretese, che si trovava al piano terreno del Caseggiato delle Due scale chiuse i battenti. Qualcuno, vedendo che così si era aperta un’ opportunità di business nel settore della ristorazione, decise di approfittarne, finanziando la costruzione di un edificio capace di accogliere e servire una clientela di lusso.
Nacque così la Caupona del dio Pan, dal soggetto del mosaico pavimentale della sala principale, che occupò un’area di quasi 180 mq e fu costruita in opera listata, che alternava, nei muri, strati di mattoni a strati di blocchetti di tufo. I suoi spazi spazi erano razionalmente ripartiti tra quelli destinati ad avventori normali, quelli per il personale di servizio e quelli riservati dalla proprietà per clienti danarosi, bisognosi di privacy,
Dopo circa un secolo di onorata attività, nel corso del IV secolo, la caupona per motivi non chiari, cambiò radicalmente destinazione d’uso: fu chiuso l’ingresso principale verso strada, da dove entravano di soliti i clienti, altre porte furono modificate o murate e cambiata la decorazione pittorica dell’interno. L’intero edificio divenne così un luogo di culto dedicato a Mithra con uno spelaeum dotato di una particolarissima pavimentazione policroma, che ha suggerito la denominazione di Mitreo dei Marmi Colorati, con le stanze adibite alle specifiche esigenze di quel culto, dall’iniziazione alla
vestizione.
[image error]
La sala da pranzo principale, però, non cambiò la modalità di utilizzo, passando però dai banchetti profani alla agape liturgiche che seguivano i sacrifici rituali: In un ambiente secondario sono stati identificati elementi decorativi che hanno una probabile valenza simbolica di grande interesse: sullo zoccolo, dipinto in rosso su fondo bianco, sono ripetuti più volte il tridente, dal quale si generano girali, e frecce.
Il tridente rientra tra i motivi decorativi cari alla tradizione della pittura romana, ma in questo caso assume un senso nella teologia mitraica, che da diversi indizi, come il rilievo di Dieburg, sembra avesse una sorta di natura trinitaria: Mithra, infatti, era arciere ed era accompagnato da da Cautes e Cautopates, anch’essi arcieri.
Nello speleaum absidato erano presenti una nicchia rettangolare, in cui forse era conservato un simulacro del dio, due altari mobili, un podium, un’aiula e un pozzo rituale con una vera marmorea. L’arredo dello spelaeum era mobile e forse in prevalenza ligneo. I due altari erano fissati a terra grazie ad alcune tacche praticate nel pavimento.
Ora, peculiarità di questo mitreo, che lo distinguono dagli edifici di questo tipo sono gli spazi ristretti, la presenza di un solo letto rituale e la peculiarità della pavimentazione, dalla cui decorazione geometrica si può ipotizzare che sul lato sinistro, a fianco del letto, venisse collocata una lunga panca. Probabilmente, chi commissionò la trasformazione dell’osteria in luogo di culto, per risparmiare o per motivi statici, decise di mantenere più inalterata possibile la planimetria originale dell’edificio, facendo di necessità virtù.
In un’altra sala sono stati invece ritrovati graffiti che rimandano al mondo religioso mitraico. Uno, in particolare, è un’invocazione al dio Mitra connesso con il gran dio Crono. Nella stessa sala, sulla parete sud, compaiono alcuni monogrammi mitraici. Al pari dei cristiani, i seguaci di questa religione misterica sentivano il bisogno di simboli alfabetici che concentrassero in sé le lettere della parolaMitra o in simboli solari.
Da evidenziare due curiosità: la prima, che risulta dall’analisi dei pollini, consiste nella presenza di ginepro, un’essenza del tutto estranea all’ambiente ostiense, le cui bacche però avevano un ruolo importante nei rituali mitraici.
L’altra è la presenza di arredi sacri, riconducibili al culto di Iside: ora, più che pensare a strani sincretismi tra le due religioni, viene il sospetto, dato il braccino corto della proprietà, che questa, per coprire le spese di gestione dell’edificio e le tasse, abbia subaffittato parte dei suoi spazi ai fedeli della dea egizia..
Le cose cambiarono drammaticamente nel V secolo: con l’affermarsi del cristianesimo a Ostia, i cui vescovi risiedono in un complesso costruito sulla via del Sabazeo, i mitrei furono sempre meno tollerati. A Ostia molti furono dati alle fiamme e distrutti da raid di estremisti cristiani, oppure chiusi dalle autorità pubblica. Da questo destino, non si salvò neppure il Mitreo dei Marmi Colorati; venne chiuso, il suo pozzo sacro interrato e un’impresa edile specializzata si incaricò di asportare i mosaici, ad eccezione di quello del dio Pan.
L’edificio così decadette progressivamente, anche a causa delle inondazioni del Tevere. Infine, dopo un crollo, forse legato al terremoto del 442-443, l’area venne interdetta e murata, precludendone l’accesso dalla strada, cosa che ne causò il definitivo abbandono
May 9, 2018
Naturalezza
[image error]
Può sembrare strano, ma nella fisica delle particelle, il concetto di “naturalezza” ha un significato assai peculiare e come dire, poco intuitivo.
Nell’ambito, alquanto esotico, della teoria quantistica dei campi, questa definizione è legato alle correzioni da applicare ai sui parametri fondamentali, affinché questa teoria funzioni, ossia, in pratica, che le equazioni ad essa associate diano risultati finiti alle alte energie. Problema che si pone soprattutto rispetto alla massa di particelle descritte da campi scalari, ossia con valore nullo di spin, come ad esempio il buon vecchio bosone di Higgs.
Queste modifiche, rinormalizzazioni della teoria, per essere naturali, dovevano evitare aggiustamenti troppo contorti e non lineari, ossia incapaci di soddisfare le seguenti condizioni:
Le proprietà osservabili delle particelle nelle condizioni di bassa energia siano stabili a fronte di piccole variazioni dei parametri fondamentali;
I fenomeni fisici a bassa energia siano indipendenti da quelli che avvengono ad alta energia.
[image error]
Criterio a prima vista assai ragionevole e che ad esempio ha avuto, come conseguenza, a valle di complessi ragionamenti e calcoli, l’introduzione dell’ipotesi di supersimmetria in cui ogni particella, compreso il bosone di Higgs, ha un partner identico in tutto e per tutto, eccettuato nello spin.
In questo mondo, a ogni fermione comune corrisponde un bosone supersimmetrico privo di spin; per esempio, l’elettrone e il quark, entrambi con spin 1/2, hanno come partner a spin nullo rispettivamente il selettrone e lo squark. Inoltre, a ogni bosone comune corrisponde un fermione supersimmetrico con spin 1/2; per esempio, il partner supersimmetrico del fotone con spin 1 è il fotino con spin 1/2, quello del gluone con spin 1 è il gluino con spin 1/2 e quello del bosone di Higgs con spin nullo è l’higgsino con spin 1/2.
Ipotesi che, dal punto di vista concettuale, permette di verificare in concreto la bontà del criterio di naturalezza: ad esempio e particelle supersimmetriche esistessero in natura come copie esatte delle loro controparti, fatta eccezione per lo spin, la maggior parte di esse si sarebbe già dovuta osservare in abbondanza.
Il fatto che non siano saltate fuori e che i dati sulla massa del bosone di Higgs poco si accordano con i modelli supersimmetrici, stanno facendo riflettere i fisici sull’effettiva applicabilità del criterio di naturalezza…
Di fatto, parafrasando Von Moltke
Nessuna ipotesi sbagliata sopravvive agli esperimenti
May 8, 2018
Massimiano di Ravenna
[image error]
Secondo una leggenda, Massimiano, primo arcivescovo di Ravenna, era un contadino di Vistro, località nei pressi di Pola, che, per la sua fede e carità, fu ordinato diacono da ragazzo: di vita assai morigerata, una mattina, zappando la terra, scoprì un vaso pieno di monete d’oro e gioielli.
Per nasconderne una parte, ne riempì un ventre di bue e due pelli di capra: il rimanente, invece lo donò all’imperatore Giustiniano, il quale per ricompensarlo dell’onestà, lo nominò arcivescovo di Ravenna, dove fu accolto dai cittadini solo dopo avere dato prova di grandi virtù.
La realtà, ahimè, assai meno poetica: Massimiano non era un morto di fame, ma l’esponente di una ricca famiglia di latifondisti di origine illirica, legata mani e piedi a Giustino, le cui fortune crebbero esponenzialmente alla nomina del loro amico a imperatore.
La sua nomina, da parte di Giustiniano, rientrava nella politica imperiale centrata sulla necessità di organizzare la nuova conquista, con Ravenna elevata a capitale della Prefettura del pretorio d’Italia, e di tenere sotto controllo la riottosa sede ecclesiastica di Roma.
Vero è che, essendo la maggior parte dei cristiani ravennati di obbedienza ariana, per farsi accettare dal suo gregge, Massimiano dovette sudare le proverbiale sette camicie: per questo adottò la strategia del bastone e della carota.
Da una parte, spedì in esilio in luoghi assai scomodi gli ariani più ferventi, dall’altra finanziò una serie di opere pubbliche, in linea con la politica propugnata da Giustiniano
[image error]
.Fece realizzare nella Basilica di Sant’Apollinare in Classe un ciclo di mosaici celebrativi della diocesi ravennate, tra cui quello absidale, con Apollinare, patrono di Ravenna, sontuosamente abbigliato col pallio vescovile e la stola, tiene le braccia alzate verso la gigantesca croce gemmata che domina la rappresentazione, che ha un duplice valore, ribadendo sia la duplice natura divina e umana di Cristo, sia, essendo Apollinare discepolo di Pietro, l’equivalenza simbolica tra le sedi di Roma e Ravenna.
[image error]
Nel cantiere di San Vitale curò la realizzazione dei celebri mosaici con i ritratti di corte di Giustiniano e dell’Imperatrice Teodora, per affermare, anche visivamente il primato politico di Bisanzio.Giustiniano porta sulle mani una patena d’oro; è preceduto da un suddiacono che porta il turibolo, da un diacono che porta l’Evangeliario e dal vescovo Massimiano. L’imperatore è circondato da tre alti dignitari ed è seguito da un gruppo di soldati di guardia. L’imperatore, diademato e nimbato, rappresenta la regalis potestas; Massimiano, con il pallio ecclesiastico e la croce, attributi della sua dignità episcopale, rappresenta la sacrata auctoritas.
[image error]
L’imperatrice Teodora incede portando sulle mani un calice d’oro tempestato di gemme. La Basilissa (imperatrice) è preceduta da due dignitari civili ed è seguita da un gruppo di dame di corte. Alta è la vibrazione del tono cromatico dei mosaici. L’imperatrice è ricoperta da un manto di porpora che nella parte inferiore reca un ricamo d’oro raffigurante i Re Magi che portano doni. Il paragone è ovvio: come i Magi portarono doni a Gesù Bambino, così noi, Giustiniano e Teodora, offriamo i nostri doni a Cristo. Le scene dei due pannelli con Giustiniano e Teodora sono una rappresentazione dell’oblatio Augusti et Augustae, cioè dell’offerta (oblatio) dei vasi liturgici che l’imperatore (Augustus) e l’imperatrice (Augusta) Bizantini facevano spesso alle più importanti chiese presenti nel territorio della loro giurisdizione
[image error]
A Pola, nella sua terra d’origine, la base del suo potere, fece costruire la chiesa di Santa Maria in Formosa, che, nella pianta, imitava la chiesa di Santa Croce a Ravenna, fatta costruire dal Galla Placidia, prendendo spunto, a sua volta, dalla basilica di Santa Croce in Gerusalemme.
La chiesa aveva muri laterali con lesene esterne, mentre l’interno era diviso in tre navate da una doppia fila di dieci colonne. L’abside centrale era circolare all’interno, con un banco semicircolare per il clero, e poligonale all’esterno, mentre ai pastophoria, ambienti delle basiliche paleocristiane sostituiti poi dalla sacrestia, laterali si addossavano due martyria a pianta cruciforme e coperti da una cupola centrale, simili come aspetto al non Mausoleo di Galla Placidia.
Il mosaico pavimentale era decorato con un motivo a spirali, associato a fiori di loto e a gigli, simboli della maestà imperiale; nell’abside, vi era un mosaico assai simile a quello di San Apollinare in Classe, con la Maria in posizione orante, in contemplazione di una croce gemmata e sembra che esistesse una pergola, con colonne tortili simile a quella dell’antica San Pietro
Secondo la tradizione la basilica fu danneggiata nel 1242 dalle ciurme venete del Tiepolo e del Querini.
La tradizione vuole anche che, dopo il sacco della città, il doge Giacomo Tiepolo abbia portato a Venezia, quale preda di guerra, le quattro colonne diafane di alabastro orientale che sostengono attualmente il ciborio dell’altare maggiore della basilica di S. Marco.
Altre colonne furono usate nella chiesa della Madonna della Salute e nel Palazzo Ducale di Venezia. Alla fine del XVI secolo la basilica era in gran parte demolita e nel 1550 Venezia inviò a Pola Jacopo Sansovino per restaurare la chiesa già spogliata delle sue bellezze ed ormai caduta in rovina. Lo stato rovinoso in cui si trovava la basilica sconsigliò il restauro e pertanto venne del tutto abbandonata.
[image error]
Nel 1847, a testimonianza del Kandler, che ne potè disegnare la pianta, della chiesa rimanevano in piedi l’abside, i pastophoria, le basi delle colonne e parti delle mura perimetrali: a inizio Novecento, però, era quasi tutto scomparso, tranne il martyria, la cosiddetta cappella del Canneto, realizzata in pietra d’Istria.


All’interno, la cappella del Canneto conteneva un preziosissimo mosaico nel catino absidale a fondo d’oro, rappresentante Cristo e San Pietro, un frammento del quale è oggi conservato nel Museo archeologico dell’Istria di Pola.
Il frammento di forma irregolare presenta uno sfondo aureo, costellato di nuvolette di colore azzurro e rosa, sul quale si stagliano le teste di Gesù Cristo e di San Pietro. Cristo, sulla destra, è raffigurato imberbe e con nimbo crucigeno; si conserva anche una piccola parte del busto. Pietro, sulla sinistra, è raffigurato secondo l’iconografia tradizionale con barba e capelli bianchi; oltre alla testa si conserva anche buona parte del busto, avvolto in un pallio chiaro. Si tratta di una rappresentazione della Traditio Legis, in cui Cristo è colto nell’atto di consegnare i codici della Legge all’apostolo Pietro.
Il Gnirs, nei primi anni di questo secolo, esplorò i resti del pavimento musivo che consiste in strisce colme di nastri, tamari e trecce. Le strisce si intrecciano in un ordito di cerchi; gli spazi vuoti sono riempiti con pesci, rosette e rami con viticci. I mosaici sono prevalentemente di colore nero e verde.
May 7, 2018
La legge della caduta tendenziale del saggio del profitto capitalistico
[image error]
Una delle tesi più complesse e controverse del pensiero di zio Karl è la legge della caduta tendenziale del saggio del profitto capitalistico, che, a suo avviso, avrebbe portato all’estinzione della società capitalista. Il punto di partenza della suo ragionamento, grazie a Dio, è alquanto banale.
In un’economia di mercato, vi è concorrenza tra imprenditori di uno stesso settore (zio Karl era troppo puro di cuore per concepire meccanismi di cartello) , che obbliga ciascuno di essi a cercare di produrre merci sempre meno costose al fine di non vedere ridotte le proprie quote di mercato (avendo una stima troppo elevate dell’intelligenza umana, non riusciva a concepire fenomeni come l’Apple).
Per ottenere questa riduzione di prezzo, gli imprenditori, dovranno investire in macchinari capaci di produrre un maggior numero di merci in minor tempo, in modo che il minore costo unitario sia compensato dalla maggiore quantità venduta.
Per mantenere questo trend, il capitalista dovrà investire parte del guadagno supplementare ottenuto nella tecnologia produttiva. Zio Karl, girando per le fabbriche, si era reso conto che i i nuovi macchinari, pur avendo rispetto ai macchinari precedenti una resa superiore in termini di produttività, avevano anche un costo superiore.
Di conseguenza, l’aumento del costo di produzione delle nuove merci sarebbe stato stato superiore all’incremento dei guadagni dovuti alla loro vendita: per cui nel lungo periodo, il saggio di profitto (la percentuale di guadagno netto, cioè quello che rimane una volta sottratte le spese di produzione) tende col tempo a diminuire e non ad aumentare.
Questo vulnus ha due antipatici effetti collaterali: da una parte il capitalista, visto la continua diminuzione della redditività, sposterà i suoi investimenti dalle attività produttive a quelle finanziare, incrementando la disoccupazione. Dall’altra cercherà di compensare i costi legati ai capex, ossia alle macchine, riducendo quelli connessi agli opex, ossia risparmiando sui salari.
Il che, però, è pezza peggiore del buco, dato che questo provoca la caduta del potere di spesa delle masse lavoratrici, che oltre essere desiderose di prendere a randellate in capo il suddetto capitalista, non hanno più i soldi per comprare le merci , riducendo di nuovo il saggio di profitto delle imprese.
Per cui, per questa legge, legata alla natura stessa del capitalismo, la rivoluzione proletaria è inevitabile: la questione è che zio Karl, pur non essendo scemo, ragionava secondo l’ottica e l’esperienza del suo tempo. Dal punto di vista logico, diversi assunti del sua riflessione, con il senno di poi si sono rilevati inesatti: da una parte la produttività del singolo operaio, a parità di infrastruttura tecnologica, può essere incrementata ottimizzando i processi e migliorando la sua formazione, dall’altra il refresh dei macchinari, con l’evoluzione tecnologica, produce una riduzione, non un incremento dei capex.
Eppure, se esaminiamo i dati economici degli ultimi decenni, si ha l’impressione di come il saggio di profitto stia calando: con tutti i punti di attenzione legati ai parametri considerati, se consideriamo, come fanno numerosi economisti, anche non marxisti, il PIL pro capite come indicatore dell’andamento del saggio di profitto, nel periodo che va dal 1973 al 2008, terminato l’effetto dovuto alla ricostruzione post Seconda Guerra Mondiale è stato all’incirca la metà del saggio di crescita registrato negli anni 1950-1973. Se dal calcolo si escludesse la Cina, esso sarebbe ancora inferiore
E all’interno di questa stessa serie storica la crescita è sempre minore col passare degli anni. La crescita mondiale negli anni Novanta è stata mediamente inferiore a quella dei decenni precedenti , e il decennio successivo si è chiuso con la peggiore crisi mondiale degli ultimi ottanta anni. Tra il 1960 e il 1970, il Pil mondiale non è mai cresciuto ad un ritmo inferiore al 4 per cento; dal 1991 in poi, in nessun anno è cresciuto ad un ritmo superiore al 4 per cento, nonostante la globalizzazione.
I motivi di tale di tale caduta sono probabilmente legati a motivazioni diverse da quelle ipotizzate da zio Karl, che vanno dalla saturazione dei mercati alla crescita dei costi d’attrito, però la sua presenza ha condizionato la storia economica di questi anni, dalle bolle speculative, nate dal ricollocare il capitale da attività industriali ad attività finanziarie a maggiore redditività, alla globalizzazione, per diminuire i costi operativi e ampliare i mercati, alla corsa verso la singolarità, per ridisegnare a fondo il processo produttivo…
May 6, 2018
Sedersi dalla parte del torto
[image error]
Tomaso Montanari è senza dubbio uomo di indubbie virtù: l’impegno quotidiano lo ha reso un uomo di ampia erudizione e il Fato è stato con lui assai benevolo, regalandogli un bel visino, una scrittura vivace e piacevole, la giusta attitudine tribunizia, la capacità di vendersi bene, di scegliere le buone frequentazioni e di evitare come la peste quello che Brecht definiva il sedersi dalla parte del torto.
Il fatto che sia un’indiscussa autorità nel campo dell’arte barocca e che abbia una buona cultura, superiore a quella dell’italiano medio, ma in fondo non è che questa sia una così notevole impresa, lo fa indurre nel vizio tipico dei nostri intellettuale, ossia esprimere con fare pontificale il suo parere su ogni aspetto dello scibile umano, anche su quelli su cui la competenza è assai vaga e superficiale.
Il che in fondo, non è gran colpa: anche il sottoscritto, in fondo, ha la stessa pessima abitudine; il problema è Montanari associa il suo desiderio di sentenziare sulla Vita, l’Universo e tutto quanto, con una speciosa tendenza ai paralogismi, degna del don Ferrante di manzoniana memoria, e una serie di posizioni che sarebbero parse retrograde e fuori moda ai tempi del buon Ruskin.
Il buon Montanari è convinto che la Storia dell’Arte sia un cimitero di monadi autistiche, per cui vede il dialogo tra Passato e Presente, tra Arte e Vita come un reato di natura penale. Che i centri storici non siano realtà vive, costruite ogni giorni dalle scelte, dai sogni e dalle utopie di chi vi abita, ma dei cadaveri imbalsamati, da far contemplare, dopo il pagamento di un opportuno obolo, a qualche ricco radical chic.
Che la Bellezza e la Cultura siano conoscenze esoteriche, da condividere tra pochi eletti e guai a involgarirle, facendole godere all’uomo comune.
E tutte queste posizioni hanno fatto capolino nella vicenda di Santa Bibiana: per chi non la conoscesse, ecco un breve riassunto.
Nell’agosto del 2017, visto che a breve ci sarebbe stata alla Galleria Borghese una mostra sul Bernini, la statua della Santa, una delle prime opere dell’artista, posta nell’omonima chiesa dell’Esquilino dopo decenni di abbandono, viene restaurata, per poi essere esposta, sino allo scorso 4 febbraio, nel museo romano.
Nel riportarla nella sua sede abituale, avvengono una serie di incidenti, degni di Fantozzi e Filini, non solo viene rotto un dito della statua, ma pare sia stata lesionata anche una delle colonne bizantine della chiesa. Grazie a Dio, entrambe sono state restaurate in tempi da recordo.
Ora Montanari avrebbe potuto, al netto della legge di Murphy, criticare con numerosi esempi e fondate argomentazione il fatto che le Sovraintendenze preferiscano, per risparmiare, affidare i lavori a ditte forse non adeguate: ma questo tema ahimé non è stato ritenuto degno di attenzione e capace di colpire la fantasia dei lettori di Repubblica.
Si è invece concentrato sulla sua solita antipatia per le mostre, visto che il popolo bue dovrebbe rimanere ignorante e non dovrebbe avere l’occasione di conoscere e apprezzare opere che di solito sfuggono alla sua attenzione.
Il fatto che la Santa Bibiana, per citare Gennaro Berger
è stata vista molto di più alla Galleria Borghese che negli ultimi 100 anni nella sua chiesa nascosta e oltraggiata da rotaie ed incuria
e che questa operazione culturale, se ben gestita, potrebbe essere un volano per rilanciare dei progetti di recupero per un’area negletta dell’Esquilino, a lui poco importa.
E’ solo l’occasione per indignarsi bevendo drink in qualche salotto, in attesa di scrivere il prossimo articolo, pieno di sagace e finta indignazione…
May 5, 2018
Cognitive Bias, Eco Chambers e Propaganda
[image error]
Quando ero molto più giovane e idealista, lessi un articolo del buon Nicholas Negroponte, che celebrava il ruolo liberatorio del Web, all’epoca non esistevano ancora i social media: secondo il grande futurologo americano, la possibilità di accedere a infinite quantità di informazioni e di confrontarci con tante esperienze diverse dalle nostre, ci avrebbe reso sia più liberi dalle menzogne del Potere, sia più consapevoli e tolleranti nei confronti del nuovo e del diverso.
In teoria, Negroponte avrebbe avuto anche ragione: nella pratica si è dimenticato, nella sua utopia, del fatto di avere a che fare con esseri umani, dotati di un’attenzione alle informazioni fortemente selettiva.
La maggior parte di queste, per noi, è puro rumore di fondo, a cui non concediamo attenzione. Per un bias cognitivo, legato alla nostra corteccia neurale e forse non condiviso con i nostri cugini scimpanzé e bonobo, che detto sono assai meno settari di noi sapiens, dato che, nonostante il fatto che siano differenti come specie, hanno in comune il 96% del linguaggio dei segni, noi tendiamo a selezionare le informazioni in funzione di quanto queste confermino la visione del mondo del gruppo di cui facciamo parte.
Meccanismo che sicuramente costituisce un vantaggio evolutivo, dato che rafforza lo spirito di corpo e facilita al creazione di organismi sociali complessi, ci permette, a differenza dei nostri cugini scimpanzé, di organizzare qualcosa di più complesso di un clan di una ventina di individui e di creare una cultura condivisa e trasmissibile tra generazioni.
Ovviamente, lo svantaggio di tale meccanismo è la facilità con cui la nostra specie è vittima della manipolazione informativa e della propaganda.
Tale facilità, nella storia, è stata sfruttata senza ritegno da leader politici e da profeti religiosi, nella sua accezione positiva, e da truffatori e demagoghi in quella negativa e che negli ultimi anni si è riproposta all’attenzione pubblico grazie ai social media e ai loro effetti sulla politica.
Studi, in cui sono all’avanguardia le università di Padova e Ca’ Foscari a Venezia, mostrano come questo confirmation bias, così si definisce in termini tecnici il meccanismo cognitivo che ho descritto, abbia un ruolo centrale nelle dinamiche sociali on line, in particolare su Facebook e Twitter.
In particolare, gli utenti on line tendono a tribalizzarsi, a formare dei gruppi centrati su narrazioni condivise.
Meccanismo che è centrato sulle Eco Chambers, le casse di risonanza, che Walter Quattrociocchi, uno dei principali studiosi del tema, definisce
Uno spazio definito sul web nel quale le idee scambiate, essenzialmente, si confermano le une con le altre. Per esempio, può essere uno spazio di persone che hanno la stessa mentalità e che si scambiano idee politiche simili, oppure una pagina su una teoria cospirazionista. Una volta entrati in questi spazi, gli utenti scambiano informazioni molto simili, in pratica facendosi eco l’un l’altro
In queste eco chambers, non importa la verità, ma la narrazione: i loro componenti tendono ad acquisire informazioni coerenti con la visione del mondo che supportano, anche se palesemente false e tendono a censurare quelle in contrasto con la propria percezione del reale.
Questa polarizzazione è accentuata da altri due meccanismi: dalla tendenza delle reti sociali complesse ad articolarsi in small worlds, una serie di isole tra loro comunicanti solo tramite un numero limitato di nodi e dagli algoritmi specifici dei social media, che per tenere alto l’interesse dell’utente e aumentarne la fidelizzazione, non fa che restituire pagine che favoriscono argomenti e persone simili a quelle a cui ha espresso gradimento in passato (ossia gli ha messo like).
Quegli algoritmi che servono a “filtrare” l’informazione – in un contesto di eccesso quantitativo di informazione – di fatto formano delle bolle di confort rispetto alle convinzioni dell’utente, rafforzando la sua autostima e rendendo difficile il rimetterle in discussione.
Le analisi compiute da Quattrociocchi hanno evidenziato una serie di dati interessanti su questa polarizzazione:
Più un utente è attivo sui social media, più risulta essere soggetto a tale fenomeno, perché avendo i relativi algoritmi una base di dati più ampia e coerente su cui agire, hanno maggiore facilità a costruire la sua bolla di conforto;
Mediamente, un utente fa riferimento a quattro o cinque echo chambers, in coerenza con i modelli delle reti a small worlds;
Più un argomento è polarizzante, ossia capace di provocare una maggiore segmentazione dell’utenza sui social media, più è facilmente aggredibile dalle fake news;
Il factchecking razionale non è sempre utile per ridurre la disinformazione e spesso non fa che aumentarne la portata: le persone che stanno nelle echo chamber non ammettono il dibattito documentato ma soltanto la contrapposizione di opinioni, ma si occupano attivamente di ciò che mette in discussione le loro idee. Sicché un tentativo di chiarimento documentato su un pezzo disinformatorio può diventare paradossalmente motivo per rilanciare ancora la disinformazione.
Paradossalmente, queste considerazioni sono state alla base della campagna elettorale di Trump, dei fautori della Brexit e, in Italia, dei Cinque Stelle e della Lega Nord.
Sfruttando i Big Data, hanno mappato la polarizzazione dei potenziali elettori, l’hanno guidata sulle loro posizioni elettorali, costruendo un’attiva rete di eco chambers a loro favorevoli, alimentandola poi con quantità industriali di fake news.
Cosa che in Italia, che, vuoi o non vuoi, ogni tanto funge, più nel male che nel bene, da laboratorio politico per il futuro, uno strano effetto collaterale, degna di un romanzo cyberpunk: gli effetti di tale polarizzazione sono stati tali da limitare al massimo i margini di manovra politica di chi li ha utilizzata, in primis i Cinque Stelle, che hanno preferito farsi terra bruciata, piuttosto che mettere in crisi il meccanismo che garantiva loro consenso elettorale.
E per contrastare questa deriva dell’informazione sui social media, connessa alle caratteristiche più profonde della natura umana, l’unico strumento utile è forse proprio quello suggerito dallo stesso Quattrociocchi
Con nuove narrazioni. L’essere umano non è razionale, come ci ostiniamo a credere, bensì ha una visione del mondo che è emotiva e percettiva. La comunicazione deve essere mirata al fabbisogno informativo dell’utente. Lo scherno e la presunzione di autorità aumentano solo la polarizzazione. Bisogna entrare nell’echo chamber, capire quali siano i bisogni informativi degli individui e il motivo della loro resistenza
May 4, 2018
Marcus Fulvius Antiocus
[image error]
Gli scavi di Vignale, tra le tante cose, hanno permesso di risolvere un piccolo mistero archeologico, relativo a un uomo che si diceva una volta, si era fatto da sé: Marcus Fulvius Antiocus. Il suo cognomen, l’elemento che lo distingueva dagli altri componenti della gens Fulvia, sembra suggerire un’origine siriana.
Marcus, nato ad Antiochia, per motivi non chiari, giunse in Italia come schiavo, impiegato nel duro lavoro nelle fornaci dei Domizi, forse a Mugnano in Teverina. Numerose tegole, prodotte in quella località e ritrovate in giro per il Lazio, infatti, riportano un marchio con sopra scritto
Antiocus Fulvi Marci Servus
ossia
Antioco, schiavo di Marco Fulvio.
Ora, poco sappiamo di questo Marco Fulvio, tranne che a un certo punto della vita, decise di affrancare Antioco e di affidargli la direzione di una fabbrica di laterizi. Così Antiocus divenne il liberto Marcus Fulvius Antiocus.
Sino a qualche anno fa, a causa dei numerosi mattoni e dolii, i grandi contenitori di derrate usate dai romani, segnati con il suo marchio, trovati nell’Esquilino si ipotizzava come questa fabbrica fosse nel nostro rione, probabilmente, per limitare i rischi d’incendio, nella zona meno urbanizzata, adiacente all’area ad spem veterem.
Così i laterizi bollati M Fulv Ant che ogni tanto saltavano fuori a Vignale, fossero arrivate da Roma, a seguito di un presunto appalto legato alla costruzione delle mansio, le stazioni di posta, lungo la via Aurelia.
Invece, negli ultimi anni, gli scavi nella villa padronale, hanno permesso di identificare una grande fornace, dedicata alla produzione di anfore, tegole e mattoni, tutti a nome di Antioco: cosa che, assieme alle analisi chimiche della argille, ha permesso di rovesciare i termini del problema.
Non era l’Esquilino a esportare materiali edili in Maremma, ma viceversa…
May 3, 2018
Tomaso Montanari, Cosa indica il dito (mozzato) della Bibiana di Bernini
La notizia della mutilazione della Santa Bibiana di Bernini, che ho dato ieri su Repubblica, ha avuto una grandissima eco: se ne sono occupati i telegiornali, e i carabinieri del Nucleo di Tutela hanno aperto un fascicolo su questa incredibile vicenda.
Nel disastro, questo è almeno un motivo di consolazione.
Innanzitutto perché forse così sapremo esattamente cosa è successo. Quel che per ora filtra, è che l’incidente sarebbe successo il 24 aprile mattina, mentre l’opera veniva ricollocata sull’altare. Un errore nell’uso del supporto (tavolette saponate) avrebbe provocato un impatto tra la statua e la nicchia, e l’anulare sarebbe stato tranciato di netto. Molte sono le cose che non sappiamo, soprattutto circa l’inconcepibile scelta di non comunicare quel che era successo.
Ma c’è un’altra ragione, anche più importante, per cui dobbiamo essere grati al clamore mediatico dell’amputazione di Bibiana. Ed è che questo clamore costringe a vedere ciò che rimuoviamo…
View original post 1.065 altre parole
May 2, 2018
Il Signore del Tempo
[image error]
Qualche settimana fa, in un post, ho parlato della possibilità che molta della simbologia dei mosaici paleocristiani derivasse dai signa imperatoria, l’insieme degli attributi del Potere Imperiale e di come tale transizione di significato, da laico a religioso, avvenisse nella fucina culturale della Ravenna di Galla Placidia.
Però, una ehm recente, chiamiamola così, scoperta sta facendo ridiscutere i termini del problema, rendendo tale transizione più articolata, complessa e senza dubbio affascinante.
La nostra storia comincia nel 1830, quando il granduca Leopoldo II, lo stesso che spedì Ippolito Rosellini in Egitto, in una fredda mattina di febbraio partì da Follonica, dove aveva posto il campo base da cui coordinava la grande impresa della bonifica maremmana, per giungere in un luogo dimenticato da Dio e dall’uomo, Vignale.
Leopoldo aveva intrapreso questo viaggio, immagino non molto comodo, per studiare il percorso della strada regia che avrebbe collegato Pisa a Grosseto, imitando quanto fatto dai romani con l’antica via consolare Aurelia/Aemilia Scauri.
Il granduca non era molto convinto della proposta dei suoi ingegneri, che volevano fare passare, con una lunga deviazione, il percorso tra le colline, e gettando il cuore oltre l’ostacolo, era intenzionato a fare attraversare, in linea retta, la pianura semipaludosa solcata dal corso del fiume Cornia, tra i poggi di Campiglia Marittima e Vignale.
Il sopralluogo era proprio finalizzato a verificare la praticabilità di tale soluzione: alla fine, nonostante le zanzare, Leopoldo decise di fare di testa sua, d’altra parte era lui che teneva i cordoni della borsa e diede il via ai lavori, che, un anno dopo, portarono alla scoperta delle terme connesse a una ricca ed ampia villa tardo antica, decorate con un ampio mosaico, che colpì l’immaginazione dei contemporanei.
Leopoldo, da principe colto e amante delle arti quale era, non solo diede ordine di rispettare i resti archeologici e di compiere una campagna di scavi, per l’epoca, all’avanguardia: ma desideroso di tutelare le scoperta, impose al proprietario del fondo di Vignale, il conte Lelio Franceschi, l’istituzione di una sorta di parco archeologico ante litteram, con delle siepi a protezione delle rovine. Addirittura fu costruito un padiglione per proteggere il mosaico dalle intemperie.
Tuttavia, questo entusiasmo iniziale scemò rapidamente e proprio perché lontano dai normali percorsi dei viaggiatori ottocenteschi, degli scavi di Vignale si perse la memoria, tanto che a inizio Novecento, un genialoide locale coprì il mosaico con un pavimento rustico e trasformò il padiglione in una rimessa per macchine agricole.
Però, a volte, le storie hanno anche un lieto fine: è giusto lasciare la parola agli archeologi Zanini ed Elisabetta Giorgi che ebbero il coraggio di credere ai ricordi di un anziano contadino
Lino Tani, classe 1924 e una memoria di ferro. A lui dobbiamo tutti quanti moltissimo, perché è grazie a un suo racconto che abbiamo riportato alla luce il mosaico tardoantico.
E’ andata così: Lino ci ha raccontato moltissime volte che da bambino, negli anni ’30, veniva portato in visita alla fattoria di Vignale e che la visita comprendeva anche un capannone per il ricovero delle macchine agricole che era proprio sul limite del nostro campo.
Lì, sui muri del capannone, tra il nerofumo delle macchine a carbone e l’olio minerale colato dai motori, il bambino Lino vedeva quelli che, nel suo ricordo di tanti anni dopo, gli sembravano essere resti di mosaici policromi, forse con figure di animali.
Questa storia Lino ce l’ha raccontata con tale chiarezza che abbiamo a lungo cercato gli eventuali resti del capannone, che ne frattempo era stato completamente distrutto.
Alla fine, la posizione del capannone è stata individuata: dei muri con i mosaici visti dal bambino Lino non era rimasto nulla, ma si era conservato il pavimento di pietre, tutto sporco di nerofumo e di olio minerale. E quando siamo andati a curiosare sotto il pavimento…
Tornando al nostro mosaico, cosa ne sappiamo ? Che è stato realizzato all’epoca di Costantino, perché una sua moneta è stata inserita nello strato di allettamento delle tessere, che è stato commissionato da un ricco senatore, dato che, come i mosaici di Piazza Armerina, è stato realizzato da artisti nord Africani e un conto è farli venire a lavorare in Sicilia, in conto in piena Maremma, e come questo senatore fosse pagano, con probabili simpatie neoplatoniche.
Questo ce lo dice il soggetto rappresentato: il Tempo che si ripete ciclicamente, rappresentato con l’attributo della ruota, e circondato agli angoli con gli attributi delle Quattro Stagioni. Mosaico che tra l’altro ha avuto una vita alquanto travagliata.
In un momento non ben definito il riquadro centrale fu danneggiato e restaurato, mantenendo lo schema generale, ma cambiando alcuni elementi: lo sfondo da bianco fu sostituito da un motivi a girali animati e la testa e il busto del Tempo furono sostituiti: che ciò sia stato connesso a una damnatio memoriae o a un tentativo di cristianizzare il tutto, non è chiaro agli studiosi. Anni dopo fu eseguita una nuova modifica, che interessò i riquadri laterali, in cui parte della decorazione fu sostituita con motivi aniconici.
Tutto molto interessante, verrebbe da dire, ma che c’entra con Ravenna ? Il diavolo, come spesso accade, si nasconde nei dettagli: il Tempo, a differenza di mosaici simili, non è seduto su una roccia o su un trono, ma sul globo di calcedonio azzurro, simbolo dell’Imperium, come ad esempio il Cristo nella teofania dell’abside della Chiesa di San Vitale della città romagnola.
Per cui, si può ipotizzare che la transizione di tale simbologia, dal dominio laico a quello religioso, sia avvenuta nella corte romana dei secondi Flavi, guidata da Elena, una vecchia cristiana dal pessimo carattere, ma dove la fazione tradizionalista e pagana, a differenza di Costantinopoli, continuava a svolgere un ruolo culturale importante.
In più è assai probabile come tale transizione sia avvenuta in ambito neoplatonico, per evidenziare come il Tempo avesse il dominio su tutte le cose materiali, evidenziandone la loro caducità: solo in seguito, forse proprio a Roma, ma mancano prove concrete, sarà stata adattata all’ambito cristiano, per evidenziare l’idea del Cristo signore del Tempo, dalla Creazione all’Apocalisse e dello Spazio. Così, come per il Sessoriano e Santa Croce in Gerusalemme, Galla Placidia, per evidenziare il suo avere Elena a modello, ne ripropose le forme nella nuova capitale imperiale
May 1, 2018
Primo Maggio
[image error]
Buon Primo Maggio a tutti ! Incipit scontato, ma doveroso, visto che, secondo qualche erudito locale, le prime celebrazioni romane di queste festa avvennero proprio all’Esquilino, davanti Santa Croce… E data la strampalata genia di anarchici, utopisti e sognatori da cui provengo, non escludo che qualcuno dei miei antenati sia stato li, in prima fila, alzando il pugno al cielo.
[image error]
Primo Maggio, però segnato da una brutta notizia: stamane Caterina, la sarta che viveva sotto i portici lato Sant’Eusebio, è morta: una donna che avuto tanto dolore nella vita, che a volte stentava a trattenere e che a volte le ha reso difficile accettare l’aiuto delle istituzioni.
L’Esquilino, proprio per la sua collocazione, è sempre stata una casa per gli ultimi: mi ricordo quando ero ragazzo di Maria, di Pietro lo scacchista, lo chiamavamo così per la sua passione per questo gioco, che dormiva a Piazza Dante, vicino al barbone che a seconda dei giorni, diceva di essere il figlio di Farinacci o di Matteotti o di quel signore che dormiva tra i banchi del mercato, tanto bravo a disegnare con i colori ad olio…
Tante volte mi sono chiesto che fine abbiano fatto: perché certo in questo rione siamo certo un branco di somari, qualcuno è pure così scemo da lamentarsi della loro presenza, troppo spesso siamo distratti e menefreghisti, però, nonostante i nostri limiti e difetti, continuiamo a mantenerci umani.
Per quanto possiamo fare ragionamenti idioti sui social, siamo un grosso e strampalato paesone: magari li chiamiamo matti, ma ci affezioniamo ai nostri barboni, in cui ci imbattiamo ogni giorno… A loro modo diventano una parte della nostra folle e disadattata famiglia allargata…
E Caterina lo era: anche se ogni tanto, sovrapensiero ho rischiato un coccolone per le sue urla, come tutti, mi preoccupavo per lei, anche se, devo essere onesto, più di offrirle un caffè o un pacchetto di sigarette, non ho fatto..
Però tutti quanti oggi ci siamo preoccupati e siamo addolorati per lei: stiamo cercando, se possibile, di organizzarle un funerale nel rione…
Poi, so che una della tante associazioni del Rione si sta impegnando far trasformare uno degli immobili abbandonati del Comune in una social house per i senzacasa… Sarebbe bello, se quello spazio fosse intitolato a Caterina.
[image error]
Detto questo, tutte le vicende di oggi, passano in secondo piano: devo confessare che prenderei a randellate in capo coloro che hanno seguito il trasloco della statua, che pare abbiano danneggiato anche una delle colonne bizantine della chiesa.





Oppure le strane sensazioni che ho provato questo pomeriggio al Concerto di San Giovanni: quella strana malinconia di sentirsi vecchio, con troppi ricordi sul groppone. Mi giravo intorno e ripensavo a quanto ero scemo da ragazzo e agli amici, da Ulche che passava la giornata a prendere a morsi, le coppie, così si chiamavano le pagnotte da un chilo a forma di otto, tagliata a metà e farcita con quantità industriali di porchetta.
A er Giamaica, che contando sulla legge dei grandi numeri per rimorchiare, attaccava bottone con qualsiasi ragazza gli capitasse a portata di Mano. O Triccheballacche che si presentava con striscioni e cartelli assurdi, convinto che così lo facessero andare in prima fila… O Marcolino che si è fumato l’infumabile assieme con il cugino Vladimir, il quale, tenendo fede al nome, per darsi un tono rivoluzionario si presentava con uno sproposito di bandiere rosse, che cercava sempre di appiopparci… Certo che con quello che combinavamo, se all’epoca ci fosse stata Facebook, ci avrebbero crocefisso davanti i Trofei di Mario…
Chissà cosa proveranno tra una ventina d’anni, i ragazzi che mi erano accanto, questo pomeriggio, che mi guardavano come se fossi stato un pinguino sulla spiaggia di Copacabana o un Englishman in New York…
Alessio Brugnoli's Blog




