Alessio Brugnoli's Blog, page 154
April 3, 2018
Il Colosso di Barletta
[image error]
Quando ero ragazzo, su un libro di scuola, mi capitò di leggere la storia dell’Eraclio di Barletta: si raccontava che, secondo un’antica tradizione, questa statua bronzea dell’imperatore bizantino fosse inizialmente sita a Costantinopoli e fosse opera di un certo Polifibo
Nel 1204, in occasione del sacco crociato della città, i veneziani l’avevano prelevata come souvenir, come ad esempio cavalli di bronzo dell’Ippodromo o dei leoni del Pireo, o del gruppo dei Tetrarchi. Però, la nave che doveva portarla a Piazza a San Marco, giunta nell’Adriatico all’altezza di Barletta, incrociò una tempesta; per evitare di affondare, i marinai gettarono in mare tutta la zavorra, statua compresa.
Una ventina d’anni dopo, un pescatore di Barletta si accorse della presenza del Colosso e con molta fatica fu recuperata: nel 1309, rischiò di fare una brutta fine, dato che i domenicani di Manfredonia chiesero e ottennero da Carlo II d’Angiò il permesso di asportare e fondere la statua, situata a quel tempo presso la dogana di Barletta, per farne delle campane per la loro chiesa.
Visto che gli abitanti di Barletta l’avevano cominciata a considerare come una sorta di simbolo civico e un’attrazione turistica ante litteram, presero a randellate in capo i domenicani che erano andati a reclamare il bronzo a basso costo e che, con grande entusiasmo, avevano cominciato a sezionare il tutto, prelevandone le braccia: per cui, i religiosi decisero, per evitare ulteriori bernoccoli di orientarsi verso soluzioni alternative.
La statua rimase nella dogana del porto di Barletta fino al 1491 quando, su commissione dei cittadini di Barletta, rifatte le gambe e le braccia dallo scultore Fabio Alfano di Napoli in forma molto differente dallo stile originale, venne posta nella sua attuale collocazione sotto il Sedile del Popolo, una loggia marmorea a sesto acuto di epoca rinascimentale edificata sulla parete orientale della basilica del Santo Sepolcro e abbattuta nel 1925.
Un annetto fa, però, tutta questa storiella è andata a farsi friggere: i restauri compiuti di recente hanno confermato come la fusione delle arti sia degli arti è avvenuta, confermando la tradizione, con massima probabilità nella seconda metà del 14esimo secolo, per cui non è detto che la statua avesse in mano un croce, mentre il tronco e la testa risalgono tra il quarto e il sesto secolo, rendendo così poco probabile l’identificazione con Eraclio.
In più, viene esclusa qualsiasi permanenza sottomarina della statua e dall’analisi delle terre di fusione, si ipotizza che questa non abbia nulla a che vedere con Costantinopoli, ma che provenga dall’area Alto Adriatica, ossia data l’epoca, da Ravenna.
Per cui, un paio di domande sorgono spontanee… Se non ha nulla a che vedere con Eraclio, chi diavolo rappresenta ? Se viene da Ravenna, quale era la sua posizione originale ? Come diavolo è finita a Barletta ?
Per rispondere a tali questione, è stato rivalutato, all’improvviso un resoconto del 1279 del frate minorita Tommaso da Pavia, considerato sino a poco tempo fa, un’accozzaglia di boiate.
Il fraticello racconta in un passo
parlamentum iussit congregari Ravenne, ut de iuribus imperii multis temporibus occupatis exigeret rationem. Verum huius tempore parlamenti aliquid accidit, quod non exstimo omittendum. Nam ad hoc parlamentum cum principibus Alamanie miles quidam Ricardus nomine curialis advenit, qui temporibus Karoli Magni scutifer Oliverii Dacie ducis fuit, qui fuit unus de 12 palatinis et Rolandi socius specialis. Fridericus igitur imperator hunc militem coram principibus requisivit, si tempore aliquo Ravenne cum Karolo fuerat et si in ipsa posset aliqua secreta ostendere, per que verbis illius posset certa fides haberi. Tunc ille ait: Cum Karolo et Rolando et meo domino Oliverio fui in hac civitate et si mecum circa civitatem volueritis equitare, certa vobis ostendam inditia, per que me verum dicere cognoscetis. Equitavit igitur imperator ad quoddam monasterium prope urbem dixitque Ricardus ad eum: In hoc monasterio est quedam capella pulcerrima, quam hedificari fecit Galla Placidia, opere mosaico decorata, in qua de alabastro sunt tria sepulcra, in quorum uno imperatoris Theodosii corpus est positum, iuxta quem ensis eius cum vexillo tale preferente insigne est positus. In alio est corpus uxoris cum suarum duarum corporibus filiarum. Sed in tercio corpus est Helisei prophete de Costantinopoli cum aliis huc translatum. Itaque iuxta dicta Ricardi capellam imperator invenit, sed propter antiquitatem et excrescentias fluviorum sic terris opertam, ut introitus per ostium non pateret in eam. Terram igitur iussit effodi et usque ad pavimentum capelle optime excavari, quibus sic per omnia actis capellam intravit, ubi ut Ricardus dixerat tres archas invenit. Cumque archa Theodosii fuisset aperta, cum vexillo et spata inventum est corpus eius, et quia in archa una veritas erat inventa, noluit imperator archas alias aperiri… Iterum Ricardus ille iam dictus eius quod dicebat alium signum dedit. Dicebat enim, quod in Karoli comitato erat miles quidam discretionis sensu permodicus, sed stature longitudine eximius, ita quod vix inveniri posset aliquod vestimentum corpori suo aptum, capiti pileum, calcaria pedibus et manui cirotheca, nisi ad eius fierent de novo mensuram. Contigit autem semel, quod imperator Karolus subito de Ravenna discederet, ita quod multi recessum ex militibus nescientes eum non fuerint tunc secuti. Inter quos vir iste longissimus accipere pre festinantia sua calcaria est oblitus et ideo tarde Karolum est secutus. Et quia sine calcaribus equitabat, omnium derisui expositus erat, quia segui alios non valebat eo quod calcaria sua in quadam fenestra huius claustri reliquerat, que sic alta erat, quod nullus alius preter ipsum manum illuc mittere poterat. At illi, qui cum imperatore erant, investigantes ibi fenestras in eo latere quo dicebat, derelicta calcaria repererunt propter antiquitatem rubiginosa, quamvis fuerint deaurata, tanteque magnitudinis erant, ut admirationi fierent universis, tanquam quoddam novum et insolitum mirarentur. Itaque habemus in hiis fidem Theodosii quam sequamur, qui monasterium istud exstruxerat seque ibi sepeliri mandaverat, habemus et sanctitatem Helisei eximiam, quam affectibus veneremur, habemus longevitatem Ricardi cum longitudine corporis, quam miremur. Et in hiis omnibus divinam nobis est attendere maiestatem, quam in omnibus et ex omnibus collaudemus, que facit magna et inscrutabilia, quorum non est numerus .
Il che sintetizzato e tradotto fa pressappoco così: Federico II, in attesa che i nobili tedeschi si decidessero a raggiungerlo a Ravenna per discutere le vicende dell’Impero, incontrò un soldato tedesco, un certo Riccardo, che si vantò di essere già stato a Ravenna ai tempi di Carlo Magno, essendo lo scudiero di Oliviero, uno dei dodici paladini e amico di Orlando… Lo Stupor Mundi, che scemo non era, visto che il tizio non pareva avere più di quattro secoli sul groppone, lo prese a pernacchioni.
Così, per dimostrare la sua identità Riccardo e qui per pigrizia cito una traduzione del professore Purpura, dell’università di Palermo, che è la massima autorità sul tema
fino ad un certo monastero vicino alla città e Riccardo gli disse: in questo monastero v’è una cappella bellissima, decorata con mosaici, che aveva fatto costruire Galla Placidia, nella quale vi sono tre sepolcri di alabastro, in uno dei quali è posto il corpo dell’imperatore Teodosio, vicino al quale la sua spada con vessillo portato innanzi e riconoscibile. In un altro v’è il corpo della moglie con le due figlie. E nel terzo il corpo del profeta Eliseo, trasportato con altri da Costantinopoli.
In seguito alle parole di Riccardo l’imperatore trovò la cappella, ma per l’antichità e le piene dei fiumi così colma di terra che l’ingresso per la porta non era possibile. Ordinò dunque di scavare fino al pavimento con cura. Fatto ciò entrò nella cappella, dove, come Riccardo aveva detto, rinvenne tre arche. E, quando venne aperta l’arca di Teodosio ( venne ritrovato il corpo di lui, e poiché nell’arca una delle verità era stata riscontrata, l’imperatore non volle che fossero aperte le altre)
Ma di nuovo quel Riccardo fornì un altro segno di ciò che diceva. Asseriva infatti che nel comitatus di Carlo v’era un soldato per discrezione molto morigerato, ma per altezza e statura eminente, al punto che a stento poteva trovare qualche veste adatta al suo corpo, cappello per la testa, calzari per i piedi e guanti per le mani, a meno che non fossero confezionati appositamente. Accadde che una volta, partendo Carlo all’improvviso da Ravenna, molti dei soldati non l’appresero in tempo e non lo seguirono.
Tra i quali quest’uomo altissimo che per la fretta dimenticò i calzari e perciò tardivamente inseguì Carlo. E poiché cavalcava senza scarpe era esposto alle risate di tutti, in quanto non era in grado di star dietro agli altri, avendo lasciato le scarpe in una certa finestra di questo chiostro, che era così alta, che nessuno, tranne lui, poteva metter mano colà.. Allora coloro che erano con l’imperatore, investigando ivi le finestre dal lato del quale si diceva, rinvennero i calzari abbandonati per l’antichità arrugginiti, sebbene fossero stati dorati, e di tanta grandezza erano, che suscitavano ammirazione in tutti, i quali si meravigliavano per un fatto così nuovo ed insolito.
E pertanto abbiamo in questi eventi la fede di Teodosio che seguiamo, che aveva costruito questo monastero e disposto di esser ivi seppellito, abbiamo anche la santità esimia di Eliseo, che affettuosamente veneriamo, abbiamo infine la longevità di Riccardo con la statura del corpo che ammiriamo. E in tutto ciò spetta a noi prestare attenzione alla maestà divina, che in tutto e per tutto lodiamo e fa cose grandi ed imperscrutabili, tanto che non è possibile enumerarle
Fatta la tara di tutti gli elementi favolistici, che dati traiamo da questa storiella ? Il primo è che a Ravenna ai tempi di Carlo Magno, come confermato da una serie di documenti storici, durante i lavori ordinati dall’imperatore per recuperare materiali edili da destinare alla sistemazione del palazzo di Aquisgrana nell’ottica della traditio e rinovatio imperii, fossero ritrovate le gambe dell’Eraclio; in qualche modo o nella tradizione orale o in documenti che non ci sono giunti, il luogo del ritrovamento è rimasto nella memoria locale.
Federico II, sempre nell’ottica di esaltare il suo legame con l’impero romano, saputolo, decide di riprendere gli scavi in quell’area, dove trova il resto della statua, che identifica come un ritratto di Teodosio: così, come in altri casi, storicamente documentati, lo fa trasportare a Barletta. Questo spiegherebbe anche il perché Carlo II d’Angiò volesse distruggerlo, proprio per cancellare qualsiasi traccia dell’odiato Svevo.
Però, dove sono stati eseguiti questi scavi ? A prima vista, leggendo il brano di fra Tommaso, la risposta sempre immediata: accanto al non mausoleo di Galla Placidia. In realtà, la situazione è un poco più complicata e per spiegarla, è necessaria una breve digressione sulla Ravenna dell’epoca.
Quando Onorio vi trasferì la capitale, si pose il problema di dove abitare: data la rapidità del trasloco, si trasferì nel praetorium del praefectus classis Ravennae, grande edificio militare del I sec. sede di uno dei due ammiragli dell’Impero romano.
Come detto, Galla Placidia fece costruire una sua residenza, che ricalcava il complesso del Sessorianum all’Esquilino, sia per proporre Ravenna come nuova Roma, sia per equiparare la sua figura ad Elena, madre del primo grande imperatore cristiano, nella speranza che Valentiniano III ricalcasse le sue orme. Valentiniano III, il cui potere dipendeva dall’appoggio del cugino Teodosio II a Costantinopoli, da una parte decise di trasformare Ravenna in una piccola Bisanzio.
Fece costruire un palazzo il Laureata, ubicato nella parte sudoccidentale della città, fra la Porta Wandalaria e la chiesa di San Giovanni Evangelista, che nel nome richiamava il palazzo costantinopolitano Daphne: come questo, vi fece associare l’area ad Scubitum, imitandoin questo modo l’Excubitorum della capitale orientale, che era il quartiere generale degli excubitores e la zecca; in più, come nella capitale orientale, come accesso monumentale al suo palazzo fece erigere una sorta di Porta della Chalke, rinominò l’antica porta della città come Porta Aurea, imitando quanto fatto dal cugino per la
Chrysea Porta e fece forse costruire un ippodromo.
Dall’altra, visto che la mamma è sempre la mamma, integrò il tutto con una chiesa palatina, San Lorenzo in Cesarea e la relativa cappella delle reliquie, dedicata ai Santi Gervasio, Protasio e Stefano, in cui erano conservate le presunte reliquie di Eliseo e di Santo Stefano, queste ultime regalate da Teodosio II a Valentiniano III; la cui decorazione era probabilmente simile a quella del non mausoleo di Galla Placidia, il che poteva provocare nella trasmissione orale, una certa confusione.
Sappiamo da Riccobaldo di Ferrara che intorno al 1295 vi fosse sul pavimento di S. Lorenzo in Cesarea una targa, probabilmente associata alla statua, con sopra scritto Divus Theodosius. Per cui fu semplice, per Federico II fare uno più uno, anche se, forse confuse Teodosio il Grande con Teodosio II, che verosimilmente, Valentiniano III aveva voluto onorare con il bronzo…
Teodorico: l’immagine di un re barbaro fra Costantinopoli e l’Italia.
Le immagini del fondatore del regno goto d’Italia dovevano essere assai diffuse, specie a Ravenna, ma non resta praticamente nulla delle opere descritte dalle fonti, spesso sono invece rintracciabili le tracce della cancellazione volontaria delle immagini del sovrano, conseguenza della confisca dei beni degli ariani e dalla rifunzionalizzazione degli edifici teodoriciani voluta da Giustiniano dopo la riconquista dell’Italia
Le immagini scultoree di Teodorico sono completamente perdute, rimane a riguardo solo la documentazione letteraria.
Una statua equestre in bronzo dorato era collocata davanti all’entrata monumentale del palazzo reale a Ravenna, originariamente realizzata per Zenone Isaurico e fatta propria da Teodorico; risparmiata dalla dannatio memoriae che colpì le immagini del re goto, forse proprio per l’originaria dedica ad un imperatore bizantino, venne trasportata ad Aquisgrana da Carlo Magno in occasione della sua visita a Ravenna nell’801. Un’eco è rintracciabile nel celebre bronzetto del Louvre, copia ridotta di un monumento equestre…
View original post 971 altre parole
April 2, 2018
Lezioni per l’Esquilino
[image error]
Karl-Heinrich Müllers, oltre ad essere stato un abile uomo d’affari, fu uno dei primi a capire come si potesse guadagnare nella riconversione immobiliare di fabbriche abbandonate, è stato un innamorato dell’Arte.
Fin da ragazzo, ha investito suoi guadagni in un collezionismo onnivoro, che andava da Beuys a Rembrandt, da Giacometti all’arte Khmer: però, come ogni collezionista, nel 1982, si è trovato davanti alla domanda tragica:
“E mo’ sta robba, ‘ndo la piazzo ?”
Come risposta ha acquistato, sulle rive dei fiume Neus, a 15 chilometri da Dusseldorf, una villa neoclassica, la Rosa Haus, costruita nel 1816 come residenza estiva di una famiglia di industriali locali. Il suo ampio parco, all’inizio del Novecento, a causa dello scavo di un’ansa artificiale del fiume Erft, al fine di limitarne le piene, si è trovato trasformato in un’isola.
Müller, per prima cosa, ha incaricato il paesaggista Korte di ricrare il paesaggio fluviale antecedente alla costruzione della Rosa Haus; poi, nel desiderio di creare una sintesi tra Natura e Cultura, ha commissionato allo scultore Heerich di progettare undici diversi padiglioni, di diverso aspetto e dimensione, illuminati solo di luce naturale, da disseminare per il parco, in modo da creare una sorta di percorso estetico e spirituale con cui far godere al meglio ai visitatori le sue collezioni.
Padiglioni completati nel 1987, che portano alla nascita del Museum Insel Hombroich; dato che l’appetito vien mangiando, nel 1994 Müllers decide di acquistare l’area confinante alla Rosa Haus, la Raketenstation, il cui nome, da fumetto di Bonvi, nasconde una realtà ben più angosciante: si tratta di una ex base missilistica della Nato, dismessa al termine della guerra fredda.
Müllers ha l’intenzione di aggiungere agli ex edifici militari, i bunker e gli hangar per i missili, una serie di padiglioni, stavolta non dedicati alla contemplazione, ma alla creazione: vorrebbe infatti utilizzarli per laboratori per costruire una comunità dedicata alla sperimentazione artistica e culturale. Si realizzano così il Siza Pavillon, sede dell’archivio Heerich per la fotografia, un auditorium, il Fontana Pavillon, per
custodire l’opera Il Sole dello scultore italiano, una foresteria per ospitare artisti.
In più, in collaborazione con un’altra collezionista, Marianne Langen, viene costruito un nuovo spazio museale, progettato da Tadao Ando, dedicato all’arte giapponese.
Dal 2002 in poi Müllers rende concreta la sua utopia, coinvolgendo decine di artisti nel suo progetto OrtLabor, che sperimenta una collaborazione comunitaria tra artisti, scienziati e architetti, per ripensare il paesaggio, in modo che si possano coniugare assieme innovazione tecnologica, esigenze di una società post industriale e rispetto per l’ambiente
Nel 2007 Müllers muore, però, consapevole di avere realizzato i suoi sogni… La sua esperienza è un’importante lezione per l’Esquilino: nei prossimi anni il Rione sarà oggetto di numerosi interventi, tra cui quello finalizzato a rendere il Mercato un polo dell’arte contemporanea.
L’obiettivo comune alle varie associazioni e comitati, ogni tanto me ne perdo qualcuno, non sarà solo pungolare le istituzioni affinché i vari progetti siano portati a compimento in tempi non geologici, ma che le varie iniziative non siano a compartimenti stagni, note solo a pochi iniziati, come sta succedendo purtroppo a quelle di Villa Altieri, ma dialoghino in una comune rete culturale, che portino avanti attività di innovazione, capaci di cambiare il rapporto tra cittadino e territorio.
L’Esquilino è stato teatro di decine di iniziative, alcune carine, altre inconcludenti, altre ancora tormentate dalla iella: ciò che è mancata, a differenza di quanto fatto da Müllers, è la continuità e la globalità. Far passare una banda sotto i Portici di Piazza Vittorio dopo una conferenza stampa è bello, ma non basta più.
Il passo successivo è usare la cultura e la socialità per il recupero dello spazio urbano, per supportare le iniziative in difesa dei più deboli, per valorizzare le nostre risorse.
E’ la sfida che ci attende a tutti quanti nei prossimi anni… E di occasioni, per portarla a buon fine, per una volta ne abbiamo a bizzeffe… Cerchiamo tutti quanti di non sprecarle…
April 1, 2018
Abu Nuwas, il cantore del vino
[image error]
Al-Hasan ibn Hani, Abu Nuwas, è un nome che a molti non dice nulla: eppure questo grande poeta, cantore della bellezza della vita in tutte le sue forme, sempre pronto a satireggiare i potenti, meriterebbe ben altra fama.
Abu Nawas nacque a Ahwàz in Persia da padre arabo, appartenente a una delle principali tribù yemenite e madre persiana e quindi probabilmente bilingue. Da bambino fu condotto a Bassora, dove scopri la sua passione per la poesia e per la bella vita: divenne e discepolo e rawi, una sorta di declamatore ufficiale, di Khalaf al-Ahmar, che oltre a scrivere versi, si dedicava a compilare antologie della poesia araba pre-
islamica.
Khalaf, benché avesse l’abitudine di spacciare per opera degli antichi qualche suo verso, cercò in ogni modo di mettere in riga Abu Nawas, con scarsi risultati: lo trasformò in poeta, ma non in un devoto musulmano.
Un aneddoto riportato da uno storico della letteratura araba racconta:
Abu Nuwas, avendo pregato il suo maestro Khalaf al Ahmar di autorizzarlo a comporre dei versi, colui così gli rispose:
“Te lo permetterò soltanto quando avrai imparato a memoria mille poemi antichi”.
Abu Nuwas s’eclissò per qualche tempo, poi ritornò ad annunciare al suo maestro che aveva imparato il numero desiderato di poemi. E glieli recitò, in effetti, impiegando parecchi giorni. Dopo di che, reiterò al maestro la sua prima domanda. Khalaf fece allora comprendere al suo allievo che non l’avrebbe autorizzato a scrivere versi finché non avesse dimenticato completamente i poemi che aveva appena imparato.“
E’ molto difficile, disse Abu Nuwas: ho fatto tanta fatica ad impararli”.
Ma il maestro restò della sua opinione. Abu Nuwas si vide allora costretto a ritirarsi per un certo tempo in un convento dove si occupò di tutto tranne che di poesia. Quando ebbe dimenticato i poemi, venne a farne certo il maestro che infine l’autorizzò a cominciare la sua carriera di poeta
A testimonianza della sua bella vita, Ahmad al-Tifachi, un erudito tunisino che visse tra il 1184 e il 1253, a cui si deve la compilazione di un testo sui costumi sessuali del suo tempo, in cui senza troppi peli sulla lingua si tratta di omosessualità maschile e femminile, di prostituzione, dei più vari costumi e vizi sessuali con grande naturalezza e senza alcun pregiudizio, così narra
Godeva, stando a quanto si racconta, di una condizione fisica straordinaria. La perfezione delle sue forme e la sua grazia riempivano gli occhi di chi lo guardava. Nessuna meraviglia dunque per i molti cuori che ha spezzato, tanto con questi pregi quanto con il suo genio di poeta. Tutta la gioventù di Basra voleva essergli amica, per l’attrazione erotica che esercitava così come per il piacere della sua compagnia
Terminato il suo apprendistato, oltre ad adottare il soprannome di Abu Nuwas, il riccioluto, che oltre a evidenziare la sua folta chioma, imitava i soprannomi adottati dagli antichi re yemeniti, si trasferì in cerca di fortuna a Baghdad, una città che muoveva i primi passi.
Chiamata all’epoca Madīnat al-Salām, ovvero La città della Pace, o città tonda, dalla sua pianta, Baghdad non solo ospitava ospitava l’ampia residenza privata e le rappresentanze pubbliche del califfo, il suo gineceo, gli edifici destinati alla sua guardia personale (dormitori, cucine, stalle per i cavalli, armerie), le costruzioni finalizzate all’espletamento delle attività burocratico-amministrative (Dīwān), le cucine necessarie all’alimentazione della vasta rete dei funzionari, il palazzo privato del vizir e i locali per i suoi più intimi collaboratori, la zecca (dār al-sikka), il ṭīrāz e l’erario, ma era anche sede della Bayt al-Ḥikma, la Casa della Sapienza, un’immensa biblioteca pubblica, che custodiva quasi mezzo milione di volumi e un ospedale aperto ai malati di ambo i sessi e che potevano fruire delle competenze mediche dei migliori medici, e della parte incaricata delle traduzioni delle opere classiche greche, persiane, siriache ed ebraiche.
A Baghdad si mescolavano, lingue, culti e i costumi. Mitologie e pratiche lontane si incontravano e fondevano. Le diverse cosmologie parlavano arabo, persiano, siriaco, greco, aramaico. Un’infinita schiera di commercianti si concentrava per scambiare merci provenienti dai capi opposti del mondo, da Al Andalus e dalle terre dei Fanchi alla lontana Cina.
Pur non riuscendo a entrare al servizio del leggendario califfo Harun al-Rashid, il protagonista di Mille e Notte, divenne il poeta ufficiale della potente famiglia nobile dei Barmecidi; di origine afghana, da Balkh, i loro antenati erano buddisti, i custodi del monastero di Nava Vihara.
Secondo la tradizione islamica, durante la conquista della Persia, la moglie del sacerdote fu catturata per breve tempo e messa nell’harem di ʿAbd Allah, fratello di Qutayba ibn Muslim, il conquistatore di Balkh, generandogli Khalid ibn Barmak (705-782); sfruttando questa sorta di parentela acquisita e il fatto di essere sostenitori degli Abbasidi, permise ai Barmecidi una rapida ascesa, diventando patroni di studiosi
e artisti, svolgendo un ruolo di primissimo piano nel processo di trasmissione delle conoscenze greche al mondo islamico, senza dimenticare quello relativo all’elaborazione delle scienze indiane, persiane, ebraiche e perfino cinesi.
Furono committenti e protettori di scienziati, tra cui Jabir ibn Hayyan, padre dell’alchimia e tra i primi a produrre la carta. Al loro servizio, Abu Nawas potè condurre la vita libertina che che tanto amava. Si dedicò l’amore libero, senza fare troppe differenze tra uomini e donne, a cui dedicò tante poesie consigliando come soluzione ad ogni problema un bel bicchiere di vino, prodotto, allora, dai conventi cristiani di cui il poeta iracheno era assiduo frequentatore.
Nel 803, però la bella vita ebbe una battuta d’arresto: il casato barmecide, per l’invidia del califfo per l’enorme ricchezza da loro accumulata e la straordinaria popolarità di cui essi godevano a causa della loro liberalità, della generosità e della grande dirittura morale, cadde in disgrazia agli occhi di Hārūn al-Rashīd e molti suoi componenti furono mandati a morte o imprigionati e condannati alla confisca dei beni.
La tradizione, però imbellettò il tutto: la leggenda narra Hārūn, avendo saputo dell’amore segreto che legava la propria sorella ʿAbbāsa con il vizir Jaʿfar, membro di tale famiglia e protagonista di tante fiabe di Mille e una Notte, il quale, essendo fratello di latte del califfo, era per la legge coranica assimilato in tutto e per tutto ad un fratello di sangue, avesse imposto ai due, per risolvere una situazione suscettibile di creare scandalo, di contrarre un matrimonio bianco. Le condizioni imposte non sarebbero però state rispettate, per cui, alla notizia della nascita di un figlio della coppia, Hārūn avrebbe fatto arrestare il vizir, facendolo poi decapitare e crocifiggere sulla porta di un ponte sul Tigri.
Abu Nawas, invece di starsene zitto e buono, scrisse un’elegia in onore dei suoi protettori: per cui, per evitare di fare una pessima fine, dovette scappare in Egitto. Potè fare ritorno alla corte di Baghdad solo in seguito alla morte di Harun al-Rashid, quando prese il trono il figlio, al-Amin, di cui Abu Nawas divenne amante.
Ciò gli diede moltissima libertà, spingendolo a produrre in questo periodo la maggior parte de suoi componimenti tra cui la sua qasida più famosa dedicata proprio alle prodezze del giovane califfo abbaside.
Oltre a cantare l’amore per il Califfo, Abu Nawas si dedicò alla poesia di caccia e dedicata al vino: nei suoi versi arricchì la lingua araba con termini di origine greca e persiana e utilizzò metafore ispirate al dibattito filosofico della Baghdad dell’epoca, ispirato al mutazilismo e centrato sul confronto tra Religione e Scienza Naturale, tra Tradizione e Aristotele.
Sotto certi aspetti, la sua poesia che l’arabista Leonardo Capezzone è centrata
un secolare discorso sull’amore in cui convergevano il sapere medico, il sapere filosofico, il sapere mistico, il sapere giuridico, per i quali il sapere poetico fungeva da saldatura, da verifica, da dispositivo di espressione quando l’esperienza si fa indicibile
E’ forse alla base del lungo percorso che porterà, con il dialogo tra diverse tradizioni alla nascita della poesia cortese. Ecco tre delle sue poesie. La prima è dedicata ad al-Amin
Riccio scorpione, la guancia vestita
di tela seta fiorita,
gemma a cui l’anima sfiora
la pelle, e respira.
Non avere a temere se a vivere,
avversa la vita ti chiama.
Hai chiusa l’anima in un corpo di luce:
ma insieme si fondono in nuvola, e il vento ti muove.
La seconda alla sofferenza d’amore
Per te ho ormai esaurito figure e attributi
che sappiano dar voce al mio patire.
Sconvolti sono i limiti del dire,
ma tu non te ne curi, nulla che a te significhi.
E numero quei tropi del soffrire
che invano scartabello a uno a uno.
Allora affido il cuore al tuo conforto
trovando in te segreta vicinanza.
Potrei volgermi pure a orecchio umano
che sappia un po’ lenire il mio pensare,
ma preferisco il duro della pietra
che il pianto non consola, ma lo tempra.
Da te, gazzella, piangi oppure ridi,
dipendono, del mondo, la tenebra e la luce
e l’ultima forse la più famosa
Così rossa è la rosa che sulla gota splende
che sa ingannare il cuore.
Si imprime nello sguardo e lo cattura,
bellezza che altera illude chi ti guarda
e alla tua mano consegna in servitù il suo cuore.
Bellezza che vezzeggiando offende: che importa
se il pugno cui affido un cuore innamorato
ha dita come spine? Che importa se poi il cuore si fa liuto
e in musica convertono le dita il suo lamento?
E infine quel mio cuore si fa freccia
lanciata dalla mano d’un arciere che a morte lo stringeva:
del sangue del mio cuore dardeggiato
io me ne vanto, e rido.
Purtroppo il tentativo di Hārūn al-Rashīd di impedire che i figli si scannassero tra loro, spartendo il califfato,fallì miseramente: tra al-Amin e al-Maʾmūn si scatenò una guerra civile, che fu vinta dal secondo.
Dopo una anno di duro assedio, al-Amin, rendendosi conto della situazione disperata in cui versava la popolazione di Baghdad, cominciò a trattare la resa negoziando un incontro e chiedendo di essere inviato dal fratello; fu però ucciso a tradimento decapitato da uno schiavo di nome Quraysh e la sua testa fu esposta davanti le porte della città.
Abu Nawas, data la sua fama, tanto da apparire, anche lui, opportunamente ripulito dai tratti più scabrosi, in Mille e una Notte ebbe salva la vita. Al-Maʾmūn era un protettore degli intellettuali, però nonostante oggi molte sue idee religiose sarebbero considerate eretiche da parecchi musulmani, era, rispetto al fratello, assia puritano.
Per cui Abu Nawas, per guadagnarsi la pagnotta, fu costretto controvoglia a scrivere poesie religiose. Ciononostante si racconta anche che il segretario del califfo avesse provocato Abu Nuwas, chiedendogli di scrivere una satira sul quarto califfo, ‘Ali. Il poeta, prevedibilmente ubriaco, non si fece pregare troppo e assecondò la sua richiesta. Purtroppo per lui questo gli valse la prigione, dove non è chiaro se morì o venne avvelenato.
Sulla sua tomba, fece scrivere il seguente epitaffio
Amici, in nome di Dio, non mi scavate
la tomba se non a Qutrabbul
tra i frantoi e le vigne; non mi mettete
vicino alle spighe.
Chi sa che io non senta nella mia fossa,
quando si pigia il vino, il calpestio
dei piedi.
Fate circolare la coppa e si dileguerà
la sventura e il mio occhio godrà
lo squisito profumo del mondo
Un vino nel cui luccichio brilla il lampo,
e quando si svela alla vista, questa
ne è quasi accecata.
Mescolato, cresce il suo profumo,
quasi cenno d’assenso di chi ami
a tutto ciò che ami.
Esquilino, l’alba di un nuovo Rinascimento?
Abbiamo sempre sostenuto che l’Esquilino possieda delle potenzialità enormi e ci siamo sempre rammaricati che, negli anni passati, pochi se ne avvedessero lasciandolo sprofondare in uno stato di abbandono se non addirittura di degrado. Fortunatamente sembra che le cose stiano finalmente cambiando e che, grazie a iniziative sia pubbliche che private, finalmente sia arrivata l’alba di un nuovo rinascimento. Tante le cose da fare ma tanti i progetti in fase di conclusione o in fase di avvio, che nel medio termine cambieranno letteralmente la faccia a questo splendido Rione.
Ecco l’elenco dei progetti terminati, in via di completamento o prossimi all’avvio di cui si hanno notizie certe. Nelle prossime settimane pubblicheremo dei post specifici su ognuno di essi. Nel frattempo speriamo che si materializzino anche nuove opportunità.
Villa Altieri: Progetto terminato e già fruibile
Museo della Scuola Romana e del primo novecento a via Merulana : Fondazione Cerasi, in…
View original post 156 altre parole
March 31, 2018
Epidemie, fake news e propaganda
[image error]
Anni fa, quando ero giovane, bello e magro, mi dedicai all’epidemologia computazionale, ossia alla definizione degli algoritmi e modelli computazionali per simulare la diffusione e l’evoluzione nello spazio e nel tempo delle malattie.
In pratica, cercavo di integrare i modelli SIS e SIR, basati su catene markoviane, con la teoria del caos e la teoria delle reti complessi, con dei risultati, senza falsa modestia, alquanto interessanti.
Dopo qualche anno, infatti, quell’impostazione teorica non solo è rimasta invariata, ma si è addirittura arricchita: gli algoritmi sono diventati assai più complessi, grazie al cloud e all’utilizzo di soluzioni basate su Apache Storm e Spark, la potenza computazionale dedicata alle simulazioni è cresciuta esponenzialmente, in più grazie ai bug data e alla trend analysis sui social media, monitorando in tempo reale la diffusione delle epidemie, è possibile raffinare e tarare in tempo reale i modelli di calcolo.
Il che, nel caso di Ebola nell’estate del 2014 e di Zika nel 2016 ha permesso di ottimizzare le strategie contro la diffusione della pandemia, con risultati positivi.
In tutto ciò, mi potreste chiedere, tu che c’entri ? Mica fai il medico… Però, i meccanismi della diffusione delle malattie batteriche e virali, sono analoghi a quelli con cui si diffondono i meme, le minime minima unità culturale come, ad esempio, una moda, una frase fatta, uno stereotipo, un modo di dire, una battuta di spirito, che si propaga tra le persone attraverso la copia o l’imitazione mediante disseminazione, condivisione e citazione.
Entrambi si basano su reti di “focolari”: le epidemie, come i meme non si diffondono seguendo un percorso lineare, ma piuttosto a “hub”.
Nel caso specifico, nei social media, ci sono alcuni utenti particolarmente “influenti” e seguiti, spesso anche con centinaia di migliaia di follower, i cui post hanno una probabilità esponenzialmente più alta di diffondersi. E se si convincono questi o si creano artificialmente questi influencer, amplificando la loro visibilità con opportuni meccanismi di coordinamento di reti complesse, è molto facile diffondere meme.
Tale tecnica è stata inizialmente utilizzata nella pubblicità: grazie al filter bubble, il meccanismo per cui i social media, utilizzando le informazioni disponibili su un utente (come posizione, click precedenti, ricerche passate), selezionano i contenuti a cui questo può accedere, e al microtargeting la pubblicità on line può far pervenire ogni volta al target più adatto messaggi confermanti, con più probabilità di provocare una reazione (like, condivisione, commento favorevole). Questa pratica va sotto il nome di dark advertising: l’associarla ai modelli epidemologici aumenta la velocità di diffusione di tali messaggi, indirizzando la propensione del potenziale cliente ad acquistare questo o quel prodotto.
La novità introdotta in Italia dai Cinque Stelle e negli Usa da Trump è l’applicazione di queste tecniche pubblicitarie dalla marketing alla politica: si è costruita a tavolino e artificialmente una rete di influencer, che, a fini politici e con algoritmi ben precisi, che possono essere ricostruiti a posteriori, hanno diffuso fake news a fini politici.
Strategia che è la naturale evoluzione della comunicazione berlusconiana: da un messaggio semplice diretto a tutti, si è passato a uno personalizzato, basato sui pregiudizi e sulle paure del singolo elettore, che oltre a portare voti, che permette anche notevoli introiti economici
Bando Premio SHORT-KIPPLE 2018
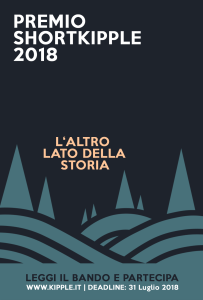 Kipple Officina Libraria bandisce per l’anno 2018
Kipple Officina Libraria bandisce per l’anno 2018
l’VIII edizione del Premio Short Kipple per il miglior racconto digenere fantastico
1) Sono ammesse solo le opere in lingua italiana inedite, mai pubblicate su carta o in digitale, neppure parzialmente. I racconti devono avere la lunghezza minima di 5 cartelle dattiloscritte e massima di 20 cartelle (per cartella s’intende, all’incirca, una pagina da 60 battute di 30 righe, cioè 1800 caratteri spazi inclusi).
2) Il contenuto deve essere SOLO ed ESCLUSIVAMENTE fantastico. I generi ammessi sono:
– Fantascienza (hard science-fiction, post-cyberpunk, steampunk, bio-punk, anticipazione, ecc.)
– Weird (New Weird, neo-noir, horror, urban fantasy, ecc.)
Testi di qualsiasi altra natura NON verranno presi in considerazione.
3) È possibile partecipare con più opere.
4) La quota di partecipazione è fissata in 5 € perogni racconto, da accreditare entro il 31 luglio 2018
I) tramite paypal: kol@kipple.it
II) con accredito sul
View original post 271 altre parole
March 30, 2018
L’emporio di Tavolara
[image error]
Qualche settimana fa, è apparsa sui giornali la notizia di un emporio villanoviano in Sardegna, nell’area protetta sull’isola di Tavolara, sviluppato ai primordi dell’età del Ferro, tra il decimo e nono secolo avanti Cristo. Scoperta che ha scatenato una gran cagnara nei siti di fanta archeologia, portando a formulare una ridda di ipotesi sull’origine sarda della lingua etrusca, che però ha nascosto la grande importanza storica del ritrovamento, che è un tassello fondamentale per descrivere l’evoluzione dei commerci nell’età del Bronzo
Dai ritrovamenti archeologici di ceramica minia, sia questa associata all’arrivo delle popolazioni indoeuropee in Greca o frutto di una naturale evoluzione locale, in Salento, nell’alto Adriatico e in Troade, sappiamo che tra il 1900 a.C. e il 1700 a.C. esisteva una complessa rete di commerci che univa la civiltà appenninica, l’Ellade e i protoluvi in Anatolia, che però sembra escludere il Mediterraneo Occidentale.
Per circa un secolo e mezzo, tra il 1700 a.C. e il 1550 a.C. per motivi attualmente non chiari, questa rete di commerci collassa, tanto che in Salento e nel Barese, per soddisfare le richieste delle popolazioni di pastori che, come in tempi storici, compivano la transumanza tra Abruzzi e Capitanata, si sviluppa un’industria ceramica locale, che produce modelli che imitano quelli di importazione greca delle generazioni precedenti
Dal 1550 a.C. in poi, anno più, anno meno, i micenei ricominciano a navigare: da quanto capiamo dalla lineare B, i mercanti non erano liberi imprenditori, ma una sorta di impiegati statali. Solo con la tarda età del Bronzo, si comincerà a diffondere, dalle testimonianze che abbiamo da Ugarit, la libera iniziativa privata
Essendo un’iniziativa politica, oltre che economica, questi primi commerci seguono una direttiva inaspettata: per non avere contrasto con le popolazioni minoiche, non si dirigono verso Oriente, ma verso Occidente. Mancando sufficienti dati archeologici, è difficile spiegare perché i Micenei evitino di inoltrarsi nell’Adriatico: probabilmente, ma è un’ipotesi non suffragata da prove, esistevano vie commerciali alternative a quelle che terminavano nella Pianura Padana per accedere allo stagno e all’ambra proveniente dal Nord Europa. In più, forse, la necessità di approvvigionarsi di lana, il principale bene di esportazione da parte delle popolazioni appenniniche, a meno che a Micene non fossero particolarmente golosi di pecorini abruzzesi, all’epoca era assai minore rispetto alla tarda età del Bronzo.
Sia come sia, i Micenei puntano al Tirreno, creando degli empori in Calabria, in Sicilia e commerciando in maniera diretta e indiretta con le popolazioni dei nuraghi. Uno scambio economico e culturale che è bidirezionale, tanto che, per esempio, i micenei, cominciano a produrre spade e pugnali che imitano nella foggia quelle sarde (le Sant’Iroxi).
Dal 1400 a.C. in poi, cambiano di nuovo le cose: il complesso e poco chiaro processo di integrazione tra micenei e minoici volge al termine e le popolazioni dell’Egeo concentrano i loro commerci in Anatolia, Siria e Adriatico, il che provoca la crescita di Frattesina e la creazione di empori micenei in Salento e nel resto della Puglia; il boom della produzione tessile micenee, testimoniato dalle tavolette in lineare B, fa ritornare in auge l’importazione della lana delle popolazioni appenniniche.
Questo riduce il commercio miceneo nel Tirreno: il loro ruolo nel commercio a lunga distanza tra Mediterraneo Occidentale e Orientale è preso dai ciprioti, con i sardi che sembrano utilizzare i lingotti a forma di pelle di bue, tipici di Cipro, come una sorta di bene rifugio, e dai siriaci. Al contempo, i popoli nuragici si affermano come principali intermediari nel commercio locale tra costa Tirrenica dell’Italia, Provenza e Spagna.
Ruolo che produce una serie di complessi cambiamenti nella società sarda e che si accentua con la crisi dell’età del Bronzo che come come in Polesine, crea in Sardegna un boom sia “produttivo”, sia commerciale. E Tavolara è la testimonianza di questo boom e delle reti commerciali che univano la Sardegna con le popolazioni della cultura laziale e villanoviana. Boom commerciale che si accentuerà dall’VIII secolo in poi con l’arrivo dei Fenici, che porterà alla nascita dei primi centri protourbani
March 29, 2018
Mausolei Imperiali a San Pietro
[image error]
Ha destato un poco di sorpresa, la storia, raccontata ieri, della presenza accanto alla basilica costantiniana di San Pietro la presenza di due mausolei imperiali, l’uno appartenente a Onorio, l’altro di incerta attribuzione, connessi tra loro per mezzo di un nartece e comunicavano con la parte settentrionale del transetto della basilica per mezzo di un altro nartece.
A dire il vero, alcuni archeologi, a seguito di scavi compiti negli anni Cinquanta, hanno provato ad attribuire il mausoleo ignoto all’epoca di Caracalla: attribuzione che però mi lascia perplesso. Da una parte, la pianta di entrambi, circolare all’esterno, ottagonale all’interno, con nicchie che alleggeriscono la struttura muraria, presuppone la conoscenza dei mausolei tardo antichi, la tomba di Galerio a Tessalonica e quelle di Elena e Costantina a Roma, derivati dal Tempio di Minerva Medica all’Esquilino.
Dall’altra, le dimensione simili dei due edifici, per il Mausoleo di Onorio il diametro è di 15 metri e mezzo, per l’altro è di poco più di 16,75 metri e le nicchie di 4,5 metri di larghezza e 2 metri di profondità, suggeriscono che siano frutto di un progetto unitario.Alcuni studiosi suggeriscono come il mausoleo ignoto risalga invece all’epoca dei Secondi Flavi e sia la tomba di Anastasia, sorellastra di Costantino e che Onorio abbia voluto imitarlo, per rendere omaggio alla famiglia del primo imperatore cristiano. Tuttavia, mancando sia una testimonianza documentale precisa, sia resti archeologici, per quanto suggestiva, anche questa ipotesi manca di fondamento.
[image error]
Nel Medioevo, entrambi i mausolei ebbero una storia complessa e affascinante: quello di Onorio si trasformò nella cappella di Santa Petronilla. Nel 757 papa Paolo I, per adempiere alla promessa fatta dal suo predecessore e fratello Stefano II al re dei Franchi Pipino, decise di traslare il corpo della presunta figlia di San Pietro dalla Catacomba di Domitilla sull’Ardeatina e non sapendo dove metterlo, decise di piazzare le reliquie in uno dei sarcofaghi teodosiani.
Nel Natale del 800, Carlo Magno si recò nel mausoleo, per rendere omaggio alla Santa e affermare la continuità simbolica del suo stato con quello degli ultimi imperatori romani, al contempo pagando una serie di lavori di decorazione e di restauro, diventando la chiesa nazionale francese a Roma.
Nell’846 i saraceni fecero scempio della costruzione e per molto tempo il corpo di Petronilla si credette perso o trafugato dai francesi. Nel 1470 le spoglie furono rinvenute durante i lavori di restauro voluti da Luigi XI, che qualche anno dopo, portarono alla scoperta della misteriosa tomba dell’uomo accompagnato con un bambino. Carlo VIII ruppe talmente le scatole a Innocenzo VIII, che il Papa dovette riconoscerne ufficialmente il patrocinio . Di conseguenza la chiesa iniziò a essere chiamata la «Cappella del Re di Francia».
Nel 1497, il Mausoleo Onoriano assume un ruolo centrale nella Storia dell’Arte; il benedettino Jean de Bilhères-Lagraulas, venuto a Roma nel 1491 a capo di una delegazione inviata da Carlo VIII presso la corte papale, governatore di Roma durante il periodo di sede vacante seguito alla morte di Innocenzo VIII, e fu poi tra i primi a essere creato cardinale di Santa Sabina da Alessandro VI, nel settembre 1493, si sente vicino alla morte.
[image error]
Per decorare la sua tomba, che da buon francese vuole in Santa Petronilla, decide di affidarsi a un giovane scultore fiorentino, tale Michelangelo a cui da l’incarico di di scolpire
“una Vergene Maria Vestita, con un Christo morto in braccio, grande quanto sia uno homo giusto”
Nel contratto per la commissione della statua, il banchiere Jacopo Galli garantisce al cardinale che la statua sarà
“la più bella opera di marmo che sia hoge in Roma et che maestro nissuno la faria megliore hoge”
Michelangelo impiega ben nove mesi per scegliere il blocco di marmo e trasportarlo dalle cave di Carrara a Roma, il contratto ufficiale per la realizzazione della Pietà vaticana, infatti, è firmato nell’agosto del 1498 e prevede un solo anno per la consegna dell’opera. Dalle ricevute di pagamento non risulta chiaro se lo scultore abbia rispettato la data di consegna: riceve un pagamento dalla banca Ghinucci, esecutrice testamentaria del cardinale Bilhères, nel luglio del 1500 e questa pare la data più verosimile per il completamento dell’opera. C’è però un insolito pagamento dello stesso Michelangelo a un certo “Sandro muratore”, che compare qui per la prima e ultima volta nei suoi conti, il 6 agosto 1499: potrebbe essere stato pagato per installare la statua della Pietà nella chiesa di Santa Petronilla. In questo caso le scadenze contrattuali sarebbero state rispettate
Ma dove era di preciso la Pietà ? Dalle caratteristiche della statua, sappiamo che non poteva essere posta molto in alto e che doveva essere situata in un luogo che ne permettesse sia la visione laterale, sia frontale.
Alcuni indizi, poi, fanno pensare che Michelangelo abbia considerato il punto di vista da sinistra a destra come quello privilegiato. Inoltre la Pietà non poteva essere posta sull’altare maggiore, che era proprio davanti all’ingresso del Mausoleo, essendo tutto lo spazio occupato dal ciborio e dalle colonne tardo antiche: per cui, la posizione più probabile sembra essere la nicchia proprio alla sua sinistra, che sappiamo da fonti quattrocentesche essere stata dedicata alla Vergine e al Salvatore.
Dopo questo momento di gloria, nel 1520, fu cominciata la demolizione del Onoriano, che negli anni successivi, portò alla scoperta della tomba di Maria, moglie del figlio di Teodosio.


Il mausoleo ignoto, invece, per le decorazioni volute da Gregorio III, in polemica con gli iconoclasti, fu dedicato alla Madonna e per una serie di miracoli, all’icona lì conservata fu prima attribuita la capacità di proteggere il fedele dalla malaria, da cui il nome di Madonna della Febbre, poi, dato che secondo una leggenda del Quattrocento, colpita da una palla da gioco durante una partita a bocce tra cardinali, cominciò a sanguinare, fu poi chiamata della Bocciata.
Cambiò infine nome in Cappella di Sant’Andrea nel 1462, quando la reliquia della testa dell’apostolo, messa in salvo dall’invasione della Morea da parte dei Turchi, giunse in Italia attraverso il porto di Ancona e fu condotta a Roma dove il cardinale Bessarione la consegnò a Pio II al ponte Milvio e fu portata in corteo fino alla basilica di san Pietro.
Dopo la demolizione del Mausoleo Onoriano, vi fu trasferita la Pietà di Michelangelo: A poco distanza sorgeva l’obelisco Vaticano che fu poi spostato nel 1586 da Domenico Fontana per papa Sisto V Peretti di fronte alla nuova basilica ancora in costruzione.
Però, portando forse iella la Pietà ai mausolei tardo imperiali, la cappella di Sant’Andrea fu demolita tra il 1776 ed il 1784, durante il pontificato di papa Pio VI, la costruzione fosse distrutta proprio per far posto alla nuova sacrestia di Carlo Marchionni.
[image error]
Ho accennato al ritrovamento durante la demolizione del Mausoleo Onoriano della tomba dell’imperatrice Maria. Il corredo ritrovato fu suntuosissimo. A tale proposito Rodolfo Lanciani racconta:
La bellissima imperatrice giaceva in una bara di granito rosso, con indosso le vesti imperiali intessute d’oro; dello stesso materiale erano il velo e la sindone che copriva la testa e il petto. La fusione di questi materiali produsse un considerevole ammontare di oro puro, il cui peso è riportato differentemente come di trentacinque o quaranta libbre. […] Alla destra del corpo c’era un cesto di argento puro, pieno di recipienti e porta-profumi, scolpiti nel cristallo di rocca, nell’agata e in altre pietre preziose. Erano trenta in totale, tra i quali c’erano due coppe, una tonda e una ovale, decorate con figure ad altorilievo, di gusto squisito, e una lampada, fatta d’oro e cristallo, della forma di una conchiglia corrugata, con il foro dell’olio protetto e camuffato da una mosca d’oro, che ruotava attorno ad un perno. C’erano anche quattro vasi d’oro, uno dei quali tempestato di gemme.
In un secondo cestello di argento sbalzato, posto sul lato sinistro, furono ritrovati centocinquanta oggetti: anelli d’oro con pietre incastonate, orecchini, collane, bottoni, spille per capelli eccetera, ricoperti di smeraldi, perle e zaffiri; una noce d’oro, che si apriva a metà; una bulla pubblicata in un lavoro di Mazzucchelli; e uno smeraldo inciso con il busto di Onorio, valutato cinquecento ducati. Gli oggetti d’argento erano scarsi; di questi troviamo menzionati solo una pinza per capelli e una cerniera a sbalzo.
Le lettere e i nomi incisi su alcuni pezzi provano che formavano il mundus muliebris (doni nuziali) e gli articoli di toletta di Maria […] A fianco dei nomi dei quattro arcangeli – Raffaele, Gabriele, Michele e Uriele – incisi su di una fascia d’oro, quelli di Domina Nostra Maria e di Dominus Noster Honorius comparivano su altri oggetti. La bulla era incisa con i nomi di Onorio, Maria, Stilicone, Serena, Termanzia e Eucheio, posti a raggiera a formare una doppia croce con l’esclamazione “Vivatis!” tra loro. Con l’eccezione di questa bulla, […] ciascun pezzo è scomparso. […] Non si trattava del lavoro di orefici del quinto secolo, ma erano di origine classica; infatti rappresentavano una porzione dei gioielli imperiali, che Onorio aveva ereditato dai suoi predecessori, e che aveva offerto a Maria in occasione del suo matrimonio. Claudiano, il poeta di corte, li descrisse espressivamente come quelli che avevano brillato sul petto e la testa delle imperatrici dei giorni andati.
[image error]
Di tutto questo ben di Dio è rimasta solo la Bulla. Il resto probabilmente è andato fuso… Per i casi della vita, all’appello delle tombe imperiali ritrovate, Maria, l’uomo misterioso, forse Eucherio, l’altro figlio di Stilicone, il bambino, mancano proprio quelle di Onorio e dell’altra moglie Termanzia.
Ora, questo non vuol dire che sotto il pavimento della Sacrestia di San Pietro vi sia la versione tardo antica della tomba di Tutankhamon. Semplicemente è che non c’è rimasta traccia documentale di un loro ritrovamento, che può essere avvenuto nell’Alto Medioevo
March 28, 2018
Il non Mausoleo di Galla Placidia






Tutti conoscono il mausoleo di Galla Placidia, uno dei gioielli paleocristiani di Ravenna, per lo splendore dei suoi mosaici: pochi però sanno come tale denominazione sia probabilmente fittizia, mancando qualsiasi certezza sulla destinazione funebre dell’edificio.
Di fatto non abbiamo la più pallida idea di dove sia stata seppellita Galla Placidia: il fatto che sia avvenuta a Ravenna è citato solo nel Liber pontificalis ecclesiae ravennatis da Agnello Ravennate, autore con un rapporto a volte creativo con la Storia, scritto quattro secoli dopo la morte dell’imperatrice.
Sia l’ipotesi che sia sepolta a Milano nella cappella di Sant’Aquilino o nel Mausoleo Onoriano a San Pietro, non sono sostenute da prove certe.
Benché nel giugno 1458 nel Mausoleo Onoriano o Capppella di Santa Petronilla fosse trovato un sontuoso sarcofago in marmo contenente due bare in cipresso, una grande e una piccola, foderate d’argento, con all’interno due corpi, un adulto e un bambino, avvolti in vestiti intessuti d’oro, non è per nulla provato che questi due membri della famiglia imperiale siano Galla e il suo primogenito Teodosio.
Così racconta un testimone dell’epoca, Nicolo’ della Tuccia da Viterbo
Si disse che i corpi erano quelli di Costantino e di suo figlio piccolo . Non fu trovata alcuna testimonianza scritta ne’ alcun segno a parte una croce con questa forma (greca)
Per cui è probabile che il corpo trovato non fosse di una donna… Solo che purtroppo ogni testimonianza concreta di quella scoperta è stata distrutta… Niccolò continua dicendo
Papa Callisto III prese possesso di ogni cosa e mando’ l’oro e l’ argento alla zecca
[image error]
Però, proprio il Mausoleo Onoriano, ci da l’idea di come potesse essere una tomba imperiale dell’epoca: di forma circolare, analogo ai mausolei costantiniani e internamente ottagonale, con otto grandi nicchie nel muro, in cui Onorio e le moglie furono seppelliti, in sarcofaghi di porfido. Insomma, qualcosa di ben diverso del Mausoleo di Galla Placidia. Un paio di studiosi, tra l’altro, hanno interpretato il secondo mausoleo presente, collegato all’Onoriano con un nartece, che nel Medioevo diventerà Santa Maria della Febbre, normalmente considerato come cenotafio di Teodosio, potesse essere l’estrema dimora dell’imperatrice, in modo che risultasse sepolta accanto al fratello. Ma anche per questa ipotesi mancano prove documentali.
Però, qualcosina dal punto di vista architettonico e iconografico possiamo dirla: in origine il Mausoleo era ben diverso da quanto appare oggi: non era infatti un edificio isolato, ma era collegato tramite un nartece alla chiesa di Santa Croce, a sua volta integrata nel palazzo imperiale di Galla Placidia. Di fatto, la sorella di Onorio sembrerebbe aver replicato a Ravenna la struttura del Palatium Sessorianum: per cui, se prendiamo come riferimento la pianta di Santa Croce in Gerusalemme, che Galla aveva fatto decorare con ricchi mosaici, il Mausoleo, come posizione non coinciderebbe con un edificio funerario, ma con la Cappella delle Reliquie. Per cui, darebbe più l’idea di un martyrion, che di una tomba, di cui condivide la tipica struttura pianta centrale, sovrastata da una cupola
Continuando con lo stesso ragionamento, l’ipotetica cappella disposta simmetricamente rispetto al mausoleo, dall’altro lato del nartece, di cui però mancano le evidenze archeologiche, che alcuni studiosi identificano con quella di San Zaccaria, fatta costruire Singledia, nipote di Galla, coinciderebbe invece con il battistero, sempre prendendo a modello la basilica romana.
Infine la tipologia di mosaici, che sono simili a quelli del battistero di San Giovanni in Fonte a Napoli, a quelli della Rotonda di San Giorgio a Tessalonica e del battistero Neoniano, sempre a Ravenna, è utilizzata in ambiti ben diversi, da quelli funerari. Per cui, data la presenza della rappresentazione di San Lorenzo prossimo al martirio, nulla vieta che l’edificio, più che un Mausoleo, possa essere una cappella dedicata alla memoria di tale santo, in cui forse Galla Placidia conservava le presunte reliquie

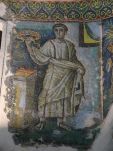




Alessio Brugnoli's Blog






