Alessio Brugnoli's Blog, page 147
June 10, 2018
Sportello per la Street Art


Un annetto fa, nel pieno della polemica sul Murale di Mauro Sgarbi nel Mercato Esquilino, lanciammo una proposta, ispirata dalle iniziative di un’altra amministrazione grillina, su come normare e semplificare il complesso processo relativo alla street art.
La risposta fu un assordante silenzio, perché d’altra parte, Amministrazione Raggi, Cultura e Arte sono parole che difficilmente si trovano nella stessa frase.
Solo che dopo un anno, la questione è sempre aperta: faccio un esempio concreto. Il buon Marco Tarascio, un caro amico,sperando che realizzerà presto un suo capolavoro per il nostro Rione, assieme a Giusi ha realizzato una splendida opera d’arte, un poetico richiamo alla classicità nel suo rappresentare le Ninfe dei Mari e i sogni poetici delle Balene, che rappresenta la continuità tra Natura e Uomo: se questa non prospera, noi perdiamo la nostra identità, riducendoci poco più che macchine senza cuore e cervello.
Opere apprezzate sia dai committenti, che così hanno commentato il frutto della creazione di Marco
Grazie per la tua sensibilità, grazie per aver reso “Arte” due serrande inguardabili, grazie per il messaggio elegante e forte che hai voluto dare
sia da tanti, tanti romani… Il problema è che in teoria, per una vecchia delibera, mi pare dei tempi di Veltroni o di Rutelli, legata alla tutela del Centro Storico come patrimonio dell’Unesco, quando insomma la street art era una cosa che accadeva a New York o a Londra, mica a casa nostra, l’opera di Marco sarebbe illegale…
E benché il Comune, in generale, se ne freghi alquanto, tanto da avere una pagina non aggiornata, che parla dei murale del Centro Storico, basterebbe che la Giusi Campanini di turno si svegliasse con il piede sbagliato, per vedere distrutti tali capolavori e Marco e il suo committente multati.
Per evitare questo paradosso o passando a Piazza Vittorio, premesso che non so come sia andata a finire la vicenda della multa, spero bene, e che continuo ad avere decine di perplessità su StendardArt, per impedire che si ripeta una situazione del genere per l’Arco di Galieno o per chi promuova public art in zona, insomma, ribadisco, anche se temo inutilmente, la necessità di regolamentare il tutto in modo chiaro e semplice, abolendo divieti anacronistici, dando una specifica dignità alla creazione artistica, non applicandovi vincoli, certo giustissimi, ma relativi all’ambito dei lavori edilizi e magari creando, data la complessità della realtà romana, uno sportello per la street e public art per ogni Municipio.
Sportello che non si occupi solo della parte burocratica, ma anche del promuovere e tutelare quanto attualmente esiste, una risorsa per arricchire e rilanciare tante aree della nostra città…
June 9, 2018
Identità e Radici























Ieri sera, la presentazione di Un amore pizzicato è stato qualcosa di più dell’occasione per conoscere un bel libro o un prologo della prossima stagione in piazza de Le danze di Piazza Vittorio (a proposito, chi non viene, si possa trovare a pranzo con Salvini e Di Maio); è stata una profonda e provocatoria riflessione sull’Identità e sulle proprie radici.
L’Identità, a differenza di ciò che afferma la cattiva politica, non è qualcosa di fisso e immutabile, ma si costruisce ogni giorno, con le esperienze che viviamo e con il dialogo con le tante persone che incontriamo; la diversità non la impoverisce, ma anzi, la rende più ricca e profonda.
L’Identità non esclude, ma include: non costruisce barriere, ma ponti. E le radici, concetto complesso e contraddittorio, specie in Calabria, dove si scontano bene e male, non sono catene che ci imprigionano, ma le ali con cui spicchiamo il volo.
Sono il nostro tesoro più profondo e prezioso, che ci ricorda ciò siamo e ci indica cosa dovremmo essere, e ci sostieni nei momenti buoi della vita. Tutto ciò, ieri, non è stato mostrato solo con le parole, ma soprattutto con la musica e la danza.
Con la ricerca di Francesco di uno stecchino per accordare la zampogna
Con l’entusiasmo di Fabio nel suonare l’organetto
Nel ballare la scottish, danza per cui il sottoscritto è negato, come può testimoniare Ilaria, che ormai ha rinunciato ad insegnarmela, che però è la stessa con cui si apre il romanzo Un amore pizzicato
Nel sonu a ballu, in attesa di tornare quest’estate a Reggio e rivedere i luoghi della Grecanica
Nella bellezza inquietante e avvolgente della pizzica
Nel sentire mia moglie cantare le musiche della sua terra
O Rossana evocare con profonda malinconia la sua terra, eterno ossimoro, tanto è aspra, quanto è dolce
O Giacomo, Madana e Mario dare fondo alle loro energie, nel suonare una travolgente tammurriata
Musica dionisiaca, che esalta tutto il nostro amore per la vita, qualunque sia la nostra origine o la nostra storia
Insomma, a martedì, per continuare a percorrere assieme la nostra strada
June 8, 2018
Burcardo
[image error]
Nella notte del 30 ottobre del 1501, a Roma, Cesare Borgia organizzò un banchetto nelle sue stanze del palazzo apostolico, cinquanta oneste meretrici, dette cortigiane, danzarono dopo cena con i servitori e gli altri presenti, dapprima vestite, poi nude. Dopo cena, i candelabri con le candele accese vennero tolti dai tavoli e messi sul pavimento, dove vennero sparse anche delle castagne, che le meretrici, strisciando tra i candelabri sule mani e sui piedi, raccoglievano, alla presenza e sotto lo sguardo del Papa, del Signore [Cesare Borgia] e di donna Lucrezia. Infine, vennero elargite in dono tuniche di seta, scarpe, berretti ed altre cose a coloro che riuscivano a conoscere carnalmente le dette meretrici per più volte
E’ uno dei brani, anche se forse interpolato, del buon Burcardo, per i quali, il prelato, che voleva essere un onesto e imparziale cronista della sua epoca, ha assunto una fama di pettegolo degna di quella di Liutprando.
Ma chi era Burcardo ? Sappiamo che nacque con tutta probabilità nel 1450 a Haslach in Alsazia, nella diocesi di Strasburgo (“Argentinensis” si definì per tutta la vita), da una famiglia di morti di fame; per tirare a campare, come accadeva all’epoca, si buttò nella carriera ecclesiastica e ragazzotto, entrò nella collegiata di San Fiorenzo della sua città natale, dove ricevette la prima istruzione che tuttavia non dovette oltrepassare le nozioni più elementari.
Impedito dalla scarsezza dei suoi mezzi a proseguire gli studi, entrò al servizio di Johannes Wegeraufft, canonico di San Tommaso e vicario “in spiritualibus” del vescovo di Strasburgo Ruprecht von Simmern, pare con funzioni di scrivano.
Posto da cui fu cacciato a pedate per una serie di gravi reati: l’aver falsificato e venduto formulari in bianco di dispense dalle pubblicazioni matrimoniali munite del sigillo del vescovo e di avere saccheggiato il tesoro e l’armeria del suo datore di lavoro.
Per non morire di fame e non essere impalato, Burcardo prese armi e bagagli e si mise in viaggio per Roma, dove giunse nell’ottobre del 1467, non ancora diciottenne, alla ricerca di miglior fortuna. Essendo una simpatica canaglia, non tardò molto a inserirsi in quella gabbia di matti che era l’Urbe dell’epoca, tanto che già Paolo II, pontefice che amava più la bisboccia che la cultura, lo mise in lista d’attesa per ottenere il beneficio, ossia la rendita, connesse alla cappellania perpetua dell’altare di S. Eligio nella chiesa di Strasburgo.
Burcardo entrò al seguito del cardinale Marco Barbo, che però non è che avesse tutta questa simpatia e stima per il nostro eroe, dato che lo classificò penultimo dei suoi ottanta familiari e commensali. Sisto IV, intanto, gli concesse altre due aspettative, quella per un canonicato nel capitolo di San Tommaso a Strasbugo e quello per un canonicato e cantoria nel capitolo di San Fiorenzo in Haslach; dato che con il cardinal Barbo vigeva la regola del tanto lavorare, poco pagare, nel 1473 Burcardo entrò nella famiglia del cardinale Giovanni Arcimboldi che gli procurò nello stesso anno il titolo di familiare e
commensale continuo del pontefice stesso, privilegio che comportava la precedenza nelle aspettative dei benefici rispetto agli altri concorrenti. Nel 1475 risulta al servizio di Tommaso Vincenzi, vescovo di Pesaro e tesoriere generale pontificio, che gli aprì le porte del palazzo vaticano.
Il grosso ostacolo, però, per percepire il reddito connesso ai benefici ecclesiastici per cui era in lista d’attesa, erano i casini combinati da ragazzo: ogni concessione, scatenava una causa con gli altri pretendenti, che terminava regolarmente davanti alla Sacra Rota, che corruttibile come era, tirava le cose per lunghe, mettendo poi all’asta tra i contendenti le sue sentenze. Così Burcardo, per tagliare la testa al toro, chiese al papa l’assoluzione dai peccati giovanili: prima da quello di falso, che ottenne il 2 otttobre 1473, e poi, visto che i concorrenti al beneficio non si erano dati per vinti, anche dal furto, confessato e perdonato nel 1475. Forte dei due decreti di assoluzione che rimuovevano ogni impedimento canonico, nel 1477 Burcardo si recò trionfante a Strasburgo, dove ottenne anche la cittadinanza, che gli dovette facilitare l’accesso al benefici e quindi ai soldi.
Da quel momento in poi, Burcardo divenne un cacciatore professionista di benefici ecclesiastici, che accumulò con ritmo vertiginoso: se vi fosse stato un campionato dedicato, lo avrebbe vinto con ampio distacco sul secondo: al contempo, cercò di completare la sua mediocre istruzione, ma non ci fu cosa. Non era per niente portato agli studi giuridici e teologici.
In compenso, l’undici aprile 1478 fu nominato accolito e cappellano pontificio, il 7 luglio dello stesso anno abbreviatore delle lettere apostoliche, il 2 febbraio 1481 protonotario apostolico e il 29 novembre infine cerimoniere della cappella pontificia al posto di Agostino Patrizi, elevato alla dignità di vescovo di Pienza e Montalcino. Quest’ultima carica, che ottenne dietro l’esborso della cospicua somma di quattrocentocinquanta ducati.
Ora Burcardo, che sin dall’adolescenza aveva dimostrato un interesse spiccato per tutto ciò che riguardava il cerimoniale ecclesiastico, trovò finalmente uno scopo nella sua confusionaria vita, cominciando a scrivere una quantità industriale di noiosissimi trattati liturgici: curò la rielaborazione del Liber pontificalis che fu presentata a papa Innocenzo VIII il 20 dicembre 1485 nell’edizione a stampa curata da Stefano Planck e che, dopo una nuova revisione eseguita in collaborazione con Giacomo de Lutiis, vescovo di Caiazzo, fu ristampata nel 1497 a Roma con il titolo di Liber pontificalis editus diligentia Augustini Patricii de Piccolominibus episcopi Pientini et Iohannis Burckardi. Ebbe altre edizioni nel 1511 (Lione e Venezia) e nel 1520 (Venezia). Quest’ultima fu riprodotta quasi integralmente nella prima edizione ufficiale del Pontificale sotto Clemente VIII, a Roma nel 1598.
Sempre in collaborazione con il Patrizi e su incarico di Innocenzo VIII il Burcardo curò anche la revisione del cerimoniale romano che fu completata nel 1488 e presentata al pontefice il 29 febbraio di quell’anno. Ebbe la sua prima edizione con il titolo di Rituum ecclesiasticorum sive sacrarum caeremoniarum S. S. romanae ecclesiae libri tres nel 1516 a Venezia e fu ristampata nel 1557 a Colonia e nel 1582 ancora a Venezia.
Il Burcardo è autore anche di un Ordo missae secundum consuetudinem Sanctae Romanae ecclesiae, un piccolo manuale pratico di liturgia ad uso dei sacerdoti che ebbe grande diffusione e fu stampato da Stefano Planck a Roma nel 1498.
Opere di una noia mortale, che lo avrebbero condannato giustamente all’oblio; tuttavia Burcardo amava tenere un diario, il famigerato Liber notarum, raccontando così le vicissitudini di Innocenzo VIII, Alessandro VI, Pio III e Giulio II, scritto con una grafia ancora più brutta di quella del sottoscritto. Il povero Paride Grassi, che prese il suo posto come maestro di cerimonie pontificie,trovandoselo tra le mani, così commentò
credo ipsum habuisse diabolum pro copista
Nel diario, la descrizione delle “cappelle” papali e delle relative cerimonie, grande passione del Burcardo, è accompagnata dalla cronaca dei fatti più notevoli della vita curiale e cittadina di Roma, scritta confredda scrupolosità, aliena da tendenze di apologista o di denigratore, indifferente alle passioni politiche, il che conferisce singolare pregio di veridicità alle sue note.
Tornando alla sua carriera ecclesiastica, Burcardo divenne nel 1485 preposito di San Fiorenzo in Haslach e e decano del capitolo di San Tommaso, quello stesso dal quale era stato scacciato per le sue malefatte giovanili, dal 1488, divenne il 30 marzo dello stesso anno anche maestro del registro delle suppliche.
Nel 1491 Burcardo aveva preso in affitto dal monastero di Farfa un terreno nei pressi della via Papalis, il tragitto seguito dai papi, con una sontuosa processione, in occasione della loro salita al soglio pontificio. Il terreno ospitava i resti di un convento medievale, in rovina. Il Burcardo fece quindi edificare la sua abitazione privata su questo terreno, inglobando nella costruzione parte dell’edificio preesistente, che comprendeva una torre, che prese il nome di Argentina, dall’ appellativo, come già detto, col quale usava firmarsi il Burcardo, episcopus argentinensis o argentinus, in quanto nativo di
Strasburgo, il cui nome latino era Argentoratum a causa delle vicine miniere d’argento.
Il suo palazzetto, in stile gotico, si componeva di due corpi di fabbrica, l’abitazione principale affacciata sull’odierna Via del Sudario, e il corpo secondario che ospitava le stalle e la servitù. La sommità della torre svettava al di sopra dell’edificio principale, come testimoniano le stampe dell’epoca. Un’annotazione del Liber Notarum parla dell’illuminazione con torce poste sulla sommità della torre in occasione della festa di San Benedetto, il 21 marzo 1500. In quell’anno, quindi, la costruzione del palazzo doveva già essere stata ultimata.
Nel 1503 iniziò una contesa fra il Burcardo e la potente famiglia Cesarini, proprietaria di un terreno adiacente quello sul quale il prelato alsaziano aveva costruito il suo palazzo. Lo stesso Burcardo raccontò l’episodio nel suo Liber notarum, alla data del 31 gennaio 1503:
Nello stesso giorno, ultimo del predetto mese di gennaio, mi querelai con Nostro Signore, Perché iersera il cardinal Cesarini mi fece annunciare dal suo cameriere Sebastiano che portassi via tutte le mie robe dalle camere da me costruite sopra il suo orto, perché questa mattina egli voleva entrare e appropriarsele come cosa sua e a lui dovuta.
Giulio II, non volendo né far torto al Burcardo né inimicarsi la famiglia dei Cesarini, incaricò l’arcivescovo di Ragusa di dirimere la questione. Questi, salomonicamente, sentenziò che la casa sarebbe passata ai Cesarini solo dopo la morte del Burcardo.
Per consolare Burcardo di questa diatriba, il papa lo nominò vescovo di Orte e Civita Castellana, ottenendo però in cambio una serie di lamentele: il nostro eroe, infatti ambiva alle sede di Nepi, dotata di entrate assai più cospicue. Nel frattempo, dato che cominciò a soffrire di gotta, cominciò a frequentare i bagni di Viterbo, senza, a leggere il Liber Notarum, avere grosso sollievo
Morì il 16 maggio 1506 nella sua casa romana “satis lamentabiliter”, come annotò il suo segretario Michael Sander, e fu sepolto il giorno seguente nella chiesa di Santa Maria del Popolo, nella cappella del cardinale di Salerno Giovanni Vera. L’orazione funebre fu recitata dall’agostiniano Raffaello Lippo Brandolini.
Il suo diario, scritto come passatempo, riscoperto nel Seicento da Godefroy e da Leibniz, ne ha preservato la memoria e di questo Burcardo, ne sarebbe stato di certo sorpreso..
June 7, 2018
Istituto Nazionale per la Grafica
[image error]
E’ sempre un’emozione visitare Palazzo Poli, il luogo dove vivono, sognano, sperano e si arrabbiano i personaggi dei miei romanzi. Già la sua storia vera è alquanto affascinante: il nucleo più antico, con fronte su piazza di Ceri, terminato nei primi anni del XVII secolo, fu commissionato dal duca di Ceri, che nel 1566 aveva acquistato il palazzo Del Monte ubicato in quell’area. L’incarico di costruire il nuovo edificio, inglobando anche proprietà vicine, fu dato all’architetto Martino Longhi, il vecchio e, alla sua morte, a Ottaviano Mascherino.
Dopo ulteriori ingrandimenti effettuati dalla famiglia Borromeo, eredi della proprietà Ceri, il palazzo fu acquistato nel 1678 da Lucrezia Colonna, poi sposa di Giuseppe Lotario Conti, duca di Poli, da cui il nome del palazzo, il quale ritrovandosi il fratello Michelangelo papa, Innocenzo XIII, personaggio pieno di contraddizioni, che qualcuno si ostina a volere beatificare, tanto conservatore in maniera religiosa, tanto amante delle Arti e della Scienza, doveva trovarsi una casa degna di tale rango
Per cui ampliò l’edificio, comprando il palazzetto già Schiavo dei Carpegna e la casa dell’Arte della Lana, già Vitelleschi. Stefano Conti, figlio di Giuseppe Lotario, compì i lavori di ristrutturazione delle nuove parti inglobate, estendendo il palazzo ai definitivi confini, fino alla piazza di Trevi, fra il 1728 e il 1730, poco prima dell’inizio dei lavori per la nuova fontana del Salvi, nel 1732.
Nella storia vera, Nel 1808, alla morte di Michelangelo Conti, senza figli, il palazzo passò alla nipote Geltrude, sposa di Francesco Sforza Cesarini, il quale già nel 1812 lo vendette a Luigi Boncompagni Ludovisi. Dopo poco più di 70 anni, la proprietà fu venduta ai costruttori Belloni, Basevi e Vitali, che stravolsero la parte più antica dell’antico palazzo Ceri, già parzialmente distrutta per i lavori di via del Tritone.
Nel 1888 il Comune di Roma espropriò la porzione ancora integra del palazzo Poli per salvaguardare la fontana e l’edificio fu destinato ad ospitare uffici, inizialmente della Sezione del Tribunale Civile, poi dalla Provincia fu affittato per gli uffici degli Ispettori Catastali. L’edificio fu sede di logge massoniche, del consolato inglese e, dal 1857 al 1885, del Collegio Poli, nota scuola francese (frequentata anche da Trilussa) che si trovava al primo piano dell’ala demolita e che dovette quindi trasferirsi nell’attuale sede fra via San Sebastianello e via Alibert, con la nuova denominazione di Istituto San Giuseppe.
Nel 1939 l’edificio fu ceduto a privati come pagamento per la costruzione, per conto del Governatorato, di nuovi uffici sulla via del Mare, finché nel nel 1978 dallo Stato, esercitando il diritto di prelazione, dall’Istituto di San Paolo di Torino, proprio per unificare, anche negli spazi, la Calcografia Nazionale e il Gabinetto Nazionale delle Stampe, creando l’Istituto Nazionale per la Grafica
Nel mio mondo immaginario, Michelangelo, nonno del Principe Padre, ha un figlio, Appio, scavezzacollo, filo giacobino e ribelle, che per sfuggire alle ire del padre, assai codino, prima si trasferirà in Egitto, dove avrà a che fare con Belzoni e Drovetti, per poi fuggire in India, dove, dopo qualche disavventura con Paolo Avitabile e Rubino Ventura, sposerà, al posto di Solaroli, la nipote della begum Sumroo, diventando ricchissimo
Torquato, il Principe Padre, invece di mangiarsi tutto, come tradizione di famiglia, impiegherà l’immensa fortuna, per creare il suo impero commerciale e industriale: mi piace così immaginare le discussioni tra Michelangelo, Gogol e Belli, tra le sale di Palazzo Poli, oppure come possa, in questo mondo, variare la storia della Sala Dantesca.
Questa fu costruita sempre da Stefano Conti,per ospitare la preziosa biblioteca di famiglia, fu poi utilizzata dai suoi discendenti come salone per le feste. Nei primi anni dell’Ottocento vi aveva allestito il suo studio il pittore Francesco Manno. La denominazione storica della sala ricorda l’iniziativa del cavaliere Romualdo Gentilucci, che fra il 1865 e il 1866 affittò e ristrutturò questo ambiente per ospitare le
ventisette grandi tele costituenti la Galleria Dantesca, tele da lui commissionate a famosi pittori del tempo, tratte dai disegni di Filippo Bigioli. Questi dipinti, di enormi dimensioni, di quattro metri per sei metri, venivano mostrati alternativamente al pubblico con speciali meccanismi e giochi di luci. Per l’inaugurazione della sala fu eseguita la Sinfonia Dantesca di Liszt per grande orchestra e cori, furono
declamati un erudito discorso e nuovi versi composti su ispirazione delle scene della Divina Commedia illustrate. Magari nel mio nondo, potrà essere il frutto della megalomania di Appio Conti….
Tornando alla realtà, nonostante le sue stranezze, due ingressi, con orari differenti, dello stesso spazio museale per mantenere la distinzione tra i suoi antenati, il Gabinetto Nazionale delle Stampe e la Calcografia Nazionale non è mica una cosa tanto normale, anche perchè, paradossalmente, entrambi hanno la stessa origine,la passione collezionistica della famiglia Corsini, specie del cardinale Neri Maria (1685-1770), infaticabile raccoglitore per la biblioteca di famiglia di stampe e disegni, e di suo zio, papa Clemente XII (1730-1740) che nel 1738 fondò la Calcografia Camerale Romana, dopo aver acquisito la collezione di lastre della famosa stamperia de’ Rossi, su suggerimento del nipote Neri, allora cardinale camerlengo, l’Istituto Nazionale per la Grafica merita di essere visitato.

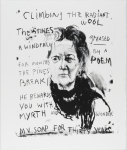
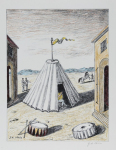
Da una parte vi è una splendida mostra di Francesco Casorati, un viaggio nel Novecento, tra informale, figurazione impegnata e visione immaginifica, che prende corpo in favolosi bestiari e vertiginosi labirinti grafici. Dall’altra la celebrazione della Litografia Bulla.
Per chi non lo sapesse, Inventata nel 1798 da Aloys Senefelder, la litografia è una tecnica di stampa da una matrice di pietra calcarea, che, sfruttando lo speciale trattamento chimico al quale la pietra viene sottoposta, permette di imprimervi un’immagine che può essere poi stampata in serie su carta o su altro supporto.
Pur essendo tradizionalmente annoverata fra le tecniche incisorie – con le quali condivide la difficoltà di dover disegnare un’immagine al rovescio rispetto a quella che sarà stampata – la litografia se ne distingue per essere una tecnica in piano: l’immagine stampata non deriva dal fatto che la matrice sia scavata – in incavo, come nel caso della calcografia, o in rilievo, come nel caso della xilografia – ma è il risultato dello speciale trattamento chimico-fisico al quale la pietra è sottoposta.
E i Bulla hanno fatto la storia di questa tecnica, sin dal 1818 a Parigi, dove Francesco, giunto dal Canton Ticino, stabilisce il primo stabilimento litografico in una delle strade più vivaci della capitale e dal 1840, quando il figlio Anselmo si trasferisce a Roma, aprendo la sua bottega in via del Vantaggio.
In tutto questo tempo, i Bulla ne hanno visti di artisti, da Giacomo Manzù a Giuseppe Capogrossi, Piero Dorazio, Cy Twombly e Massimo Campigli, da Jannis Kounellis a Mimmo Paladino, Luigi Ontani, Gianni Dessì, Enzo Cucchi e Jim Dine.
Insomma, uno spazio che arricchisce l’anima e ci avvicina alla Bellezza, con un piccolo neo, sottolineato anche dalle persone che vi lavorano, di una competenza, disponibilità e gentilezza straordinarie: la mancanza di libreria, in cui vendere i cataloghi delle splendide mostre e perché no, anche qualcuna delle stampe esposte
June 6, 2018
Un amore pizzicato
[image error]
Come sapete, a giugno Le danze di Piazza Vittorio terminano i loro laboratori invernali, presso la scuola Di Donato e tornano a suonare e a danzare ogni due martedì nei giardini di Piazza Vittorio: quest’anno cominceremo il 12.
Danzare non è un gesto inutile, come affermano i mediocri di cuore e gli scarsi di cervello: è gridare al mondo la propria volontà di vivere, è riappropriarsi dello spazio urbano, rendendolo più umano, è abbattere le mura della paura per costruire ponti con il diverso, cose di cui, in questi giorni, ne abbiamo sempre più bisogno, come anticorpi contro la barbarie che ci assedia ogni istante, rubandoci sogni e respiri.
Cose che facciamo con semplicità, per il gusto di donare, senza aspettarci nulla in cambio… Quest’anno, però, inauguriamo la bella stagione, con un evento, che si terrà venerdì otto giugno, alle 20.00, nella Sala Giuseppina, presso il Palazzo del Freddo, in via Principe Eugenio 65: la presentazione del libro Un amore pizzicato di Giuseppe Vivace.
Libro che è una storia d’amore, di dolore e di Anánkē, la necessità inalterabile e il fato, ambientato nel mondo delle danze clandestine di Milano, in cui si balla dal Bal Trad alla Viddaneddha; non si parla solo di musica, ma di coraggio e rimpianti, tra le acque confuse dei Navigli e la Calabria più aspra… Insomma, i due estremi tra cui oscilla il pendolo della mia vita.
A presentare il libro, oltre all’autore, vi saranno Francesco Serratore, che oltre ad essere uno degli zampognari di riferimento dell’Esquilino, è un colto e sensibile etnomusicologo e la cantante Rossana Camera: il sottoscritto, come moderatore, cercherà di non annoiarvi troppo.
Al termine della presentazione, ci scateneremo con la musica e la danza, finché il buon Andrea Fassi ci sopporterà…
June 5, 2018
L’acqua del Paradiso
[image error]
Oggi è stata una giornata complessa e controversa, dove però, sotto certi aspetti, ho avuto qualche piccola lezione di saggezza. Per condividerla, senza approfondire troppo le circostanze, utilizzero una buona vecchia favola sufi
Nel corso della loro vita da nomadi, Harith il Beduino e sua moglie Nafìsa erano soliti piantare la loro logora tenda dove potevano trovare qualche palma da dattero, qualche ramoscello rinsecchito per il loro cammello, o uno stagno di acqua salmastra.
Erano anni che facevano questa vita e ogni giorno Harith compiva gli stessi gesti: con la trappola prendeva i topi del deserto per via della loro pelle, e con le fibre di palma intrecciava corde che vendeva alle carovane di passaggio.
Un giorno, tuttavia, una nuova sorgente sgorgò dalle sabbie del deserto. Harith si portò l’acqua alle labbra e gli sembrò l’acqua del paradiso. Quell’acqua, che noi avremmo trovato terribilmente salata, era infatti molto meno torbida di quella che era abituato a bere. “Devo assolutamente farla assaggiare a qualcuno che sappia apprezzarla”, si disse Harith.
Si incamminò quindi sulla strada per la città di Bagdad e per il palazzo di Harun El-Rashid, fermandosi solo per sgranocchiare qualche dattero. Portava con sé due otri pieni d’acqua: uno per sé e l’altro per il califfo.
Alcuni giorni dopo raggiunse Bagdad e andò direttamente a palazzo. Le guardie ascoltarono la sua storia e, non potendo fare altrimenti – era questa l’usanza – lo ammisero all’udienza pubblica tenuta dal califfo.
“Comandante dei credenti”, disse Harith, “sono un povero beduino e conosco tutte le acque del deserto, benché sappia ben poco di altre cose. Ho appena scoperto quest’Acqua del Paradiso e ho subito pensato di portarvela perché, in verità, è un regalo degno di voi”.
Harun il Sincero assaggiò l’acqua e, dato che capiva i suoi sudditi, ordinò alle guardie di far accomodare il beduino e di trattenerlo finché non avrebbe fatto conoscere la sua decisione. Poi chiamò il capitano delle guardie e gli disse: “Ciò che per noi è niente, per lui è tutto. Al calar della notte conducetelo fuori dal palazzo. Non lasciate che veda il possente Tigri; scortatelo fino alla sua tenda senza permettergli mai di bere acqua dolce. Poi dategli mille monete d’oro con i miei ringraziamenti per i suoi servigi. Ditegli che lo nomino guardiano dell’Acqua del Paradiso e che dovrà offrirne da bere a mio nome a tutti i viaggiatori”
June 4, 2018
L’ex cinema Apollo e la Lucrezia Borgia de noantri…
E’ inutile girarci attorno: la vicenda del Cinema Teatro Apollo è una perfetta metafora di come Roma sia entrata in tilt negli ultimi anni.
La sua vicenda comincia a fine Ottocento, in quella che era piazza Guglielmo Pepe, dove Giuseppe Jovinelli e Concetta Calabrese fecero costruire per vari anni dei baracconi ad uso teatro in legno; per molto tempo questa piazza era stata un importante luogo di incontro ed intrattenimento. I continui rischi di incendio però, a cui erano sottoposte queste strutture, portarono Giuseppe Jovinelli alla decisione di costruire il suo primo teatro in muratura, il teatro Jovinelli (oggi Ambra Jovinelli) inaugurato nel 1909.
Pochi anni dopo, nel 1917, fece costruire un altro teatro, il Politeama Margherita (oggi ex cinema Apollo) adiacente al teatro Jovinelli. Il progetto per questo nuovo teatro venne affidato all’ingegner Luigi Federico Bobini e venne costruito all’angolo tra via Cairoli e viale Principessa Margherita (l’attuale via Giovanni Giolitti), realizzando uno dei gioielli del liberty romani.
L’ingresso principale era situato proprio all’angolo e doveva essere maggiormente segnalato da una cupola soprastante il vestibolo circolare che in corso d’opera non venne più realizzata. Il teatro, dalla struttura in cemento armato, conteneva più di duemila posti a sedere nella sua platea ovale.
Venne inaugurato nel 1918 con uno spettacolo di varietà a carattere popolare, vi recitarono Petrolini, Cacini, Totò e Aldo Fabrizi e dagli anni Cinquanta cominciò a svolgere la funzione di cinema con il nome di “Apollo”. Per un certo periodo fu anche un cinema a luci rosse, il “Pussycat”.
A fine anni Novanta, però, il cinema porno cominciò a non tirare più: per cui, per tornare a guadagnare, la proprietà decise di trasformarlo in una sala Bingo; la notizia provocò una rivolta da parte degli abitanti del Rione, che, appoggiati da intellettuali e artisti, convinsero il sindaco Veltroni a comprare, per una cifra pari a 3 milioni di euro, lo stabile.
Poco dopo, sempre Veltroni bandì una gara internazionale per trasformare l’Apolllo in centro culturale. Il progetto prevedeva la creazione di un cinema multietnico, per proiettare pellicole in tutte le lingue e di tutte le culture dell’Esquilino e altre attività tra cui bar e negozi. La gara venne vinta dalla Calendula, un’associazione temporanea di imprese che si fece carico dei lavori e che si impegnò a pagare 138 mila euro l’anno di affitto al Campidoglio.
Però, per cominciare i lavori, si attesero il parere della Sovraintendenza, che, come suo solito, se la prese alquanto comodo, dando qualche segno di vita a fine 2007; nel frattempo Veltroni, convinto di fare polpette di Berlusconi, si dimise in anticipo rispetto alla scadenza naturale.
Dopo il commissariamento, arrivò Alemanno, che tutto pensava, tranne che a valorizzare l’Apollo. L’accordo con la Calendula fu rinegoziato, a suo favore, con la durata della concessione allungata a trenta anni e l’affitto ridotto a a 50 mila euro l’anno, a partire dal nono anno. Ma anche questo accordo andò a peripatetiche; per cui la Calendula, per cercare di sollecitare il Campidoglio, fece intervenire anche la CNA, la confederazione degli artigiani. Ma pure la CNA dopo alcuni tentativi abbandonò il campo. Tutto
finì con il solito ricorso al Tar dove i privati accusarono il Comune di essersi disinteressato e il Campidoglio replicò dicendo che i privati cercavano solo di spuntare offerte migliori.
Ai tempi del sindaco marziano, la questione, con la vittoria del Comune nella causa, sembrò essere sbloccata; ma stavolta, furono le tendenze suicide del PD romano a mandare tutto a ramengo. Così venne il turno della Raggi, la quale dinanzi alla parola Cultura non metterà certo mano alla pistola, ma di sicuro diviene cieca, sorda e muta.
Non solo ignorò gli appelli e i progetti di tanti artisti e intellettuali romani, che proponevano di trasformare l’Apollo nella Casa dell’Arte di Strada, non solo non mise in sicurezza la struttura di fronte ai primi crolli, ma sentendosi la reincarnazione di Lucrezia Borgia, dinanzi alla segnalazione del pericolo amianto, ha fatto spallucce.
La sindaca Raggi ha infatti scritto, nero su bianco, che il Campidoglio è al corrente almeno dal gennaio 2017 del fatto che, vista la situazione di pericolo rilevata dal Centro di Riferimento Regionale Amianto – Dipartimento Prevenzione della ASL di Viterbo, lo stabile dell’ex Cinema Apollo è sottoposto a sequestro conservativo disposto dalla Procura della Repubblica e affidato dal Tribunale in custodia giudiziale al Direttore del Dipartimento Patrimonio di Roma Capitale. È passato un anno e mezzo da allora e fregandosene, tanto, avrà forse pensato, visti i risultati elettorali in zona, i tumori è assai probabile vengano a elettori del PD, non ha preso alcun provvedimento a tutela della salute pubblica.
Ma i cittadini di via Giolitti e dell’Esquilino, dinanzi a tanta ignavia, non si sono arresi: vi è una petizione on line per chiedere al Campidoglio di bonificare l’area e venerdì 8 giugno, alle otto di mattina, vi sarà una manifestazione di protesta…
June 3, 2018
Il futuro di Andrea e Beppe
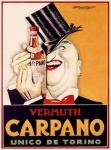



Dato che oggi il buon Roberto Cera ha presentato la terza edizione dell’antologia Penny Steampunk, in cui dovrebbe essere presente anche il sottoscritto, colgo l’occasione per fare un attimo il punto su quanto bolle in pentola nella stesura delle avventure di Andrea Conti e Beppe Antonini, che prima o poi, concluso l’incubo del romanzo ucronico esquilino, dovrei riprendere.
A dire il vero, ho buttato giù i primi capitoli delle loro imprese in una New York figlia dei sogni di Tesla, con anarchici, malviventi italiani e irlandesi, dove il buon Howard Philip Lovercraft è un detective alla Marlowe e dove sui tetti dei primi grattacieli, fanno capolino i primi supereroi alla Wesley Dodds.
Lo stesso vale per le avventure piemontesi di Thomas Edward Lawrence che deve vedersela con un Salgari ricco sfondato e con gli esperimenti di uno scienziato pazzo di Pavia, un certo Albert Einstein, che vuole misurare la velocità della luce nel fluido eterico…
Poi, nel retrocranio, sto pensando a buttare giù le avventure palermitane dei miei eroi, una sorta di prequel de Il Canto Oscuro, in cui entrambi hanno a che fare con i Florio, i Whitaker, la Mafia, Joe Petrosino e il buon Boldini… E ovviamente, il loro viaggio nel selvaggio West, dove, finalmente, Beppe capirà cosa diavolo volesse da lui Toro Seduto…
In parallelo, vorrei raccontate le avventure del Principe Padre e del nonno di Andrea, ispirate alle mie ricerche sugli strambi italiani che vivevano all’epoca in Egitto e in India… E questo, senza dimenticare i miei tradizionali contributi a Penny Steampunk… Per la prossima edizione dell’antologia, sto pensando a un racconto in cui Beppe e Andrea, sempre in fuga da Roma, approdano a Maiorca, in cui hanno a che fare con quel pericolo pubblico di Juan March, con il giovane Gaudì e gli strambi marchingegni del buon Raimondo Lullo.
Inoltre, sempre per omaggiare il buon Roberto Cera, butterò giù un novella, in cui i miei eroi faranno una capatina a Torino, a causa della passione per il vermut del Principe Padre, intenzionato a investire nella storica distilleria Carpano, in forti crisi per la concorrenza agguerrita di nuovi marchi.
Detto fra noi e non me l’abbiano i miei amici torinesi, la storia del vino aromatizzato all’assenzio è antica quanto l’uomo: per gli antichi greci, bere vino assoluto era qualcosa da barbari, per cui lo tagliavano con delle cose che, a noi moderni, parrebbero assurde: Aristotele e l’ottimo Apicio parlano ad esempio di il “defrito” una salsa ottenuta con mosto cotto, il “mulso” mosto legato con miele ed il “Conditum Paradoxum” fatto con datteri e spezie.
Di tutti questi ehm esperimenti sopravviveranno la retsina e il Il “vinum ellenicus absinthiatum” o vino Ippocratico prende il nome del famoso medico Ippocrate , padre putativo della medicina, non tanto perché ne abbia trascritto la ricetta, ma dal fatto che per filtrarlo si utilizzavano le famose “maniche di Ippocrate” una sorta di imbuto chiuso fatto con tessuto che aveva il compito di trattenere le spezie.
Vinus ellenicus absinthiatum che veniva usato come una sorta di aperitivo, per stimolare i succhi gastrici prima delle abbuffate trimalcioniche. Pare che grandi estimatori ne fossero Cicerone e Plinio il vecchio, il che fa venire qualche dubbio sulla loro morigeratezza. Nel Medio Evo, il buon Pietro Barliario, scrisse un paio di trattati in cui ne consigliava l’uso moderato per inappetenti, visto che poco si fidava degli effetti
dell’assenzio.
Nel 1555, è pubblicato il “De Secreti” ad opera di un fantomatico Alessio Piemontese, secondo molti lo pseudonimo di Girolamo Ruscelli, uno scrittore viaggiatore che raccolse diverse preparazioni a base di vino aromatizzato con spezie, usate per lo più come medicinali
La svolta avvenne In seguito alla guerra di successione spagnola, iniziata nel 1701, che vide contrapporsi la Francia e l’Inghilterra, quest’ultima si trovò a dover superare i problemi derivanti dall’impossibilità di ricevere le normali forniture di vino francese. Per tale motivo, nel 1703, tra l’Inghilterra e il Portogallo, fu stipulato il trattato di Methuen che prevedeva vari accordi di tipo politico, militare e commerciale, con
particolare riguardo all’importazione in Inghilterra di pregiati vini liquorosi portoghesi, a fronte dell’esportazione in Portogallo di pregiati tessuti inglesi.
Molto diffuso dai mercanti inglesi che, di fatto, ne avevano assunto il monopolio commerciale, il vino liquoroso ebbe un grande successo in tutta Europa, sia per il gradimento delle dame verso il gusto dolce, sia per l’intrinseco significato antifrancese che tale consumo comportava.
Questo nuovo scenario aprì le porte sia a prodotti già diffusi su scala locale, come il Marsala, prodotto della Sicilia che aveva metodi di vinificazione e invecchiamento simili a quelli dei vini portoghesi, sia a nuovi esperimenti di vino aromatizzato.
I primi esperimenti di una cosa chiamata vermut, furono i fiorentini: nel 1773 il Villifranchi nel suo “Enologia Toscana” cita preparazioni a base di vino bianco ed erbe, fra cui spicca l”assenzio a cui viene dato il nome di “wermuth”, ma questa mistura, di cui non abbiamo alcuna idea di che sapore avesse, non ebbe successo commerciale.
Le cose cambiarono con Antonio Benedetto Carpano, di origini biellesi, nativo di Bioglio, garzone della liquoreria Marendazzo, sita in Piazza delle Fiere, l”odierna Piazza Castello, emigrato a Torino in cerca di fortuna. Come ogni pasticcere dell”epoca era abituato a prodursi in proprio le proprie bagne alcoliche per i dolci ed i ripieni per cioccolatini, pertanto doveva essere sicuramente praticod”infusioni di erbe e spezie.
Iniziò ad elaborare un prodotto a base vino Moscato, vino che trovò a Torino in grande quantità, seguendo i dettami dell”infusione di frutta e spezie secondo la tradizione della Valsesia, dove era residente. Qui da secoli si preparavano ratafià, che per chi non è un notorio ubriacone come il sottoscritto, è un liquore a base di alcool e succhi di frutta, sulla cui paternità litigano piemontesi e ciociari.
Dopo vari esperimenti, nel 1786 elaborò finalmente il nostro vermut, il cui nome tedescofono, deriva sia dall’amore di Carpano per Goethe, sia per lusingare Vittorio Amedeo III, all’epoca impegnato a dimostrare la sua discendenza da Carlo Magno.
E il Savoia ne fu tanto lusingato, da imporlo come bevanda a tutta la sua corte, imponendo al contempo la fine della produzione del rosolio reale. Nel 1847 “La Fabbrica Vermouth & Liquori” apparteneva a Giuseppe Benedetto Carpano, che la cedette ai suoi figli Luigi ed Ottavio che, visto il successo del prodotto, decisero di aprire due magazzini con annesso opificio al di fuori della cinta daziaria della Torino di allora. Il primo in Barriera di Nizza (oggi via Nizza 224), la seconda a Carmagnola.
Da quell’anno però, cominciò a subire la concorrenza spietata della “Distillleria nazionale di spirito di vino all”uso di Francia”, fondata il primo luglio Clement Michel, Carlo Re , Carlo Agnelli, ed Eligio Baudino, a cui seguiranno Alessadro Martini, Teofilo Sola ed il liquorista Luigi Rossi e della Cora.
Concorrenza che ne ridusse progressivamente le quote di mercato: nel mio mondo, in cui il vermut ha ancora il colore dorato originario, questo fatto, nel 1903, porta il Principe Padre a volervi investire, rilanciare il marchio, puntando sull’innovazione tecnologica e sulla pubblicità… E a condurre le trattative, ovviamente, vengono spedite le sue vittime preferite…
June 2, 2018
Il Marziano è vivo !








Debbo confessare una cosa: non mi aspettavo il successo della presentazione di De Core, il Marziano è vivo e combatte assieme a noi, a cui ho partecipato ieri sera, nella Sala Giuseppina, presso il Palazzo del Freddo.
Perché, diciamola tutta, questi primi scampoli d’estate invitano ad andare al mare, piuttosto che fare capolino a una presentazione di un fumetto underground. Poi, il vir esquilinus medio, è di solito alquanto pigro, quando esce dalla sua zona di confort; per qualche aborigeno locale, Primavalle, Tufello e Trullo sono luoghi altrettanto alieni di Marte, Giove e Saturno.
Però nonostante tutto, tante persone hanno vinto la loro pigrizia e assistito a una sorta di viaggio onirico in quell’inferno dantesco che è diventata la nostra città: in cui vi è il girone degli iracondi, degli indifferenti, delle drogati di consumismo, dei terrorizzati dall’apparente diversità.
Un viaggio in cui il Marziano, che è in tutti, nel nostra volontà di non omologarci alle aspettative di un Leviatano che ci vuole sempre più automi, destinati solo a produrre e consumare, che usa le paure e le angosce immaginari per schiacciarci sotto il suo tallone, è il nostro Virgilio.
Ci mostra il nostro lato oscuro, prendendo anche parecchie mazzate in capo, ma ci mostra anche la possibilità di cambiare, accettando la sfida dell’Utopia, semplicemente ricordando il significato vero e profondo di poche semplici parole: bellezza, speranza, curiosità, stupore, solidarietà.
Viaggio che si è realizzato nelle storie che ci hanno raccontato gli artisti presenti ieri, che hanno partecipato al progetto: Mauro Sgarbi, ormai esquilino onorario (voci non confermate dicono che sarebbe pure tentato di trasferirsi da questi pizzi), il duo Jest, il pugliese innamorato der Trullo, ed Er Pinto, anonimo e libero poeta metropolitano, Junk, il lato ironico e vulcanico del punk romano e Marta Bianchi, altra vecchia conoscenza di Piazza Vittorio, poetessa di immagini e silenzi.
E quell’apparente burbero di Enrico Astolfi, che spero che prima o poi pubblichi un seguito di De Core, magari ambientato proprio all’Esquilino..
Insomma, grazie ad Andrea per l’ospitalità, a Valeria per il aiuto che ci ha dato e tutti i presenti per la bella esperienza che abbiamo vissuto assieme…
May 31, 2018
Un applauso ai Ragazzi del Cinema America
[image error]
Un annetto fa, un presunto artista di Piazza Vittorio, in realtà più un abile copista e un monotono ruminatore di vecchie idee altrui, di scarsa cultura, ma di grande invidia e livore, cominciò la sua privata faida contro il murale di Mauro Sgarbi nel Nuovo Mercato Esquilino.
Il perché desiderasse cancellare un’opera apprezzata da tutti, è difficile a dirsi: forse perché, incrociandola ogni giorno, la usava come criterio per misurare la sua umana mediocrità. Però, il nostro eroe, chiamiamolo così, che dal vivo non ha mai brillato di coraggio, per farlo cancellare andò a piagnucolare dal politico grillino di turno.
Il quale, poco sapendo e ancor meno capendo, qualità che sembrano essere indispensabili per fare carriera nei Cinque Stelle, scrisse un’interrogazione, convinto che l’opera fosse stata realizzata e pagata dal Municipio, invece che essere stata una libera iniziativa di cittadini.
Peccato che, grazie a un suo collega pentastellato con più sale in zucca, tale iniziativa, che era stata coperta da un silenzio omertoso, venne alla luce. Dinanzi alla levata di scudi degli abitanti del Rione di tanti artisti romani, prima il politico mentì spudoratamente sul contenuto dell’interrogazione, poi, preso in castagna, cominciò a soffrire di un improvviso e inspiegabile mutismo selettivo.
Avendo tale politico un rapporto conflittuale con l’italiano e con le procedure amministrative, per un vizio di forma la sua interrogazione, con suo sommo sollievo, è finita nel dimenticatoio. Dato che dal letame nascono i fiori, tutta la cagnara generata dagli intrighi clientelari dell’artista di Piazza Vittorio ha avuto due simpatici effetti collaterali: il primo, aver trasformato il murale di Mauro Sgarbi in un simbolo della libertà dell’Arte, il secondo l’aver acceso l’interesse di tanti street artist per il Mercato Esquilino, che speriamo a breve, grazie alla loro creatività diverrà una galleria d’arte a cielo aperto.
Ora, con il senno di poi, ma al politico grillino chi gliel’ha fatto fare a infilarsi in tale canea, da cui è uscito con le ossa rotte ? Più che una questione di scelta personale, è tutto legato alla natura stessa del suo Movimento, che, come il Fascismo, ha ridotto la politica a ripetere a pappagallo slogan dal bel suono, ma dal significato nullo.
Tali slogan, però, per funzionare, hanno bisogno di un pubblico tanto disperato, quanto ignorante, che ha perso sia la speranza che il mondo possa cambiare in meglio, sia la capacità di pensare e di riconoscere il Bello e il Buono.
Alla Disperazione, ci sta pensando la Crisi economica; per ottenere l’Ignoranza, i grillini si stanno impegnando a fondo con la Politica, dichiarando guerra, specie a Roma, agli spazi di solidarietà e cultura. Tra le vittime di questa caccia al Pensiero, vi sono i ragazzi del Cinema America, a cui è stata rubata, con cavilli burocratici, la loro arena estiva a San Cosimato: che poi questa porcata si sia conclusa con una figura barbina del Campidoglio, è un altro paio di maniche
Ma la Cultura è come un’erbaccia cattiva ed infestante: la puoi provare a estirpare, ma questa continua a spuntare ostinata, dove meno te l’aspetti… Per cui, non si sono arresi e hanno ampliato e arricchito il loro progetto… Di conseguenza, lascio la parola a loro
Abbiamo appena pubblicato il programma de Il Cinema in Piazza, pronto ad invadere tutta la città! Duecento notti di Cinema ad ingresso gratuito, con 190 differenti opere cinematografiche e 50 incontri, illumineranno il Parco della Cervelletta a Tor Sapienza, coloreranno il Porto Turistico di Roma ad Ostia e spalancheranno le porte del Liceo Kennedy di Trastevere al resto della città. Il progetto è organizzato dal Piccolo Cinema America, oggi più che mai orgoglioso di poter annunciare che, dal 1 Giugno all’8 Settembre, sotto la luce del proiettore della Cervelletta, potrete incontrare Asia Argento con il suo “Scarlet Diva”, Matteo Garrone assieme ad una sua retrospettiva completa, passando per Paola Cortellesi, Milani, PIF, e Placido. Sulle rive del mare invece vi aspetteranno Carlo Verdone Official, Luca Guadagnino per la presentazione de “L’impero dei sensi” di Nagisa Ōshima, Claudio Amendola, Riccardo Scamarcio, Claudio Bisio, Luca Zingaretti e tantissimi altri. E poi a Trastevere ci saranno Gigi Proietti con “Febbre da Cavallo”, Silvio Orlando, Francesco Bruni, Giuliano Montaldo, Roberto Andò, Cristina Comencini, Laura Bispuri… e le altre decine di sorprese che vi lasciamo scoprire nel programma.
Le retrospettive romperanno il silenzio assordante dei territori di questa città con i capolavori di Miyazaki e Almodóvar fino a Tarantino, Fellini e Pasolini. Mentre i classici Disney accoglieranno i più piccoli e romantici, gli altri potranno godersi le maratone dalla sera fino all’alba con “Indiana Jones” di Spielberg, “Il Padrino” di Coppola, “Sátántangó” di Béla Tarr e “Via col vento” di Victor Fleming.
Tutto questo non poteva rientrare in un bando di Roma Capitale, perché questa è la nostra idea di città, questa è la Roma che vogliamo, in cui saremmo voluti crescere ed in cui vogliamo far crescere i nostri futuri figli. La modalità dell’accoglienza, la cura nelle relazioni, la costruzione condivisa di un evento generano non solo una grande capacità di attrazione ai luoghi, ma anche nuove visibilità comunicative oltre i confini dei singoli territori. Con questo progetto vogliamo rompere il dualismo tra centro e periferia, vogliamo ricostruire un senso di città, laica, libera, viva e solidale. Ringraziamo Regione Lazio, Ente Regionale RomaNatura, SIAE, BNL Gruppo BNP Paribas, IPAB Asilo Savoia e numerosi altri partner, come Radio Rock, che troverete sul sito, perché senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile.
Ma ora tocca a voi, ora abbiamo bisogno, più che mai, di ognuno voi. Aiutateci ad informare ogni angolo di Roma, nei gruppi di quartiere e nelle vostre bacheche: il Cinema è sceso in Piazza ed ha solo bisogno che l’intera città ne diventi l’unica protagonista
Alessio Brugnoli's Blog



