Alessio Brugnoli's Blog, page 140
August 7, 2018
La sonata della Chitarra Battente
Come sapete, quest’anno le sonate estive de Le danze di Piazza Vittorio quest’anno sono legata da un filo conduttore: un viaggio nel Mondo e nella Storia, per riscoprire gli strumenti che accompagnano la danza e la musica popolare.
Questa sera, la sonata è dedicata alla chitarra battente, uno strumento le cui origini risalgono al XIV secolo. Per dirla tutta, è una variante delle chitarra barocca, tanto che i brani di Corbetta ne La Guitarre Royalle dediée au Roy e di de Visée in Livre de Guitarre, dedie au Roy sono eseguibili da entrambe le tipologie di strumenti.
La differenza è nella tecnica con cui sono suonate: la chitarra barocca, inclusa in orchestre che comprendevano la tiorba, l’arciliuto, la viola da gamba e il cembalo, era suonata a pizzico: tipologia che produceva un suono acuto, adatto alla musica da camera
La chitarra battente, invece, veniva suona con la botta, quella che oggi chiamiamo pennata, con la mani sinistra che si limita a tenere la posizione degli accordi. Di conseguenza, il suono era più pieno e tondo e permetteva di accompagnare al meglio il canto.
Se la chitarra barocca si è evoluta progressivamente nella nostra chitarra classica, la chitarra battente, passando alla musica popolare, ha mantenuto la forma delle origini,simile ad un otto allungato, con larghezza delle spalle prossima a quella della pancia. Le fasce laterali sono più spesso di altezza superiore a quelle della chitarra francese e il fondo dello strumento può essere sia piatto che bombato.
Il fondo piatto è costituito spesso da due tavole affiancate, quello bombato è spesso costituito da una serie di doghe di due diversi legni, di colore chiaro e scuro, incollate fra loro e alternate in modo da creare un motivo cromatico. La tavola armonica è quasi sempre in abete, talvolta può essere in ciliegio o gelso.
Il piano armonico può presentare una o tre buche. In quest’ultimo caso oltre alla buca centrale sono presenti due buche, più piccole, contrapposte e situate in prossimità delle spalle. Sia nei modelli con unica buca centrale, che nei modelli a tre buche, vi è sempre inserita in esse una decorazione chiamata rosa, realizzata in legno, in cartoncino o pergamena. Il manico, in legno di noce, pero, pioppo, prugnolo, è più corto di quello della chitarra francese. La tastiera spesso è assente o comunque, se presente, è posta allo stesso livello della tavola armonica e reca un numero di tasti che varia da 9 a 12.



L’accordatura a seconda delle diverse zone dell’Italia, può variare da 6 a 14 corde. In termini di curiosità, anche Stradivari realizzò delle chitarre battenti e uno dei capolavori della liuteria del Seicento, è chitarra battente realizzata a Perugia nel 1725 da Jacopo Mosca Cavelli, un artigiano probabilmente originario di Pesaro
Questo splendido esemplare – lungo 93 cm, largo 25 e spesso 14, costruito con legni di abete e noce, con parti decorate in avorio, madreperla e guscio di tartaruga – è presumibilmente appartenuto a qualche membro delle famiglie Chigi o Pamphilij.
Nella parte alta del piano armonico, in prossimità dell’attaccatura del manico, è intarsiata una citazione biblica dall’Apocalisse: Sicut citharoedorum citharizantium in citharis suis, un estratto del passo che dice: La voce che udii era come quella di suonatori di arpa che si accompagnano nel canto con le loro arpe (Ap 14, 2).
Per cui, se vi interessa, ci trovate questa sera alla solita panchina: sino alle 20.30 faremo il repertorio tradizionale, poi ci scateneremo, con il buon Giacomo, in qualche brano accompagnato dalla voce di Emanuela Cinà, con la chitarra battente.
August 6, 2018
Dall’India alla Grecia (Parte IV)
[image error]
— Giungemmo: è il Fine. O sacro Araldo, squilla!
Non altra terra se non là, nell’aria,
quella che in mezzo del brocchier vi brilla,
o Pezetèri: errante e solitaria
terra, inaccessa. Dall’ultima sponda
vedete là, mistofori di Caria,
l’ultimo fiume Oceano senz’onda.
O venuti dall’Haemo e dal Carmelo,
ecco, la terra sfuma e si profonda
dentro la notte fulgida del cielo.
E’ l’incipit di Alexandros, uno dei poemi conviviali di Pascoli, che racconta uno degli episodi più famosi della vita del Macedone.: l’ammutinamento della sua falange in India, che lo costringe a tornare indietro a Babilonia, dove morirà. La realtà storica, probabilmente, è assai più complicata: Alessandro, nella fasi finali della sua campagna, ha dovuto affrontare diverse congiure da parte della sua nobiltà. Al contempo, però, si è dovuto anche confrontare con una realtà geopolitica ben diversa da quella che si aspettava.
Basandosi sui precedenti geografi greci, probabilmente Alessandro ipotizzava come l’India si limitasse alla valle dell’Indo, al nostro Pakistan e che fosse abitato da tribù tanto sagge, quanto primitive e pacifiche. Per cui, nel trovarsi davanti un’estensione geografica assai più ampia, una civiltà paragonabile a quella Greca e un complesso mosaico di stati in guerra tra loro, lo spiazzò e lo fece riflettere sulla necessità di non impelagarsi in una campagna improvvisata.
Di conseguenza, si concentrò sulla necessità di organizzare al meglio il confine orientale dell’Impero, fondando una serie di satrapie sul corso dell’Indo, in modo da controllare l’importante via commerciale e di colonie di veterani macedoni, per ellenizzare l’area, a loro volta protette da un cuscinetto di stati alleati. Al contempo, verificata con Nearco la praticabilità della via marittima per l’India, per controllarla al meglio e semplificarsi la logistica in vista di una futura campagna, gli balenò nella mente l’idea di organizzare una campagna di conquista delle coste del Golfo Persico.
Tutti questi progetti però naufragarono con la morte di Alessandro a Babilonia e con il prevalere delle spinte centrifughe nei suoi domini: in teoria, nel primo accordo tra i diadochi, poco interessati alla valle dell’Indo, l’11 giugno 323 a.C. l’area fu così divisa:
Gedrosia e Arachosia, zona Pakistan a Sibirizio
Paropamisa, il nostro Hindo Kush a Ossiarte, suocere di Alessandro Magno
Punjab a Taxile, alleato locale dei macedoni
La valle dell’Indo a Poro che da nemico di Alessandro, capita l’antifona, si era autoproclamato suo fraterno amico, utilizzando il suo appoggio per espandersi ai danni dei vicini
Il Gandhara al macedone Peitone
Anche questa soluzione durò meno di una settimana: Peitone, dopo avere domato nel sangue un paio di rivolte , non di locali, ma di coloni greco macedoni, poco entusiasti nel pagare le tasse, si buttò con sommo entusiasmo nella guerra civile macedone. Di questo ne approfittò Poro che si impadronì, più per accordi diplomatici che con le armi del Gandhara e del Punjab e poi tentò il colpo gobbo: alleato con Chandragupta Maurya, che apparteneva a a un antico ramo cadetto di un antico clan principesco indiano, tentò di conquistare il regno Magatha che dominava il bacino del Gange, che si trovava in una situazione molto simile a quella del regno di Alessandro.
Il regno indiano, infatti, era retto fino al 329 a.C. dal saggio rajah Mahapadma Nanda, ma, quando, alla sua morte, non venne nominato alcun successore e i suoi sette figli assursero contemporaneamente al trono, incominciando una guerra civile per assicurarselo interamente. Da diverse fonti storiche si evince che il reame era nel caos più completo e che intere province si erano rese del tutto autonome, sia quelle hymalaiane, sia il territorio di Kalinga e l’area del Deccan, così come s’intravede che i sette figli eredi non fossero minimamente all’altezza del padre, e – tanto meno –
popolari, cosicché il reame stava iniziando a disintegrarsi.
Poro, che voleva utilizzare Chandragupta, ottimo generale e imparentato alla lontana con i Nanda, come re fantoccio cominciò così una politica del Dividi et Impera ai danni del regno del Maghata. Il che però fu visto come una minaccia dai coloni macedoni dell’Indo, che chiesero aiuto a Seleuco Nicatore, che decise di risolvere la questione nel suo soluto modo, ossia con l’assassinio. Così incaricò Eumene di fare fuori Poro: mal gliene incolse, perché il suo posto fu preso da Chandragupta, il quale, a differenza di Porro, che era intenzionato a rimanere in qualche modo legato al sistema macedone, era intenzionato a costituire un suo impero.
Così Chandragupta invase i domini macedoni, costringendo Seleuco a intervenire direttamente con l’esercito: che successe in quei frangenti è poco chiaro… Alcuni studiosi, con ragionamenti assai complessi sulla titolatura Maurya, hanno ipotizzato che Chandragupta si sottomettesse a Seleuco, prendendo il posto di Poro, come una sorta di satrapo dell’India seleucide, cosa che però contrasta notevolmente con quanto riportano le fonti delle epoca.D’altra parte è anche poco probabile una schiacciante sconfitta di Seleuco: in questo caso non si spiegherebbe l’efficacia del suo esercito nelle successive campagne. E’ possibile, che dopo aver guerreggiato entrambi con poco entusiasmo, i due contendenti, si siano seduti al tavolo a trattare.
A Seleuco, dell’India, importava ben poco. A Chandragupta fregava ancora meno, di impelagarsi in una lunga e faticosa guerra con i macedoni. Per cui, si trovò un compromesso. Seleuco cedeva a Chandragupta la Gedrosia, l’Aracosia, il Punjab e l’Indo. In cambio Chandragupta doveva mantenere invariati i privilegi commerciali dei mercanti seleucidi, garantire il quieto vivere e l’autonomia amministrativa delle colonie greco macedone, che approfittando di questo limbo, tornarono con sommo piacere alla loro tradizione di evasione fiscale, cedere 500 elefanti, che oltre a costargli un occhio della testa, permisero a Seleuco di trionfare ad Ipso.
In più, si instaurarono rapporti diplomatici, culminati tra nel matrimonio da Bindusara, figlio di Chandragupta e suo erede al trono e una figlia di Seleuco, che le cronache indiane chiamano Dharma. Matrimonio da cui nacque Aśoka, quale, trascurando la propensione all’omicidio politico, forse ereditata da Seleuco, prima di convertirsi al buddismo fece strage di fratelli e fratellastri, parlava tranquillamente il greco, come dimostrato dalle vicende del suo governatorato di Taxila e usò una titolatura reale modellata su quella macedone.
Per cui, una delegazione diplomatica macedone si recò Pataliputra, capitale dell’impero Maurya. Ne faceva parte Megastene, di cui sappiamo ben poco, tranne il suo essere stato funzionario di Sibirizio. Al ritorno della sua ambasciata, scrisse un’opera Indika, una sorta di riflessione sul suo viaggio. Il problema è che di tale opera sono rimasti pochi frammenti, alcuni probabilmente interpolati. Da quel poco che possiamo capire, il suo interesse non era etnografico, ma politico: Megastene, data la sua esperienza sul campo, si era reso conto come il dominio di Chandragupta era altrettanto disomogeneo di quello Alessandro, ma a differenza di questo, non era così fragile da cadere al primo soffio di vento.
Per cui Megastene voleva trarre dal suo viaggio presso i Maurya una lezione di buon governo, da fornire a Seleuco, in modo che rendesse più forti le fondamenta del suo dominio: questa trasfigurazione del dato reale indiano, però, rende complicato, per noi contemporanei, capire cosa effettivamente vide l’ambasciatore.
Però, che fosse un osservatore attento della realtà circostante, lo intuiamo da diversi indizi. Il primo è la descrizione di Pataliputra, in cui apprendiamo come la città si estendeva lungo le rive del Gange per una lunghezza di oltre nove miglia ed era delimitata da un’alta palizzata di legno, munita di feritoie e fiancheggiata da 570 bastioni. Era circondata all’esterno da un profondo fossato che serviva, oltre che di difesa di scolo per le acque. Lungo la palizzata davano accesso alla città 64 porte. Il palazzo reale era di una magnificenza tale che non reggevano al confronto i palazzi di Susa e di Ecbatana. Nei parchi erano piante ed alberi rari e grandi vasche con pesci.
Gli scavi archeologici, che hanno identificato la sala delle udienze dei Maurya, hanno confermato questa descrizione: la sua grande scala è indicata dalle sopravvissute basi di ottanta colonne in pietra, la cui originaria altezza è stata stimata di aver raggiunto circa i dieci metri, e che sono a circa cinque metri di distanza. La disposizione delle colonne è indicativa di strutture achemenidi, come quelle a Persepoli, sia come scala che per l’abbondanza di colonne, il che implica un’influenza, magari mediata proprio dai macedoni.
Il secondo è legato al fatto che Megastene fosse il primo a rendersi conto delle somiglianze, nei miti, nei riti e in alcuni termini linguistici, tra mondo greco e indiano. Cosa che per noi moderni, che diamo per scontata l’esistenza degli indoeuropei, ma che poteva lasciare perplesso un greco dell’epoca. Megastene, a differenza di noi, non ipotizzò l’esistenza di antenati comuni, ma seguì l’ipotesi che a lui, data la sua esperienza, poteva sembrare più razionale ossia che qualche antico saggio ellenico si fosse recato in India, per apprenderne la saggezza.
Il terzo è la sua consapevolezza, sfuggita ad esempio agli accompagnatori di Alessandro Magno, che in India vi fossero almeno due religioni differenti. Secondo Strabone,
Megastene compie una diversa ripartizione dei filosofi, dicendo che sono di due tipi, uno dei quali egli chiama i Brachmanes (brahmani), e l’altro il Sarmanes (sramana)
Ossia distinse tra induisti e buddisti, evidenziandone le somiglianze, la credenza nella reincarnazione, l’atarassia, il disinteresse per la fisica e la realtà transeunte, e le differenze, che identifica soprattutto in ambito etico…
August 5, 2018
Rhegion e l’Islam
[image error]
Tra una settimana, me ne scenderò in vacanza a Reggio: così colgo l’occasione, per riprendere una chiacchierata sul complesso rapporto tra Islam e Italia medioevale. Stavolta, la vicenda, come spesso accade da quelle parti, è frutto di come dire, un’errata valutazione da parte dei buddaci, gli abitanti di Messina. Uno di loro, Eufemio da Messina, di famiglia ricchissima era un tumarca, una sorta di ammiraglio, della flotta bizantina: più per la sua scarsa propensione nel pagare le tasse che per i suo millantati successi contro gli arabi, destò la preoccupazione della corte di Costantinopoli e fu accusato di aver sposato una suora novizia, dopo averla rapita in un convento, Omonizia.
Cosa che, in caso di probabile condanna, avrebbe portato al sequestro dei suoi beni da parte del demanio imperiale e una serie di raffinate torture, culminate nella mutilazione del naso: Eufemio, poco convinto dell’imparzialità della gustizia bizantina, organizzò quindi una rivolta. Infatti, di ritorno da un’incursione navale contro la costa africana, apprese che stava per essere arrestato, salpò per Siracusa, che occupò, mentre Fotino lo strategos del thema di Sicilia, viste le brutte, riparo a Catania. Eufemio ben presto riuscì ad ottenere il supporto di una larga parte dei comandanti militari dell’isola e non solo respinse un tentativo da parte di Fotino di recuperare Siracusa, ma lo inseguì e lo scacciò da Catania, e alla fine lo catturò e lo giustiziò, assieme al patrizio Gregora, il responsabile
dell’amministrazione civile. Così. attorno all’823 a Siracusa, in pieno delirio di grandezza si proclamò imperatore indipendente della Sikelia, da Costantinopoli.
Ma il suo dominio fu effimero: dovette subire a sua volta la ribellione di un uomo noto dalle fonti arabe come “Balaṭa” e di suo cugino Michele, comandante di Palermo. I due uomini denunciarono l’usurpazione da parte di Eufemio del titolo imperiale e marciarono contro Siracusa, sconfissero Eufemio e si impadronirono della città. Come uno dei suoi predecessori, Elpidio, che si era rivoltato all’Imperatrice Irene, Eufemio risolse di cercare riparo presso i nemici dell’Impero e con pochi seguaci salpò per Ifrīqiya. Qui inviò una delegazione alla corte aghlabide a Qayrawān, richiedendo all’emiro aghlabide Ziyādat Allāh un esercito affinché sostenesse la conquista della Sicilia da parte di Eufemio: in cambio, una volta conquistata la Sicilia, Eufemio avrebbe pagato agli Aghlabidi un tributo annuale.
Ziyadat Allah da tempo pensava a invadere l’isola vicina, ma come dire, gli mancava sempre il pretesto: per cui, trovandosi davanti Eufemio, dopo aver ringraziato Dio grande e misericordioso, se ne uscì con l’equivalente arabo
“Ma te pare che io nun te do’ disinteressatamente ‘na mano”
Però, poco convinto della bontà dell’iniziativa organizzò una flotta di di 70 navi, al cui comando era Asad ibn al-Furāt ibn Sinān, un settantenne il mestiere principale era fare il professore di diritto. Flotta che riempì di tutte le teste calda dell’area, visto che ogni giorno doveva fronteggiare le tensioni tra Arabi e Berberi, dissenso e rivolte all’interno dell’élite governante araba (la jund) e critiche per la loro preoccupazione per il loro stile di vita lussurioso dagli eruditi islamici
Il 14 giugno 827, le flotte alleate salparono dalla baia di Susa, e dopo tre giorni raggiunsero Mazara nella Sicilia sudoccidentale, dove avvenne lo sbarco il 16 giugno 827: secondo quanto racconta il cronista Tommaso Fazello, Asad
diede alle fiamme le proprie navi, per significare che, ormai, non era più questione di tornare indietro e che la Sicilia, in un modo o nell’altro, doveva essere occupata.
Dopo lo sbarco, i unirono con soldati fedeli a Eufemio, ma l’alleanza presto cominciò a deteriorarsi: un distaccamento musulmano scambiò alcuni dei partigiani di Eufemio con truppe lealiste, e ne seguì uno scontro con esse. Anche se alle truppe di Eufemio fu ordinato di collocare un segno distintivo sui propri elmetti, Asad annunciò la sua intenzione di condurre la campagna senza di essi.
Subito dopo, Balaṭa, colui che aveva cacciato Eufemio dalla Sicilia che sembra aver assunto le funzioni, se non il titolo, dello strategos imperiale sull’isola, condusse la propria armata a scontrarsi con gli invasori. Le due armate si scontrarono in una pianura a sudest di Mazara, dove le truppe di Asad, dopo esortazioni dal loro comandante, conseguirono una vittoria. Balaṭa fu così costretto al ritiro dapprima a Enna e poi a Reggio, forse con la speranza di reclutare nuove truppe. Tuttavia, perì qui poco dopo il suo arrivo.
Asad decise di approfittare della situazione e avanzò verso Palazzolo Acreide; qui i bizantini avevano eretto la loro base difensiva, una fortezza che doveva reggere all’assalto degli arabi. Asad era indeciso, poiché prima di proseguire voleva aspettare le navi con i rinforzi provenienti dall’Africa. Anche i bizantini non si muovevano, sperando in cuor loro che il persiano non andasse oltre. Le cronache arabe ci narrano infatti che Asad un giorno mentre era accampato presso Palazzolo ricevette dei messaggeri bizantini, o abitanti facoltosi siracusani, che lo pregavano di non andare oltre, di non dirigersi verso Siracusa. In cambio della sua ritirata questi gli avrebbero offerto molto oro e si sarebbero a lui sottomessi. Pare infatti che Asad ricevette una prima quantità di cinquantamila soldi d’oro.
Ma dopo qualche giorno, Asad si accorse, o ebbe intuizione, che vi era un piano dietro quella “falsa” sottomissione. Infatti i bizantini in realtà tentavano l’esercito degli arabi con il denaro per dare tempo ai siracusani di allestire una solida difesa in vista dell’imminente assedio. Asad se ne rese conto quando vide che il restante denaro pattuito non gli arrivava e quando seppe che Eufemio, forse spaventato dalla bramosia di conquista degli arabi, aveva deciso di far pace con i bizantini e li incoraggiava a non cedere all’esercito d’oriente.
Asad così, per non finire tra l’incudine e il martello, levò subito il campo da Palazzolo, forzando o schivando la fortezza e si diresse a marce forzate veso Siracusa, per stringerla d’assedio. Impresa alquanto velleitaria, perché aveva solo 8000 soldati ed era privo di macchine da guerra. Si accampò nei pressi della latomia del Paradiso, poi in quella dei Cappuccini e nelle restanti latomie siracusane: grandi cave di pietra bianca tipiche del territorio siracusano e vicinissime alla città, nei pressi di Neapolis e Acradina, ma dopo diversi assalti fallimentari, si decise a chiedere soccorso al suo datore di lavoro.
Il problemi poi è che, mentre dentro Siracusa, i viveri abbondavano, Ziyadat Allah, andando al risparmio, non è che avesse largheggiato: di conseguenza, in poco tempo, furono gli assedianti, non gli assediati a patire la fame.Assedianti che entrarono in sciopero e mandarono una delegazione sindacale, guidata da Ibn-Kadin, che chiedeva, in qualsiasi modo di tornarsene a casa, minacciando l’ammutinamento: Asad se la cavò prendendo a staffilate sul fondoschiena i più facinorosi.
Discussione che nel frattempo, aveva permesso a Costantinopoli di organizzare una spedizione di soccorso, guidata ahimè dal dux di Venezia Giustiniano Partecipazio, il quale sbarcò, vide l’esercito arabo e mandò un ambasciata ad Asad chiedendogli un ricco contributo in cambio del suo tornarsene in patria senza combattere. Asad, uomo di mondo, era anche lui convinto che una tangente fosse meno fastidiosa di una battaglia, pagò senza fiatare il denaro preso a Palazzolo Acreide: così il buon Giustiniano Partecipazio, facendo ciao con la manina, imbarcò tutti e se ne tornò in laguna.
Sfiga volle che scoppiasse nell’esercito arabo un’improvvisa epidemia di dissenteria, dovuta alle acque della vicina palude Lisimelia, che mieté tra le numerose vittime anche lo stesso Asad. Alla sua morte, l’esercito deise di nominare un comandante meno testardo e la scelta cadde su Mohammed-ibn-el-Gewâri, il quale, visto che i sospirati rinforzi non arrivavano, gli Aghlabiti stavano subendo una fantozziana invasione di Bonifacio II di Toscana, in quale, sbagliando clamorosamente rotta, invece di andare in Corsica, era sbarcato vicino Cartagine, dove si stava dedicando al saccheggio libero, prese baracche e burattini, e si ritirò nei pressi di Mineo, dove ritrovarono il buon Eufemio, che aveva cambiato idea per l’ennesima volta
Eufemio, da buddaci quale era, si era convinto che i musulmani, dopo la batosta e privati della guida di Asad, potessero tornare ad essere dei burattini nelle sue mani, Dopo la resa di Mineo, l’armata musulmana si divise in due: una parte espugnò Agrigento a occidente, mentre l’altra, insieme con Eufemio, attaccò Enna. La guarnigione di Enna cominciò le negoziazioni, offrendo di riconoscere l’autorità di Eufemio, ma quando Eufemio con una piccola scorta si incontrò con i loro emissari, fu assassinato dai lealisti bizantini.
A Bisanzio, dopo la fregatura presa dai veneziani, decise di applicare l’antico proverbio del chi fa da sé, fa per tre, spedendo in Sicilia una nuova flotta sotto il comando di Teodoto, che conosceva bene l’isola, essendo già stato in passato suo strategos. Dopo lo sbarco, Teodoto condusse il suo esercito fino a Enna, dove gli Arabi stavano proseguendo l’assedio. Fu sconfitto nella battaglia conseguente, ma riuscì a trovare riparo nella fortezza con la maggior parte del suo esercito. I musulmani ora divennero talmente confidenti della vittoria che cominciarono a battere le loro prime monete sull’isola, a nome di Ziyādat Allāh e Muḥammad b. Abī l-Jawārī, che tuttavia perì poco tempo dopo e fu sostituito da Zubayr ibn Gawth.
Poco tempo dopo, però, Teodoto riuscì a capovolgere la situazione: condusse un’incursione che prima mandò in rotta un distaccamento di saccheggiatori musulmano e poi sconfisse l’esercito musulmano principale il giorno successivo, uccidendo 1.000 soldati e inseguendo il resto fino all’accampamento fortificato musulmano, che assediò. I musulmani tentarono di rompere l’assedio in una sortita notturna, ma Teodoto aveva previsto tale mossa e li sconfisse in un’imboscata. Il resto dell’esercito musulmano cercò ancora una volta rifugio a Mineo, dove Teodoto li bloccò e li ridusse presto al punto da essere costretti a mangiare i propri cavalli e persino cani. Quando ricevette la notizia di tale sconfitta, la guarnigione araba di Agrigento abbandonò la città e si ritirò a Mazara. Pertanto, nell’autunno del 829, la Sicilia era stata quasi del tutto liberata dagli invasori musulmani.
Ma l’inerzia della guerra cambiò nel 830, quando una flotta di Al Andalus, condotta da Aṣbagh ibn Wakil, arrivò in Sicilia, per pure desiderio di saccheggio: ma la guarnigione assediata a Mineo, promettendo di riconoscere Asbagh emiro della Sicilia, gli chiesero aiuto. Asbagh accettò la proposta e marciò su Mineo, costringendo Teodoto a ritirarsi ad Enna; per sua fortuna, la dissenteria tornò a flagellare l’esercito arabo e tra i caduti vi fu lo stesso Asbag. Teodoto ne approfittò per guidare la controffensiva, ma sul più bello, quando stava per cogliere l’agognata vittoria, morì per una caduta da cavallo.
Da quel momento in poi, l’avanzata araba prevalse: nel 831, dopo un assedio sommamente gonfiato dalle cronache cristiane e arabe, fu conquistato il villaggio di Panormus: in pratica il suo comandante, lo spatharios Simeone, accettò la resa in cambio della partenza in tutta sicurezza dei suoi abitanti, patto che fu rispettato dai musulmani. Dopo poco anche Messina, nel mondo antico considerata città indifendibile, si consegnò agli invasori musulmani, portando Reggio in prima linea nella lotta contro i Saraceni, che dovettero combattere più contro la iella che contro la resistenza bizantina.
Nell’841/42 la Sicilia fu invasa da cavallette e sia Reggio, sia Balarm patirono la fame: nel 846/47 ci fu un’altra carestia e nel 852/53 un terremoto. Un momento cruciale del conflitto è segnato, nell’859, dalla inopinata conquista saracena di Enna, vero punto strategico dell’intero sistema difensivo dell’isola, già varie volte sottoposta ad assedio. Il kastron di San Giovanni, come si chiamava allora Enna, posto esattamente al centro della Sicilia, era dotato di difese naturali e costruite che lo rendevano assolutamente inespugnabile. La sua caduta, infatti fu dovuta solo a tradimento. Nell’anno 878 il mondo comprese che la conquista della Sicilia da parte dell’Islam era ormai vicina. In quell’anno, infatti, venne conquistata la capitale del Thema e città più grande e nobile dell’intero occidente, Siracusa.
Così, all’improvviso, Rhegion si trovò ad essere la sede dello stratego di Sicilia, stratego di Sicilia, con il suo Pretorio, centro amministrativo e nuova capitale dell’Occidente. Coerentemente, l’Arcivescovo di Reggio divenne il primate dell’Occidente imperiale. Dall’879 sappiamo che a Reggio era attiva una zecca, i cui resti sembra fossero sotto l’attuale palazzo San Giorgio a Piazza Italia, erede dell’officina siracusana, che coniò monete in oro e in rame. Si tratta, di emissioni celebrative della cooptazione al trono del secondo figlio dell’imperatore Basilio I, Alessandro (futuro Alessandro I), che affiancava il primogenito Leone (futuro Leone VI). Le monete auree dovevano servire per eseguire i donativi all’esercito ed ai funzionari occidentali previsti dal cerimoniale di corte. A quel tempo nell’intero Impero Romano erano attive solo le zecche di Costantinopoli e di Reggio.
A dare un poco di respiro ai bizantini, ci fu la rivolta dei berberi di Sicilia contro l’emiro d’Africa, per biechi motivi fiscali. In cambio della pace, lo stratego di Rhegion si schierò con i secessionisti, ma mal gliene incolse. A quel tempo, infatti, prese il potere il famigerato Ibrāhīm II, il quale aveva litigato di brutto con il califfo di Baghdad al-Mu’tadid, il quale lo aveva accusato di essersi fatto prendere da un eccessivo entusiasmo nel reprimere le rivolte berbere. Al -Mu’tadid, quindi, gli tolse il titolo di emiro, ma Ibrāhīm se ne fregò altamente: autoproclamatosi Ghazi, grande combattente per la Jihad, sbarcò a Trapani, distruggendo la flotta ribelle, riconquistò Balarm e dopo stragi d’ogni tipo, riprese il controllo della Sicilia musulmana. Dopo aver sottratto Taormina ai bizantini, decise di colpire la testa dell’idra, sbarcando in Italia: sulle sue intenzioni sono nate infinite legende.
Chi dice che dall’Italia, volesse puntare a Costantipoli. Chi invece afferma volesse conquistare Roma. Probabilmente voleva semplicemente recuperare i possessi arabi persi nella Penisola negli anni precedenti e imporre una sorta di vassallaggio alle città campane.Il 10 giugno del 901 conquistò Reggio: le cronache arabe parlano di bottino e schiavi in quantità industriale: in realtà, visto che le tasse a Bisanzio continuarono ad arrivare con regolarità, è probabile che la città, per quieto vivere, si sia arresa senza combattere.
Ibrāhīm continuò ad avanzare verso nord, sino a morire, sempre per dissenteria, nel 902, mentre assediava Cosenza. Però, la resa di Reggio, fece scattare un campanello di allarme a Costantinopoli. La città mantenne il suo status di capitale, ma si provvide a creare una seconda sede per lo stratego e per il prezioso archivio del Thema, scegliendo l’inespugnabile fortezza di Santa Severina, nel Marchesato crotonese, che da poco era stata riconquistata dalle mani dei Saraceni. Il kaston di Santa Severina, rimesso in luce grazie a recenti scavi, doveva garantire l’invulnerabilità dello stratego e del Pretorio.
La difesa di Reggio dovette essere riorganizzata su nuove basi, ovvero antiche. Alle spalle della città fu costruita tutta una serie di fortezze a mezza costa sui rilievi dell’Aspromonte, le cosiddette Motte. che spesso riutilizzavano siti di fortificazioni reggine di epoca ellenistica. Il concetto, efficace, era quello di permettere la temporanea conquista di Reggio, mantenendo una impenetrabile difesa subito a monte della città, fin dalla fortezza dell’exokastron, per poi bloccare tutti gli accessi alle ricche vallate in cui si allevavano i bachi da seta.
La morte di Ibrahim, non fermò i tentativi arabi di conquistare la Calabria. Nel 914/5 un esercito giunto dall’Africa effettuò grandi devastazioni in Calabria, facendo molti prigionieri da tenere come schiavi o da far riscattare a caro prezzo. Dopo averla riconquistata e razziata nel 918, i Saraceni tentavano di chiudere Reggio in una sacca: nel 922 conquistarono Oppido Mamertina; nel 923 fu la volta di Bruzzano. Per ottenere il mantenimento della pace, le città calabresi accettarono di pagare un tributo, fino alla rivolta intestina di Agrigento, sunnita, contro la Balarm sciita, che diede un poco di respiro a Rhegion
Nell’anno 951 l’imperatore Costantino VII inviò in Calabria un esercito al comando del patrikios Malaceno, che doveva unire le sue forze con quelle dello stratego di Calabria Pascalio. In quel mentre, il nuovo emiro fatimida di Sicilia, Al-Hasan, occupò Reggio, che era stata preventivamente abbandonata dai suoi abitanti, e si diresse verso Gerace. Nel 952 Malaceno fu sconfitto ed ucciso presso Gerace. La sconfitta venne, però, mitigata, da un intervento diplomatico dell’imperatore, che acconsentì, in cambio del ritiro dell’armata fatimide, alla costruzione di una moschea a Reggio.
Nel 956, grazie alla presenza in Calabria del grande generale Mariano Argiro, si poté concludere una pace di breve durata con i Musulmani. Sempre nel 956, intanto, una squadra navale romea, arrivata a Reggio, ordinò la distruzione della moschea. Nel 964, l’imperatore Niceforo Foca, conscio della riacquistata potenza militare romea tentò di riconquistare la Sicilia, approfittando della reazione opposta dei Messinesi della Val Demenna all’emiro siciliano. Taormina, che era riuscita a ritornare libera, fu riconquistata dopo un duro assedio, e, come era già avvenuto, la resistenza si concentrò nella fortezza di Rometta.
La grave crisi di governo che travagliò l’Impero bizantino dopo la morte dell’Imperatore Giovanni I Zimisce, nel 976, fece dei possedimenti greci nel sud Italia un invitante obiettivo per Abū l-Qāsim ʿAlī, l’emiro kalbita di Balarm che si mosse verso la terraferma peninsulare italica. Nel 977 depredò Taranto, facendo numerosi prigionieri e bruciando alcuni quartieri. L’emiro fu tenuto sotto controllo dal longobardo Pandolfo Testadiferro, principe di Capua e Benevento, Duca di Spoleto e poi anche principe di Salerno. Pandolfo morì nel marzo del 981 ma i suoi figli e successori erano troppo deboli e divisi per difendersi con successo dai Saraceni. Nel 978-981, come era già accaduto nel 975, Abū l-Qāsim ʿAlī saccheggiò Reggio, Sant’Agata ed altri territori calabresi e pugliesi. In risposta a queste incursioni intervenne stavolta l’imperatore Ottone II con un esercito di cavalieri corazzati, intenzionato a incorporare il Sud Italia nei suoi domini.
Così, dopo aver conquistato Taranto, avanzò in Calabria, dove si scontrò a Capo Colonna con Abū l-Qāsim, in una battaglia, che dal punto di vista strategico, fu un pareggio. L’emiro di Balarm morì per le ferite, lasciando l’esercito senza guida, ma le perdite tedesche furono tali da impedire qualsiasi altra offensiva. Gli unici a guardagnarci, in fondo furono i bizantini, che videro i loro nemici annullarsi a vicenda.
Nel frattempo, la popolazione di Rhegion cresceva a dismisura, a causa dei profughi provenienti dalla Sicilia: questi comprendevano parte dei burocrati locali, molti rimasero a servizio dei conquistatori, facendo una brillante carriera sotto i fatimidi, tra cui Jawhar al-Siqilli, Giafar il Siciliano, conquistatore dell’Egitto e della Siria, ricchi latifondisti, che poco gradivano la politica di Balarm di dare la terra ai contadini, specie se berberi, e tanti ecclesiastici, con l’eccezione dei monaci basiliani, che convinti di trovare il martirio, furono invece integrati nel sistema agricolo ed economico della Sicilia musulmana.
Tanti ecclesiastici che riempirono la chiesa ortodossa di santi calabresi, spesso non riconosciuti, con l’eccezione di San Nilo, dai cattolici: tra questi sono famosi Sant’Elia il Nuovo, San Giovanni il Mietitore, Sant’Elia lo Speleota, San Nicodemo di Mammola, grandi asceti e San Fantino il Giovane, che ebbe un ruolo importante per la creazione dei monasteri sul Monte Athos e che morì a Tessalonica.
La pace legata alla battaglia di Stilo, fu di breve durata: Già nel 985, però, l’offensiva islamica era ripresa, con la conquista di Gerace e quella di Cosenza, le cui mura furono abbattute. Nel 994, a riprova dell’ampiezza dell’offensiva musulmana, fu conquistata Matera ed un rinnegato cristiano, alla testa dei razziatori saraceni, si stabilì nei dintorni della città lucana, com’era avvenuto a Reggio.
Nel 1006 si ebbe un’altra riprova dell’efficacia della strategia di collaborazione imperiale con le repubbliche marinare italiane, già fruttuosa in occasione della liberazione di Bari da un assedio saraceno, per merito del Doge di Venezia, due anni prima. In quell’anno l’alleanza romeo-pisana vinse una grande battaglia navale al largo di Reggio, ma tre anni dopo altre bande saracene erano presenti nella valle del Crati, arrivando nuovamente a conquistare Cosenza.
A salvare però i bizantini, fu l’enorme propensione alla guerra civile degli arabi di sicilia, pronti a scannarsi per motivi economici, agricoltori contro commercianti, religiosi, sunniti contro sciiti, etnici, berberi contro resto del mondo
Nel 1033 l’emiro di Sicilia ‘Ahmad ‘al ‘Akhal venne coinvolto in uno scontro con suo fratello Abu Hafs. Disperando di potere resistere alle forze del fratello, ‘al ‘Akhal decise di rivolgersi per aiuti militari all’Impero Romano. L’imperatore Michele IV comprese immediatamente la grande opportunità che veniva offerta ai Romei, che non si erano mai arresi alla prospettiva di considerare la Sicilia definitivamente perduta. Gli aiuti promessi all’emiro, al comando del catepano d’Italia, il comandante in capo di tutti i Themi imperiali in occidente, Costantino Opos, compirono delle azioni belliche in Sicilia, per poi ritornare a Reggio, portando con sé, quale splendido bottino, ben quindicimila cristiani, che erano stati liberati con la forza, o semplicemente ricevuti in seguito a riscatto.
In più la morte di ‘Ahmad ‘al ‘Akhal fece balenare agli occhi di Bisanzio la possibilità di riconquistare la Sicilia: fu organizzata una grande spedizione militare, al comando del grande generale Giorgio Maniace e di Harald Hardrada, futuro re di Norvegia.
La riconquista dell’isola fu molto più dura del previsto, giacché dopo due anni di feroci combattimenti, solo la metà orientale poteva dirsi effettivamente liberata. Il culmine della campagna fu rappresentato dall’ingresso trionfale di Giorgio Maniace a Siracusa, come era avvenuto a Belisario cinque secoli prima. All’inizio del 1040, a Troina, finalmente l’esercito imperiale colse una decisiva vittoria contro i Saraceni.Ma ahimé, come tradizione, i bizantini si dedicarono al loro sport preferito, pugnalarsi alle spalle, e Maniace fu richiamato in patria… Così quanto conquistato fu perso e gli unici a trarne giovamento furono i Normanni, che nel 1059 misero fine alla Rhegion Bizantina
August 4, 2018
Le avventurose origini del nostro Sole
[image error]
In Quinto Liceo, quando studiavo Geografia Astronomica, non è che si dedicasse così tanta attenzione al nostro Sole: veniva considerato una stella banale, priva di personalità, il signor Nessuno della nostra Galassia.
Invece, gli ultimi studi, hanno evidenziato una storia assai affascinante: per prima, siamo riusciti a capire, cosa ci fosse, prima della sua nascita, nel nostro angolo di Universo. Questo grazie all’alluminio-26, un isotopo altamente radioattivo, con un’emivita di circa 730.000 anni, che si trova nelle meteoriti più antiche del nostro sistema solare.
Fino a qualche tempo fa, si pensava che fosse frutto dell’esplosione di una supernova, avvenuto accanto alla nebulosa solare, poco prima della formazione della nostra stella. Ora, benché tutto sia possibile, la probabilità di un evento del genere, è come dire, assai trascurabile.
Nel 2012, però, due studiosi francesi, Gounelle e Meynet, hanno dimostrato come tali isotopo si potesse essere formato nel nucleo di una stella massiccia, con una massa di circa 30 volte il Sole, presente nella nostra regione del Cosmo, che esplodendo come supernova, avrebbe dato origine alla nebulosa da cui nacque la nostra stella.
Gigante che, in modo scherzoso, è stata soprannominata dagli astronomi, Coatlicue, la dea azteca del fuoco e della fertilità, madre delle stelle del sud. Era sorella di Chimalman e Xochitlicue. Coatlicue fu resa feconda da una sfera piumata. I suoi figli (compreso Coyolxauhqui) la uccisero, ma Huitzilopochtli, il dio del Sole (il figlio che aveva in grembo) fuoriuscì dal suo ventre. Huitzilopochtli uccise i suoi fratelli e sorelle, compreso Coyolxauhqui.
Ora, la nebulosa nata dall’esplosione di Coatlicue dovette essere una sorta di nursery di stelle di seconda generazione, in cui il Sole nacque relativamente tardi. Nel 2014, alcuni scienziati australiani hanno dimostrato come l’oro, l’argento e il platino siano arrivati da queste parti circa 100 milioni di anni prima della nascita del Sole, mentre le terre rare fecero capolino trenta milioni di anni prima.
Per cui, il Sole è forse il fratello più giovane di una numerosa nidiata di stelle, che dovrebbe contare circa un centinaio di astri; quando nascevano, la pressione del loro vento solare e della luce che emettevano, comprimeva il gas della nebulosa madre, provocando l’accensione di nuove stelle, che si sono allontanate le une dalle altre a causa delle lievi differenze di velocità con cui ruotano rispetto al centro della Via Lattea
Ciò ha spinto molti astrofisici a cercare di identificare il suo parentado, basandosi sia sull’analisi dei rapporti tra gli elementi chimici tra le stelle presenti nel nostro vicinato, sia utilizzando tecniche che in biologia, sono utilizzati in cladistica.
Così, nel 2014, Ivan Ramirez ha finalmente trovato uno dei fratelli del nostro Sole: si tratta di una stella identificata con la sigla HD 162826, che ha una massa superiore del 15% del nostro astro e che lievemente più azzurra, che si trova a 110 anni luce di distanza, nella costellazione di Ercole
L’inizio della vita del Sole, poi. non deve essere stato molto tranquillo e a testimoniarlo potrebbero essere cristalli blu intrappolati in meteoriti. Era un Sole molto più attivo, quello primordiale, con flussi molto intensi di particelle cariche e sebbene non sia affatto semplice trovare materiale risalente a quei tempi, alcuni minerali del Fiel Museum potrebbero sicuramente essere tra i più antichi mai studiati. Hibonite è il nome dei cristalli di ghiaccio blu e la loro composizione porta i segni delle reazioni chimiche che si sarebbero verificate a quel tempo.
Molti hanno dimensioni inferiori ai 100 micron di diametro ma nonostante questo hanno registrato benissimo l’ambiente di 4.5 miliardi di anni fa, intrappolandone i gas. Si tratta di cristalli che si sono formati al primo raffreddamento del disco di gas e polvere che avrebbe formato poi il Sole. Alcuni cristalli sono stati colpiti dalle particelle sparate dal giovane Sole e quando i protoni hanno colpito gli atomi di calcio e alluminio nei cristalli, gli atomi stessi si sono divisi in neon e elio, rimasti poi intrappolati all’interno per miliardi di anni.
Studiando questi cristalli con una nuova tecnologia svizzera (spettrometro di massa all’avanguardia con laser per sciogliere parte del cristallo) è stato possibile ottenere un segnale deciso in grado di mostrare la presenza di neon e elio in seguito all’uso del laser: la prima prova concreta dell’attività del Sole primordiale. Il materiale primordiale del Sistema Solare, quindi, ha ricevuto una radiazione dal Sole che in seguito non c’è stata, a testimonianza della potenza del Sole di allora.
[image error]
Tra l’altro, poi, è possibilissimo che i nostri pianeti siano una sorta di seconda generazione, il che spiegherebbe perché il nostro sistema solare sia alquanto diverso da quelli scoperti nel resto della Galassia. Secondo le simulazioni di Konstantin Batygin, un ricercatore del Caltech che si occupa di scienze planetarie, e Gregory Laughlin dell’Università della California, inizialmente il sistema solare era costituito da un numero di Superterre e da Giove.
In questo scenario quando i pianeti erano ancora immersi in un disco di gas e polvere attorno ad un Sole relativamente giovane, Giove è diventato così massiccio e gravitazionalmente influente che è stato in grado di creare un varco nel disco. E mentre il Sole attirava il disco di gas verso se stesso, anche Giove ha iniziato a spostarsi verso l’interno, come se venisse tirati da un enorme nastro trasportatore.
Questo avvicinarsi al Sole, con le relative perturbazioni gravitazionali, ha provocato la distruzione delle Superterre, i cui frammenti sarebbero caduti nel Sole, alimentandone la fusione e quindi causandone l’aumento dell’attività
E questo sarebbe stato anche il destino di Giove, se non si fosse formato Saturno, il è stato tirato verso il sole ad una velocità maggiore, permettendogli così di recuperare. Una volta che i due pianeti massicci si sono trovati abbastanza vicini, si sono agganciati in un particolare tipo di rapporto chiamato risonanza orbitale, ovvero i loro periodi di rivoluzione sono tali da essere esprimibili come rapporto di numeri interi.
Tale risonanza ha rafforzato l’influenza gravitazionale tra i due pianeti, che hanno iniziato a cedersi vicendevolmente momento angolare ed energia, quasi come una danza ritmata: cosa che ha permesso loro di allontanarsi dal Sole, migrando verso l’attuale orbita e lasciandosi dietro i residui delle Superterre, i planetesimi, non caduti nel nostro astro, i quali hanno cominciato una turbolenta fase di aggregazione, in cui potrebbe essere avvenuto l’ipotetico impatto tra la Terra e Theia, da cui avrebbe avuto origine la nostra Luna
Finalisti del Premio ShortKipple 2018
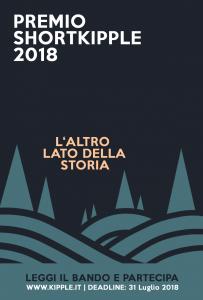 La KippleOfficinaLibraria annuncia, con rullo di tamburi e gran sfoggio di fiati, i finalisti del Premio ShortKipple 2018, concorso riservato ai racconti fantastici e SF inediti scritti in lingua italiana.
La KippleOfficinaLibraria annuncia, con rullo di tamburi e gran sfoggio di fiati, i finalisti del Premio ShortKipple 2018, concorso riservato ai racconti fantastici e SF inediti scritti in lingua italiana.
Community Zero, di Emiliano Maramonte
Cronotopo, di Raul Ciannella
NewCoin, di Alessandro Napolitano
Porta Alchemica, di Alessio Brugnoli
Torpore, di Matt Bryar
Undo, di Stefano Spataro
Rimanete connessi per conoscere, a breve, il vincitore del contest più rapido e iperbolico d’Italia. KeepTalking!
August 3, 2018
Le falangi d’Oriente. Uomini e armi nell’Asia Centrale ellenistica
La satrapia di Battriana e Sogdiana viene assegnata nel 329 a.C. al persiano Artabazo, quindi al macedone Clito ; la provincia è tutt’altro che pacificata, e l’insediamento di 3000 colonia greci a Battra , complica ulteriormente la situazione, una seconda rivolta viene repressa duramente da Perdicca. Nel 321 la provincia viene assegna al cipriota Stasanore di Soli , che succede ad un Filippo, ricordato solo da Diodoro .
Con la divisione dell’impero (316 a.C.) la Battriana viene assegnata, come tutte le province orientali a Seleuco, che ne assegna il governo al figlio Antioco; questi respinge numerose offensive portate dai nomadi delle steppe. In questo periodo si assiste ad un notevole sviluppo urbano, con la fondazione di nuove città e il potenziamento delle precedenti, molte delle quali sono dotate dello statuto di polis, si tratta di città a popolamento misto, dove convivo greci ed indigeni . Comincia la coniazione di monete…
View original post 2.889 altre parole
Angkor (Parte II)
[image error]
Come accennato nella puntata precedente, alla morte di Jayavarman V, per l’indebolimento dell’autorità imperiale e per il potere acquisito dagli alti funzionari, si scatenò il caos. Le iscrizioni degli anni successivi, ovviamente da prendere con le molle, si parla di templi danneggiati e generali premiati per avere sconfitto i nemici del re: sono nominati almeno tre re, Udayadityavarman I e Jayaviravarman a sud e Suryavarman a nord
Quest’ultimo apparteneva alla piccola nobiltà terriera, i cui antenati erano assai devoti alla divinità solare Surya; in ogni modo Suryavarman era un colossale figlio di buona donna, che grazie a una complessa serie di matrimoni, alleanze, battaglie e imbrogli, riuscì a impadronirsi di Angkor nel 1006.
Vinta una battaglia finale, Suryavarman consolidò il suo potere chiamando a una dichiarazione di fedeltà i tamvrac (pubblici ufficiali che si occupavano della riscossione delle tasse nelle province) nel nuovo palazzo reale, il quale, purtroppo costruito in materiali deperibili, non è sopravvissuto, ma pare sia stato il primo circondato da mura di laterite, misuranti 600 m per 250, sulle quali si aprivano 5 gopuras, torri monumentali, ricche di ornamenti, che di solito venivano poste all’ingresso dei templi.
Il che potrebbe far pensare come Suryavarman si equiparasse a una divinità indù: in realtà, non si è mai ben capito di che religione fosse veramente: alcuni indizi, tipo il titolo postumo di Nirvanapada, il patrocinio esercitato su templi buddisti e iscrizioni che citano la distruzione di templi induisti, farebbero pensare a una sua osservanza buddista.
D’altra parte, però, è attestata la sua alleanza con potenti famiglie di bramini shivaiti di Angkor e la posa di linga secondo il culto devaraja. È quindi probabile si trattasse di atti volti a punire chi gli si era opposto più o meno apertamente, anche attraverso la depauperazione di templi, e a redistribuire le ricchezze ammassate a favore degli elementi a lui favorevoli.
[image error]
La sia opera più importante ad Angkor, fu il baray occidentale, il secondo serbatoio d’acqua della città, un immenso bacino idrico artificiale che ha le dimensioni di 8 km per 2,2 km e può contenere più di 123 milioni di litri d’acqua.
Nel 1050, dopo più di quaranta anni di regno, gli successe Udayadityavarman II. Ci sono molti dubbi sul fatto che fosse imparentato con il predecessore e questo di fatto indebolì la sua posizione politica in quel covo di vipere che era la corte Khmer. Sappiamo anche come, durante il suo regno, si scatenarono le numerose rivolte che vennero soffocate con il sangue dal suo generale Sangrama.
In compenso, forse per cercare di rafforzare con la propaganda la sua traballante posizione politica, si dedicò con sommo impegno all’edilizia. Per prima cosa, costruì, per simmetria con quanto fatto da Kavindrarimathana su un isolotto artificiale preesistente del Baray orientale, il Mebon occidentale, su un isolotto del lago artificiale fatto costruire da Suryavarman.
[image error]
In origine il tempio, dedicato a Visnù, comprendeva una piscina quadrata di circa 100 metri di lato attorniata da una recinzione con tre ingressi per lato, di cui sopravvivono in buone condizioni solo quelli orientali. Al centro svettava una piattaforma in arenaria di circa 9 m di lato, collegata all’ingresso centrale del lato est da una strada rialzata in laterite e arenaria.Gli ornamenti delle torri di ingresso, sormontate da un loto a otto petali, sono bassorilievi di animali entro piccole cornici.
[image error]
In più, per riprendere la tradizione dei precedenti re, eresse il Baphuon, un tempio-montagna a cinque livelli, dedicato al dio Shiva, che lanciò la moda di una moda di decorazioni scolpite, che alternavano motivi floreali con bassorilievi di piccole dimensioni, con rappresentazioni di miti indù.
Il Baphuon si estende in direzione est-ovest e la base della piramide, rettangolare anziché quadrata come nei templi-montagna precedenti, misura 132 per 107 metri. cinque livelli hanno la stessa altezza, anche questa caratteristica inusuale nei templi khmer. Il recinto esterno misura 360 per 120 metri.
Come dicevo, Caratteristici sono anche i bassorilievi, scolpiti su mattonelle disposte una sull’altra sulle mura del tempio a guisa di piastrelle.
Il suo aspetto colpì profondamente Zhou Daguan, un ambasciatore spedito dall’imperatore Chengzong della dinastia Yuan ai suoi strampalati vicini cambogiani che durante la sua visita dal 1296 al 1297 scrisse della «Torre di Bronzo…un vero e proprio spettacolo sorprendente, con più di dieci camere alla base» che superava in altezza la stessa “Torre d’Oro” (il Bayon).
Zhou Daguan, oltre che dall’architettura, fu colpito anche dalle usanze Khmer. Scrisse infatti che sia gli uomini che le donne non si coprivano il petto, camminavano a piedi scalzi, ed indossavano solo un pezzo di stoffa cinto alla vita.
Le donne comuni non portavano ornamenti, sebbene alcune portassero anelli d’oro o bracciali. Sembra che le donne più belle fossero mandate a servire alla corte del re o della famiglia reale.
Lo colpì molto, da misogino quale era, che tutti i commerci fossero fatti dalle donne. Nelle zone di mercato non c’erano edifici, e le donne vendevano le loro merci su grandi tappeti posati per terra. Sembra che per occupare il proprio spazio al mercato si dovesse pagare un affitto agli ufficiali.
Daguan affermò che la gente Khmer non aveva tavoli o sedie nelle proprie case. Secondo i suoi racconti cuocevano il cibo in pentole di terracotta usate per bollire il riso e per preparare delle zuppe. I mestoli erano fatti con pezzi di noci di cocco e la zuppa veniva servita in piccole ciotole fatte di foglie intrecciate, apparentemente a impermeabili.
Cose descrisse una processione imperiale
Quando il re esce, le truppe sono alla testa della scorta; poi vengono le bandiere, gli stendardi e i musici. A palazzo le donne, da trecento a cinquecento, indossando abiti fioriti e con fiori nei capelli, portano delle candele nelle loro mani e formano un gruppo. Le candele sono accese anche in pieno giorno. Poi vengono altre donne del palazzo reale, portando lance e scudi, poi le guardie private del re, seguiti da carri trainati da capre e da cavalli, tutti coperti d’oro.
Ministri e principi viaggiano sopra degli elefanti e davanti a loro si possono vedere, da lontano, una quantità innumerevole di ombrelli rossi. Dopo di loro vengono le vedove e le concubine del re su delle portantine, dei carri a cavallo o sopra elefanti. Hanno più di cento parasole, tutti ricamati d’oro. Dietro di loro viene il sovrano, in piedi sopra un elefante, con in mano la spada sacra. Le zanne degli elefanti sono ricoperte d’oro.
Tornando al Baphuon, nel tardo quindicesimo secolo fu convertito in tempio buddista; Una statua di Budda alta 9 metri e lunga 70 metri fu costruita sul lato occidentale del secondo livello, cosa che probabilmente richiese la demolizione della torre che sovrastava per 8 metri e che quindi spiegherebbe oggi la sua assenza. Il tempio fu costruito in arenaria su una base sabbiosa e a causa delle sue immense dimensioni si dimostrò presto instabile. Delle grosse porzioni erano probabilmente già collassate al tempo in cui fu aggiunta la statua di Buddha.
Cosa che peggiorò con tempo, facendo crollare nei secoli il tempio…
August 2, 2018
Il triangolo, no! Non lo avevo considerato
Strano destino, quello di Palestrina: famosa in tutto per il tempo della Fortuna, è assai meno nota per i suoi tanti gioielli del Barocco. Tra questi, il più affascinante è senza dubbio il cosiddetto Triangolo Barberini, il casino di caccia che la famiglia nobiliare volle far costruire nel suo feudo prenestino. Misterioso, perché, a causa dei bombardamenti della Seconda guerra mondiale, gli stessi che permisero di riportare alla luce l’antico santuario latino nel centro storico, i documenti che ne parlavano, andarono tutti distrutti.
Si ipotizza, a causa dello stemma araldico che domina il portale d’ingresso, che unisce la “torre” Giustiniani e le “api” Barberini, che possa essere stato costruito intorno al 1653, quando Maffeo Barberini, per rappacificarsi con i Pamphilj e recuperare parte del patrimonio di famiglia, messo sotto sequestro dalla Camera Apostoliche per le tangenti prese dal suo parentado durante la guerra di Castro, sposo Olimpia Giustiniani, pronipote di Innocenzo X.
La storia tra l’altro racconta che Olimpia, appena dodicenne, dopo le nozze si rifiutò di recarsi a casa dello sposo né acconsentì alla consumazione del matrimonio. Sua madre a questo punto si rivolse a lei dicendole che era stata fortunata in quanto molte altre ragazze da marito della buona società romana dell’epoca erano costrette a sposare mariti molto più anziani di loro, mentre lei aveva la possibilità di sposare il principe Barberini che aveva 22 anni. La ragazza ad ogni modo continuò a rifiutarsi ed a questo punto intervenne Olimpia Maidalchini che spinse la nipote sulla carrozza che la portò a Palazzo Barberini dove iniziò la sua vita matrimoniale.
Grazie ai cronisti dell’epoca, sappiamo il nome dell’architetto: Francesco Contini, il professionista a cui si rivolgevano i Barberini quando andavano al risparmio e non avevano intenzione di riempire le esose tasche di Bernini, autore tra l’altro della Chiesa di Santa Rosalia nel palazzo baronale di Palestrina, il mausoleo della famiglia nobiliare, in cui si svolge un mio racconto presente nell’antologia Operazione Europa
Contini era un seguace di Borromini, benché facesse parte della commissione di esperti che, il 7 febbraio 1657, raccomandò il suo licenziamento come architetto di Sant’ Agnese, capace, con il suo rigore geometrico, di trasfigurare in una realtà metafisica l’irruente fantasia dell’architetto ticinese. E questo rigore esplode nel complesso del Triangolo, situato a via dell’Olmata, tra Casilina e Prenestina, in un’area di m. 242 x 206 assieme ai Casali, tre edifici, collegati simmetricamente da muri che formano due cortili interni, di cui uno centrale e ai due lati una cappella dedicata a S. Filippo Neri ed un magazzino.
Marocco nel 1875 sulla cappella dice:
«Al fiorentino Santo Filippo Neri fu dedicata una chiesa molto graziosa entro la città annessa al palazzetto de’ Barberini ed i popolani non trascurarono di venerare un simile prototipo, che con una vita innocente e tranquilla e nell’istesso tempo rigido e castigato meritò di essere chiamato Santo dal popolo romano e per i miracoli confermato tale dal Santo Vicario di Cristo».




Il Triangolo Barberini è collocato esattamente nel punto d’incontro degli assi del rettangolo complessivo. Tutta l’impostazione planimetrica, a vedere la pianta del Cingoli del 1675 era imperniata su una rigorosa geometria che delineava persino la disposizione degli alberi da frutto in esagoni concentrici, sei viali secondari ed un ampio viale principale alberato convergenti verso il Triangolo, oltre a simmetriche aiuole di piante ornamentali.
La pianta dell’edificio, come dice bene il nome e che reinterpreta in maniera creativa la borrominiana Sant’Ivo della Sapienza , è rappresentata da un triangolo equilatero, di circa 20 metri di lato, che si sviluppa in tre livelli (terra, mezzano, primo piano). Vi è, inoltre, un piano interrato ove erano situate le cucine come testimoniano un forno ed una cappa semicircolare. Per ciascun livello la pianta triangolare ospita un vasto ambiente esagonale al centro e forma, negli spazi di risulta, tre piccoli ambienti triangolari ( stanze e vano-scala).
L’ultima sala esagonale “buca” il soffitto, esce all’aperto in una specie di torretta-altana che lascia spazio ad altre tre terrazze triangolari su due spigoli delle quali prendono posto due statue di guardiani a mezzo busto. La scala che raccorda i piani si trasforma in chiocciola nell’altana centrale e sale alla terrazza esagonale dove, all’uscita, si incontra con altre due cariatidi-gendarme, inquietanti figure, mezzi uomini, a difesa dell’edificio. Quattro statue in totale guardano in direzioni opposte per garantire la sorveglianza simbolica su tutti i lati del palazzo. Il piano nobile e l’altana presentano alle pareti tracce di affreschi e stucchi con motivi floreali oramai in pessimo stato di conservazione.
Perché Contini ha voluta realizzare un edificio dalla pianta così bizzarra ? Ci sono due chiavi di lettura: la prima è relativa alla celebrazione dei suoi datori di lavoro. Se ci pensiamo bene, il due triangoli, come a Sant’Ivo, richiamano l’ape dei Barberini, che si slancia verso l’alto nella torre dei Giustiniani. Un’esaltazione del matrimonio tra Maffeo e Olimpia, che dialogava, nel rapporto tra Micro Cosmo e Macro Cosmo, con lo stemma dell’ingresso, come in una metafora delle poesie del Marino.
La seconda è legata alla passione di Maffeo per l’Alchimia. Il triangolo esprime sia l’ideale della Divinità, dunque simbolo della Trinità, sia l’idea dell’Ascesi dell’uomo verso la trascendenza divina; il Macro-Cosmo, l’universale, ma anche l’idea della proiezione Divina o di potenze celesti verso l’umanità e la natura. Di fatto, il Triangolo Barberini è una sorta di Pentacolo di Salomone, l’unione dell’Umano e del Divino, del Fuoco e dell’Acqua, del Maschile e del Femminile, l’armonia degli opposti da cui nasce la Saggezza, specchio sia degli elementi base dell’Alchimia, sale, zolfo, mercurio, trasformate in Oro dal Magnum Opus, Nigredo, Albedo, Rubedo.
[image error]
La battaglia di Zela – 2 agosto 47 a.C. (fonti)
Plut. Caes. 50 [Plutarco, Vite parallele: Cesare, intr. A. La Penna, tr. D. Magnino, Milano 2009(2), 434-435 (con note)]
κἀκεῖθεν ἐπιὼν τὴν Ἀσίαν ἐπυνθάνετο Δομίτιον μὲν ὑπὸ Φαρνάκου τοῦ Μιθριδάτου παιδὸς ἡττημένον ἐκ Πόντου πεφευγέναι σὺν ὀλίγοις, Φαρνάκην δὲ τῇ νίκῃ χρώμενον ἀπλήστως καὶ Βιθυνίαν ἔχοντα καὶ Καππαδοκίαν Ἀρμενίας ἐφίεσθαι τῆς μικρᾶς καλουμένης, καὶ πάντας ἀνιστάναι τοὺς ταύτῃ βασιλεῖς καὶ τετράρχας. [2] εὐθὺς οὖν ἐπὶ τὸν ἄνδρα τρισὶν ἤλαυνε τάγμασι, καὶ περὶ πόλιν Ζῆλαν μάχην μεγάλην συνάψας αὐτὸν μὲν ἐξέβαλε τοῦ Πόντου φεύγοντα, τὴν δὲ στρατιὰν ἄρδην ἀνεῖλε· [3] καὶ τῆς μάχης ταύτης τὴν ὀξύτητα καὶ τὸ τάχος ἀναγγέλλων εἰς Ῥώμην πρός τινα τῶν φίλων Ἀμάντιον ἔγραψε τρεῖς λέξεις· “ἦλθον, εἶδον, ἐνίκησα.” [4] Ῥωμαϊστὶ δὲ αἱ λέξεις εἰς ὅμοιον ἀπολήγουσαι σχῆμα ῥήματος οὐκ ἀπίθανον τὴν βραχυλογίαν ἔχουσιν.
Di lì passato in Asia, Cesare venne a sapere che Domizio, sconfitto da Farnace, figlio di Mitridate[1]…
View original post 2.912 altre parole
August 1, 2018
La battaglia di Canne – 2 agosto 216 a.C. (Liv. XXII, 42-49)
di Tito Livio, Storia di Roma dalla sua fondazione, vol. V (libri XXI-XXIII), note di M. Scàndola, Milano 1991(3), pp. 316-337.
 Scena dello scontro, di I. Dzis.
Scena dello scontro, di I. Dzis.
[42] Ubi inluxit, subductae primo stationes, deinde propius adeuntibus insolitum silentium admirationem fecit. Tum satis comperta solitudine in castris concursus fit ad praetoria consulum nuntiantium fugam hostium adeo trepidam ut tabernaculis stantibus castra reliquerint, quoque fuga obscurior esset, crebros etiam relictos ignes. Clamor inde ortus ut signa proferri iuberent ducerentque ad persequendos hostes ac protinus castra diripienda et consul alter uelut unus turbae militaris erat: Paulus etiam atque etiam dicere prouidendum praecauendumque esse; postremo, cum aliter neque seditionem neque ducem seditionis sustinere posset, Marium Statilium praefectum cum turma Lucana exploratum mittit. Qui ubi adequitauit portis, subsistere extra munimenta ceteris iussis ipse cum duobus equitibus uallum intrauit speculatusque omnia cum cura renuntiat insidias profecto esse: ignes in parte castrorum quae uergat in hostem…
View original post 5.129 altre parole
Alessio Brugnoli's Blog






