Andrea Viscusi's Blog: Unknown to Millions, page 42
July 16, 2016
Babbo
Mercoledì 13 luglio 2016, intorno alle ore 11:30, mio padre è morto, meno di un mese dopo aver compiuto sessant'anni. Portato via da un male scoperto alla fine dell'anno scorso, contro il quale ha combattutto fino a quando le forze glielo hanno permesso, venendone infine sconfitto. Una di quelle cose che come si sente dire ti mangiano da dentro, espressione di cui non avevo compreso la portata finché non l'ho visto accadere davanti ai miei occhi, a un ritmo esponenziale.
Mi piacerebbe poter dire che se ne è andato senza soffrire, ma non è così. Negli ultimi giorni lo stadio avanzato della malattia, l'indebolimento del fisico e gli inevitabili strascichi delle lunghe terapie tentate nei mesi passati non gli permettevano di trovare riposo. Ero con lui in quel momento, gli stavo tenendo la mano quando ha letteralmente esalato l'ultimo respiro e rovesciato gli occhi. L'ho sollevato insieme all'infermiere per adagiarlo sul letto, ora che finalmente poteva sdraiarsi senza sentire dolore. Posso dire però che se ne è andato sereno. Ha passato gli ultimi giorni in casa, come aveva sempre voluto, con accanto le persone che gli volevano bene. Non è stato facile, perché lo abbiamo visto appassirsi di giorno in giorno, smettere prima di mangiare, poi di dormire, bere, camminare.
Immagino che la morte dei genitori sia un passaggio obbligato della vita adulta, e che quello che sto passando sia tutto sommato comune nell'esperienza di vita di tutti. Non ritegno il mio dolore particolarmente acuto o diverso rispetto a quello di chiunque altro. Eppure mi rendo conto che è impossibile comprenderlo senza averlo vissuto. Espressioni quasi astratte come mi ha lasciato un vuoto dentro, piangere fino a finire le lacrime, smettere di soffrire, che trovavo quasi fastidiose per la loro banalità, hanno assunto ora una prospettiva diversa. Ora so, ora capisco. E mi sento quasi in colpa per aver sminuito dentro di me la portata di queste frasi, quando le ho sentite dire in precedenza. In prospettiva, mi sembra che anche altre cose assumano un senso diverso, penso a tutti quei libri e film in cui un evento del genere è un punto centrale della storia, e che all'epoca posso aver considerato come scontato, ma adesso devo riconsiderare. Perché no, non è scontato.
Devo a mio padre molto di quello che sono. È probabilmente grazie a lui che ho subìto la contaminazione della narrativa fantastica, quando da bambino mi portava i volumi presi in edicola de La Storia Ancestrale; oppure quelli dei dinosauri, degli insetti, dei giochi matematici. Forse tutte le cose risalenti alla mia infanzia che conservo con più cura (e non sono molte, perché ho davvero pochi ricordi della mia vita prima dei nove-dieci anni), me le ha procurate lui. Mio padre era un amante dei libri pur non essendo un gran lettore, gli piaceva comunque circondarsi di manuali, atlanti, enciclopedie. Ingengere mancato, ha abbandonato l'università un paio di esami prima della laurea, ma ha sempre conservato la passione per i numeri e la meccanica. Quanto di tutto questo sia filtrato a me non è difficile da capire.
Quando ho pubblicato Spore, che era "il mio primo libro", ovviamente ne ha voluto una copia, e mi ha chiesto di inserire una dedica. Io, senza pensarci troppo, ho scritto:
Mio padre era un gran lavoratore, anche questo si sente dire spesso, ma di fatto è così. Ha lavorato fino a due settimane prima della sua scomparsa, certo con ritmi più morbidi, ma con la preoccupazione di continuare a offrire il servizio ai suoi clienti. Per gli ultimi trent'anni ha sempre avuto attività sue, che gestiva praticamente da solo, ma ha fatto anche esperienze e progetti diversi, dalla politica alla beneficenza, non sempre fortunati. Durante gli europei di calcio del 2000 (quelli persi con la Francia per colpa dell'infame golden goal), il giorno della finale passò il pomeriggio sulla spiaggia a fare il venditore ambulante di bandiere dell'Italia, per provare anche quel tipo di attività. Non ebbe un gran successo, devo ammettere. Mio padre in media usciva alle 6 di mattina e rientrava a casa dopo le 21, ma non per questo era uno di quei "padri assenti" da telefilm, quelli per cui il figlio esprime il desiderio che possano passare più tempo con lui. Non ho mai sentito la sua mancanza, anzi, c'è stato in tutta una serie di momenti importanti: c'era quando ho fatto il mio primo incidente da neopatentato, c'era quando ho corso la prima maratona, c'era alla prima presentazione del mio libro, c'era quella volta che avevo bisongo di piangere perché non ero più sicuro di cosa avrei fatto.
Era una persona educata ma piuttosto chiusa, facile alla battuta ma che esitava a dare confidenza. Erano poche le persone al di fuori della famiglia che si potessero dichiarare davvero vicine a lui, infatti molti hanno appreso della sua morte del tutto all'oscuro della malattia scoperta sei mesi prima. Era testardo al limite dell'arroganza, spesso era impossibile fargli cambiare idea su un argomento, in particolare su questioni pratiche e di lavoro per cui aveva già elaborato una sua strategia. Aveva un forte senso di dignità, che ha conservato anche negli ultimi giorni, quando sarebbe stato più facile lasciarsi andare: martedì sera, quando sono rimasto a dormire nella stanza con lui per quella che sarebbe stata la sua ultima notte, ho chiesto se volesse che gli tenessi la mano, e ha risposto, deciso: "Assolutamente no!". Sentiva su di sé la responsabilità di chi gli stava intorno, e non mi riferisco soltanti ai familiari, ma anche a chi ha lavorato per lui (con cui ha mantenuto i rapporti anche in seguito) e chi contava su di lui per lavoro. La sua responsabilità si estendeva anche a chi non aveva alcun modo di apprezzarla: basta pensare che l'ultima volta che è uscito di casa è stato per controllare che la nuova vasca per le tartarughe, che aveva acquistato qualche settimana fa ma non era riuscito a installare, fosse stata montata nel modo giusto da me e mio cognato. Si preoccupava che potessero stare bene, visto che la vasca precedente era rotta e rimaneva spesso senz'acqua. Può sembrare una cosa marginale, ma bisogna considerare lo sforzo immane che ha compiuto, solo per accertarsi che quelle bestie ottuse e ingrate fossero sistemate: facile provare amore per un cane, ma un rettile che sta per lo più rintanato nel suo guscio e non esprime alcun tipo di emozione o attaccamento è un'altra cosa.
La cosa curiosa è che rileggendo il paragrafo qui sopra, se non sapessi che il soggetto è mio padre, potrebbe essere una descrizione che si applica anche a me. Per molti aspetti, pur senza rendermente conto, ho finito per diventare come lui. Col senno di poi, mi rendo conto che mi ha insegnato molto, ma lo ha fatto nel modo più efficace, da buon narratore, usando lo show don't tell. Non si trattava di lezioni impartite con parole e l'indice alzato, ma di mostrare come le cose dovessero essere fatte, in modo che potessi capire da solo, col tempo, qual era la giusta condotta da seguire. Sono convinto che, pur essendo scomparso, non abbia finito di insegnarmi, e che negli anni a venire imparerò ancora tanto da lui. Con questo non voglio idealizzarlo, perché aveva anche i suoi difetti e lati oscuri. Una delle cose che più spesso gli ho rimproverato è la mancanza di interessi al di là del lavoro. Faceva una netta distinzione tra le attività utili e inutili, e le seconde non meritavano il suo tempo. Forse se fosse stato appassionato di qualunque cosa, avrebbe potuto trascorrere questi ultimi mesi dedicandosi a essa, e godersi di più il poco tempo rimasto a pescare, a guardarsi le partite, a suonare la chitarra, a costruire modellini... qualunque cosa. Temo però che anche se avesse avuto un hobby, non lo avrebbe mai eletto a sua attività principale, pur sapendo che gli rimaneva poco tempo. Avrebbe volute essere utile fino in fondo. Un'altra cosa che non mi convinceva era il modo in cui si gettava a capofitto su progetti e idee di dubbia validità, spesso affidandosi fin troppo a persone che non avevano dimostrato lo stesso interessamento la stessa dedizione, finendo così per trovarsi da solo con un'impresa pressoché impossibile. Ma resta il fatto che anche da questi suoi punti deboli posso imparare qualcosa.
Mio padre non lascerà un segno nella storia, questo lo so, ma al tempo stesso so che lascia un mondo migliore di come lo ha trovato, e questo non è poco. Se anche i dottori che lo hanno avuto in cura, gente che vede malattia e morte quasi quotidianamente, si sono commossi e sono passati a salutarlo, qualcosa deve pur significare.
Non ho particolari rimpianti nei suoi confronti. Sono sicuro che era fiero di me e di quello che facevo, come mi hanno confermato anche molte delle persone raccolte per il funerale. Forse l'unica cosa che mi dispiace è che non sia mai venuto nella nuova casa in cui mi sono trasferito a febbraio, ma le cose da sistemare erano tante, e abbiamo continuato a rimandare, ignari che invece il tempo era poco... e così non è stato possibile. Ho parlato con lui, mercoledì mattina, un paio d'ore prima di quel momento finale (quando pensavo che sarebbe rimasto forse per una decina di giorni ancora), e gli ho detto quello che volevo dirgli e non avevo mai avuto l'occasione, o forse il coraggio, cose che devono rimanere tra un gentiore e un figlio. Purtroppo non sono sicuro che abbia capito tutto, perché in quel momento aveva già perso lucidità, ma ha annuito, mi ha stretto la mano, quindi spero che abbia sentito e compreso, e che questo lo abbia aiutato ad andarsene in pace.
Una cosa che non saprò mai è se lui fosse consapevole del poco tempo che gli rimaneva. Il male che lo ha colto è uno di quelli che lascia poco scampo, che ti marchia con una data di sadenza a sei mesi, e questo lo sapeva fin dal primo momento. Ma credo che ci abbia creduto, almeno all'inizio, di potercela fare, altrimenti non si spiega perché tenesse un diario così meticoloso di tutti i suoi aggiornamenti: quello che mangiava, le medicine prese, dolori, evacuazioni, reazioni, temperature, visite, prescrizioni. L'ultima registrazione su quel diario è del 10 luglio, domenica, quando mi ha chiesto di trascrivere la pressione che l'infermiere gli aveva appena misurato. Eppure anche quando i risultati degli esami hanno mostrato che non c'erano miglioramenti, ha continuato a dire #celafaremo, che scriveva proprio in questa forma, come hashtag di chiusura di tutti i messaggi che mandava. So che la speranza è un sentimento fondamentale in questi casi, ma ho il sospetto che il #celafaremo fosse più a beneficio di chi gli stava intorno che suo, perché era troppo intelligente e ben informato per poterci credere fino in fondo.
Di fronte a quello che è successo, mi rendo conto di quanto sia seducente l'idea di un aldilà, la speranza che da qualche parte quella persona ti sita aspettando. Non sono religioso, so che la morte non è un "passaggio" ma una mera applicazione del principio di entropia, eppure per un attimo ci ho quasi voluto credere, e anche in questo caso non mi sento di condannare chi ha bisogno di crederlo per poter affrontare una perdita del genere. Ho anche provato a chiederlo, in maniera del tutto indelicata, a qualcuno che aveva vissuto la morte di un genitore prima di me: come si fa a superare una cosa del genere?
Non si può, mi è stato risposto entrambe le volte. Era una risposta che non mi aspettavo, ma che già inizio a sentire appropriata. Questa non è una cosa che va superata, non si può dimenticare e lasciarla dietro, ma bisogna conviverci, giorno per giorno, portarsela dentro e trarne il meglio. Anche tornando, gradualmente, alla confortante routine quotidiana, si continua a vivere con la consapevolezza che non è tutto come prima, che c'è un vuoto dentro che non verrà più riempito.
Quindi è vero, adesso ho un vuoto dentro con cui devo convivere, ma è un buco che la forma di mio padre, ed è una forma intorno alla quale posso costruire qualcosa, qualcosa che mi renda sempre più quello che sono, che è in gran parte dovuto a quello che era lui. Dicono che gli somiglio anche, questo non lo so perché non sono capace di vedere le somiglianze, eppure deve essere vero, perché in questi giorni è quando colgo di sfuggita una mia immagine allo specchio che mi sale di colpo il magone, come se non essendo preparato a vedere il mio volto mi sembrasse per un attimo di aver visto il suo. Possiamo anche pensare, a questo punto che una banalità in più o in meno non fa differenza, che se gli occhi sono lo specchio dell'anima, allora è possibile che io abbia davvero i suoi. L'ho detto all'inizio e lo ripeto, non scrivo tutto questo perché penso che la mia perdita e il mio dolore siano più forti o speciali di quello che chiunque altro ha sperimentato in questo momento. Ma avevo bisogno di scrivere queste parole, di lasciare un segno, e se significa usare per una volta questo spazio per qualcosa di personale, che sia. Volevo che tutte queste riflessioni rimanessero impresse, che ciò che mio padre è stato, e continua a essere in me e per me, fosse chiaro. Queste cose sono successe, e dovevano essere raccontate.
Solo che finora ho sbagliato, perché ho parlato di mio padre, ma lui non era "mio padre". Era babbo.
È per lui che scrivo tutto questo, è per lui che continuerò a vivere nel nome della curiosità e della dedizione, è per lui che ho trovato queste ultime lacrime, anche quando pensavo di averle finite.
Ciao babbo.
DOMENICO VISCUSI14-6-1956 - 13-7-2016
Mi piacerebbe poter dire che se ne è andato senza soffrire, ma non è così. Negli ultimi giorni lo stadio avanzato della malattia, l'indebolimento del fisico e gli inevitabili strascichi delle lunghe terapie tentate nei mesi passati non gli permettevano di trovare riposo. Ero con lui in quel momento, gli stavo tenendo la mano quando ha letteralmente esalato l'ultimo respiro e rovesciato gli occhi. L'ho sollevato insieme all'infermiere per adagiarlo sul letto, ora che finalmente poteva sdraiarsi senza sentire dolore. Posso dire però che se ne è andato sereno. Ha passato gli ultimi giorni in casa, come aveva sempre voluto, con accanto le persone che gli volevano bene. Non è stato facile, perché lo abbiamo visto appassirsi di giorno in giorno, smettere prima di mangiare, poi di dormire, bere, camminare.
Immagino che la morte dei genitori sia un passaggio obbligato della vita adulta, e che quello che sto passando sia tutto sommato comune nell'esperienza di vita di tutti. Non ritegno il mio dolore particolarmente acuto o diverso rispetto a quello di chiunque altro. Eppure mi rendo conto che è impossibile comprenderlo senza averlo vissuto. Espressioni quasi astratte come mi ha lasciato un vuoto dentro, piangere fino a finire le lacrime, smettere di soffrire, che trovavo quasi fastidiose per la loro banalità, hanno assunto ora una prospettiva diversa. Ora so, ora capisco. E mi sento quasi in colpa per aver sminuito dentro di me la portata di queste frasi, quando le ho sentite dire in precedenza. In prospettiva, mi sembra che anche altre cose assumano un senso diverso, penso a tutti quei libri e film in cui un evento del genere è un punto centrale della storia, e che all'epoca posso aver considerato come scontato, ma adesso devo riconsiderare. Perché no, non è scontato.
Devo a mio padre molto di quello che sono. È probabilmente grazie a lui che ho subìto la contaminazione della narrativa fantastica, quando da bambino mi portava i volumi presi in edicola de La Storia Ancestrale; oppure quelli dei dinosauri, degli insetti, dei giochi matematici. Forse tutte le cose risalenti alla mia infanzia che conservo con più cura (e non sono molte, perché ho davvero pochi ricordi della mia vita prima dei nove-dieci anni), me le ha procurate lui. Mio padre era un amante dei libri pur non essendo un gran lettore, gli piaceva comunque circondarsi di manuali, atlanti, enciclopedie. Ingengere mancato, ha abbandonato l'università un paio di esami prima della laurea, ma ha sempre conservato la passione per i numeri e la meccanica. Quanto di tutto questo sia filtrato a me non è difficile da capire.
Quando ho pubblicato Spore, che era "il mio primo libro", ovviamente ne ha voluto una copia, e mi ha chiesto di inserire una dedica. Io, senza pensarci troppo, ho scritto:
A mio padre, che mi ha insegnato la curiosità e la dedizioneCredo che di non aver mai azzeccato così tanto una dedica. La curiosità è quella che lo portava a chiedersi continuamente come le cose funzionavano, e preferiva risolvere un problema su un'auto o un elettrodomestico con una lunga sessione di reverse engineering piuttosto che affidandosi a qualche specialista. La dedizione era la sua capacità di impegnarsi con tutto se stesso per ottenere un risultato, senza necessariamente affrettare i passi, ma lavorando con precisione per ottenerlo anche nel lungo termine.
Mio padre era un gran lavoratore, anche questo si sente dire spesso, ma di fatto è così. Ha lavorato fino a due settimane prima della sua scomparsa, certo con ritmi più morbidi, ma con la preoccupazione di continuare a offrire il servizio ai suoi clienti. Per gli ultimi trent'anni ha sempre avuto attività sue, che gestiva praticamente da solo, ma ha fatto anche esperienze e progetti diversi, dalla politica alla beneficenza, non sempre fortunati. Durante gli europei di calcio del 2000 (quelli persi con la Francia per colpa dell'infame golden goal), il giorno della finale passò il pomeriggio sulla spiaggia a fare il venditore ambulante di bandiere dell'Italia, per provare anche quel tipo di attività. Non ebbe un gran successo, devo ammettere. Mio padre in media usciva alle 6 di mattina e rientrava a casa dopo le 21, ma non per questo era uno di quei "padri assenti" da telefilm, quelli per cui il figlio esprime il desiderio che possano passare più tempo con lui. Non ho mai sentito la sua mancanza, anzi, c'è stato in tutta una serie di momenti importanti: c'era quando ho fatto il mio primo incidente da neopatentato, c'era quando ho corso la prima maratona, c'era alla prima presentazione del mio libro, c'era quella volta che avevo bisongo di piangere perché non ero più sicuro di cosa avrei fatto.
Era una persona educata ma piuttosto chiusa, facile alla battuta ma che esitava a dare confidenza. Erano poche le persone al di fuori della famiglia che si potessero dichiarare davvero vicine a lui, infatti molti hanno appreso della sua morte del tutto all'oscuro della malattia scoperta sei mesi prima. Era testardo al limite dell'arroganza, spesso era impossibile fargli cambiare idea su un argomento, in particolare su questioni pratiche e di lavoro per cui aveva già elaborato una sua strategia. Aveva un forte senso di dignità, che ha conservato anche negli ultimi giorni, quando sarebbe stato più facile lasciarsi andare: martedì sera, quando sono rimasto a dormire nella stanza con lui per quella che sarebbe stata la sua ultima notte, ho chiesto se volesse che gli tenessi la mano, e ha risposto, deciso: "Assolutamente no!". Sentiva su di sé la responsabilità di chi gli stava intorno, e non mi riferisco soltanti ai familiari, ma anche a chi ha lavorato per lui (con cui ha mantenuto i rapporti anche in seguito) e chi contava su di lui per lavoro. La sua responsabilità si estendeva anche a chi non aveva alcun modo di apprezzarla: basta pensare che l'ultima volta che è uscito di casa è stato per controllare che la nuova vasca per le tartarughe, che aveva acquistato qualche settimana fa ma non era riuscito a installare, fosse stata montata nel modo giusto da me e mio cognato. Si preoccupava che potessero stare bene, visto che la vasca precedente era rotta e rimaneva spesso senz'acqua. Può sembrare una cosa marginale, ma bisogna considerare lo sforzo immane che ha compiuto, solo per accertarsi che quelle bestie ottuse e ingrate fossero sistemate: facile provare amore per un cane, ma un rettile che sta per lo più rintanato nel suo guscio e non esprime alcun tipo di emozione o attaccamento è un'altra cosa.
La cosa curiosa è che rileggendo il paragrafo qui sopra, se non sapessi che il soggetto è mio padre, potrebbe essere una descrizione che si applica anche a me. Per molti aspetti, pur senza rendermente conto, ho finito per diventare come lui. Col senno di poi, mi rendo conto che mi ha insegnato molto, ma lo ha fatto nel modo più efficace, da buon narratore, usando lo show don't tell. Non si trattava di lezioni impartite con parole e l'indice alzato, ma di mostrare come le cose dovessero essere fatte, in modo che potessi capire da solo, col tempo, qual era la giusta condotta da seguire. Sono convinto che, pur essendo scomparso, non abbia finito di insegnarmi, e che negli anni a venire imparerò ancora tanto da lui. Con questo non voglio idealizzarlo, perché aveva anche i suoi difetti e lati oscuri. Una delle cose che più spesso gli ho rimproverato è la mancanza di interessi al di là del lavoro. Faceva una netta distinzione tra le attività utili e inutili, e le seconde non meritavano il suo tempo. Forse se fosse stato appassionato di qualunque cosa, avrebbe potuto trascorrere questi ultimi mesi dedicandosi a essa, e godersi di più il poco tempo rimasto a pescare, a guardarsi le partite, a suonare la chitarra, a costruire modellini... qualunque cosa. Temo però che anche se avesse avuto un hobby, non lo avrebbe mai eletto a sua attività principale, pur sapendo che gli rimaneva poco tempo. Avrebbe volute essere utile fino in fondo. Un'altra cosa che non mi convinceva era il modo in cui si gettava a capofitto su progetti e idee di dubbia validità, spesso affidandosi fin troppo a persone che non avevano dimostrato lo stesso interessamento la stessa dedizione, finendo così per trovarsi da solo con un'impresa pressoché impossibile. Ma resta il fatto che anche da questi suoi punti deboli posso imparare qualcosa.
Mio padre non lascerà un segno nella storia, questo lo so, ma al tempo stesso so che lascia un mondo migliore di come lo ha trovato, e questo non è poco. Se anche i dottori che lo hanno avuto in cura, gente che vede malattia e morte quasi quotidianamente, si sono commossi e sono passati a salutarlo, qualcosa deve pur significare.
Non ho particolari rimpianti nei suoi confronti. Sono sicuro che era fiero di me e di quello che facevo, come mi hanno confermato anche molte delle persone raccolte per il funerale. Forse l'unica cosa che mi dispiace è che non sia mai venuto nella nuova casa in cui mi sono trasferito a febbraio, ma le cose da sistemare erano tante, e abbiamo continuato a rimandare, ignari che invece il tempo era poco... e così non è stato possibile. Ho parlato con lui, mercoledì mattina, un paio d'ore prima di quel momento finale (quando pensavo che sarebbe rimasto forse per una decina di giorni ancora), e gli ho detto quello che volevo dirgli e non avevo mai avuto l'occasione, o forse il coraggio, cose che devono rimanere tra un gentiore e un figlio. Purtroppo non sono sicuro che abbia capito tutto, perché in quel momento aveva già perso lucidità, ma ha annuito, mi ha stretto la mano, quindi spero che abbia sentito e compreso, e che questo lo abbia aiutato ad andarsene in pace.
Una cosa che non saprò mai è se lui fosse consapevole del poco tempo che gli rimaneva. Il male che lo ha colto è uno di quelli che lascia poco scampo, che ti marchia con una data di sadenza a sei mesi, e questo lo sapeva fin dal primo momento. Ma credo che ci abbia creduto, almeno all'inizio, di potercela fare, altrimenti non si spiega perché tenesse un diario così meticoloso di tutti i suoi aggiornamenti: quello che mangiava, le medicine prese, dolori, evacuazioni, reazioni, temperature, visite, prescrizioni. L'ultima registrazione su quel diario è del 10 luglio, domenica, quando mi ha chiesto di trascrivere la pressione che l'infermiere gli aveva appena misurato. Eppure anche quando i risultati degli esami hanno mostrato che non c'erano miglioramenti, ha continuato a dire #celafaremo, che scriveva proprio in questa forma, come hashtag di chiusura di tutti i messaggi che mandava. So che la speranza è un sentimento fondamentale in questi casi, ma ho il sospetto che il #celafaremo fosse più a beneficio di chi gli stava intorno che suo, perché era troppo intelligente e ben informato per poterci credere fino in fondo.
Di fronte a quello che è successo, mi rendo conto di quanto sia seducente l'idea di un aldilà, la speranza che da qualche parte quella persona ti sita aspettando. Non sono religioso, so che la morte non è un "passaggio" ma una mera applicazione del principio di entropia, eppure per un attimo ci ho quasi voluto credere, e anche in questo caso non mi sento di condannare chi ha bisogno di crederlo per poter affrontare una perdita del genere. Ho anche provato a chiederlo, in maniera del tutto indelicata, a qualcuno che aveva vissuto la morte di un genitore prima di me: come si fa a superare una cosa del genere?
Non si può, mi è stato risposto entrambe le volte. Era una risposta che non mi aspettavo, ma che già inizio a sentire appropriata. Questa non è una cosa che va superata, non si può dimenticare e lasciarla dietro, ma bisogna conviverci, giorno per giorno, portarsela dentro e trarne il meglio. Anche tornando, gradualmente, alla confortante routine quotidiana, si continua a vivere con la consapevolezza che non è tutto come prima, che c'è un vuoto dentro che non verrà più riempito.
Quindi è vero, adesso ho un vuoto dentro con cui devo convivere, ma è un buco che la forma di mio padre, ed è una forma intorno alla quale posso costruire qualcosa, qualcosa che mi renda sempre più quello che sono, che è in gran parte dovuto a quello che era lui. Dicono che gli somiglio anche, questo non lo so perché non sono capace di vedere le somiglianze, eppure deve essere vero, perché in questi giorni è quando colgo di sfuggita una mia immagine allo specchio che mi sale di colpo il magone, come se non essendo preparato a vedere il mio volto mi sembrasse per un attimo di aver visto il suo. Possiamo anche pensare, a questo punto che una banalità in più o in meno non fa differenza, che se gli occhi sono lo specchio dell'anima, allora è possibile che io abbia davvero i suoi. L'ho detto all'inizio e lo ripeto, non scrivo tutto questo perché penso che la mia perdita e il mio dolore siano più forti o speciali di quello che chiunque altro ha sperimentato in questo momento. Ma avevo bisogno di scrivere queste parole, di lasciare un segno, e se significa usare per una volta questo spazio per qualcosa di personale, che sia. Volevo che tutte queste riflessioni rimanessero impresse, che ciò che mio padre è stato, e continua a essere in me e per me, fosse chiaro. Queste cose sono successe, e dovevano essere raccontate.
Solo che finora ho sbagliato, perché ho parlato di mio padre, ma lui non era "mio padre". Era babbo.
È per lui che scrivo tutto questo, è per lui che continuerò a vivere nel nome della curiosità e della dedizione, è per lui che ho trovato queste ultime lacrime, anche quando pensavo di averle finite.
Ciao babbo.
DOMENICO VISCUSI14-6-1956 - 13-7-2016
Published on July 16, 2016 02:41
July 7, 2016
Interruzione temporanea
 Post di servizio per informare che Unknown to Millions andrà in pausa per un po'. Non è una pausa di riflessione né una vacanza estiva, è che al momento mi trovo in una situazione che non mi permette di dedicare al blog il tempo e soprattutto la disposizione d'animo necessaria per scrivere. Ho bisogno di occuparmi di cose che, a differenza di un post sul blog, non possono aspettare, per cui tengo in sospeso tutto, a tempo indefinito, ovvero fino a quando le cose non si saranno risolte. Il che, ironicamente, potrebbe anche avvenire molto presto.
Post di servizio per informare che Unknown to Millions andrà in pausa per un po'. Non è una pausa di riflessione né una vacanza estiva, è che al momento mi trovo in una situazione che non mi permette di dedicare al blog il tempo e soprattutto la disposizione d'animo necessaria per scrivere. Ho bisogno di occuparmi di cose che, a differenza di un post sul blog, non possono aspettare, per cui tengo in sospeso tutto, a tempo indefinito, ovvero fino a quando le cose non si saranno risolte. Il che, ironicamente, potrebbe anche avvenire molto presto.Mi pareva corretto avvertire quei due-tre lurker che girano da queste parti, anche se sono cosciente che il mondo potrà benissimo fare a meno di Unknown to Millions, come può fare a meno praticamente di qualunque cosa.
Potrei aggiungere molte altre cose che mi passano per la testa in questo momento, ma esulerebbero dai temi di questo blog, quindi concluso semplicemente con un arrivederci a tempi migliori.
Published on July 07, 2016 02:55
July 2, 2016
L'arco narrativo dell'Undicesimo Dottore
Visto che non avremo niente di nuovo di Doctor Who fino a natale, ma su questo blog ho voluto creare una rubrica apposita, per riempire il vuoto di questi mesi mi concedo una piccola riflessione. Mi è capitato più volte di imbattermi in discussioni e commenti in cui si affrontava il tema del passaggio dall'Undicesimo Dottore (Matt Smith) al Dodicesimo (l'attuale Peter Capaldi), e in genere viene detto che la storia dell'Unidcesimo è incompleta e poco organica, senza un vero e proprio arco narrativo che ne comprenda il percorso e conduca a una conclusione degna. Il che è tremendamente errato, o almeno un'interpretazione molto superficiale. Quindi mi permetto di esporre quella che ritengo sia la storia che abbraccia tutto il periodo di Matt Smith, e che molti non sono stati in grado di cogliere. Sia chiaro, non penso di essere l'unico eletto ad aver capito la cosa, gli elementi mi paiono evidenti, e in realtà mi sorprende il fatto che molti sembrano non averli colti. Ma appunto, se qualcuno là fuori non ci è arrivato, provo a spiegarlo.
 Forse il problema più grosso nel poter cogliere l'intero arco narrativo è che il punto di inizio e di arrivo è tutto incapsulato in un unico episodio:
The Time of the Doctor
, che è appunto l'episodio in cui l'Undicesimo Dottore (che poi sarebbe già la tredicesima rigenerazione) lascia il posto alla sua incarnazione successiva. Breve recap della puntata (che non si trova commentata sul blog perché ho iniziato dalla stagione 8): il Dottore è alla ricerca di Gallifrey (ricordiamo che siamo appena dopo The Day of the Doctor, in cui ha scoperto che non è stato distrutto ma incapsulato in un microuniverso parallelo) e un segnale misterioso lo porta su Trenzalore, qui scopre che i Time Lord lo stanno chiamando per poter tornare nell'universo "madre", ma al loro ritorno si oppone tutto il resto delle specie senzienti perché la Time War esploderebbe di nuovo. Il Dottore si stabilisce quindi sul pianeta e lo protegge dai continui attacchi che cercano di distruggere il punto di accesso dei Time Lord, in attesa del momento giusto per poterli far tornare. Qui vive oltre 300 anni e arriva alla fine della sua vita (trattandosi dell'ultime rigenerazione), quando ormai sono rimasti solo i Dalek ad opporsi e stanno vincendo. Alla fine sono proprio i Time Lord a concedergli un'altra rigenerazione e permettergli di cacciare i Dalek, per poi scomparire del tutto. Si tratta di un episodio lungo e con abbondanza di sottotrame e personaggi nuovi, eppure tutti gli elementi per comporre l'intera storia, a partire dalla quinta stagione fino all passaggio da Eleven a Twelve sono lì.
Forse il problema più grosso nel poter cogliere l'intero arco narrativo è che il punto di inizio e di arrivo è tutto incapsulato in un unico episodio:
The Time of the Doctor
, che è appunto l'episodio in cui l'Undicesimo Dottore (che poi sarebbe già la tredicesima rigenerazione) lascia il posto alla sua incarnazione successiva. Breve recap della puntata (che non si trova commentata sul blog perché ho iniziato dalla stagione 8): il Dottore è alla ricerca di Gallifrey (ricordiamo che siamo appena dopo The Day of the Doctor, in cui ha scoperto che non è stato distrutto ma incapsulato in un microuniverso parallelo) e un segnale misterioso lo porta su Trenzalore, qui scopre che i Time Lord lo stanno chiamando per poter tornare nell'universo "madre", ma al loro ritorno si oppone tutto il resto delle specie senzienti perché la Time War esploderebbe di nuovo. Il Dottore si stabilisce quindi sul pianeta e lo protegge dai continui attacchi che cercano di distruggere il punto di accesso dei Time Lord, in attesa del momento giusto per poterli far tornare. Qui vive oltre 300 anni e arriva alla fine della sua vita (trattandosi dell'ultime rigenerazione), quando ormai sono rimasti solo i Dalek ad opporsi e stanno vincendo. Alla fine sono proprio i Time Lord a concedergli un'altra rigenerazione e permettergli di cacciare i Dalek, per poi scomparire del tutto. Si tratta di un episodio lungo e con abbondanza di sottotrame e personaggi nuovi, eppure tutti gli elementi per comporre l'intera storia, a partire dalla quinta stagione fino all passaggio da Eleven a Twelve sono lì.
Mettiamo le carte in tavola, ricordando quali sono i temi ricorrenti delle singole stagioni di Matt Smith:
Stagione 5: le "crepe" nella realtà. Ricorrono per tutta la stagione e nel finale si scopre che sono generate dall'esplosione del Tardis, a sua volta causata dal tentativo di River Song di salvare il Dottore imprigionato nel Pandorica. Questo imprigionamento è una sentenza a cui tutti i suoi nemici di comune accordo lo hanno condannato, per preservare l'integrità dell'universo, sapendo che lo avrebbe distrutto. Per rimediare tutto questo, il Dottore riavvia l'universo e tutti sono contenti.Stagione 6: il Silenzio. Silence will fall (già accennato nella stagione precedente), ovvero il tentativo di uccidere il Dottore prima che possa rispondere alla domanda " Doctor Who? ", che sarà pronunciata proprio su Trenzalore. Questo incidentalmente dà origine anche a River Song, ma la questione è marginale.Stagione 7: il tema ricorrente è Clara/Impossible Girl, che in ultimo è un pretesto per ritornare al passato del Dottore, al War Doctor e all'ultimo giorno della Time War, e in The Day of the Doctor si scopre che Gallifrey non è davvero distrutto ma solo chiuso in un universo-bolla per proteggerlo. Inizia così la ricerca del pianeta perduto dei Time Lord.
Tutti questi fili tra loro non direttamente collegati, che sembrano fare da collante solo alle singole stagioni, in realtà vengono intrecciati insieme durante The Time of the Doctor. Le parti chiave avvengono principalmente nei colloqui tra il Dottore la papessa, nei brevi momenti di tregua durante l'assedio di Trenzalore. Qui apprendiamo diverse cose:Le crepe nell'universo sono la soglia attraverso cui i Time Lord si affacciano dal loro universo portatile.La domanda Doctor who? è il messaggio che i Time Lord stanno inviando dall'altra parte, in modo da sapere quando possono emergere.La setta del Silenzio è un ramo separatista della Chiesa che ha deciso di intervenrie con la forza per prevenire la risposta alla domanda (e i Silence in particolare sarebbero dei confessori, opportunamente riciclati come forza lavoro).Ricomponendo il tutto, si può ottenere la storia nel suo ordine "cronologico", o almeno nella sequenza di rapporti causa-effetto che ha portato alle varie situazioni che si succedono, in ordine non cronologico, nel corso delle stagioni. Nell'ultimo giorno della Time War, il Dottore fa sparire Gallifrey chiudendolo in un universo parallelo.I Time Lord sanno di essere rinchiusi in un inframondo e intendono tornare all'universo madre. Iniziano così a diffondere in tutto lo spazio e il tempo il messaggio "Doctor who?" A questa domanda solo il Dottore (che è l'unico Time Lord ancora presente nell'universo principale) può rispondere, per questo i Time Lord sanno che quando riceveranno risposta sarà il momento di tornare.La formazione delle crepe nel tessuto della realtà (vedi sotto punto 8) permette ai Time Lord di inviare il loro messaggio nell'universo e attendere la risposta.Il Dottore dopo aver rivissuto gli eventi della Time War capisce che Gallifrey è intrappolato e inizia a cercarlo. Arriva quindi su Trenzalore dove trova una delle crepe da cui il messaggio Doctor who? si origina.Su Trenzalore sono arrivati anche tutte le altre razze, in particolare la Chiesa. Tutte queste vogliono impedire il ritorno dei Time Lord per evitare che la Time War riprenda, per questo tengono il pianeta sotto assedio e intimano al Dottore di non rispondere alla chiamata dei gallifreyani.Il Dottore fa una sorta di accordo con la Papessa, ma una corrente interna alla Chiesa non ci crede e decide di intervenire direttamente per evitare che il Dottore possa rispondere. A capo di questa sezione c'è Madame Kovarian (la signora con la benda sull'occhio della stagione 6).La Kovarian fonda la setta del Silenzio, mette su la sua squadra e torna indietro nel tempo per fermare il Dottore. Il suo piano iniziale è quello di imprigionare il Dottore e impedire che possa arrivare a Trenzalore per rispondere.Con il supporto degli altri suoi nemici il Silenzio crea la prigione Pandorica e il complotto che porta il Dottore a esservi imprigionato. Il piano però non funziona alla perfezione, e per liberare il Dottore River Song fa esplodere il Tardis, che crea le crepe nella realtà attraverso cui i Time Lord possono affacciarsi per lanciare il loro messaggio (vedi sopra punto 3).Come piano alternativo (visto che hanno fatto pegio che meglio) il Silenzio decide di uccidere il Dottore, per farlo rapisce e "programma" Rivers Song. Il Dottore viene ufficialmente ucciso (per quello che ne sanno loro) nel 2011 (primo episodio della stagione 6).Il Dottore in realtà è sopravvissuto e può così arrivare a Trenzalore, dove sostiene l'assedio fino all'ultimo minuto, quando Clara chiede l'intervento dei Time Lord per salvarlo, e loro gli concedno la rigenerazione.A questo punto in effetti non è chiarissimo se i Time Lord hanno deciso subito di uscire o se ne sono rimasti nel loro universo ancora un po', sta di fatto che senza che nessuno ci facesse caso sono tornati visto che alla fine della nona stagione il Dottore raggiunge Gallifrey.Il percorso è un po' ingarbugliato perché come sempre stiamo parlando di eventi passati e futuri che si influenzano a vicenda, per cui le azioni compiute dalla setta che vuole impedire l'arrivo del Dottore sono quelli che permettono in primo lugo che i Time Lord lo chiamino, e così via. Ma questo è il solito wibbly-wobbly a cui gli spettatori di Doctor Who sono avvezzi.

Non dico che la storia sia perfettamente coerente e progettata fin dall'inizio. Probabilmente molti elementi sono stati fatti combaciare solo a posteriori, e in questo senso un esempio perfetto è il frammento dell'episodio The God Complex, in cui il Dottore visita la stanza che dovrebbe contenere la sua più grande paura. In quel momento non viene mostrato cosa contiene, ma in The Time of the Doctor vediamo che era la solita crepa nel tessuto della realtà. Dubito proprio che all'epoca questo fosse già stato previsto, probabilmente la scena era rimasta ambigua proprio per permettere in seguito di ricollegarsi con qualunque cosa potesse servire.
Ma, al di là della completezza o anche della bontà di questa storia, non si può negare che un tentativo di unificare (se pur a posteriori) in un unico arco narrativo tutto il percorso dell'Undicesimo Dottore è stato fatto. Rivedendo le sue prime stagioni con il senno di poi è un esercizio interessante, che conferisce una prospettiva diversa su alcuni aspetti.
 Forse il problema più grosso nel poter cogliere l'intero arco narrativo è che il punto di inizio e di arrivo è tutto incapsulato in un unico episodio:
The Time of the Doctor
, che è appunto l'episodio in cui l'Undicesimo Dottore (che poi sarebbe già la tredicesima rigenerazione) lascia il posto alla sua incarnazione successiva. Breve recap della puntata (che non si trova commentata sul blog perché ho iniziato dalla stagione 8): il Dottore è alla ricerca di Gallifrey (ricordiamo che siamo appena dopo The Day of the Doctor, in cui ha scoperto che non è stato distrutto ma incapsulato in un microuniverso parallelo) e un segnale misterioso lo porta su Trenzalore, qui scopre che i Time Lord lo stanno chiamando per poter tornare nell'universo "madre", ma al loro ritorno si oppone tutto il resto delle specie senzienti perché la Time War esploderebbe di nuovo. Il Dottore si stabilisce quindi sul pianeta e lo protegge dai continui attacchi che cercano di distruggere il punto di accesso dei Time Lord, in attesa del momento giusto per poterli far tornare. Qui vive oltre 300 anni e arriva alla fine della sua vita (trattandosi dell'ultime rigenerazione), quando ormai sono rimasti solo i Dalek ad opporsi e stanno vincendo. Alla fine sono proprio i Time Lord a concedergli un'altra rigenerazione e permettergli di cacciare i Dalek, per poi scomparire del tutto. Si tratta di un episodio lungo e con abbondanza di sottotrame e personaggi nuovi, eppure tutti gli elementi per comporre l'intera storia, a partire dalla quinta stagione fino all passaggio da Eleven a Twelve sono lì.
Forse il problema più grosso nel poter cogliere l'intero arco narrativo è che il punto di inizio e di arrivo è tutto incapsulato in un unico episodio:
The Time of the Doctor
, che è appunto l'episodio in cui l'Undicesimo Dottore (che poi sarebbe già la tredicesima rigenerazione) lascia il posto alla sua incarnazione successiva. Breve recap della puntata (che non si trova commentata sul blog perché ho iniziato dalla stagione 8): il Dottore è alla ricerca di Gallifrey (ricordiamo che siamo appena dopo The Day of the Doctor, in cui ha scoperto che non è stato distrutto ma incapsulato in un microuniverso parallelo) e un segnale misterioso lo porta su Trenzalore, qui scopre che i Time Lord lo stanno chiamando per poter tornare nell'universo "madre", ma al loro ritorno si oppone tutto il resto delle specie senzienti perché la Time War esploderebbe di nuovo. Il Dottore si stabilisce quindi sul pianeta e lo protegge dai continui attacchi che cercano di distruggere il punto di accesso dei Time Lord, in attesa del momento giusto per poterli far tornare. Qui vive oltre 300 anni e arriva alla fine della sua vita (trattandosi dell'ultime rigenerazione), quando ormai sono rimasti solo i Dalek ad opporsi e stanno vincendo. Alla fine sono proprio i Time Lord a concedergli un'altra rigenerazione e permettergli di cacciare i Dalek, per poi scomparire del tutto. Si tratta di un episodio lungo e con abbondanza di sottotrame e personaggi nuovi, eppure tutti gli elementi per comporre l'intera storia, a partire dalla quinta stagione fino all passaggio da Eleven a Twelve sono lì.Mettiamo le carte in tavola, ricordando quali sono i temi ricorrenti delle singole stagioni di Matt Smith:
Stagione 5: le "crepe" nella realtà. Ricorrono per tutta la stagione e nel finale si scopre che sono generate dall'esplosione del Tardis, a sua volta causata dal tentativo di River Song di salvare il Dottore imprigionato nel Pandorica. Questo imprigionamento è una sentenza a cui tutti i suoi nemici di comune accordo lo hanno condannato, per preservare l'integrità dell'universo, sapendo che lo avrebbe distrutto. Per rimediare tutto questo, il Dottore riavvia l'universo e tutti sono contenti.Stagione 6: il Silenzio. Silence will fall (già accennato nella stagione precedente), ovvero il tentativo di uccidere il Dottore prima che possa rispondere alla domanda " Doctor Who? ", che sarà pronunciata proprio su Trenzalore. Questo incidentalmente dà origine anche a River Song, ma la questione è marginale.Stagione 7: il tema ricorrente è Clara/Impossible Girl, che in ultimo è un pretesto per ritornare al passato del Dottore, al War Doctor e all'ultimo giorno della Time War, e in The Day of the Doctor si scopre che Gallifrey non è davvero distrutto ma solo chiuso in un universo-bolla per proteggerlo. Inizia così la ricerca del pianeta perduto dei Time Lord.
Tutti questi fili tra loro non direttamente collegati, che sembrano fare da collante solo alle singole stagioni, in realtà vengono intrecciati insieme durante The Time of the Doctor. Le parti chiave avvengono principalmente nei colloqui tra il Dottore la papessa, nei brevi momenti di tregua durante l'assedio di Trenzalore. Qui apprendiamo diverse cose:Le crepe nell'universo sono la soglia attraverso cui i Time Lord si affacciano dal loro universo portatile.La domanda Doctor who? è il messaggio che i Time Lord stanno inviando dall'altra parte, in modo da sapere quando possono emergere.La setta del Silenzio è un ramo separatista della Chiesa che ha deciso di intervenrie con la forza per prevenire la risposta alla domanda (e i Silence in particolare sarebbero dei confessori, opportunamente riciclati come forza lavoro).Ricomponendo il tutto, si può ottenere la storia nel suo ordine "cronologico", o almeno nella sequenza di rapporti causa-effetto che ha portato alle varie situazioni che si succedono, in ordine non cronologico, nel corso delle stagioni. Nell'ultimo giorno della Time War, il Dottore fa sparire Gallifrey chiudendolo in un universo parallelo.I Time Lord sanno di essere rinchiusi in un inframondo e intendono tornare all'universo madre. Iniziano così a diffondere in tutto lo spazio e il tempo il messaggio "Doctor who?" A questa domanda solo il Dottore (che è l'unico Time Lord ancora presente nell'universo principale) può rispondere, per questo i Time Lord sanno che quando riceveranno risposta sarà il momento di tornare.La formazione delle crepe nel tessuto della realtà (vedi sotto punto 8) permette ai Time Lord di inviare il loro messaggio nell'universo e attendere la risposta.Il Dottore dopo aver rivissuto gli eventi della Time War capisce che Gallifrey è intrappolato e inizia a cercarlo. Arriva quindi su Trenzalore dove trova una delle crepe da cui il messaggio Doctor who? si origina.Su Trenzalore sono arrivati anche tutte le altre razze, in particolare la Chiesa. Tutte queste vogliono impedire il ritorno dei Time Lord per evitare che la Time War riprenda, per questo tengono il pianeta sotto assedio e intimano al Dottore di non rispondere alla chiamata dei gallifreyani.Il Dottore fa una sorta di accordo con la Papessa, ma una corrente interna alla Chiesa non ci crede e decide di intervenire direttamente per evitare che il Dottore possa rispondere. A capo di questa sezione c'è Madame Kovarian (la signora con la benda sull'occhio della stagione 6).La Kovarian fonda la setta del Silenzio, mette su la sua squadra e torna indietro nel tempo per fermare il Dottore. Il suo piano iniziale è quello di imprigionare il Dottore e impedire che possa arrivare a Trenzalore per rispondere.Con il supporto degli altri suoi nemici il Silenzio crea la prigione Pandorica e il complotto che porta il Dottore a esservi imprigionato. Il piano però non funziona alla perfezione, e per liberare il Dottore River Song fa esplodere il Tardis, che crea le crepe nella realtà attraverso cui i Time Lord possono affacciarsi per lanciare il loro messaggio (vedi sopra punto 3).Come piano alternativo (visto che hanno fatto pegio che meglio) il Silenzio decide di uccidere il Dottore, per farlo rapisce e "programma" Rivers Song. Il Dottore viene ufficialmente ucciso (per quello che ne sanno loro) nel 2011 (primo episodio della stagione 6).Il Dottore in realtà è sopravvissuto e può così arrivare a Trenzalore, dove sostiene l'assedio fino all'ultimo minuto, quando Clara chiede l'intervento dei Time Lord per salvarlo, e loro gli concedno la rigenerazione.A questo punto in effetti non è chiarissimo se i Time Lord hanno deciso subito di uscire o se ne sono rimasti nel loro universo ancora un po', sta di fatto che senza che nessuno ci facesse caso sono tornati visto che alla fine della nona stagione il Dottore raggiunge Gallifrey.Il percorso è un po' ingarbugliato perché come sempre stiamo parlando di eventi passati e futuri che si influenzano a vicenda, per cui le azioni compiute dalla setta che vuole impedire l'arrivo del Dottore sono quelli che permettono in primo lugo che i Time Lord lo chiamino, e così via. Ma questo è il solito wibbly-wobbly a cui gli spettatori di Doctor Who sono avvezzi.

Non dico che la storia sia perfettamente coerente e progettata fin dall'inizio. Probabilmente molti elementi sono stati fatti combaciare solo a posteriori, e in questo senso un esempio perfetto è il frammento dell'episodio The God Complex, in cui il Dottore visita la stanza che dovrebbe contenere la sua più grande paura. In quel momento non viene mostrato cosa contiene, ma in The Time of the Doctor vediamo che era la solita crepa nel tessuto della realtà. Dubito proprio che all'epoca questo fosse già stato previsto, probabilmente la scena era rimasta ambigua proprio per permettere in seguito di ricollegarsi con qualunque cosa potesse servire.
Ma, al di là della completezza o anche della bontà di questa storia, non si può negare che un tentativo di unificare (se pur a posteriori) in un unico arco narrativo tutto il percorso dell'Undicesimo Dottore è stato fatto. Rivedendo le sue prime stagioni con il senno di poi è un esercizio interessante, che conferisce una prospettiva diversa su alcuni aspetti.
Published on July 02, 2016 06:00
June 29, 2016
Coppi Night 26/06/2016 - Quo vado?
È risaputo che non sono appassionato di cinepanettoni (se ancora questo termine è in uso), ma nemmeno li considero come il male primario della società. Se uno vuole pagare il biglietto del cinema per vedersi due ore di gaffe e battute in dialetto e muatnde di pizzo, bon, faccia pure. Certo bisogna avere il buon senso di riconoscere che si sta guardando una stronzata, e chi fa questi i film dovrebbe avere il buon gusto di ammettere che sta facendo soltanto una stronzata, senza presentarsi qua e là con le varie marchette come se il suo fosse un cinema sperimentale.
 Da qualche anno però al cinepanettone si oppone il fenomeno Checco Zalone, coi suoi filmetti meno beceri e più profondi, il new black che mette d'accordo critica e pubblico. Ecco la rivoluzione del cinema italiano, le buone idee sviluppate come solo i leali apprendisti della commedia dell'arte possono fare!
Da qualche anno però al cinepanettone si oppone il fenomeno Checco Zalone, coi suoi filmetti meno beceri e più profondi, il new black che mette d'accordo critica e pubblico. Ecco la rivoluzione del cinema italiano, le buone idee sviluppate come solo i leali apprendisti della commedia dell'arte possono fare!
Ma anche no. Degli altri film di Zalone ho visto solo il primo (molto distrattamente, era qualcosa come il 26 agosto e stavo cercando di addormentarmi sul divano prima di squagliarmi del tutto), e l'avevo trovato scialbo a banalotto, ma potenzialmente gradevole per chi apprezza questo genere di comicità. Quo vado? però mi sembra tutt'altra storia.
Prima di tutto perché è appunto una storia sconclusionata, squilibrata, strutturalmente sgraziata, che inizia con il protagonista che narra la propria storia, segue prima un tema, se ne dimentica e ne acchiappa un altro, torna a quello precedente, ne sovrappone un altro, lo lascia in sospeso, contraddice quanto detto prima, riparte da quello iniziale, contraddice pure quello, e a quel punto non ti sforzi nemmeno più di capire cosa vorrebbe dire. Quindi, se uno ti chiede "di che parla questo film?" non puoi rispondere davvero dicendo "è la storia di questo tizio col posto statale", perché buona parte della storia non è questo, ma nemmeno "è la storia di questo tizio che va a vivere in Norvegia", perché anche questo è meno di metà film, anche se sembra la parte centrale e più importante della storia, e così via.
Ma la cosa più irritante, è che questo film cerca così forzatamente di introdurre "temi importanti" da risultare stucchevole e indigesto. Come quando hai un amico che fa yoga e cerca di infilare in tutti i discorsi qualche riferimento allo yoga anche quando non c'entra nulla per farti capire quanto lui è illuminato e spingerti a chiedergli di parlarne ancora e illuminare anche te. Questa iniezione forzata di mulculturalità, autodeterminazione sessuale, senso di civiltà, fino anche all'ambientalismo Melevisione level (sapevate che il krill è la base dell'ecosistema artico????). Santiddio, ma si pensa davvero di potersi atteggiare così da furbetti, con quel distacco radical chic che finge di sporcarsi le mani ma mantiene in realtà le distanze da tutto questo, perché queste sono cose che voi popolo bove dovete capire, sono importanti, e io ora ve lo insegno così perché non sapreste seguire le slide in power point.
Ma a quanto pare funziona davvero così, perché questo film è stato salutato come la novità, la freschezza, il nuovo corso, e ha fatto anche uno sbotto di soldi. Tre-quattro risate le ho pure fatto, lo ammetto, per qualche battuta piazzata al momento giusto, ma tutto il resto è così leziosamente ipocrita che mi fa quasi rimpiangere l'onestà intellettuale di quei cinepanettoni che dicevamo all'inizio. E se arrivo a parlare di onestà intellettuale parlando di Carlo Vanzina e similari, capite la misura della mia disperazione.
 Da qualche anno però al cinepanettone si oppone il fenomeno Checco Zalone, coi suoi filmetti meno beceri e più profondi, il new black che mette d'accordo critica e pubblico. Ecco la rivoluzione del cinema italiano, le buone idee sviluppate come solo i leali apprendisti della commedia dell'arte possono fare!
Da qualche anno però al cinepanettone si oppone il fenomeno Checco Zalone, coi suoi filmetti meno beceri e più profondi, il new black che mette d'accordo critica e pubblico. Ecco la rivoluzione del cinema italiano, le buone idee sviluppate come solo i leali apprendisti della commedia dell'arte possono fare!Ma anche no. Degli altri film di Zalone ho visto solo il primo (molto distrattamente, era qualcosa come il 26 agosto e stavo cercando di addormentarmi sul divano prima di squagliarmi del tutto), e l'avevo trovato scialbo a banalotto, ma potenzialmente gradevole per chi apprezza questo genere di comicità. Quo vado? però mi sembra tutt'altra storia.
Prima di tutto perché è appunto una storia sconclusionata, squilibrata, strutturalmente sgraziata, che inizia con il protagonista che narra la propria storia, segue prima un tema, se ne dimentica e ne acchiappa un altro, torna a quello precedente, ne sovrappone un altro, lo lascia in sospeso, contraddice quanto detto prima, riparte da quello iniziale, contraddice pure quello, e a quel punto non ti sforzi nemmeno più di capire cosa vorrebbe dire. Quindi, se uno ti chiede "di che parla questo film?" non puoi rispondere davvero dicendo "è la storia di questo tizio col posto statale", perché buona parte della storia non è questo, ma nemmeno "è la storia di questo tizio che va a vivere in Norvegia", perché anche questo è meno di metà film, anche se sembra la parte centrale e più importante della storia, e così via.
Ma la cosa più irritante, è che questo film cerca così forzatamente di introdurre "temi importanti" da risultare stucchevole e indigesto. Come quando hai un amico che fa yoga e cerca di infilare in tutti i discorsi qualche riferimento allo yoga anche quando non c'entra nulla per farti capire quanto lui è illuminato e spingerti a chiedergli di parlarne ancora e illuminare anche te. Questa iniezione forzata di mulculturalità, autodeterminazione sessuale, senso di civiltà, fino anche all'ambientalismo Melevisione level (sapevate che il krill è la base dell'ecosistema artico????). Santiddio, ma si pensa davvero di potersi atteggiare così da furbetti, con quel distacco radical chic che finge di sporcarsi le mani ma mantiene in realtà le distanze da tutto questo, perché queste sono cose che voi popolo bove dovete capire, sono importanti, e io ora ve lo insegno così perché non sapreste seguire le slide in power point.
Ma a quanto pare funziona davvero così, perché questo film è stato salutato come la novità, la freschezza, il nuovo corso, e ha fatto anche uno sbotto di soldi. Tre-quattro risate le ho pure fatto, lo ammetto, per qualche battuta piazzata al momento giusto, ma tutto il resto è così leziosamente ipocrita che mi fa quasi rimpiangere l'onestà intellettuale di quei cinepanettoni che dicevamo all'inizio. E se arrivo a parlare di onestà intellettuale parlando di Carlo Vanzina e similari, capite la misura della mia disperazione.
Published on June 29, 2016 00:00
June 21, 2016
Coppi Night 19/06/2016 - Beetlejuice
A: non mi piace commentare i film che hanno una qualche rilevanza storica o hanno raggiunto col tempo lo status di cult, perché tanto non avrei niente da dire in più rispetto a quanto milioni di persone hanno già detto prima di me.B: non mi piacciono in generale i lavori di Tim Burton, trovo le tematiche ripetitive e l'estetica non mi convince.A + B = questo post avrà contenuti davvero scarsi.
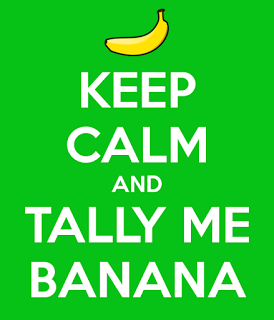 Avevo già visto Beetlejuice diversi anni fa (decenni, probabilmente), e se non altro ho potuto constatare che tutto sommato il film non è invecchiato male. La moda può essere cambiata (ma in fondo nemmeno tanto, per i personaggi stereotipati che compaiono), ma per il resto la struttura del film è ancora abbastanza moderna. Anche gli effetti speciali, basati su modellini e trucchi prospettici, non sono da buttare, e questo conferma l'impressione che questo tipo di effetti rimane valido, al di là della CGI che una volta superata appare ridicola.
Avevo già visto Beetlejuice diversi anni fa (decenni, probabilmente), e se non altro ho potuto constatare che tutto sommato il film non è invecchiato male. La moda può essere cambiata (ma in fondo nemmeno tanto, per i personaggi stereotipati che compaiono), ma per il resto la struttura del film è ancora abbastanza moderna. Anche gli effetti speciali, basati su modellini e trucchi prospettici, non sono da buttare, e questo conferma l'impressione che questo tipo di effetti rimane valido, al di là della CGI che una volta superata appare ridicola.
Alcune scene e sequenze rimangono simpatiche, come gli uffici dell'aldilà e il ballo durante la cena, ma nel complesso non posso dire di adorare questo film come sembra invece essere sentimento comune. Ma ricordando gli assiomi A e B, si capisce come mai non ho questo stesso amore viscerale.
Una cosa che però non è mai capita è il piano di Betelgeuse. Cioè, a quali regole/leggi universali risponde? Perché durante lo spot in tv può dire il suo nome, invitando a ripeterlo, e in seguito no? E perché è intrappolato nel plastico? E perché può intervenire solo quando lo chiamano ma si manifesta lo stesso nella casa e attacca i vivi? E perché inizialmente pronunciare il suo nome serve a evocarlo e nella scena finale invece quando lo chiamano invece di guadagnare ulteriore forza viene distratto? Insomma, mi pare che il personaggio a cui film deve il suo nome sia impossibile da comprendere, o che semplicemente si astato scritto senza una coerenza precisa (vedi assioma B).
Ma forse a tutte queste domande rimaste taciute per trent'anni risponderà il sequel attualmente in produzione. Il che non è comunque una motivazione sufficiente a invogliarmi a vederlo.
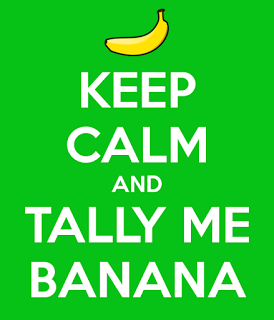 Avevo già visto Beetlejuice diversi anni fa (decenni, probabilmente), e se non altro ho potuto constatare che tutto sommato il film non è invecchiato male. La moda può essere cambiata (ma in fondo nemmeno tanto, per i personaggi stereotipati che compaiono), ma per il resto la struttura del film è ancora abbastanza moderna. Anche gli effetti speciali, basati su modellini e trucchi prospettici, non sono da buttare, e questo conferma l'impressione che questo tipo di effetti rimane valido, al di là della CGI che una volta superata appare ridicola.
Avevo già visto Beetlejuice diversi anni fa (decenni, probabilmente), e se non altro ho potuto constatare che tutto sommato il film non è invecchiato male. La moda può essere cambiata (ma in fondo nemmeno tanto, per i personaggi stereotipati che compaiono), ma per il resto la struttura del film è ancora abbastanza moderna. Anche gli effetti speciali, basati su modellini e trucchi prospettici, non sono da buttare, e questo conferma l'impressione che questo tipo di effetti rimane valido, al di là della CGI che una volta superata appare ridicola.Alcune scene e sequenze rimangono simpatiche, come gli uffici dell'aldilà e il ballo durante la cena, ma nel complesso non posso dire di adorare questo film come sembra invece essere sentimento comune. Ma ricordando gli assiomi A e B, si capisce come mai non ho questo stesso amore viscerale.
Una cosa che però non è mai capita è il piano di Betelgeuse. Cioè, a quali regole/leggi universali risponde? Perché durante lo spot in tv può dire il suo nome, invitando a ripeterlo, e in seguito no? E perché è intrappolato nel plastico? E perché può intervenire solo quando lo chiamano ma si manifesta lo stesso nella casa e attacca i vivi? E perché inizialmente pronunciare il suo nome serve a evocarlo e nella scena finale invece quando lo chiamano invece di guadagnare ulteriore forza viene distratto? Insomma, mi pare che il personaggio a cui film deve il suo nome sia impossibile da comprendere, o che semplicemente si astato scritto senza una coerenza precisa (vedi assioma B).
Ma forse a tutte queste domande rimaste taciute per trent'anni risponderà il sequel attualmente in produzione. Il che non è comunque una motivazione sufficiente a invogliarmi a vederlo.
Published on June 21, 2016 23:20
June 18, 2016
The Witness, o epiphany porn
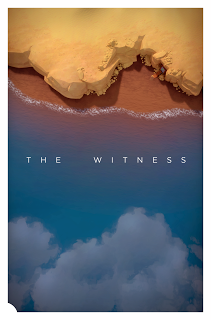 Tempo fa ho parlato sul blog di
Braid
, il videogioco puzzle-platform di manipolazione temporale sviluppato da Jonathan Blow e uscito nel 2008. Nonostante un'accoglienza fredda, col tempo Braid si è affermato come uno dei giochi "indie" di maggior successo, abbastanza da poter permettere a Blow di dedicarsi alla creazione di un nuovo gioco. Quel gioco è
The Witness
, annunciato inizialmente per il 2011 ma uscito alla fine a gennaio 2016. Sette anni di lavoro durante i quali Blow ha messo su un piccolo team di collaboratori e investito circa cinque milioni di dollari (in pratica tutto quanto ricavato da Braid) per poter dichiarere il nuovo gioco pronto. Dopo l'esperienza straordinaria di Braid sapevo già che avrei provato anche questo, e a distanza di qualche mese dall'uscita e dopo settimane di permanenza sull'isola, sono pronto.
Tempo fa ho parlato sul blog di
Braid
, il videogioco puzzle-platform di manipolazione temporale sviluppato da Jonathan Blow e uscito nel 2008. Nonostante un'accoglienza fredda, col tempo Braid si è affermato come uno dei giochi "indie" di maggior successo, abbastanza da poter permettere a Blow di dedicarsi alla creazione di un nuovo gioco. Quel gioco è
The Witness
, annunciato inizialmente per il 2011 ma uscito alla fine a gennaio 2016. Sette anni di lavoro durante i quali Blow ha messo su un piccolo team di collaboratori e investito circa cinque milioni di dollari (in pratica tutto quanto ricavato da Braid) per poter dichiarere il nuovo gioco pronto. Dopo l'esperienza straordinaria di Braid sapevo già che avrei provato anche questo, e a distanza di qualche mese dall'uscita e dopo settimane di permanenza sull'isola, sono pronto.The Witness è anch'esso un puzzle game. L'obiettivo del gioco è quello di risolvere una serie di enigmi, tutti basati sulla stessa meccanica: tracciare una linea da un punto di partenza a un punto di uscita su un pannello, soddisfacendo di volta in volta tutti i requisiti del puzzle. Il giocatore si muove con una visuale in prima persona all'interno di una vasta isola in 3D, passando da un ambiente all'altro e imbattendosi nei pannelli da risolvere. Tutto qui. Così semplice che la tagline del gioco è soltanto "Explore an abandoned island". The Witness si può considerare affine certi giochi puzzle-avventura come The Myst e il più recente The Talos Principle. Ma è anche molto di più.
La prima cosa che salta agli occhi giocando The Witness è la cura e ricchezza dell'ambientazione. L'isola è vasta e variegata, suddivisa in aree tra loro contigue ma caratterizzate da diversi biomi: spiaggia, roccia, deserto, giardino, foresta, giungla, palude, montagna, caverne. Ma non tutto è naturale, perché edifici e strutture si trovano praticamente ovunque: ci sono la città, il tempio, il castello, il monastero, il laboratorio, il porto. L'isola è davvero abbandonata, perché non ci sono altri personaggi, non ci sono in effetti tracce di vita esclusa l'abbondante e lussureggiante flora. Ma le costruzioni in cui ci si imbatte di continuo (molte delle quali in rovina) sembrano narrare la soria di un posto abitato per molto tempo e da culture diverse. Gli stessi pannelli su cui compaiono i puzzle sono inseriti coerentemente nell'ambiente, sempre installati sui supporti adeguati, con cavi di alimentazione che corrono da uno all'altro, in modo da far capire che non si tratta di elementi astratti ma concrete costruzioni che qualcuno ha posto lì. A tutto questo si aggiungono le statue: personaggi diversi tra loro, dal re seduto sul trono all'artista che dipinge, dall'agente della security al giocoliere. Se quindi ci troviamo in un'isola abbandonata, c'è anche la netta impressione che molta storia sia passata in questo luogo, e forse siamo arrivati troppo tardi per poterla vedere di persona. Il paragone con Lost viene quasi spontaneo, ma lo scopo di The Witness non è quello di nutrire i misteri. Anzi, è proprio l'opposto: lo scopo ultimo di tutto questo è la conoscenza.
 Uno degli aspetti più importanti di questo gioco è che non include nessun tipo di tutorial. Contrariamente a come siamo abituati, a parte un breve flash iniziale che illustra i tasti da usare per muoversi nell'ambiente, al giocatore non viene data nessuna indicazione. Questo può sembrare paradossale per un gioco che si basa sulla soluzione di puzzle, in cui ci si aspetterebbe che, almeno all'inizio, venisse insegnato quali sono le regole da seguire. The Witness non fa nessuno sforzo di questo tipo, limitandosi a fornire alcune sequenze di pannelli "illustrative", che il giocatore può completare in sequenza per cercare di determinare con le sue risorse le leggi da rispettare. Se all'inizio questo meccanismo può sembrare frustrante, soprattutto quando ci si accorge di aver interpretato male gli insegnamenti dei pannelli, col procedere del gioco ci si accorge che questo tipo di comunicazione è più efficace di qualunque istruzione fornita a parole. Nelle fasi più avanzate infatti si riesce quasi a riconoscere in modo subconscio quello che un pannello vuole dire, si capisce quando una regola deve essere applicata in maniera creativa, si intuisce già dal primo sguardo il modo in cui la soluzione deve essere cercata. Si tratta di un accumulo di conoscenze graduale e all'inizio impercettibile, ma che alla fine del gioco cambia completamente la prospettiva con cui si affronta l'esperienza, e la cosa diventa evidente se si inizia una nuova partita.
Uno degli aspetti più importanti di questo gioco è che non include nessun tipo di tutorial. Contrariamente a come siamo abituati, a parte un breve flash iniziale che illustra i tasti da usare per muoversi nell'ambiente, al giocatore non viene data nessuna indicazione. Questo può sembrare paradossale per un gioco che si basa sulla soluzione di puzzle, in cui ci si aspetterebbe che, almeno all'inizio, venisse insegnato quali sono le regole da seguire. The Witness non fa nessuno sforzo di questo tipo, limitandosi a fornire alcune sequenze di pannelli "illustrative", che il giocatore può completare in sequenza per cercare di determinare con le sue risorse le leggi da rispettare. Se all'inizio questo meccanismo può sembrare frustrante, soprattutto quando ci si accorge di aver interpretato male gli insegnamenti dei pannelli, col procedere del gioco ci si accorge che questo tipo di comunicazione è più efficace di qualunque istruzione fornita a parole. Nelle fasi più avanzate infatti si riesce quasi a riconoscere in modo subconscio quello che un pannello vuole dire, si capisce quando una regola deve essere applicata in maniera creativa, si intuisce già dal primo sguardo il modo in cui la soluzione deve essere cercata. Si tratta di un accumulo di conoscenze graduale e all'inizio impercettibile, ma che alla fine del gioco cambia completamente la prospettiva con cui si affronta l'esperienza, e la cosa diventa evidente se si inizia una nuova partita.Una delle critiche più spesso mosse a The Witness è che si tratta di un enorme mondo 3D in cui muoversi solo per risolvere dei puzzle in 2D. Insomma, tanto valeva far comparire i pannelli in sequenza uno dopo l'altro, no?
Beh, no. Perché l'ambiente svolge un ruolo fondamentale nella soluzione di molti enigmi. È vero che tutto quello che si può fare è tracciare linee (in effetti questo è l'unico modo in cui il giocatore può intergaire col mondo), ma ciò che circonda il pannello è spesso determinante per capire non solo come risolvere il puzzle, ma anche che effetto questo comporta. L'esempio più immediato è quello dei cavi di alimentazione, che si accendono una volta risolto un pannello. Seguendoli (in un senso o nell'altro) si può capire dove bisogna dirigersi per procedere, oppure cosa è richiesto per poter avanzare. In realtà l'esplorazione dell'isola è molto libera, e sono poche le zone davvero inaccessibili, anche se può capitare di imbattersi troppo presto in un'area che non si è ancora pronti a risolvere, perché contiene puzzle che non abbiamo ancora imparato a risolvere. Oltre a questo, il mondo che circonda il giocatore è anche una continua fonte di sorprese, dagli ingegnosi trucchi prospettici per cui una macchia di arbusti può assumere forma umana, fino a quella cosa di cui non posso parlare perché è uno spoiler troppo forte e costituisce la più grande rivelazione di tutto il gioco. Ma credetemi, guardarsi intorno, ammirare la bellezza e la complessità dell'isola è parte integrante dell'esperienza di gioco, e anzi è la parte che ha richiesto la maggior parte dei sette anni di sviluppo.
Ok, ma di cosa parla questo gioco? Qual è la "storia" di The Witness? E chi è questo "testimone"?
Ecco, questo è un altro aspetto che è aperto ad interpretazione e che ha deluso molti giocatori. In termini molto generici un plot esiste, ma è davvero molto vago e anche difficile da raggiungere, perché si trova proprio in una di quelle parti dell'isola accessibile solo con un estremo sforzo di attenzione, che molti potrebbero non trovare mai. Ma anche con questi elementi alla mano, la storia risulta davvero effimera e non lineare, con forti componenti metanarrative, qualcosa che non si può raccontare in modo chiaro. E che, in ultima analisi, non riveste un'importanza determinante. Quindi non dovete imbarcarvi in The Witness in cerca della risoluzione dei misteri dell'isola, non dovete aspettarvi di scoprire cosa ci fanno quelle statue, e chi è che ha installato i pannelli e perché c'è un laser che esce fuori da un tempio sotterraneo e punta alla cima di una montagna.
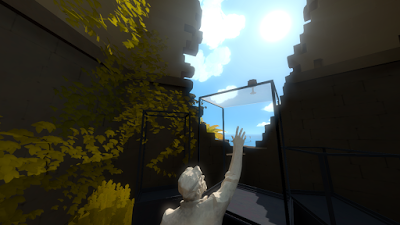 Quello che abbonda in The Witness sono invece gli spunti di riflessione. All'interno del gioco sono infatti sparse diverse decine di registrazioni audio, che raccolgono citazioni di scienziati, filosofi, poeti, mistici, oltre a sei filmati (proiettati in un'apposita sala cinematografica) anch'essi tratti da documentari o conferenze di personaggi come Richard Feynman e Gangaji. Alcuni sono molto lunghi (anche un'ora di durata), ma sono essenziali per trasmettere chiave interpretativa del gioco. Forse il più rivelatore è la clip tratta dal film Nostalghia di Trakovskij, in cui il protagonista cerca di attraversare uno stagno (la piscina di Santa Caterina) con una candela accesa in mano. I suoi sforzi per compiere nel modo giusto un'azione di per sé completamente inutile sono perfettamente in linea con quelli compiuti dal giocatore, e, come viene detto da Feynman in uno degli altri filmati, veicola un perfetto esempio di come un'opera d'arte (Jonathan Blow è convinto che i videogiochi dovrebbero essere equiparati a una forma d'arte) dica molto più su chi l'ha creata che sul mondo esterno. A questo proposito consiglio di guardare questo ottimo video che spiega in modo eccellente la questione, ma attenzione, fatelo solo dopo aver completato e ricominciato il gioco almeno una volta per non incorrere in spoiler. Queste citazioni sembrano illustrare approcci tra loro opposti e in alcuni casi sono in aperta contraddizione: scienza contro religione, ragione contro misticismo, ricerca contro inuito. Eppure, trovarsi con questi spunti nel corso di un gioco che, per sua natura, invita proprio a cercare risposte in modo sempre diverso, si viene colpiti più in profondità, e si arriva a comprendere che forse la strada che si percorre non è poi così importante, purché se ne possa trarre un insegnamento.
Quello che abbonda in The Witness sono invece gli spunti di riflessione. All'interno del gioco sono infatti sparse diverse decine di registrazioni audio, che raccolgono citazioni di scienziati, filosofi, poeti, mistici, oltre a sei filmati (proiettati in un'apposita sala cinematografica) anch'essi tratti da documentari o conferenze di personaggi come Richard Feynman e Gangaji. Alcuni sono molto lunghi (anche un'ora di durata), ma sono essenziali per trasmettere chiave interpretativa del gioco. Forse il più rivelatore è la clip tratta dal film Nostalghia di Trakovskij, in cui il protagonista cerca di attraversare uno stagno (la piscina di Santa Caterina) con una candela accesa in mano. I suoi sforzi per compiere nel modo giusto un'azione di per sé completamente inutile sono perfettamente in linea con quelli compiuti dal giocatore, e, come viene detto da Feynman in uno degli altri filmati, veicola un perfetto esempio di come un'opera d'arte (Jonathan Blow è convinto che i videogiochi dovrebbero essere equiparati a una forma d'arte) dica molto più su chi l'ha creata che sul mondo esterno. A questo proposito consiglio di guardare questo ottimo video che spiega in modo eccellente la questione, ma attenzione, fatelo solo dopo aver completato e ricominciato il gioco almeno una volta per non incorrere in spoiler. Queste citazioni sembrano illustrare approcci tra loro opposti e in alcuni casi sono in aperta contraddizione: scienza contro religione, ragione contro misticismo, ricerca contro inuito. Eppure, trovarsi con questi spunti nel corso di un gioco che, per sua natura, invita proprio a cercare risposte in modo sempre diverso, si viene colpiti più in profondità, e si arriva a comprendere che forse la strada che si percorre non è poi così importante, purché se ne possa trarre un insegnamento.Quindi, considerando tutto questo, che cos'è The Witness? Volendo sintetizzare al massimo, si tratta di epiphany porn . Blow voleva qualcosa che mettesse il giocatore nelle condizioni di ottenere una serie quasi programmata di epifanie, termine con il quale si intende il momento in cui qualcosa di precedentemente oscuro si rivela in modo spontaneo come conosciuto e naturale. Questo avviene in primo luogo con i puzzle, ma non solo, e ci sono almeno tre-quattro epifanie davvero eccezionali che valgono da sole tutto il tempo trascorso sull'isola. È anche un gioco che insegna e incoraggia a cambiare prospettiva, in senso letterale e metaforico, e a osservare con attezione ciò che ci circonda. Questo effetto è così forte che straripa al di fuori del gioco, e come tutti affermano, porta a guardare anche il "mondo reale" in modo diverso, alla ricerca di schemi e connessioni che abbiamo imparato a riconoscere o intuire a colpo d'occhio. Infine, come già valeva per Braid è anche un gioco sull'ossessione, sulla necessità di trovare un senso e uno scopo a qualunque cosa. Sembra paradossale, per un gioco che spinge a osservare attentamente ogni particolare al limite della pareidolia, ma questa autoironia non è casuale e non è la prima volta che viene espressa da Blow. In effetti non c'è nemmeno modo di sapere se il gioco è stato finito al 100%, perché non ci sono indizi che rivelano se tutto quello che c'era da trovare è stato trovato, cosa che ha fatto imbestialire i gamer completazionisti.
The Witness comunque non è un gioco per tutti. Non per una questione di intelligenza: molto banalmente, se non siete portati ai puzzle, o se vi annoiano, allora lasciate perdere, perché non troverete soddisfazione. Non potrebbe essere altrimenti per una raccolta di più di 600 puzzle, con un tempo medio di gioco di 80 ore... e si parla solo del tempo effettivo in-game, perché state sicuri che passarete molte altre ore a fare schemi, note, ritagliare pezzetti di carta, disegnare e cancellare linee con la matita. È un gioco che può essere molto frustrante, ma enormemente più soddisfacente. A volte ci si può trovare nel vicolo cieco di un puzzle di cui abbiamo capito male il concetto di base (mi è capitato due volte, ed è davvero terribile), ma anche in quel caso non bisogna disperare. Con il suo ambiente aperto, The Witness invita ad andare altrove, godersi i colori saturi dell'isola e provare altro, o smettere del tutto di cercare, come dice uno dei guru dei filmati. Tutti i puzzle sono risolvibili, con le sole regole fornite all'interno del gioco, senza bisogno di ricorrere ad aiuti esterni di nessun tipo. Con pazienza, tempo e serenità, si può arrivare alla fine (o alle fini) da soli, e godere di tutte le epifanie che Blow ha voluto mettere a disposizione.

The Witness per ora è disponibile solo su PC e PS4 (è previsto che venga rilasciato in seguito anche per altre piattaforme, ma ci vorrà ancora tempo) acquistabile su Steam e Humble Store. Non costa poco, per essere un gioco indipendente, ma vista la durata e intensità dell'esperienza, merita la spesa. Soprattutto sapendo che quei 36 € saranno usati per la realizzazione del prossimo gioco di Jonathan Blow.
Published on June 18, 2016 09:06
June 16, 2016
Coppi Night 12/06/2016 - The Lobster
Sapevo che mi sarei trovato davanti a un film strano, ma non avevo bene la percezione di quanto "strano" potesse essere. The Lobster, preso molto alla lontana, si potrebbe considerare una distopia: un mondo in cui tutte le persone (o almeno gli adulti) sono obbligati ad avere un partner, e se non riescono a trovarlo, sono condannati a essere trasformati in animali. In un mondo del genere, venire lasciati dal compagno può comportare guai seri, perché chi è da solo può essere arrestato e diventare una bestia.
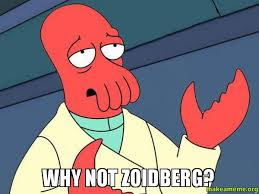 È da questa situazione che parte il protagonista, che dopo essere stato abbandonato dalla moglie viene forzatamente invitato in uno speciale centro per single, dove appunto chi è solo può cercare un partner con cui formare una coppia stabile, il tutto nel tempo massimo di qualche settimana, dopodiché scatta la trasformazione. Questa specie di resort è un posto bizzarro con regole assurde, che cerca di indottrinare al meglio i suoi occupanti sui vantaggi della vita di coppia, ed è solo trovando un compagno che se ne può uscire in forma umana.
È da questa situazione che parte il protagonista, che dopo essere stato abbandonato dalla moglie viene forzatamente invitato in uno speciale centro per single, dove appunto chi è solo può cercare un partner con cui formare una coppia stabile, il tutto nel tempo massimo di qualche settimana, dopodiché scatta la trasformazione. Questa specie di resort è un posto bizzarro con regole assurde, che cerca di indottrinare al meglio i suoi occupanti sui vantaggi della vita di coppia, ed è solo trovando un compagno che se ne può uscire in forma umana.
Ma il protagonisa (la cui storia viene inizialmente narrata in terza persona da una voce femminile di cui si scoprirà l'identità solo in seguito) riesce invece a fuggire, e dal centro per coppie finisce nel gruppo di rivoluzionari che perseguono invece la vita solitaria. Qui le regole sono opposte: ogni tentativo di approccio è punito, e l'obiettivo del gruppo è proprio quello di sferrare un attacco all'albergo per single.
The Lobster è un film che procede lentamente, si prende tutto il tempo per le sue scene, ma risulta comunque scorrevole. Le situazioni surreali che si presentano di volta in volta suscitano più di un sorriso, ma al tempo stesso non si può dire che si tratti di una commedia o una parodia. In realtà, sotto il livello superficiale di assurdo, si può scorgere un messaggio piuttosto forte, qualcosa che ha a che fare con l'autodeterminazione e l'affermazione di se stessi. È embleatico infatti che il gruppo ribelle che si oppone all'ordine costituito sia a sua volta incasellato in regole precise e inderogabili, che rendono la vita dei solitari tanto schematica quanto quella delle coppie. Viene allora da pensare che il tentativo di imporre una visione, qualunque essa sia, di attribuire cateogire ed etichette alle persone (ma soprattutto, a se stessi) sia uno sforzo vano e in ultima analisi comunque limitante.
Alla luce di questa interpretazione (che è la mia, e può benissimo essere contestata) assume un senso agrodolce anche la scena finale, in cui vediamo di nuovo il protagonista in procinto di compiere l'ennesima assurdità per potersi sentire "parte di qualcosa". E allora ci si può chiedere se è davvero l'amore quello che cerchiamo, o soltanto l'affermazione la propria identità attraverso ciò che gli altri percepiscono di noi.
Forse ci ho voluto leggere fin troppo, ma penso che The Lobster sia volutamente ambiguo e aperto a interpretazioni diverse, e quando un film, pur non dicendo qualcosa di esplicito e univoco, riesce comunque a evocare certe riflessioni nello spettatore, allora è un'opera compiuta.
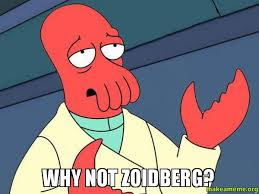 È da questa situazione che parte il protagonista, che dopo essere stato abbandonato dalla moglie viene forzatamente invitato in uno speciale centro per single, dove appunto chi è solo può cercare un partner con cui formare una coppia stabile, il tutto nel tempo massimo di qualche settimana, dopodiché scatta la trasformazione. Questa specie di resort è un posto bizzarro con regole assurde, che cerca di indottrinare al meglio i suoi occupanti sui vantaggi della vita di coppia, ed è solo trovando un compagno che se ne può uscire in forma umana.
È da questa situazione che parte il protagonista, che dopo essere stato abbandonato dalla moglie viene forzatamente invitato in uno speciale centro per single, dove appunto chi è solo può cercare un partner con cui formare una coppia stabile, il tutto nel tempo massimo di qualche settimana, dopodiché scatta la trasformazione. Questa specie di resort è un posto bizzarro con regole assurde, che cerca di indottrinare al meglio i suoi occupanti sui vantaggi della vita di coppia, ed è solo trovando un compagno che se ne può uscire in forma umana.Ma il protagonisa (la cui storia viene inizialmente narrata in terza persona da una voce femminile di cui si scoprirà l'identità solo in seguito) riesce invece a fuggire, e dal centro per coppie finisce nel gruppo di rivoluzionari che perseguono invece la vita solitaria. Qui le regole sono opposte: ogni tentativo di approccio è punito, e l'obiettivo del gruppo è proprio quello di sferrare un attacco all'albergo per single.
The Lobster è un film che procede lentamente, si prende tutto il tempo per le sue scene, ma risulta comunque scorrevole. Le situazioni surreali che si presentano di volta in volta suscitano più di un sorriso, ma al tempo stesso non si può dire che si tratti di una commedia o una parodia. In realtà, sotto il livello superficiale di assurdo, si può scorgere un messaggio piuttosto forte, qualcosa che ha a che fare con l'autodeterminazione e l'affermazione di se stessi. È embleatico infatti che il gruppo ribelle che si oppone all'ordine costituito sia a sua volta incasellato in regole precise e inderogabili, che rendono la vita dei solitari tanto schematica quanto quella delle coppie. Viene allora da pensare che il tentativo di imporre una visione, qualunque essa sia, di attribuire cateogire ed etichette alle persone (ma soprattutto, a se stessi) sia uno sforzo vano e in ultima analisi comunque limitante.
Alla luce di questa interpretazione (che è la mia, e può benissimo essere contestata) assume un senso agrodolce anche la scena finale, in cui vediamo di nuovo il protagonista in procinto di compiere l'ennesima assurdità per potersi sentire "parte di qualcosa". E allora ci si può chiedere se è davvero l'amore quello che cerchiamo, o soltanto l'affermazione la propria identità attraverso ciò che gli altri percepiscono di noi.
Forse ci ho voluto leggere fin troppo, ma penso che The Lobster sia volutamente ambiguo e aperto a interpretazioni diverse, e quando un film, pur non dicendo qualcosa di esplicito e univoco, riesce comunque a evocare certe riflessioni nello spettatore, allora è un'opera compiuta.
Published on June 16, 2016 03:40
June 11, 2016
Coppi Night 05/06/2016 - Zombeavers
Questa settimana presentiamo un altro eminente membro del club "b-movie con creature random zombificate che attaccano ragazzi arrapati". Non voglio essere frainteso, io apprezzo una puttanata con mostri animati peggio di Dodò dell'Albero Azzurro come chiunque altro, però credo che qualcuno si sia fatto trascinare un filino oltre in questa corsa alle armi del ridicolo.
 Non c'è molto da dire sulla trama di questo film, solito gruppo di ragazzi (tre uomini, tre donne, accoppiati tra loro) che se ne va a passare il weekend nella casa nel bosco, si preoccupa principalmente di bere e copulare, fino a quando non si presenta la minaccia, nello specifico castori zombie che devono la loro condizione di non-morti assetati di sange a una contaminazione con non specificate sostanze tossiche riversate nel loro habitat. Mezz'ora di battute sul sesso, primo topless e presentazione di personaggi di contorno, e poi via al macello. Tutto come da libro di testo di Splatterologia 101.
Non c'è molto da dire sulla trama di questo film, solito gruppo di ragazzi (tre uomini, tre donne, accoppiati tra loro) che se ne va a passare il weekend nella casa nel bosco, si preoccupa principalmente di bere e copulare, fino a quando non si presenta la minaccia, nello specifico castori zombie che devono la loro condizione di non-morti assetati di sange a una contaminazione con non specificate sostanze tossiche riversate nel loro habitat. Mezz'ora di battute sul sesso, primo topless e presentazione di personaggi di contorno, e poi via al macello. Tutto come da libro di testo di Splatterologia 101.
Il fatto è che visto un castoro zombie aperto a metà che cerca di azzannarti la vagina, visti tutti. La continua riproposizione di situazioni di pericolo non alza di un minio la tensione, e per quanto è chiaro che l'obiettivo di un film del genere non sia spaventare ma divertire, nemmeno questo funziona, se non in un paio di occasioni, perché appunto le situazioni che si presentano sono sempre le solite. C'è poi il problema di focus piuttosto frequente in questo tipo di film, per cui non si capisce chi sia il protagonista della storia. L'ultimo sopravvissuto della mattanza infatti risulta abbastanza imprevedibile, ma non nell'acceione di "sorprendente", quanto "non ha senso che sia questo ad arrivare alla fine". Sappiamo tutti che Game of Thrones ci ha abituati al valar morghulis, tutti devono morire e non è detto che chi sembra il protagonista riesca davvero a sopravvivere. Ma in una storia del genere c'è bisogno di un punto di riferimento, un protagonista con cui lo spettatore possa identificarsi anche in maniera minima, e che rappresenti quindi il centro della vicenda. Altrimenti, si parla di una sceneggiatura scritta seguendo il lancio di dadi, cosa che non mi sento di escludere.
Nemmeno la parte umoristica riesce a reggere il resto, e vorrei sapere chi è che nel 2016 ride ancora per la ragazza che parla di sesso con la signora anziana, soprattutto se non ci sono sotto le risate registrate a suggerirti "oh, guarda che questo era divertente!!!" C'è anche qualche conflitto tra i ragazzi per via di tradimenti e promiscuità varia, per cui almeno una mezz'ora di film è spesa in discussioni tra di loro su chi ha scopato chi e perché, ma seriamente, chissenfrega!?
Insomma, se anche qualche scena è gradevole, decisamente non è un film che possa sostenere l'interesse per 80 minuti, fosse stato un corto di metà della durata ne avrebbe guadagnato sensibilmente.
 Non c'è molto da dire sulla trama di questo film, solito gruppo di ragazzi (tre uomini, tre donne, accoppiati tra loro) che se ne va a passare il weekend nella casa nel bosco, si preoccupa principalmente di bere e copulare, fino a quando non si presenta la minaccia, nello specifico castori zombie che devono la loro condizione di non-morti assetati di sange a una contaminazione con non specificate sostanze tossiche riversate nel loro habitat. Mezz'ora di battute sul sesso, primo topless e presentazione di personaggi di contorno, e poi via al macello. Tutto come da libro di testo di Splatterologia 101.
Non c'è molto da dire sulla trama di questo film, solito gruppo di ragazzi (tre uomini, tre donne, accoppiati tra loro) che se ne va a passare il weekend nella casa nel bosco, si preoccupa principalmente di bere e copulare, fino a quando non si presenta la minaccia, nello specifico castori zombie che devono la loro condizione di non-morti assetati di sange a una contaminazione con non specificate sostanze tossiche riversate nel loro habitat. Mezz'ora di battute sul sesso, primo topless e presentazione di personaggi di contorno, e poi via al macello. Tutto come da libro di testo di Splatterologia 101.Il fatto è che visto un castoro zombie aperto a metà che cerca di azzannarti la vagina, visti tutti. La continua riproposizione di situazioni di pericolo non alza di un minio la tensione, e per quanto è chiaro che l'obiettivo di un film del genere non sia spaventare ma divertire, nemmeno questo funziona, se non in un paio di occasioni, perché appunto le situazioni che si presentano sono sempre le solite. C'è poi il problema di focus piuttosto frequente in questo tipo di film, per cui non si capisce chi sia il protagonista della storia. L'ultimo sopravvissuto della mattanza infatti risulta abbastanza imprevedibile, ma non nell'acceione di "sorprendente", quanto "non ha senso che sia questo ad arrivare alla fine". Sappiamo tutti che Game of Thrones ci ha abituati al valar morghulis, tutti devono morire e non è detto che chi sembra il protagonista riesca davvero a sopravvivere. Ma in una storia del genere c'è bisogno di un punto di riferimento, un protagonista con cui lo spettatore possa identificarsi anche in maniera minima, e che rappresenti quindi il centro della vicenda. Altrimenti, si parla di una sceneggiatura scritta seguendo il lancio di dadi, cosa che non mi sento di escludere.
Nemmeno la parte umoristica riesce a reggere il resto, e vorrei sapere chi è che nel 2016 ride ancora per la ragazza che parla di sesso con la signora anziana, soprattutto se non ci sono sotto le risate registrate a suggerirti "oh, guarda che questo era divertente!!!" C'è anche qualche conflitto tra i ragazzi per via di tradimenti e promiscuità varia, per cui almeno una mezz'ora di film è spesa in discussioni tra di loro su chi ha scopato chi e perché, ma seriamente, chissenfrega!?
Insomma, se anche qualche scena è gradevole, decisamente non è un film che possa sostenere l'interesse per 80 minuti, fosse stato un corto di metà della durata ne avrebbe guadagnato sensibilmente.
Published on June 11, 2016 01:25
June 7, 2016
Rapporto letture - Maggio 2016
Prima di iniziare il rapporto letture vero e proprio devo fare una rettifica. Anzi, devo proprio ammettere di essere un cretino: infatti nel rapporto di aprile elencavo la lettura di 3 libri, glissando completamente sul fatto che pochi giorni prima avevo ampiamente commentato Real Mars di Alessandro Vietti, e quindi ho evidentemente letto anche questo nel corso dle mese. Si tratta di una banale dimenticanza, certo, in realtà c'è anche una ragione più profonda per questa svista, ovvero il fatto che non riesco più a usare stabilmente anobii per tenere traccia delle mie letture, un po' perché il portale funziona così di merda che mi leva di sentimento, un po' perché molte delle cose che leggo (soprattutto in digitale) non sono lì indicizzate e non posso stare a inserire le schede ogni volta. Quindi sta capitando, ultimamente, che quando devo riprendere i testi letti nel mese precedente devo praticamente afidarmi alla memoria. E no, non è per niente affidabile.
A questo putno, avendo parlato del romanzo in un post dedicato, non mi metto ad aggiungere il minicommento al libro di Vietti, e rimando direttamente a quel post. Chiarito questo, passiamo alle letture completate a maggio. Almeno per quel che mi ricordo.
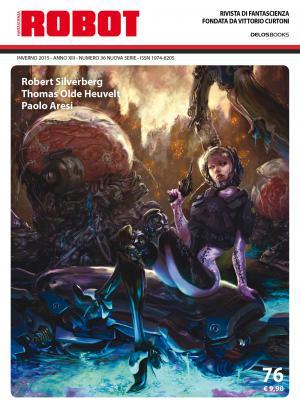 Il primo è il numero 76 di Robot, come sempre letto con qualche mese di ritardo. Il volume contiene un paio di racconti interessanti, dal primo di Thomas Olde Heuvelt, il primo non-anglofono vincitore del Premio Hugo per la categoria racconti, con una storia più surreale che di fantascienza, ma con un sottotesto profondamente umano. Anche il romanzo breve di Robert Silverberg in chiusura, un'ucronia piuttosto complessa, delinea un contesto affascinante, nonostante l'intera storia sia una serie di intrighi politici. Buono anche il racconto di Massimo Soumaré, anche se trovo un po' penalizzante la scelta piuttosto ricorrente negli ultimi numeri della rivista di dare così tanto spazio a reinterpetazioni degli universi narrativi di altri autori: Kareena infatti è ambientato sullo stesso Mondo9 di Dario Tonani, così come molti altri racconti presentati in precedenza su Robot, così come sempre sul numero 76 si trovano una ventina di brevi racconti ambientati nel mondo di Trainvile di Alain Voudì, che ho dovuto saltare visto che finora ho letto solo la prima parte e non voglio spoilerarmi. Insomma, capisco la volontà di puntare sulle saghe di successo degli autori di casa nostra, ma in questo modo chi segue Robot si trova un po' la mano forzata a riprendere questi testi. Comunque la qualtià complessiva è buona, alcuni articoli interessanti altri non dicono niente di nuovo, ma ci si può stare. Voto: 7/10
Il primo è il numero 76 di Robot, come sempre letto con qualche mese di ritardo. Il volume contiene un paio di racconti interessanti, dal primo di Thomas Olde Heuvelt, il primo non-anglofono vincitore del Premio Hugo per la categoria racconti, con una storia più surreale che di fantascienza, ma con un sottotesto profondamente umano. Anche il romanzo breve di Robert Silverberg in chiusura, un'ucronia piuttosto complessa, delinea un contesto affascinante, nonostante l'intera storia sia una serie di intrighi politici. Buono anche il racconto di Massimo Soumaré, anche se trovo un po' penalizzante la scelta piuttosto ricorrente negli ultimi numeri della rivista di dare così tanto spazio a reinterpetazioni degli universi narrativi di altri autori: Kareena infatti è ambientato sullo stesso Mondo9 di Dario Tonani, così come molti altri racconti presentati in precedenza su Robot, così come sempre sul numero 76 si trovano una ventina di brevi racconti ambientati nel mondo di Trainvile di Alain Voudì, che ho dovuto saltare visto che finora ho letto solo la prima parte e non voglio spoilerarmi. Insomma, capisco la volontà di puntare sulle saghe di successo degli autori di casa nostra, ma in questo modo chi segue Robot si trova un po' la mano forzata a riprendere questi testi. Comunque la qualtià complessiva è buona, alcuni articoli interessanti altri non dicono niente di nuovo, ma ci si può stare. Voto: 7/10
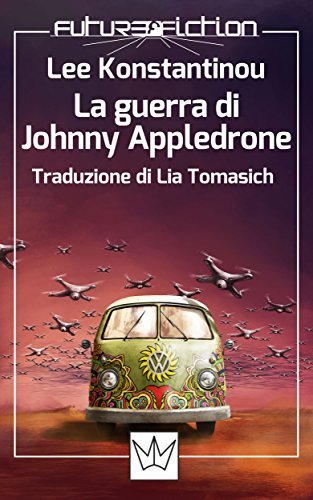 Altro romanzo breve della collana Future Fiction (da cui ormai attingo con frequenza) è La guerra di Johnny Appledrone, di Lee Konstantinou. Una storia di un futuro vicinissimo, dove un giovane disoccupato il cui migliore amico è l'assistente animato nel portale di ricerca lavoro (che lo incoraggia ad accettare qualunque tipo di occupazione anche non retribuita) finisce a lavorare per le pubbliche relazioni del mitologico personaggio del titolo. Johnny Appledrone è un guru dronepunk, che si occupa di costruire e programmare droni liberi dal sistema di controllo governativo, cercando così di avviare la sua piccola rivoluzione. Il protagonista non condivide né comprende in pieno le sue motivazioni, ma nella sua posizione si trova a dover sostenere e promuovere la sua battaglia, e finisce per essere uno degli ultimi testimoni della sua opera. Il racconto è leggero, ma riesce a toccare una serie di temi estremamente attuali, di cui forse dovremmo davvero iniziare a preoccuparci. Voto: 7.5/10
Altro romanzo breve della collana Future Fiction (da cui ormai attingo con frequenza) è La guerra di Johnny Appledrone, di Lee Konstantinou. Una storia di un futuro vicinissimo, dove un giovane disoccupato il cui migliore amico è l'assistente animato nel portale di ricerca lavoro (che lo incoraggia ad accettare qualunque tipo di occupazione anche non retribuita) finisce a lavorare per le pubbliche relazioni del mitologico personaggio del titolo. Johnny Appledrone è un guru dronepunk, che si occupa di costruire e programmare droni liberi dal sistema di controllo governativo, cercando così di avviare la sua piccola rivoluzione. Il protagonista non condivide né comprende in pieno le sue motivazioni, ma nella sua posizione si trova a dover sostenere e promuovere la sua battaglia, e finisce per essere uno degli ultimi testimoni della sua opera. Il racconto è leggero, ma riesce a toccare una serie di temi estremamente attuali, di cui forse dovremmo davvero iniziare a preoccuparci. Voto: 7.5/10
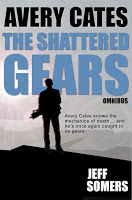 Infine, come avevo promesso un paio di mesi fa, ho recuperato il resto dei racconti di Avery Cates pubblicati nei mesi scorsi da Jeff Somers. Ho adorato la serie di Avery Cates, e scoprendo che l'autore aveva ripreso a scrivere in quell'ambientazione mi ha esaltato. Somers ha pubblicato 6 racconti in digitale, in seguito raccolti in
The Shattered Gears Omnibus
. La storia procede direttamente dopo l'ultimo romanzo The Final Evolution, anche se a distanza di qualche anno (non si sa quanto), nel mondo postapocalittico in cui gli ultimi rimasugli di umanità cercando di darsi un ordine per il poco che gli rimane da vivere prima dell'estinzione. In tutto questo, Avery Cates si trova di nuovo a essere coinvolto in giochi di potere che per qualche ragione vedono in lui un elemento chiave. E siame alle solite fughe, sparatorie, evasioni, e fucking fuck fucker ogni tre parole. Le storie di questa serie sono terribilmente divertenti da leggere, cariche di umorismo pulp, nichilismo, e tanta sana violenza. Il tutto in un mondo popolato di androidi, monaci elettrici, telecinetici, precog e ogni altra sorta di pacchianata vi possa venire in mente. Chiaramente, l'omnibus non conclude la storia, anzi si chiude con una (prevedibile) sorpresa finale, quindi non rimane che aspettare il seguito. Voto: 7/10
Infine, come avevo promesso un paio di mesi fa, ho recuperato il resto dei racconti di Avery Cates pubblicati nei mesi scorsi da Jeff Somers. Ho adorato la serie di Avery Cates, e scoprendo che l'autore aveva ripreso a scrivere in quell'ambientazione mi ha esaltato. Somers ha pubblicato 6 racconti in digitale, in seguito raccolti in
The Shattered Gears Omnibus
. La storia procede direttamente dopo l'ultimo romanzo The Final Evolution, anche se a distanza di qualche anno (non si sa quanto), nel mondo postapocalittico in cui gli ultimi rimasugli di umanità cercando di darsi un ordine per il poco che gli rimane da vivere prima dell'estinzione. In tutto questo, Avery Cates si trova di nuovo a essere coinvolto in giochi di potere che per qualche ragione vedono in lui un elemento chiave. E siame alle solite fughe, sparatorie, evasioni, e fucking fuck fucker ogni tre parole. Le storie di questa serie sono terribilmente divertenti da leggere, cariche di umorismo pulp, nichilismo, e tanta sana violenza. Il tutto in un mondo popolato di androidi, monaci elettrici, telecinetici, precog e ogni altra sorta di pacchianata vi possa venire in mente. Chiaramente, l'omnibus non conclude la storia, anzi si chiude con una (prevedibile) sorpresa finale, quindi non rimane che aspettare il seguito. Voto: 7/10
A questo putno, avendo parlato del romanzo in un post dedicato, non mi metto ad aggiungere il minicommento al libro di Vietti, e rimando direttamente a quel post. Chiarito questo, passiamo alle letture completate a maggio. Almeno per quel che mi ricordo.
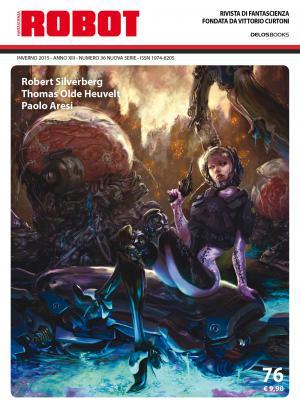 Il primo è il numero 76 di Robot, come sempre letto con qualche mese di ritardo. Il volume contiene un paio di racconti interessanti, dal primo di Thomas Olde Heuvelt, il primo non-anglofono vincitore del Premio Hugo per la categoria racconti, con una storia più surreale che di fantascienza, ma con un sottotesto profondamente umano. Anche il romanzo breve di Robert Silverberg in chiusura, un'ucronia piuttosto complessa, delinea un contesto affascinante, nonostante l'intera storia sia una serie di intrighi politici. Buono anche il racconto di Massimo Soumaré, anche se trovo un po' penalizzante la scelta piuttosto ricorrente negli ultimi numeri della rivista di dare così tanto spazio a reinterpetazioni degli universi narrativi di altri autori: Kareena infatti è ambientato sullo stesso Mondo9 di Dario Tonani, così come molti altri racconti presentati in precedenza su Robot, così come sempre sul numero 76 si trovano una ventina di brevi racconti ambientati nel mondo di Trainvile di Alain Voudì, che ho dovuto saltare visto che finora ho letto solo la prima parte e non voglio spoilerarmi. Insomma, capisco la volontà di puntare sulle saghe di successo degli autori di casa nostra, ma in questo modo chi segue Robot si trova un po' la mano forzata a riprendere questi testi. Comunque la qualtià complessiva è buona, alcuni articoli interessanti altri non dicono niente di nuovo, ma ci si può stare. Voto: 7/10
Il primo è il numero 76 di Robot, come sempre letto con qualche mese di ritardo. Il volume contiene un paio di racconti interessanti, dal primo di Thomas Olde Heuvelt, il primo non-anglofono vincitore del Premio Hugo per la categoria racconti, con una storia più surreale che di fantascienza, ma con un sottotesto profondamente umano. Anche il romanzo breve di Robert Silverberg in chiusura, un'ucronia piuttosto complessa, delinea un contesto affascinante, nonostante l'intera storia sia una serie di intrighi politici. Buono anche il racconto di Massimo Soumaré, anche se trovo un po' penalizzante la scelta piuttosto ricorrente negli ultimi numeri della rivista di dare così tanto spazio a reinterpetazioni degli universi narrativi di altri autori: Kareena infatti è ambientato sullo stesso Mondo9 di Dario Tonani, così come molti altri racconti presentati in precedenza su Robot, così come sempre sul numero 76 si trovano una ventina di brevi racconti ambientati nel mondo di Trainvile di Alain Voudì, che ho dovuto saltare visto che finora ho letto solo la prima parte e non voglio spoilerarmi. Insomma, capisco la volontà di puntare sulle saghe di successo degli autori di casa nostra, ma in questo modo chi segue Robot si trova un po' la mano forzata a riprendere questi testi. Comunque la qualtià complessiva è buona, alcuni articoli interessanti altri non dicono niente di nuovo, ma ci si può stare. Voto: 7/10 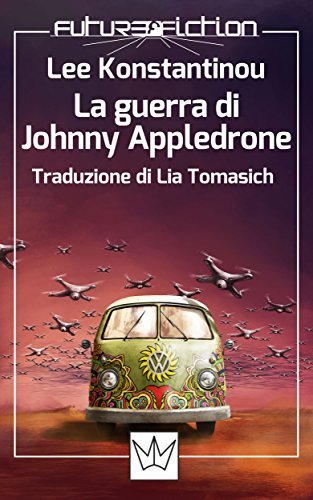 Altro romanzo breve della collana Future Fiction (da cui ormai attingo con frequenza) è La guerra di Johnny Appledrone, di Lee Konstantinou. Una storia di un futuro vicinissimo, dove un giovane disoccupato il cui migliore amico è l'assistente animato nel portale di ricerca lavoro (che lo incoraggia ad accettare qualunque tipo di occupazione anche non retribuita) finisce a lavorare per le pubbliche relazioni del mitologico personaggio del titolo. Johnny Appledrone è un guru dronepunk, che si occupa di costruire e programmare droni liberi dal sistema di controllo governativo, cercando così di avviare la sua piccola rivoluzione. Il protagonista non condivide né comprende in pieno le sue motivazioni, ma nella sua posizione si trova a dover sostenere e promuovere la sua battaglia, e finisce per essere uno degli ultimi testimoni della sua opera. Il racconto è leggero, ma riesce a toccare una serie di temi estremamente attuali, di cui forse dovremmo davvero iniziare a preoccuparci. Voto: 7.5/10
Altro romanzo breve della collana Future Fiction (da cui ormai attingo con frequenza) è La guerra di Johnny Appledrone, di Lee Konstantinou. Una storia di un futuro vicinissimo, dove un giovane disoccupato il cui migliore amico è l'assistente animato nel portale di ricerca lavoro (che lo incoraggia ad accettare qualunque tipo di occupazione anche non retribuita) finisce a lavorare per le pubbliche relazioni del mitologico personaggio del titolo. Johnny Appledrone è un guru dronepunk, che si occupa di costruire e programmare droni liberi dal sistema di controllo governativo, cercando così di avviare la sua piccola rivoluzione. Il protagonista non condivide né comprende in pieno le sue motivazioni, ma nella sua posizione si trova a dover sostenere e promuovere la sua battaglia, e finisce per essere uno degli ultimi testimoni della sua opera. Il racconto è leggero, ma riesce a toccare una serie di temi estremamente attuali, di cui forse dovremmo davvero iniziare a preoccuparci. Voto: 7.5/10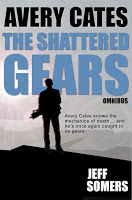 Infine, come avevo promesso un paio di mesi fa, ho recuperato il resto dei racconti di Avery Cates pubblicati nei mesi scorsi da Jeff Somers. Ho adorato la serie di Avery Cates, e scoprendo che l'autore aveva ripreso a scrivere in quell'ambientazione mi ha esaltato. Somers ha pubblicato 6 racconti in digitale, in seguito raccolti in
The Shattered Gears Omnibus
. La storia procede direttamente dopo l'ultimo romanzo The Final Evolution, anche se a distanza di qualche anno (non si sa quanto), nel mondo postapocalittico in cui gli ultimi rimasugli di umanità cercando di darsi un ordine per il poco che gli rimane da vivere prima dell'estinzione. In tutto questo, Avery Cates si trova di nuovo a essere coinvolto in giochi di potere che per qualche ragione vedono in lui un elemento chiave. E siame alle solite fughe, sparatorie, evasioni, e fucking fuck fucker ogni tre parole. Le storie di questa serie sono terribilmente divertenti da leggere, cariche di umorismo pulp, nichilismo, e tanta sana violenza. Il tutto in un mondo popolato di androidi, monaci elettrici, telecinetici, precog e ogni altra sorta di pacchianata vi possa venire in mente. Chiaramente, l'omnibus non conclude la storia, anzi si chiude con una (prevedibile) sorpresa finale, quindi non rimane che aspettare il seguito. Voto: 7/10
Infine, come avevo promesso un paio di mesi fa, ho recuperato il resto dei racconti di Avery Cates pubblicati nei mesi scorsi da Jeff Somers. Ho adorato la serie di Avery Cates, e scoprendo che l'autore aveva ripreso a scrivere in quell'ambientazione mi ha esaltato. Somers ha pubblicato 6 racconti in digitale, in seguito raccolti in
The Shattered Gears Omnibus
. La storia procede direttamente dopo l'ultimo romanzo The Final Evolution, anche se a distanza di qualche anno (non si sa quanto), nel mondo postapocalittico in cui gli ultimi rimasugli di umanità cercando di darsi un ordine per il poco che gli rimane da vivere prima dell'estinzione. In tutto questo, Avery Cates si trova di nuovo a essere coinvolto in giochi di potere che per qualche ragione vedono in lui un elemento chiave. E siame alle solite fughe, sparatorie, evasioni, e fucking fuck fucker ogni tre parole. Le storie di questa serie sono terribilmente divertenti da leggere, cariche di umorismo pulp, nichilismo, e tanta sana violenza. Il tutto in un mondo popolato di androidi, monaci elettrici, telecinetici, precog e ogni altra sorta di pacchianata vi possa venire in mente. Chiaramente, l'omnibus non conclude la storia, anzi si chiude con una (prevedibile) sorpresa finale, quindi non rimane che aspettare il seguito. Voto: 7/10
Published on June 07, 2016 00:51
June 4, 2016
Coppi Night 29/05/2016 - Castaway on the Moon
Scorrete velocemente la pagina delle recensioni e troverete pochi titoli del cinema orientale. C'è un abbastanza recente Battle Royale ma a parte questo non me ne vengono proprio altri in mente. In effetti come mi è capitato di affermare altre volte, è un tipo di cinema che non riesco a comprendere a pieno, sicuramente per lacune mie. Infatti anche il film qui presente credo che lo avrei difficilmente visto, se non mi fosse stato volutamente regalato per avvicinarmi al settore. Quindi mi ci sono avvicinato con tutto lo scetticismo del caso, pensando che sì, può darsi sia un ottimo film, ma è pur sempre un film coreano e io non è che li capisca del tutto, quindi magari rimarrò insoddisfatto. Invece, mi sono dovuto ricredere un po' su tutta la linea.
 Il film inizia come una sorta di parodia del più famoso Castaway, con la sottile differenza che il naufrago è rimasto intrappolato su un piccolo isolotto sul fiume che scorre nel mezzo della città (una qualche megalopoli coreana, non so bene quale sia). L'incidente occorre in seguito a un tentativo di suicidio, che si conclude con il tragicomico naufragio sull'isola a poche centinaia di metri dalla civiltà ma completamente isolata da essa. Inizialmente seguiamo i tentativi di sopravvivenza del protagonista, che sulle prime cerca il modo di ritornare al punto di partenza (solo per tornare a suicidarsi), ma poi viene a pace con la situazione e con se stesso, e comincia a provare piacere per quella noia totalizzante che lo assale.
Il film inizia come una sorta di parodia del più famoso Castaway, con la sottile differenza che il naufrago è rimasto intrappolato su un piccolo isolotto sul fiume che scorre nel mezzo della città (una qualche megalopoli coreana, non so bene quale sia). L'incidente occorre in seguito a un tentativo di suicidio, che si conclude con il tragicomico naufragio sull'isola a poche centinaia di metri dalla civiltà ma completamente isolata da essa. Inizialmente seguiamo i tentativi di sopravvivenza del protagonista, che sulle prime cerca il modo di ritornare al punto di partenza (solo per tornare a suicidarsi), ma poi viene a pace con la situazione e con se stesso, e comincia a provare piacere per quella noia totalizzante che lo assale.
Interviene poi una svolta piuttosto brusca, con l'introduzione di un nuovo personaggio: una ragazza che vive isolata per sua scelta, conducendo decine di vite virtuali ma senza mai uscire di casa, o anche dalla sua stanza. La ragazza scopre per caso il naufrago sull'isolotto, avvistabile col telescopio dalla sua finestra, e inizia a seguirne le avventure, fino a decidere di volerlo contattare. Inizia così una lenta e scarna corrispondenza tra i due, che pure li porta a sviluppare un legame profondo.
Può sembrare una storia simpatica ma banalotta, i due amici di penna che si scrivono e si innamorano, ma non è questo. Non c'è mai traccia di un interesse romantico tra i due, tanto più che il naufrago fino alla fine non sa chi sia chi gli sta scrivendo. In realtà quella che vediamo svilupparsi è una relazione più istintiva, è la ricerca di un appiglio presso qualcuno di affine, qualcuno che condivide i tuoi stessi demoni (come ho letto da qualche parte). E quando il mondo irrompe a distruggere il precario equilibrio che si era creato in questa situazione paradossale, perché il mondo fa così, irrompe e distrugge sempre, allora è in quel momento che questo appiglio si rivela essenziale, e sono quegli ultimi tre secondi di film, quell'immagine semplice ma esplicita, a renderlo chiaro.
C'è anche una chiara componente satirica, una critica alla spersonalizzante società capitalistica contemporanea, che ti riempie di jingles che ti tornano in testa quando stai affogando o ti permette di creare un'identità completamente inventata sui social network. In effetti entrami i protagonisti vivono alle estreme conseguenze la disumanizzazione imposta da questo livello di civiltà, tuttavia la questa critica non è presentata in modo didascalico e pesante, e anche la contrapposizione città-natura non è così sbilanciata verso la seconda, perché in più di un'occasione il naufrago ha modo di approfittare delle opportunità che derivano dall'ambiente urbano.
Non so se Castaway on the Moon sia un film più "occidentale" rispetto agli standard del cinema asiatico, e quindi se è questo che mi ha permesso di capirlo e apprezzarlo di più, oppure se semplicemente affronti temi così universali da infrangere le barrire culturali. Per di più, nonostante la profondità di questi temi, è anche un film che riesce a essere leggero, alternando sequenze comiche e drammatiche, un film che riesce a farti affezionare a un'anatra che galleggia e farti commuovere per un piatto di noodles.
 Il film inizia come una sorta di parodia del più famoso Castaway, con la sottile differenza che il naufrago è rimasto intrappolato su un piccolo isolotto sul fiume che scorre nel mezzo della città (una qualche megalopoli coreana, non so bene quale sia). L'incidente occorre in seguito a un tentativo di suicidio, che si conclude con il tragicomico naufragio sull'isola a poche centinaia di metri dalla civiltà ma completamente isolata da essa. Inizialmente seguiamo i tentativi di sopravvivenza del protagonista, che sulle prime cerca il modo di ritornare al punto di partenza (solo per tornare a suicidarsi), ma poi viene a pace con la situazione e con se stesso, e comincia a provare piacere per quella noia totalizzante che lo assale.
Il film inizia come una sorta di parodia del più famoso Castaway, con la sottile differenza che il naufrago è rimasto intrappolato su un piccolo isolotto sul fiume che scorre nel mezzo della città (una qualche megalopoli coreana, non so bene quale sia). L'incidente occorre in seguito a un tentativo di suicidio, che si conclude con il tragicomico naufragio sull'isola a poche centinaia di metri dalla civiltà ma completamente isolata da essa. Inizialmente seguiamo i tentativi di sopravvivenza del protagonista, che sulle prime cerca il modo di ritornare al punto di partenza (solo per tornare a suicidarsi), ma poi viene a pace con la situazione e con se stesso, e comincia a provare piacere per quella noia totalizzante che lo assale.Interviene poi una svolta piuttosto brusca, con l'introduzione di un nuovo personaggio: una ragazza che vive isolata per sua scelta, conducendo decine di vite virtuali ma senza mai uscire di casa, o anche dalla sua stanza. La ragazza scopre per caso il naufrago sull'isolotto, avvistabile col telescopio dalla sua finestra, e inizia a seguirne le avventure, fino a decidere di volerlo contattare. Inizia così una lenta e scarna corrispondenza tra i due, che pure li porta a sviluppare un legame profondo.
Può sembrare una storia simpatica ma banalotta, i due amici di penna che si scrivono e si innamorano, ma non è questo. Non c'è mai traccia di un interesse romantico tra i due, tanto più che il naufrago fino alla fine non sa chi sia chi gli sta scrivendo. In realtà quella che vediamo svilupparsi è una relazione più istintiva, è la ricerca di un appiglio presso qualcuno di affine, qualcuno che condivide i tuoi stessi demoni (come ho letto da qualche parte). E quando il mondo irrompe a distruggere il precario equilibrio che si era creato in questa situazione paradossale, perché il mondo fa così, irrompe e distrugge sempre, allora è in quel momento che questo appiglio si rivela essenziale, e sono quegli ultimi tre secondi di film, quell'immagine semplice ma esplicita, a renderlo chiaro.
C'è anche una chiara componente satirica, una critica alla spersonalizzante società capitalistica contemporanea, che ti riempie di jingles che ti tornano in testa quando stai affogando o ti permette di creare un'identità completamente inventata sui social network. In effetti entrami i protagonisti vivono alle estreme conseguenze la disumanizzazione imposta da questo livello di civiltà, tuttavia la questa critica non è presentata in modo didascalico e pesante, e anche la contrapposizione città-natura non è così sbilanciata verso la seconda, perché in più di un'occasione il naufrago ha modo di approfittare delle opportunità che derivano dall'ambiente urbano.
Non so se Castaway on the Moon sia un film più "occidentale" rispetto agli standard del cinema asiatico, e quindi se è questo che mi ha permesso di capirlo e apprezzarlo di più, oppure se semplicemente affronti temi così universali da infrangere le barrire culturali. Per di più, nonostante la profondità di questi temi, è anche un film che riesce a essere leggero, alternando sequenze comiche e drammatiche, un film che riesce a farti affezionare a un'anatra che galleggia e farti commuovere per un piatto di noodles.
Published on June 04, 2016 03:23
Unknown to Millions
Il blog di Andrea Viscusi since 2010
Libri, fantascienza, serie tv, Futurama, Doctor Who
Libri, fantascienza, serie tv, Futurama, Doctor Who
- Andrea Viscusi's profile
- 81 followers



