Antonio Gallo's Blog: MEDIUM, page 52
August 3, 2023
Enheduana: principessa, sacerdotessa, poetessa dell’impermanenza
 Principessa, sacerdotessa, poetessa
Principessa, sacerdotessa, poetessa
Le poesie complete della sacerdotessa Enheduana, la prima autrice conosciuta al mondo, recentemente tradotte dall’originale sumerico. Enheduana fu un’alta sacerdotessa e principessa reale che visse a Ur, nell’attuale Iraq meridionale, intorno al 2300 a.C. Non solo Enheduana ha la particolarità di essere la prima autrice di cui conosciamo il nome, ma le poesie a lei attribuite sono inni di grande potenza. Sono un raro lampo della voce femminile nel mondo antico spesso dominato dagli uomini, trattando temi che sono rilevanti oggi come lo erano quattromila anni di esilio, disgregazione sociale, il potere della narrazione, identità di genere, la devastazione della guerra e le terrificanti forze della natura. Questo libro è la prima traduzione completa (in inglese) delle sue poesie dall’originale sumerico. Le traduzioni di Sophus Helle replicano l’intensità e le immagini degli inni originali, bombe a orologeria letterarie che sono rimaste sepolte per millenni. Oltre alle sue traduzioni, Helle fornisce informazioni sul contesto storico in cui le poesie di Enheduana furono composte e diffuse, la struttura letteraria ei temi delle opere e la loro ricezione sia nel mondo antico che in quello moderno. Ingiustamente dimenticate per millenni, le poesie di Enheduana sono una lettura essenziale per chiunque sia interessato alla storia letteraria delle donne, della religione, dell’ambiente, del genere, della maternità, della paternità e dell’impero. (Il libro)
Enheduana è la prima autrice conosciuta della storia. Fu una sacerdotessa sumera e i suoi componimenti poetici affrontano temi di conflitto e instabilità che risuonano anche nei nostri tempi incerti. Le sue opere includono inni e preghiere rivolte ai templi di Sumer e Akkad, come Eridu, Sippar ed Esnunna. Alcuni dei suoi componimenti più noti sono “L’inno a Inanna” e “Inninsagura”.
Enheduana è considerata una figura importante nella storia della letteratura e della poesia, e le sue opere sono state recentemente tradotte dall’originale sumero. La sua eredità poetica è un prezioso tesoro che ci permette di apprezzare la bellezza e la profondità delle sue parole anche oggi.
L’articolo che segue è stato scritto da uno studioso della Free University of Berlin e pubblicato sulla autorevole rivista digitale AEON, liberamente tradotta con l’aiuto di Google, in attesa di leggere il libro. Le traduzioni di Sophus Helle replicano l'intensità e l'immaginario delle poesie originali.
Il libro è stato pubblicato dalla Yale University Press ed è accompagnato da un sito Web, che include una traduzione letterale e un’analisi riga per riga del poema più noto di Enheduana, nonché collegamenti a ulteriori letture e risorse per saperne di più sul suo mondo.
Circa 4.200 anni fa, l’area che oggi chiamiamo Iraq meridionale fu scossa da rivolte. Le città stato sumere un tempo indipendenti erano state sottoposte a un unico governo dal leggendario re Sargon di Akkad.
Nel corso di quello che gli storici moderni chiamano il periodo antico accadico, il regno di Sargon e dei suoi successori rimodellò le città appena conquistate in innumerevoli modi: i vecchi nobili furono retrocessi e nuovi uomini portati al potere, i vecchi nemici furono sconfitti e nuovi standard di governo furono imposti.
Il mondo sumerico divenne molto più grande e ricco, ma anche più instabile. Il malcontento per il nuovo impero aumentò, provocando un flusso costante di rivolte mentre le città tentavano di riconquistare la loro indipendenza.
Una di queste rivolte è rappresentata in un affascinante poema noto come “L’esaltazione di Inana”. Oltre ad essere un capolavoro poetico a sé stante, “L’esaltazione” si distingue per essere la prima opera letteraria conosciuta che è stata attribuita a un autore che possiamo identificare nella documentazione storica, piuttosto che a una tradizione anonima o a un narratore immaginario . La narratrice del poema è Enheduana, l’alta sacerdotessa della città di Ur e figlia di Sargon. Secondo “The Exaltation”, fu gettata in esilio da una delle tante rivolte che afflissero l’antico impero accadico.
 Tavolette incise con L’esaltazione di Inana in tre parti. Antico periodo babilonese, c1750 a.C. Per gentile concessione della Yale Babylonian Collection
Tavolette incise con L’esaltazione di Inana in tre parti. Antico periodo babilonese, c1750 a.C. Per gentile concessione della Yale Babylonian CollectionNon sappiamo con certezza se il poema sia stato scritto dalla stessa Enheduana storica, come rivisitazione letteraria di un evento reale, o da un poeta successivo che scrive a suo nome, nella versione antica di un romanzo storico che doveva celebrare il famosa alta sacerdotessa. Quello che sappiamo è che la poesia trasmette il senso di come sarebbe stato vivere un periodo di profonda turbolenza, sia come racconto personale che come eco conservata nella memoria culturale di epoche successive.
Questo è uno dei motivi per cui le opere attribuite a Enheduana — che, oltre a ‘L’Esaltazione’, comprendono altri quattro poemi, continuano a parlarci, millenni dopo la loro composizione. Mentre il mondo diventa sempre più instabile, abbiamo molto da imparare da questa antica sacerdotessa. Le poesie non si limitano a registrare la realtà di uno sconvolgimento storico, vanno un ulteriore passo avanti trasformando quell’instabilità in un’intuizione cosmica, un’occasione per riflettere su com’è veramente il mondo. Contengono, compresso nei loro versi spesso criptici, il germe di un’antica filosofia del cambiamento.
Se le poesie cercano di trasformare il cambiamento radicale da un fenomeno politico transitorio in un principio universale, lo fanno principalmente esaltando la dea Inana, meglio conosciuta con il suo nome babilonese e assiro Ishtar. Due dei poemi attribuiti a Enheduana, “L’esaltazione” e “L’inno a Inana”, cercano di elevare Inana al vertice del pantheon sumerico, eclissando gli antichi dei maschi, Enlil e An, che governano il cosmo secondo la maggior parte degli altri Testi sumerici.
 Tavoletta incisa con l’Inno a Inana. Per gentile concessione del British Museum, Londra
Tavoletta incisa con l’Inno a Inana. Per gentile concessione del British Museum, LondraInana è spesso descritta come la divinità protettrice della guerra e dell’amore, e questo è probabilmente vero. Ma nelle poesie di Enheduana appare più precisamente come la dea del cambiamento. La distruzione della guerra e la passione dell’amore sono simili in quanto sono entrambe forze potenti che travolgono e trasformano le vite umane, ed è questo senso di spiazzamento che definisce Inana in tutte le sue manifestazioni. Per descrivere la forza di questo scuotimento, le poesie di Enheduana spesso richiamano metafore dal mondo naturale, come tempeste e animali selvatici. In “The Exaltation”, le viene detto:
Tu sei come
un’alluvione improvvisa che
sgorga lungo il
montagne …
Nel frattempo, “The Hymn” la descrive come un falco che piomba per nutrirsi di altri dei. Un’altra fonte comune di metafore in queste poesie è la guerra, ma questa non è la guerra come il parco giochi degli eroi che conosciamo dal genere epico. Per Enheduana, il campo di battaglia non è un luogo in cui gli uomini possono dimostrare la loro forza: gli umani appaiono nelle sue poesie non come agenti ma solo come vittime della guerra, come quando il poeta canta dei soldati che vengono portati via in catene
Mentre
il vento riempie il
piazze dove loro
ballato…
La guerra è raffigurata come una forza impersonale alimentata dalla
spietata volontà di Inana:
i portelli schiacciano le teste,
le lance mangiano carne, e
gli assi sono inzuppati
sangue …
Ma il selvaggio guerriero che riduce in polvere i teschi dei suoi nemici è solo uno dei personaggi di Inana. In altri testi, appare come una giovane ragazza innocente che si strugge per il suo amante, il dio pastore Dumuzi. Un’altra delle poesie attribuite a Enheduana si chiama “The Temple Hymns”, ed è una raccolta di 42 brevi odi agli dei, ai templi e alle città sumere. Qui troviamo due inni a Inana nella sua veste sensuale, come la dea del desiderio e del piacere corporeo, così come un inno a Inana nella sua veste di terrificante guerriera che “lava le sue armi per la battaglia”.
Questa scissione nella persona di Inana è chiaramente catturata nel pianeta che fungeva da suo segno nei cieli: Venere. Poiché è così vicino al Sole, Venere può essere vista dall’occhio umano solo poco prima dell’alba, quando sorge prima del Sole sull’orizzonte orientale, e al tramonto, quando indugia dietro al Sole sull’orizzonte occidentale. Non si può seguire il percorso del pianeta attraverso i cieli, solo osservarlo in queste due posizioni opposte: est e ovest, alba e tramonto. Quel senso di totale contraddizione è una perfetta metafora astronomica del carattere di Inana.
L’elogio inno di Inana è stato un luogo per riflettere sull’instabilità del periodo antico accadico per due motivi. Uno era politico. Inana era la divinità protettrice dell’impero di Sargon, quindi la devozione di Enheduana alla dea ha una chiara sfumatura politica: nell’elevare Inana, le poesie elevano anche implicitamente il regime imperiale che Inana si pensava sostenesse. L’altro ha a che fare con il carattere della dea. Proprio come Inana, il periodo antico accadico finì per essere associato nella cultura sumera e babilonese a continui sconvolgimenti e cambiamenti.
Non solo nelle poesie di Enheduana, ma attraverso una serie di altre fonti storiche, il periodo antico accadico è descritto come un periodo di leggende e drammi straordinari, non diversamente dal posto speciale occupato dalle incursioni vichinghe o dall’età d’oro della pirateria. nell’immaginario storico occidentale. Sargon e suo nipote Naram-Sîn, che salì al trono nel 2254 a.C. e portò l’impero al suo apice, furono ricordati per millenni come figure quasi mitiche: Sargon come esempio di potere, Naram-Sîn come despota arrogante che portò disastro sul suo popolo.
Queste raffigurazioni sono spesso respinte dagli storici moderni come la creazione di miti di periodi successivi, ma nessuno dubiterebbe che il periodo antico accadico sia stato un periodo di grandi cambiamenti. Dall’inizio del III millennio a.C., l’area che oggi è l’Iraq meridionale era stata punteggiata da dozzine di città-stato, ciascuna con la propria divinità locale, dialetto e amministrazione, e, sebbene le città facessero parte di una più ampia rete di commerci, conflitti e scambio culturale, sono rimasti staterelli separati.
Il re ha dovuto sopprimere nove rivolte in un solo anno. L’esercito di Sargon invase le città: Kish, Uruk, Eridu, Nippur, Larsa, Umma, Lagash, Girsu, Isin, Eshnunna, Sippar, Eresh e molte altre ancora. Nel secolo successivo, gli antichi re accadici lavorarono duramente per allineare le città, sopprimendo le differenze locali per stabilire uno standard amministrativo imperiale. I nobili che avevano governato le città per secoli furono sostituiti da nuove élite, tratte dall’esercito e spinte verso vette di potere precedentemente sconosciute.
Il mondo deve essersi sentito più grande che mai. I soldati delle pianure dell’Iraq si sono fatti strada nelle montagne della Turchia e dell’Iran, i commercianti hanno viaggiato fino all’Afghanistan per andare a prendere pietre preziose e l’arte del tempo mostra l’influenza degli stili egiziani. I porti di Ur avrebbero assistito all’arrivo di eccitanti merci esotiche come lapislazzuli, avorio, corniola, occhio di gatto, diaspro, diorite e serpentino.
E questi sono solo gli oggetti che sopravvivono nell’arca documentazione geologica. C’erano anche cibi, bevande, vestiti e profumi stranieri che i cittadini di Ur non avevano mai visto prima. L’afflusso di ricchezza e materiali a sua volta ha consentito importanti progressi nella tecnologia e nell’arte. L’esempio più noto di entrambi questi sviluppi è una statua in bronzo, tradizionalmente ritenuta raffigurante Sargon, che mostra vividamente la raffinatezza degli artisti di corte e l’abilità tecnica dei suoi fabbri.
 Maschera di Sargon di Akkad. Da Ninive, c2250 a.C. Per gentile concessione di Wikipedia
Maschera di Sargon di Akkad. Da Ninive, c2250 a.C. Per gentile concessione di WikipediaAi nuovi poteri piaceva particolarmente commissionare sigilli cilindrici, che erano usati come forma di identificazione personale, proprio come una firma oggi: si farebbe rotolare il proprio sigillo su un documento per firmarlo. Ma i sigilli divennero anche segni di prestigio, poiché i loro intricati motivi riflettevano lo status dei loro proprietari. Gli antichi scalpellini accadici furono spinti a soddisfare i loro nuovi mecenati: i sigilli di questo periodo sono minuscole, splendide opere di scultura.
The newly empowered especially liked to commission cylinder seals, which were used as a form of personal identification, much like a signature today: one would roll one’s seal over a document to sign it. But the seals also became markers of prestige, as their intricate patterns reflected the status of their owners. The Old Akkadian stonecutters were pushed hard to satisfy their new patrons: the seals of this period are tiny, gorgeous works of sculpture.
 Sigillo cilindrico accadico raffigurante la dea Inana che poggia il piede sul dorso di un leone, mentre Ninshubur si trova di fronte al suo omaggio, c2350–2150 aEV. Per gentile concessione di Wikipedia
Sigillo cilindrico accadico raffigurante la dea Inana che poggia il piede sul dorso di un leone, mentre Ninshubur si trova di fronte al suo omaggio, c2350–2150 aEV. Per gentile concessione di WikipediaMa tutto questo potere, ricchezza ed espressione artistica era strettamente concentrato intorno alla corte del re. L’insoddisfazione tra le vecchie élite era enorme, come dimostrano le continue rivolte del periodo. Questa resistenza raggiunse il culmine sotto Naram-Sîn, in quella che è conosciuta come la Grande Rivolta, quando il re dovette sopprimere nove rivolte in un solo anno. Facendolo con successo, Naram-Sîn si dichiarò un dio vivente — il primo re nell’antica storia del Vicino Oriente a farlo. Non c’è da stupirsi, quindi, che si sia guadagnato una reputazione di arroganza. I poeti successivi capovolgeranno la sua affermazione: la storia delle sue nove vittorie divenne la storia delle sue nove sconfitte.
Anche il regno di Naram-Sîn dovette fare i conti con una minaccia più lenta, ma alla fine più mortale. Il clima stava cambiando. Per ragioni che rimangono poco chiare ai geologi, gran parte del mondo ha attraversato una grave siccità in questo periodo, in quello che è noto come “evento di 4,2 chilometri” (ovvero un evento di natura incerta che si è verificato 4.200 anni fa). Qualunque sia la sua causa esatta, la siccità colpì particolarmente duramente l’antico impero accadico, causando carestie e ondate migratorie.
Alla fine, lo stato in difficoltà non ce la fece più: sotto il figlio di Naram-Sîn, Shar-kali-sharri, l’antico impero accadico crollò, lasciando dietro di sé una complessa eredità di leggende e cambiamenti. È una metafora perfetta per il posto del periodo nella storia che, durante questo periodo, i segni della scrittura cuneiforme ruotassero di 90 gradi in senso antiorario, diventando più astratti e più facili da scrivere. Anche la scrittura ha subito la sua rivoluzione letterale.
Possiamo solo immaginare cosa provasse un fabbro medio di Ur o un pastore di Akkad riguardo all’ascesa e alla caduta dell’Antico Impero accadico. Anche per le élite, le loro vite sono il più delle volte catturate solo da brevi istantanee, come i sigilli cilindrici che attestano la loro esistenza e poco altro. Questo fa parte dell’intrigo che si aggrappa alle poesie di Enheduana. “L’esaltazione” sembra offrire un resoconto personale del dramma politico del periodo antico accadico, raccontato dalla stessa figlia dell’imperatore. Enheduana non fu tanto un testimone oculare dell’insurrezione quanto l’occhio del suo ciclone.
Tuttavia, dobbiamo tenere presente che la poesia è, nella migliore delle ipotesi, una rielaborazione letteraria di un’esperienza reale (se è stata scritta dalla stessa Enheduana), e nella peggiore una ricostruzione da parte di scrittori molto successivi di come potrebbe essere stata la ribellione ( se è stato scritto da altri a suo nome). La storia delle nove vittorie di Naram-Sîn che furono trasformate in nove sconfitte dai poeti successivi dovrebbe ricordarci che la memoria culturale non è una guida affidabile per ciò che è realmente accaduto.
Tuttavia, le poesie sono chiaramente una risposta letteraria al periodo antico accadico, scritte nel bel mezzo di esso o come una successiva meditazione sulla sua eredità e, come notato, quell’eredità è durata per secoli. Sargon e Naram-Sîn erano ancora molto vivi nella memoria babilonese quando la cultura cuneiforme si estinse negli ultimi secoli a.C. Sarebbe sufficiente per renderli una fonte affascinante per comprendere questo periodo turbolento, ma direi che “The Exaltation” e “The Hymn” continuano a fare della turbolenza che stanno descrivendo il fondamento di un tipo specifico di intuizione cosmica.
Il cambiamento, anche catastrofico, è stata un’occasione per vedere il mondo più chiaramente. Di fronte a un disturbo sociale, si può scegliere di sopprimerlo intellettualmente, spiegandolo come una momentanea aberrazione di un ordine mondiale stabile, oppure trasformarlo nel fondamento di una nuova visione del mondo. Credo che, nelle poesie di Enheduana, si veda la strategia successiva perseguita con sorprendente insistenza: “L’esaltazione” e “L’inno” sono dedicati a una dea che lei ritrae come:
… un furioso,
inondare precipitosamente quello
attraversa il
terra e foglie
niente dietro.
Nel fare questa affermazione, mi ispiro al , il mito della creazione dei Maya K’iche’, che fu messo per iscritto intorno all’anno 1550, sulla scia dell’arrivo dei colonizzatori europei che portarono le popolazioni indigene nel sull’orlo dell’annientamento. In Emergency (2022), il suo affascinante studio sul Popol Vuh, il poeta e critico letterario Edgar Garcia mostra che, piuttosto che offrire una resistenza o una condanna della violenza occidentale, il testo sembra fare qualcosa di molto più sottile: ripiega l’esperienza del colonialismo in un ritmo cosmico di crisi e creazione, di emergenze che portano all’emergere di nuove possibilità.
La cataclismica trasformazione che i popoli maya subirono durante il XVI secolo è quindi inserita in un principio universale di ripetizioni e interruzioni che, per quanto possiamo dedurre dal Popol Vuh, già strutturava la visione del mondo K’iche’. Il cambiamento, anche quello catastrofico, non era visto come una minaccia concettuale da superare, ma come un’occasione per vedere il mondo più chiaramente. E lo stesso vale per le poesie di Enheduana.
Nell’elevare Inana, “The Hymn” fa due punti. Il primo è che Inana controlla tutto ciò che la circonda. Ciò è trasmesso da tre miti che il poema trasmette in un formato in miniatura. Racconta di come Inana abbia distrutto Ebih, una montagna che non ha rispettato; di come ha terrorizzato il dio An facendogli condividere il suo tempio; e di come ha cambiato il genere dei suoi devoti rituali, trasformando gli uomini in donne e le donne in uomini. Le persone, gli dei, persino il paesaggio: tutti sono soggetti ai poteri di trasformazione di Inana.
Il secondo punto è che Inana non è soggetta ad alcun controllo se non il suo. Come sottolinea ripetutamente la poesia, nessun ordine può essere imposto alle sue azioni:
Lei capovolge cosa
Lei ha finito; nessuno
può conoscere il suo corso.
Anche le sue compagne divinità non hanno alcuna speranza di prevedere le sue decisioni:
Lei confonde il
assemblea dei grandi
dei con i suoi consigli,
nessuno sa perché.
Il cambiamento emana verso l’esterno da Inana, ma lei stessa rimane intoccata dai tentativi degli altri di cambiarla. Stabiliti questi due punti, “The Hymn” si apre in una lunga litania che delinea gli attributi contraddittori di Inana:
Distruggere e
creare, piantare
e da strappare
sono tuoi, Inana
…
Trasformare i bruti
in deboli
e per fare il
piccolo potente
sono tuoi, Inana.
Per invertire i picchi
e pianure, per aumentare
su e da ridurre
sono tuoi, Inana
…
Per fare piccolo o
maestoso, debole o
enorme, da trattenere
e dare liberamente
sono tuoi, Inana.
Per conferire il
rituali dei re
e gli dei, per obbedire
e per ingannare,
parlare di calunnia,
mentire, ingannare,
e sopravvalutare
sono tuoi, Inana.
L’elenco continua per circa 60 righe, allungando le nostre menti con la sua lunghezza e molte contraddizioni per darci un’idea di come potrebbe essere una forza divina di costante cambiamento.
“The Hymn” e “The Exaltation” cercano di elevare Inana alla testa del pantheon, al di sopra dei tradizionali sovrani degli dei, An ed Enlil. Ma, così facendo, non stanno solo facendo un punto sulla religione, stanno anche facendo un’affermazione sulla cosmologia. Se il mondo è governato da questo tipo di dea, cosa ci dice del mondo? Cosa significherebbe vivere in un universo governato dall’incarnazione del capriccio, del conflitto, della contraddizione, del caos e della complessità?
Le poesie di Enheduana evocano un mondo di radicale impermanenza, in cui nulla intorno a noi — né le montagne all’orizzonte né i sessi dei nostri stessi corpi — può essere dato per scontato. In queste poesie, la confusione non è un’incapacità intellettuale di afferrare il mondo, ma una risposta adeguata al mondo così com’è realmente: se la figura di Inana dovrebbe ispirarci qualcosa, è l’umiltà intellettuale. La natura dell’universo non è né singola né prevedibile, poiché l’universo è governato da una dea che è essa stessa profondamente divisa e costantemente mutevole.
Molte religioni hanno cercato di rappresentare il regno dell’esperienza come una superficie mutevole oltre la quale giace una verità trascendente ed eterna in cui possiamo trovare conforto. Ma nessuna tale trascendenza o tranquillità mentale si trova nelle poesie attribuite a Enheduana. L’unica verità stabilita in “The Hymn” e “The Exaltation” è che il cambiamento, come personificato da Inana, è supremo. Vivere in questo mondo, secondo Enheduana, significa vivere con la consapevolezza che il futuro può differire radicalmente dal presente, proprio come il presente del periodo antico accadico differiva radicalmente dal suo passato.
Questa visione del mondo può sembrare ben lontana dal modo in cui per lo più gli diamo un senso nella nostra epoca moderna. Gli accademici di ogni genere sono uniti nella loro ricerca di regolarità che aiutino a spiegare il mondo che vediamo intorno a noi, dalle leggi chimiche attraverso i modelli psicologici ai sistemi sociali come il capitalismo o il patriarcato. In altre parole, quando cerchiamo di comprendere un dato fenomeno oggi, molto spesso lo facciamo esplorando le strutture che lo modellano, il che significa che il cambiamento e la confusione incarnati da Inana possono sembrare un modo piuttosto ingenuo di spiegare il mondo.
Ma ci sono segnali che i nostri tempi sempre più mutevoli incontrano un crescente interesse per il cambiamento come strategia per comprendere il mondo. Nel loro libro Impermanence (2022), un team di antropologi britannici, danesi e australiani promuove quella che vedono come una teoria emergente del flusso all’interno delle scienze sociali. Questo corpo di ricerca in erba trae ispirazione da filosofie non occidentali come il buddismo — che ha riflettuto sul significato del cambiamento e dell’impermanenza radicale per millenni — per riformulare argomenti familiari all’interno dell’antropologia e della sociologia.
La domanda che spinge quel libro, e il movimento accademico dietro di esso, può essere riassunta come segue: in che modo l’attenzione al cambiamento influenza la nostra percezione dei nostri oggetti di indagine? I fenomeni sociali (il libro esplora esempi come la migrazione, i musei e l’alcolismo) hanno un aspetto diverso quando sono visti come in uno stato di flusso continuo piuttosto che come determinati da strutture sociali semi-statiche?
Come si rimane sani di mente in un momento come questo? Come si vive in un momento come questo? Certo, una rondine non fa un’estate accademica. Ma, anche nella cultura popolare, si può rilevare un crescente interesse per le filosofie che basano esplicitamente la loro visione del mondo su costanti ccambiare. Un esempio chiave è lo stoicismo, che promuove il distacco e l’equanimità di fronte a un mondo che vede come incostante e caotico. Secondo Google Trends e Google Ngram — che tengono traccia delle menzioni di una determinata parola rispettivamente nelle ricerche di Google e nei testi caricati su Google Libri — l’interesse per lo stoicismo è in costante aumento, il che potrebbe indicare che le persone in tutto il mondo sentono un bisogno crescente per guide intellettuali a tempi turbolenti.
E chi può biasimarli? Sono cresciuti in quella che ora sembra una bolla storica di relativa calma. Il mondo occidentale intorno alla fine del millennio era sufficientemente libero da guerre, conflitti ideologici e pandemie globali perché gli esperti parlassero con sicurezza di un ordine mondiale duraturo. Francis Fukuyama ha dichiarato “la fine della storia” e, mentre ero dolorosamente consapevole delle ingiustizie che affliggevano gran parte del globo, almeno il mio angolo di esso si sentiva al sicuro.
Ora, avendo appena compiuto 30 anni, mi confronto con una realtà molto diversa. Davanti a me, davanti a noi, giacciono le catastrofi della crisi climatica e gli sconvolgimenti sociali necessari per ridurre le emissioni e adattarsi alle condizioni meteorologiche estreme. Poi c’è il COVID-19, che è improbabile che sia l’ultima pandemia globale di questo secolo, poiché non sono state messe in atto misure serie per prevenire il ripetersi di malattie simili. Poi c’è la guerra in Ucraina, e la turbolenza economica che ha portato; e le divisioni in corso che affliggono le democrazie occidentali e sembrano approfondirsi ogni anno che passa. E così via. L’elenco è familiare, quasi cliché, ma ogni voce contiene vero orrore.
Entro la fine della mia vita, è estremamente probabile che il mondo sembri ancora più instabile di quanto non sia oggi. Collettivamente, avremo attraversato un periodo di trasformazione che non ha eguali nella storia umana. Non so come sentirmi al riguardo, perché non è il genere di cose per cui sono stato educato a sentirmi in alcun modo. Come si rimane sani di mente in un momento come questo? Come si vive in un momento come questo?
Enheduana non offre risposte chiare a queste domande e non la considererei un modello per vivere bene in tempi difficili. Ma le sue poesie mi affascinano in parte perché descrivono, con intensità abbagliante, un mondo in cui il cambiamento è la norma. Queste sono poesie di e su tempi instabili. Questo è uno dei motivi per cui sono attratto da loro: voglio capire cosa significa vivere in un mondo del genere, perché probabilmente dovrò farlo.
Originally published at https://aeon.co/essays/ancient-sumerian-poetry-turns-instability-into-cosmic-insight
[image error]July 29, 2023
“Niente che sia oro dura”
 Foto@angallo
Foto@angalloSe c’è una cosa di cui tutti abbiamo paura, questa cosa è il cambiamento. Una parola che fa venire i brividi, causa tensione ed apprensione. Tutti vorremmo, forse, che le cose restassero così come sono. Vorremmo continuare a godere di ciò che abbiamo conquistato e ben conosciamo.
Ho detto forse, perché a molti, invece, piacerebbe cambiare sempre, sostituire il presente con il futuro. Altri vorrebbero prolungare il passato nel presente. Resta il fatto che niente resta. Anche se sembra che tutti amiamo e rincorriamo le novità.
La verità è che tutti abbiamo paura del nuovo, dell’avventura del domani che ci aspetta, del futuro che ci dobbiamo inventare. C’è una bellissima poesia del poeta americano Robert Frost che focalizza in poche parole la sua attenzione su questo concetto.
Otto semplici versi per esprimere questa idea e trasmettere a chi legge la sua angoscia. Ve la propongo in lingua inglese seguita dalla versione in lingua italiana. E’ inutile che io dica che ogni traduzione è un tradimento.
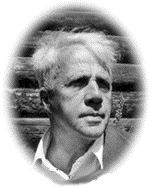
Nothing Gold Can Stay/Nature’s first green is gold,/Her hardest hue to hold./Her early leaf’s a flower;/But only so an hour./Then leaf subsides to leaf./So Eden sank to grief,/So dawn goes down to day./Nothing gold can stay.
— — — —
Niente che sia d’oro dura/In Natura il primo verde è dorato,/e subito svanisce./Il primo germoglio è un fiore/che dura solo un’ora./Poi a foglia segue foglia./Come l’Eden affondò nel dolore/Così oggi affonda l’Aurora./Niente che sia d’oro dura.
Breve poesia, struggente nella sua tristezza. Mette il lettore di fronte alla sua realtà esistenziale, la sua limitata esperienza, la sua mortalità, l’evanescenza della giovinezza e dell’innocenza. Tutte le cose devono concludersi. Frost evidenzia questo concetto nei primi quattro versi e in quello numero 7.
La giovinezza è qui rappresentata col suo primitivo, originario colore: l’oro, la prima foglia e l’alba. I versi descrivono la bellezza giovanile, ma anche la volatilità della natura. Quel verde che non dura, solo un’ora e l’alba sfuma nel giorno. Non la si può fermare.
Un altro concetto sviluppato dal poeta è quello della brevità della vita, nell’evolversi del suo ciclo con il quale il lettore deve confrontarsi. Foglia succede a foglia, una legge alla quale nessun essere nell’universo può sfuggire.
Non potettero sfuggire a questo destino nemmeno chi, nell’Eden, ebbe la fortuna di abitare. Dal loro destino furono costretti a precipitare nel dolore. Dovettero affrontare l’inevitabile corruzione. Essi persero così l’originaria innocenza. Tutte le cose belle sono destinate a finire. Anche l’oro dell’estate diventerà dorato in autunno prima di consumersi definitivamente.
Un altro poeta descrisse quelle foglie “hectic red” — “malaticce” -. Qualche altro disse “tutto scorre”, nell’ineluttabilità del cambiamento. L’elemento allegorico è presente nella breve poesia e si manifesta realisticamente nelle foglie che si trasformano. Noi non siamo altro che foglie sull’albero della vita.
[image error]July 28, 2023
Tutta la vita in un podcast …
 Foto@angallo
Foto@angalloPrima o poi l’intera vita umana, dalla nascita al trapasso, sarà visibile in un podcast. E’ possibile prevedere che il vissuto di ogni persona, sarà visibile e ri-vivibile in questa forma. Avete letto bene, una vita rivista, se non per chi è trapassato, ma almeno per i suoi sopravvissuti. Tante sono ormai le registrazioni audio e video che documentano la vita degli esseri umani.
Ognuno di noi può ritrovarsi in un montaggio di podcast autobiografico. Finiremo tutti in una biblioteca digitale fatta di podcast microchippati. L’immagine che vedete a corredo di questo post futuristico, da mondo nuovo Huxleyano, propone un mio momento digitale.
Ma cosa significa questa parola? “Podcast” è una combinazione di “iPod” (un dispositivo di riproduzione musicale) e “broadcast” (trasmissione). Il termine è stato coniato nel 2004 da Ben Hammersley, un giornalista britannico, per descrivere la pratica di creare e distribuire file audio su Internet che potevano essere scaricati e ascoltati su dispositivi portatili come l’iPod.
Oggi, il termine “podcast” si riferisce a qualsiasi tipo di contenuto audio digitale distribuito su Internet e disponibile per il download su dispositivi mobili e computer. Il podcast nasce in formato audio ma diventa anche video digitale ed è costituito da episodi che riguardano un tema specifico.
Dalla culla alla tomba, appunto. I podcast possono essere ascoltati, visti, vissuti e ri-vissuti, commentati su tv, computer, tablet o smartphone, disponibili su piattaforme digitali. Possono essere creati da chiunque e possono trattare qualsiasi argomento, dall’intrattenimento alla politica, dalla scienza alla cultura. Possono essere registrati in qualsiasi momento e caricati online per essere ascoltati e visti su richiesta.
In genere, sono gratuiti e finanziati attraverso la pubblicità o il crowdfunding. Possono essere gestiti in qualsiasi momento e ovunque, il che li rende una opzione comoda per chiunque voglia vivere contenuti, mentre si sposta o svolge altre attività. Possono essere scaricati, ascoltati e visti anche offline, il che li rende una attività ideale totale.
Sono documenti che ci permettono di conoscere meglio la vita e il lavoro, ci offrono una finestra sul passato che altrimenti sarebbe stata chiusa. Inoltre, i podcast sono diventati un mezzo popolare per raccontare storie e documentare eventi importanti, quindi è possibile che sempre più persone scelgano di registrare la loro vita in questo modo. E’ possibile prevedere che questo strumento diventi la norma per tutta la vita umana.
Sono più che buone le previsioni per il futuro di questa industria. Una crescita continua che continuerà in modo significativo, con un aumento del numero di spettatori che trascorrono il loro tempo ad ascoltare, vedere e rivedere una vita vissuta in digitale.
L’io di ognuno di noi, il selfie che ci persegue, si trasforma in podcast. Si prevede che la spesa pubblicitaria per questo prodotto aumenterà, con valori di miliardi di dollari.
Gli annunci audio video diventeranno sempre più popolari e gli inserzionisti si concentreranno sulla creazione di contenuti pubblicitari mirati per raggiungere specifici segmenti di pubblico.
L’avanzamento delle tecnologie pubblicitarie consentirà agli inserzionisti di migliorare il targeting degli annunci e di coinvolgere. L’introduzione di tecnologie come l’Intelligenza Artificiale e l’Internet delle Cose potrà portare a nuove esperienze di vita e ad una maggiore personalizzazione dei contenuti.
I podcast diventeranno sempre più personalizzati e esclusivi, offrendo esperienze uniche. Le aziende potranno creare podcast interni per coinvolgere i dipendenti o offrire contenuti riservati a determinati gruppi di utenti.
Questa industria si espanderà a livello globale, con un aumento del numero di utenti in paesi emergenti con l’intento di affermare la loro identità. Ciò potrà portare a una maggiore diversità di contenuti e a una crescita del mercato internazionale.
Emergeranno nuovi modelli di business nel settore come abbonamenti premium, sponsorizzazioni e partnership con aziende. Questi modelli offriranno nuove opportunità di monetizzazione per i creatori.
Si prevede che i podcast si integreranno sempre più con altri social media. Ciò porterà a nuove forme di storytelling e a una maggiore interazione tra diversi canali di comunicazione.
Queste previsioni indicano che l’industria dei podcast continuerà a crescere e ad evolversi, offrendo nuove opportunità per i creatori di contenuti, gli inserzionisti e gli ascoltatori.
Ma come creare un podcast? Si possono seguire questi passaggi: definire il proprio obiettivo pensare a cosa si vuole comunicare e perché. Scegliere un tema specifico su cui concentrarsi. Acquistare l’attrezzatura necessaria sia audio che video, partendo dal proprio cellulare. Si possono trovare apparecchiature a prezzi accessibili sul mercato. Scegliere un software di registrazione.
Ci sono diversi programmi disponibili per registrare e modificare l’audio e il video del podcast. Pianificare gli argomenti degli episodi, scrivere uno script o degli appunti per guidare la produzione. Assicurarsi di avere un formato coerente per ogni episodio. Registrare e modificare. Utilizzare il software di editing per migliorare la qualità audio e video rimuovere eventuali errori o aggiungere effetti sonori.
Caricare il podcast su una piattaforma di hosting. Queste piattaforme consentono di distribuire il podcast su diverse altre piattaforme. Promuovere il podcast utilizzando i social media, il proprio sito web o altri canali di comunicazione per promuovere il podcast e raggiungere un pubblico più ampio. Invitare gli ascoltatori a condividere il podcast con i loro amici e familiari.
Va ricordato che la costanza è importante per il successo del podcast. Pianificare e pubblicare episodi regolarmente per mantenere l’interesse degli ascoltatori. Creare e conservare. Stiamo costruendo la nostra vita futura. Nulla dovrà sfuggirci, non dovremo dimenticare alcunchè del nostro vissuto.
Ci rivedremo e ci ri-vedranno. Non scompariremo. Potremo sempre ritornare. Non solo qualche volta. Vivremo in eterno, anche dopo il trapasso. Tutta la vita in un podcast …[image error]
July 25, 2023
Finzione & Realtà
 Foto@angallo
Foto@angalloIl rapporto tra finzione e realtà è complesso e sfaccettato. La finzione è una risposta alla realtà. Anche la finzione più surreale o ultraterrena è una risposta alla realtà. Un autore crea personaggi basati su persone che conosce o che ha incontrato.
La realtà modella la finzione: la realtà ha un impatto significativo sulla finzione, poiché la maggior parte delle invenzioni e degli sviluppi possono essere ricondotti a idee di fantasia
La finzione può modellare il pensiero della vita reale: le esperienze immaginarie possono modellare il modo in cui le persone pensano nella loro vita reale. Le persone tendono a dimenticare che le storie di fantasia sono inventate e non hanno alcun legame con la realtà, motivo per cui non sorprende vedere come le esperienze di fantasia possono plasmare il modo in cui le persone pensano nella loro vita reale
La narrativa ha un impatto nel mondo reale: Storie, letteratura e finzione hanno un impatto nel mondo reale e possono cambiare le sorti della vita
C’è una linea sottile tra finzione e realtà: la linea tra finzione e realtà è più sfocata oggi che mai. La finzione è più efficace quando prende spunto dal mondo reale e assomiglia molto alla verità
C’è uno scambio costante tra finzione e realtà: la finzione non è messa in quarantena dalla realtà, poiché c’è uno scambio costante tra i due mondi
Sebbene la finzione possa non essere la realtà, è chiaro che ci sono molti modi in cui finzione e realtà si intersecano e si influenzano a vicenda.
La finzione influenza la nostra percezione: anche se la finzione non può influenzare direttamente la realtà, può influenzare la nostra percezione della realtà in modi di cui potremmo non essere consapevoli in quel momento[image error]
La finzione può cambiare le percezioni del mondo reale: uno studio ha rilevato che la letteratura di fantasia può influenzare in modo significativo le credenze della vita reale
La narrativa dà forma a valori e credenze: le storie sono un serbatoio segreto di valori e cambiare le storie in cui vivono gli individui e le nazioni può cambiare i loro valori e le loro credenze
La finzione può modellare il modo in cui le persone pensano: le esperienze immaginarie possono modellare il modo in cui le persone pensano nella loro vita reale, poiché le persone tendono a dimenticare che le storie di fantasia sono inventate e non hanno alcun collegamento con la realtà
La finzione può essere una fuga dalla realtà: le storie di fantasia possono essere una fuga dalla realtà e una finestra su un mondo diverso, motivo per cui le persone trascorrono molto tempo immerse in romanzi, film, opere teatrali, serie TV o qualsiasi altra forma di finzione
La finzione può influenzare la realtà in vari modi, modellando valori e credenze, cambiando le percezioni del mondo reale e influenzando la nostra percezione della realtà.
July 23, 2023
La perduta arte della conversazione
 Santorini dal mare (Foto@angallo)
Santorini dal mare (Foto@angallo)Una foto che è tutta una conversazione. Alle spalle di Chiara, mia nipote, la straordinaria immagine di Santorini vista dal mare, mentre il veloce traghetto si allontana dall’isola incantata. Una conversazione in pixel che avrebbe fatto rimpiangere quella fatta di parole, ma che poi, col passare del tempo, sarebbe stata raccontata in forma di ricordo.
Negli ultimi anni, con l’avvento della tecnologia e dei mezzi di comunicazione digitali, la conversazione reale sembra essere diventata una specie in via di estinzione. Molti di noi passano gran parte della giornata a comunicare con gli altri attraverso i social media, i messaggi di testo, le e-mail, emoticon e altri graffiti vari, abituandosi a una forma di comunicazione emotiva, ma meno diretta e immediata. Di conseguenza, la conversazione reale sta diventando sempre più rara e preziosa.
La conversazione reale è un’arte che richiede un certo grado di abilità e di attenzione. È un modo di comunicare che permette di connetterci con gli altri in modo profondo e significativo, di esprimere i nostri pensieri e sentimenti in modo chiaro e di ascoltare gli altri con empatia e comprensione. Dal vivo, si suole dire.
Ci sono molti vantaggi nella conversazione reale. Innanzitutto, permette di stabilire una connessione più autentica con gli altri. Quando si parla di persona, si possono cogliere molti segnali non verbali, come l’espressione del viso, il tono della voce e il linguaggio del corpo, che aiutano a comprendere meglio ciò che l’altra persona sta dicendo e come si sente. Inoltre, la conversazione reale permette di creare un ambiente più intimo e accogliente, dove le persone possono sentirsi a proprio agio e parlare liberamente.
Albert Einstein, a suo tempo, disse che era fin troppo ovvio che “la tecnologia sta distruggendo la nostra umanità.” Evidentemente, non aveva ancora visto la condizione in cui ci troviamo oggi. Mi riferisco all’uso del cellulare, altrimenti detto smartphone, una vera e propria appendice del nostro corpo, inclusa la mente. Sarebbe stato interessante chiedergli cosa ne pensa di questo strumento che ha letteralmente cambiato il modo con il quale interagiamo socialmente.
Cosa accade quando diventiamo così dipendenti da questo strumento? Secondo alcuni esperti, quella che era un tempo considerata un’arte sta scomparendo. Mi riferisco a quell’arte che il grande saggista inglese Samuel Johnson, in un suo famoso saggio, chiamò “l’arte della conversazione”. Se finisce la conversazione, c’è il rischio che scompaia anche il tessuto sociale della comunità a cui apparteniamo.
C’è stato un momento in cui abbiamo pensato che tutta questa tecnologia potesse migliorare i nostri rapporti, le relazioni e le connessioni. Man mano, però, che questa stessa tecnologia diventa più sofisticata, avvolgente ed imprevedibile nei suoi impieghi, ci rendiamo conto che non è una rete che ci protegge e ci difende. Sembra, piuttosto, una realtà sempre più oppressiva sulla nostra esistenza, tanto da farci temere per la nostra introspezione e creatività e intimacy.
Se scompare la conversazione, le relazioni umane perdono quella empatia che si manifesta in maniera piuttosto fisica, come ad esempio il contatto degli occhi, del corpo, della presenza fisica. Perdiamo i toni della voce, i movimenti del suo corpo, il senso della presenza. Osservate un gruppo di persone che sta parlando e vi accorgerete che la conversazione si interrompe spesso per permettere a qualcuno di rispondere al cellulare. L’interazione cessa, gli argomenti si frammentano, i fili si spezzano, la qualità dei contatti si deteriora. Adddio empatia!
La medesima cosa accade quando ci si siede a tavola in un posto dedicato al cibo. Prima siede il cellulare e poi il suo padrone. Che cos’è, allora, che ci tiene “legati” e non “collegati” al cellulare? Anche se siamo con gli altri abbiamo forse paura di essere soli. Si può capire chi in un vagone della metro, in un bus, su di un treno, resta collegato attaccato al suo piccolo schermo, oppure, in tuta e connesso con gli auricolari, fa il suo footing mattutino ascoltando musica, le ultime notizie o conversa piacevolmente con la sua metà.
Abbiamo visto molte situazioni di pericolo vissute al cellulare e rilanciate in televisione. Molte vite sono continuamente salvate da questo gadget che è un prolungamento del nostro corpo, in grado di fare cose che il nostro stesso corpo non sa e non può fare. Si spiega così il fatto che ci spinge a non staccarci mai da lui. Eppure, dobbiamo trovare un modo per imparare a conviverci, un maniera razionale e ragionevole di usarlo. Non è possibile accettare l’idea che qualcuno possa essere falciato da un treno ad un passaggio a livello chiuso e non possa accorgersi del treno in arrivo.
Sì, è vero, il cellulare ci stimola, ci avverte, ci sollecita, non ci fa annoiare, ci tiene compagnia, ci intrattiene, ci guida e ci controlla. Uno studioso di comunicazione ha scritto in un suo libro che il cellulare, diversamente dal telefono fisso, ci offre la possibilità di risolvere qualsiasi problema in qualsiasi momento, condizione e situazione. Questa possibilità elimina situazioni forzate ed emotive. Bisogna però stare attenti a non delegare tutto allo strumento, in questo caso il cellulare, ma si può pensare a tutti gli altri media che usiamo.
Penso a chi, in cerca di gratificazione, riconoscimento o accettazione, posta su Facebook una foto e aspetta il riscontro in forma di “likes”. Il riconoscimento personale, il riscontro del suo narcisismo. E’ necessario conoscere lo strumento, non diventarne dipendenti, saperlo gestire per non essere gestiti. Bisogna creare spazi apposti dove il cellulare, ma anche gli altri media moderni, non devono entrare.
Non solo lo smartphone, quindi, ma anche la tv, la radio, il pc. E ricordare che esistono sempre due “bottoni”, come si chiamava una volta la “stanza dei bottoni”, due pulsanti. Oggi si chiamano “opzioni”: “on” e “off”. Non esiste una via di mezzo …[image error]
Studiare oggi …
 Ieri e oggi a scuola
Ieri e oggi a scuolaStudiare oggi non è come ieri. Non molto tempo fa. Solo qualche ventennio. Allora, i saperi erano cartacei, oggi sono anche digitali. Fa la differenza. L’esercizio del pensare è quanto mai dinamico, relativo ed imprevedibile. Sì, è vero che lo studio e l’apprendimento sono cambiati molto negli ultimi anni grazie alla diffusione della tecnologia e degli strumenti digitali. Oggi, infatti, abbiamo a disposizione un’enorme quantità di informazioni e risorse online, che ci permettono di accedere a una vasta gamma di conoscenze e saperi.
Tuttavia, questo cambiamento comporta anche nuove sfide e opportunità per gli studenti. Ad esempio, la grande quantità di informazioni disponibili può rendere difficile distinguere tra fonti affidabili e non affidabili, e richiede quindi una maggiore attenzione e capacità critica.
Inoltre, l’utilizzo della tecnologia può anche influire sull’esercizio del pensiero, poiché spesso ci troviamo a navigare in modo passivo tra le informazioni, senza approfondire e mettere in discussione ciò che leggiamo. Tuttavia, se usato in modo consapevole e critico, lo strumento digitale può diventare un valido alleato per lo studio e l’apprendimento, permettendo di accedere a una vasta gamma di conoscenze e saperi in modo rapido ed efficace. Come in molte altre cose, è importante trovare un equilibrio tra l’utilizzo della tecnologia e gli approcci tradizionali allo studio, per ottenere i migliori risultati possibili.
Una sfida importante è quella di sviluppare la capacità di valutare la qualità e l’affidabilità delle fonti di informazione disponibili online. Oltre alla grande quantità di informazioni disponibili, spesso ci troviamo di fronte a notizie e dati falsi, fuorvianti o manipolati. Per questo motivo, è importante sviluppare un pensiero critico e imparare a valutare la veridicità e l’attendibilità delle fonti di informazione, in modo da evitare di cadere in trappole e di acquisire conoscenze errate.
Un’altra sfida consiste nel mantenere la concentrazione e l’attenzione durante lo studio, soprattutto quando si utilizzano dispositivi digitali che possono essere fonte di distrazioni come i social network o le notifiche di messaggi. Per questo motivo, può essere utile impostare dei tempi prestabiliti per lo studio e per l’utilizzo dei dispositivi digitali, in modo da mantenere la produttività e la concentrazione.
D’altra parte, l’utilizzo della tecnologia può rappresentare anche un’opportunità per gli studenti, che possono accedere a una vasta gamma di risorse e strumenti per lo studio e l’apprendimento. Ad esempio, ci sono numerosi software e applicazioni che possono aiutare gli studenti a organizzare il proprio lavoro, a prendere appunti, a creare mappe concettuali, a fare esercizi e a monitorare i propri progressi.
L’utilizzo della tecnologia può anche favorire la collaborazione e l’apprendimento sociale, consentendo agli studenti di comunicare e collaborare con altri compagni di studio o con insegnanti e tutor online. Questo può essere particolarmente utile per gli studenti che studiano a distanza o che hanno difficoltà a partecipare alle lezioni in presenza. E’ importante trovare un equilibrio tra l’utilizzo di strumenti digitali e gli approcci tradizionali allo studio, in modo da trarre il massimo beneficio da entrambi. Ecco alcuni consigli:
Scegliere le fonti di informazione con cura: quando si utilizza la tecnologia per lo studio, è importante valutare con attenzione la qualità e l’affidabilità delle fonti di informazione. Si consiglia di utilizzare fonti ufficiali e di affidabilità comprovata, come libri di testo, pubblicazioni accademiche o siti web di istituzioni accreditate.
Utilizzare strumenti digitali in modo strategico: ci sono molti strumenti digitali utili per lo studio, come app per prendere appunti, mappe concettuali, esercizi online, ma è importante utilizzarli in modo strategico. Ad esempio, si può decidere di utilizzare app per prendere appunti durante le lezioni, ma poi rivedere e riorganizzare gli appunti su carta per favorire la memorizzazione.
Impostare limiti di tempo: l’utilizzo della tecnologia può essere fonte di distrazioni, pertanto è importante impostare limiti di tempo per l’utilizzo di dispositivi digitali e per la navigazione online. Si possono ad esempio impostare sessioni di studio di una certa durata, durante le quali si evitano le distrazioni.
Collaborare con altri studenti: l’utilizzo della tecnologia può favorire la collaborazione con altri studenti, ad esempio attraverso chat, forum o piattaforme di apprendimento online. Questo può essere utile per scambiare idee, discutere argomenti, o lavorare insieme su progetti.
Mantenere un equilibrio tra l’utilizzo della tecnologia e gli approcci tradizionali: è importante trovare un equilibrio tra l’utilizzo della tecnologia e gli approcci tradizionali allo studio, come la lettura di libri o la scrittura a mano. L’utilizzo della tecnologia può essere utile per accedere alle informazioni e per organizzare il lavoro, ma gli approcci tradizionali possono aiutare a favorire la memorizzazione e la comprensione dei contenuti.
[image error]July 21, 2023
Gente di poca fede nel XXI secolo: nè dio, nè patria, nè famiglia

L’espressione “gente di poca fede” è generalmente usata per descrivere coloro che non credono in una determinata religione o credo spirituale. Tuttavia, nell’affermazione “né dio, né patria, né famiglia”, sembra che si stia parlando di qualcosa di più ampio, ovvero una mancanza di fiducia o di attaccamento ai valori tradizionali.
Nel XXI secolo, molte persone hanno scelto di allontanarsi dalle istituzioni religiose e dalle credenze tradizionali per una serie di motivi, tra cui l’aumento dell’accesso all’informazione e la crescente diversità culturale e religiosa.
Tuttavia, questo non significa automaticamente che queste persone non abbiano fede o che non credano in nulla. Molte persone possono ancora avere una forte spiritualità o una filosofia personale che guida le loro scelte e azioni.
Per quanto riguarda la patria e la famiglia, anche qui le cose sono cambiate rispetto al passato. Molti si sentono parte di comunità più ampie, come quelle regionali o globali, e vedono il mondo in modo più interconnesso. Inoltre, i concetti di patria e famiglia stanno evolvendo, con molte persone che vedono la loro identità come qualcosa di più fluido e inclusivo rispetto alle definizioni tradizionali.
“Gente di poca fede” nel XXI secolo potrebbe essere meglio descritta come coloro che non si identificano con le istituzioni e i valori tradizionali, ma che possono ancora avere una forte spiritualità o una filosofia personale che guida le loro scelte e azioni.
Ci sono molti valori tradizionali con cui le persone potrebbero non identificarsi più nel 21° secolo, e questi possono variare a seconda di fattori culturali, sociali e storici. Ecco alcuni esempi:
Ruoli di genere: in passato, c’erano chiare aspettative su come uomini e donne avrebbero dovuto comportarsi e su quale dovesse essere il loro ruolo nella società. Tuttavia, nel 21° secolo, molte persone rifiutano questi ruoli di genere tradizionali e credono che gli individui dovrebbero essere liberi di esprimersi e perseguire i propri obiettivi indipendentemente dal loro genere.
Matrimonio e famiglia: in passato, il matrimonio era spesso visto come un’istituzione necessaria e desiderabile e avere figli era considerato un aspetto centrale della vita adulta. Tuttavia, negli ultimi anni, molte persone hanno scelto di ritardare il matrimonio o di non sposarsi affatto, e alcune hanno anche scelto di non avere figli. Inoltre, vi è una maggiore accettazione delle strutture familiari non tradizionali, come le famiglie monoparentali e le coppie dello stesso sesso con figli.
Religione: in passato, molte società erano dominate da un’unica religione e spesso c’era una forte aspettativa che gli individui aderissero alle dottrine e alle pratiche di quella religione. Tuttavia, nel 21° secolo, c’è molta più diversità in termini di credenze e pratiche religiose, e molte persone rifiutano del tutto la religione organizzata.
Nazionalismo: in passato, il patriottismo e la lealtà al proprio paese erano spesso visti come valori essenziali, e c’era una forte enfasi sull’identità e l’unità nazionale. Tuttavia, nel 21° secolo, c’è una maggiore consapevolezza delle questioni globali e un riconoscimento dell’interconnessione di diverse culture e società, portando alcune persone a mettere in discussione l’importanza dell’identità e dei confini nazionali.
Questi sono solo alcuni esempi di valori tradizionali con cui le persone potrebbero non identificarsi nel 21° secolo. È importante notare che questi cambiamenti non sono necessariamente universali o uniformi e che individui e comunità diversi possono avere prospettive diverse su questi problemi.
I cambiamenti nei valori tradizionali che vediamo nel 21° secolo possono avere effetti ad ampio raggio sulla società nel suo insieme. Ecco alcuni modi in cui questi cambiamenti possono avere un impatto sulla società:
Maggiore diversità e inclusione: poiché le persone rifiutano i valori e le norme tradizionali, c’è più spazio per la diversità e l’inclusione nella società. Ciò può portare a una maggiore accettazione di culture, stili di vita e identità diversi e può promuovere un senso di unità e comprensione tra gruppi diversi.
Nuove norme sociali e culturali: man mano che i valori tradizionali vengono sostituiti da nuove norme, potremmo assistere a cambiamenti nel comportamento sociale, nelle pratiche culturali e persino nelle leggi e nelle politiche. Ad esempio, l’accettazione di strutture familiari non tradizionali può portare a cambiamenti nel diritto di famiglia e nelle politiche di adozione, mentre il rifiuto dei ruoli di genere può portare a cambiamenti nelle norme e nelle aspettative sul posto di lavoro.
Conflitto e tensione: mentre i cambiamenti nei valori tradizionali possono portare a una maggiore inclusività e diversità, possono anche creare conflitti e tensioni tra gruppi diversi. Ad esempio, alcune persone possono resistere ai cambiamenti nei ruoli di genere tradizionali o nelle pratiche religiose, portando a scontri culturali e tensioni sociali.
Nuove opportunità e sfide: man mano che i valori tradizionali vengono sostituiti da nuove norme e pratiche, potrebbero esserci nuove opportunità di innovazione e progresso, nonché nuove sfide e rischi. Ad esempio, il rifiuto dei tradizionali ruoli di genere può portare a maggiori opportunità per le donne sul posto di lavoro, ma può anche creare nuove sfide per quanto riguarda l’equilibrio tra lavoro e vita privata e le responsabilità familiari.
I cambiamenti nei valori tradizionali che vediamo nel 21° secolo possono avere effetti sia positivi che negativi sulla società nel suo insieme. È importante che gli individui e le comunità affrontino questi cambiamenti in modo ponderato e rispettoso, con un occhio alla promozione dell’inclusione, della comprensione e del progresso.
Ecco alcuni esempi di come i cambiamenti nei valori tradizionali hanno già avuto un impatto sulla società:
Maggiore diversità e inclusività: negli ultimi anni, c’è stato un crescente riconoscimento dell’importanza della diversità e dell’inclusività in molte aree della società, anche sul posto di lavoro, nell’istruzione e nella politica. Ad esempio, molte aziende hanno implementato iniziative di diversità e inclusione per promuovere una maggiore rappresentanza di gruppi diversi e molte scuole hanno implementato programmi per insegnare agli studenti culture e prospettive diverse.
Nuove norme sociali e culturali: i cambiamenti nei valori tradizionali hanno portato anche a nuove norme sociali e culturali. Ad esempio, l’accettazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso ha portato a cambiamenti nelle leggi e nelle politiche in molti paesi e il rifiuto dei ruoli di genere ha portato a maggiori opportunità per le donne in molti settori della società, anche sul posto di lavoro e in politica.
Conflitto e tensione: mentre i cambiamenti nei valori tradizionali possono portare a una maggiore inclusività e diversità, possono anche creare conflitti e tensioni tra gruppi diversi. Ad esempio, i dibattiti su questioni come l’aborto, il matrimonio tra persone dello stesso sesso ei diritti dei transgender hanno portato a tensioni sociali e politiche in molti paesi.
Nuove opportunità e sfide: i cambiamenti nei valori tradizionali hanno creato nuove opportunità e sfide in molti settori della società. Ad esempio, il rifiuto dei tradizionali ruoli di genere ha creato nuove opportunità per le donne sul posto di lavoro, ma ha anche creato nuove sfide per quanto riguarda l’equilibrio tra lavoro e vita privata e le responsabilità familiari.
Allo stesso modo, l’accettazione di strutture familiari non tradizionali ha creato nuove opportunità per l’adozione e la maternità surrogata, ma ha anche sollevato interrogativi sul ruolo dei genitori e delle famiglie nella società.
C’è chi vive il presente guardando continuamente al passato, ritenendo di difendersi in una realtà che ritiene ostile e pericolosa. C’è anche però chi ritiene che il presente non sia altro che il futuro del passato e perciò bisogna guardare sempre più in avanti.
Una cosa sembra essere certa e cioè che i tradizionali cambiamenti sono destinati a diventare vere e proprie mutazioni anche sotto la spinta di una tecnologia sempre più invasiva e trans-umana. Tutto sta a capire che andare oltre l’umano è un rischio che l’uomo non può correre, è in ballo la sua sopravvivenza.[image error]
July 16, 2023
Saper leggere, per saper pensare
 “Pensare per uno scopo” — Versione Kindle 2023
“Pensare per uno scopo” — Versione Kindle 2023Pausa. Riflettere. Pensare. “Pensare per uno scopo”. Il piccolo libro di filosofia della collana Pelican di Susan Stebbing aveva un grande obiettivo: fornire a tutti gli strumenti per pensare con chiarezza, da soli. Venne pubblicato nel 1939, l’ho riletto in versione Kindle e ne valeva la pena. Grazie ad un articolo pubblicato sulla rivista digitale AEON, che ho usato per questo post, ma sopratutto grazie alle coincidenze significative che esistono. Vi dico il perchè. Sarà un pò complicato spiegarlo a chi leggerà superficialmente questo scritto. M’interessa poco, l’importante per me è mettere insieme non solo i miei ricordi, ma anche il piacere che mi offrono ogni giorno le fondamentali abilità linguistiche sulle quali si basa la mia ereditaria patologia: la Bibliomania: ascoltare, parlare, leggere, scrivere e comunicare.
 Un manuale di pronto soccorso per pensare con chiarezza, su come rilevare le illogicità nei processi mentali di altre persone e come evitarle nei nostri
Un manuale di pronto soccorso per pensare con chiarezza, su come rilevare le illogicità nei processi mentali di altre persone e come evitarle nei nostri
L. Susan Stebbing, pubblicò Thinking to Some Purpose nel 1939, sottolineando la necessità per le persone comuni di sviluppare le proprie capacità di pensiero critico, per evitare di essere fuorviate da una lingua ingannevole e da logiche basate su infondate conclusioni. Era profondamente consapevole del potere del linguaggio e dei suoi potenziali usi e abusi, avvertiva la necessità di una migliore comprensione di questo aspetto della comunicazione umana. Era la chiave per una società informata e impegnata. La sua società, quella del suo tempo, in Inghilterra. Siamo alla vigilia della seconda guerra mondiale e lei avvertiva la necessità per un popolo democratico di pensare chiaramente, senza le distorsioni dovute a pregiudizi inconsci e ignoranza non riconosciuta. Un chiaro appello al pensiero individuale, critico e razionale. Tipicamente inglese. Per la sua epigrafe, Stebbing scelse una citazione sulla libertà di pensiero del libero pensatore del XVIII secolo Anthony Collins, che aveva scritto:
… se abbiamo il diritto di conoscere qualsiasi Verità, abbiamo il diritto di pensare liberamente, o di usare le nostre Comprensioni, nel tentativo di scoprire il Significato di qualsiasi Proposizione, nel considerare la natura della Prove a favore o contro di essa, e nel giudicarle secondo l’apparente Forza o debolezza delle prove: perché non c’è altro modo per scoprire la Verità.
Anthony Collins, Discorso del pensiero libero (1713)
Stebbing fu una docente universitaria e poi professore in un mondo filosofico quasi completamente dominato dagli uomini. Nel 1933, fu la prima donna nel Regno Unito ad essere nominata professore ordinario di filosofia. Stebbing è rimasta poco conosciuta al di fuori dei circoli accademici specialistici e non ha nulla dell’aura quasi mitica che circonda il “grande” pensiero filosofico come quello di Bertrand Russell o di G.E. Moore, entrambi suoi contemporanei. Stebbing nacque nel nord di Londra nel 1885. Morì nel 1943 a soli 57 anni di cancro.
 L. Susan Stebbing
L. Susan StebbingIn Thinking to Some Purpose, un testo filosofico rivolto al grande pubblico, si propose di riflettere sulla lettura, ma anche di educare le persone a capire la filosofia intesa come un beneficio per il mondo reale, addestrando i suoi lettori su come praticarla. Il libro è descritto sulla copertina dell’edizione Pelican come “Un manuale di pronto soccorso per pensare con chiarezza, che mostra come rilevare le illogicità nei processi mentali di altre persone e come evitarle nei nostri”. Proprio come il manuale dell’utente di un’auto istruisce il proprietario su come percorrere la strada. Un libro scritto per aiutare i suoi lettori a pensare nel modo giusto ed evitare le insidie comuni. Pensare con chiarezza come “liberi pensatori”.
Il “libero pensiero” risale all’Illuminismo europeo e originariamente implicava il rifiuto dell’autorità religiosa e del dogma accademico alla luce dei nuovi sviluppi della scienza. In sostanza, i liberi pensatori spingevano per una democratizzazione della conoscenza e credevano che dovessimo seguire la nostra ragione piuttosto che la Bibbia o gli antichi testi filosofici. Il frontespizio di Thinking to Some Purpose include anche una citazione del filosofo del XVIII secolo Anthony Collins che ho citato innnanzi.
Come i liberi pensatori del XVII e XVIII secolo, Stebbing credeva che dovremmo evitare l’autorità come fonte di conoscenza e affidarci invece alle nostre capacità razionali. Credeva che gli individui fossero veramente liberi solo quando fossero in grado di pensare con chiarezza. Per lei, scrivere, mentre l’ombra del fascismo e del nazismo calava sull’Europa negli anni ’30, era un problema urgente. Nell’epilogo di Thinking to Some Purpose, dice al lettore che: “Il mio argomento è la libertà della mente.”
Fin qui il libro con il suo contenuto e le intenzioni di chi lo scrisse. Coincidenza significativa ha voluto che io conoscessi questo libro, agli inizi degli anni sessanta, in un luogo dove il pensiero pensato aveva davvero bisogno di essere aiutato, conosciuto ed organizzato. Nei testi della bibliografia che dovetti studiare durante il corso di infermiere mentale c’era anche questo libro. Ero finito in Inghilterra a fare quel lavoro per guadagnarmi da vivere e studiare. Era un testo al quale mr. Smith, il tutor del corso, teneva molto. Prima coincidenza.
Successivamente, la seconda coincidenza volle che me lo ritrovassi, come testo adottato, durante il corso per corrispondenza che avevo con il Metropolitan College di St. Albans nel corso di cultura e civiltà inglese. Tutto sembra “tenersi”, come dicono i francesi. Un testo scritto e pubblicato nel giorno della mia data di nascita, un testo in uso per il corso di infermieristica mentale in un ospedale mentale per deficienti mentali, secondo la terminologia del tempo, un libro di testo per lo studio della lingua e della cultura di lingua inglese. Coincidenze quanto mai significative e decisive per avere la conferma, anche a distanza di oltre mezzo secolo, che bisogna saper leggere per ben capire. Per liberare la propria mente.
Originally published at https://aeon.co .
[image error]July 13, 2023
La “merda” dell’artista
 Alla Tate Gallery di Londra
Alla Tate Gallery di LondraNon poteva sfuggirmi l’anniversario di un artista che è passato alla storia per la sua “merda”. Scomparve il 13 luglio del 1963 a soli 29 anni. Ero in Inghilterra, a quel tempo, lessi sui giornali delle sue opere e ricordo che apparvero anche alla Tate Gallery. Non ebbi modo di andarci per vedere la scatola, ma ricordo che quando arrivavano scatolette simili per i pazienti dell’ospedale dove lavoravo, alcuni colleghi studenti infermieri mi sfottevano dicendo erano “made in Italy”.
Nessuno come lui famoso per una scatola. Dice la sorella: «Noi all’epoca non gli davamo mica molta importanza, ci sembrava che le sue opere fossero normali. Abbiamo capito che non era così quando, immediatamente dopo la sua morte, sono arrivate tutte le richieste dall’Italia e dall’estero».
Di famiglia nobile, Piero Manzoni cresce a Milano: liceo Leone XIII, facoltà di Legge all’Università Cattolica. Ogni estate, durante le vacanze ad Albisola, frequenta Lucio Fontana, amico di famiglia: rimarranno amici per sempre. Un percorso di vita normale, che si smonta quando «il Piero» comincia a frequentare gli artisti alternativi del bar Jamaica. Giovanissimo, ha bisogno di arte, ma non gli interessa il figurativo. Sperimenta un’arte inedita, provocatoria e irriverente, ostentazione della libertà di creare.
Nel ’55 dipinge impronte di oggetti «banali»: chiodi, forbici, tenaglie. Le materie che usa sono il gesso, il caolino, la colla, il feltro, la fibra di cotone, il peluche. Già si avvertono le sue opere come anomalie di un genio mai completamente compreso. Sono cinque le fasi fondamentali nella sua breve vita: la Vernice bianca, per tutte le opere che sono oggetti comuni, anche il pane. Uno dei primi e più famosi è l’Achrome rettangolare Beyond the canvas.
Poi le «secrezioni di artista», con il suo fiato, il sangue e le feci, conservati in scatolette o sotto vetro. L’apertura di Azimuth, la sua Galleria personale in Brera, che propone un’arte irripetibile, libera oltre la libertà e il buon senso. La pubblicazione della rivista Azimuth, luogo di riflessione creato con il contributo degli artisti più celebri degli anni Sessanta. Le performance sempre più bizzarre e sorprendenti.
Nell’aprile del 1960 firma la sua scarpa destra dichiarandola opera d’arte, facendo lo stesso con una scarpa di Schifano. Inventa una sua Body Art, con la sua firma sui corpi degli individui che li rende opere d’arte, regolarmente certificate da una bolla di accompagnamento. Il 21 luglio 1961 fa diventare «cibo» la sua arte, con le uova bollite marchiate dal suo dito, e offerte come spuntino ai presenti.
Il 12 agosto 1961 mette in vendita 90 scatolette da 30 grammi l’una, della poi inflazionata Merda d’artista (la sua), prodotte e inscatolate nel maggio 1961, vendute a un equivalente valore in oro. Febbraio 1963: «il Piero» muore per infarto nel suo studio in Brera. L’ultima performance. Ha 29 anni. I suoi prodotti non si trovano in nessun supermercato, ma se ci fossero, lui ne sarebbe contento. (Almamatto)
Ecco alcune delle sue principali teorie ed opere:
L’arte come prodotto: Manzoni ha sostenuto che l’arte dovrebbe essere vista come un prodotto, analogamente a qualsiasi altro prodotto di consumo. Ha promosso l’idea che l’artista dovrebbe essere visto come un produttore, che produce opere d’arte da offrire al mercato.
L’arte come azione: Manzoni ha anche promosso l’idea che l’arte non sia solo un oggetto, ma anche un’azione. Ha suggerito che l’artista dovesse essere visto come un performer, che crea opere d’arte attraverso l’azione, piuttosto che attraverso la creazione di oggetti.
L’arte come provocazione: Manzoni ha utilizzato spesso il suo lavoro per provocare il pubblico, sfidando le convenzioni dell’arte tradizionale e sfidando gli spettatori a confrontarsi con le loro idee preconcette sull’arte.
L’arte come messaggio: Manzoni ha anche sostenuto che l’arte dovrebbe avere un messaggio, che trasmette una visione del mondo o una critica sociale. Ha utilizzato spesso il suo lavoro per esplorare temi come il potere, l’autorità e la corruzione.
Le teorie di Manzoni hanno contribuito a sfidare le convenzioni dell’arte tradizionale e a promuovere un approccio più radicale e provocatorio all’arte. Ci sono diversi esempi di opere d’arte di Piero Manzoni che riflettono le sue teorie sull’arte. Ecco alcuni esempi specifici:
“Linea di lunghezza infinita” (1959): Quest’opera consiste in una lunga striscia di carta di 16 chilometri, che rappresenta il tentativo di Manzoni di creare una linea infinita. L’opera riflette la sua idea dell’arte come azione, poiché la creazione della linea ha richiesto un’azione fisica continua da parte dell’artista.
“Impronte d’artista” (1960): In questa serie di opere, Manzoni ha creato impronte delle sue dita e del suo pollice su fogli di carta. L’opera riflette la sua idea dell’arte come prodotto, poiché le impronte sono state create come oggetti d’arte da offrire al mercato.
“Merda d’artista” (1961): Quest’opera, forse la più controversa di Manzoni, consiste in 90 lattine di metallo sigillate contenenti le feci di Manzoni. L’opera riflette la sua idea dell’arte come provocazione, sfidando gli spettatori a confrontarsi con le loro idee preconcette sull’arte e sulla sua valutazione.
“Sculture viventi” (1961): In questa serie di opere, Manzoni ha invitato persone a mettersi in piedi su un piedistallo e a farsi fotografare come “sculture viventi”. L’opera riflette la sua idea dell’arte come azione e come messaggio, poiché l’invito alle persone a diventare “sculture viventi” è stato inteso come una critica alla società che oggettifica le persone.
Manzoni riflette la sua visione radicale dell’arte come prodotto, azione, provocazione e messaggio, sfidando le convenzioni dell’arte tradizionale e promuovendo una visione più estesa dell’arte.[image error]
July 12, 2023
Una realtà utopica o distopica?
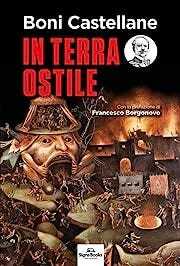 Il Libro
Il Libro Il quadro
Il quadroIl “Cristo scende agli Inferi” è il dipinto di un seguace di Bosch che risale al 1575 circa. Il tema è la discesa di Cristo agli Inferi, ma come in tutti i dipinti simili, il soggetto è solo un pretesto per mettere in scena una visione dell’Inferno e delle punizioni dei dannati. La storia della discesa di Cristo nel Limbo per salvare le anime dei giusti vissuti prima della sua venuta ha goduto di un posto speciale nell’immaginario popolare europeo. In questa visione l’oscurità dell’Inferno è spezzata dall’irruzione abbagliante di Cristo. Nel tempo compreso tra la sua morte e la risurrezione il Cristo impugna la croce col vessillo della vittoria e sfonda le porte infere, inutilmente tamponate da uno stuolo di diavoli difensori. L’Inferno è presentato in varie forme. Ha la struttura urbana della città di Dite, con torri, terrazze e ponti che scavalcano i fiumi infernali. Nel suo fondo emerge la città in fiamme, la Babilonia infernale, simile a una prigione, nella quale i dannati sono giustiziati. E al centro sopravvive l’immagine della gola del Leviatano, incarnato da un Budda accoccolato che apre la sua gola ai dannati. E un’altra immagine è quella della prua della nave di Caronte, cui i dannati confluiscono attraverso un gigantesco imbuto.
Se questa è la descrizione del quadro del seguace di Bosch ed è stata scelta dall’editore e dall’autore del libro, mi pare giusto dire a chi decide di leggerlo che questo è il suo contesto, o per meglio dire “la terra ostile”, alla quale l’autore intende condurlo a leggere. Mai come in questo caso, chi si occupa di libri ha la possibilità di comprendere il suo significato.
Un libro non è soltanto un oggetto creato per essere unicamente il contenitore di un messaggio. Serve anche a creare e offrire a chi legge una o più idee, aprire porte su imprevisti orizzonti, indicare vie di uscita e soluzioni di difesa.
Il libro di Boni Castellane fa fare al lettore, non senza fatica, una ricerca ed uno studio sulla propria identità, nella realtà del suo tempo, quella che stiamo vivendo ora. Cosa, non solo strana, ma anche eccezionale, è che non sappiamo bene chi realmente sia Boni Castellane. Solo un “nom de plume” che leggo anche altrove in cerca della “Verità”.
Chiunque possa essere, consiglio a tutti di leggere questo libro. Sia chi crede nelle “Utopie” che nelle “Distopie”. Ciascuno di noi ha il diritto di comprendere se stiamo diventando schiavi in questo nostro tempo, oppure se possiamo crederci ancora uomini liberi.
«Una rivoluzione sta avvenendo», sottolinea Francesco Borgonovo nella prefazione di “In terra ostile” di Boni Castellane. «L’obiettivo finale è quello di cambiare non soltanto i comportamenti, le abitudini e lo stare al mondo dell’essere umano, ma di modificarne radicalmente la natura, la costituzione, persino la biologia. La reazione, tuttavia, è possibile. Anche perché, semplicemente, esiste, è istintiva, spontanea, talvolta incontrollata. Ha bisogno, però, di essere alimentata. Di acqua fresca per il pensiero, soprattutto. Ed è esattamente quella che fornisce Boni Castellane: avatar concretissimo, hacker del liberalismo, troll guerrigliero, in questa fase storica gli tocca la parte dell’antivirus, del software reazionario che infetta per bloccare un’altra e peggiore infezione. Boni è il legionario accecato dal sole, il miliziano nascosto tra le fronde. Senza sparare un colpo, difende la cittadella. Tutt’intorno, è terra ostile».
Questa è la presentazione editoriale del libro di cui vedete qui sopra la copertina. Per leggerlo ho dovuto avere la copia cartacea tra le mani. Non esiste la versione Kindle e non mi meraviglio. L’autore difende, ovviamente, a denti stretti, il suo spazio vitale nella realtà di un territorio che lui considera in partenza “ostile”. Il virtuale, infatti, non può non essere, per lui, che“terra ostile”. Sin dalla copertina il lettore può farsene un’idea.
Ma questo è un libro utopico o distopico? La risposta è soggettiva e dipende dalle opinioni e dalle percezioni di ogni individuo. Tuttavia, è possibile dire che ci sono aspetti della nostra società e del nostro mondo che potrebbero essere considerati distopici da alcune persone. Come nel caso in esame.
Molte persone potrebbero vedere come distopici i crescenti livelli di disuguaglianza economica, il cambiamento climatico, la diffusione delle malattie pandemiche, la crescente polarizzazione politica e la riduzione delle libertà civili. Allo stesso tempo, altre persone potrebbero vedere come positivi gli sviluppi tecnologici, il miglioramento della salute e del benessere, l’aumento dell’aspettativa di vita e l’abbassamento dei livelli di povertà.
In generale, l’idea di una realtà distopica suggerisce un futuro in cui le condizioni sociali, politiche ed economiche sono estremamente negative e opprimenti. Tuttavia, la realtà attuale, come sempre del resto, è complessa e presenta aspetti positivi e negativi. Spetta a noi individuare e affrontare i problemi che ci troviamo ad affrontare, cercando di costruire un mondo migliore per noi stessi e per le generazioni future.
Il termine “distopia” indica un tipo di società immaginaria caratterizzata da condizioni estremamente negative, opprimenti e disumane. In una distopia, le istituzioni sociali, politiche ed economiche sono spesso autoritarie e oppressive, e i cittadini sono privati delle loro libertà e dei loro diritti fondamentali. La distopia è spesso descritta come l’opposto della utopia, ovvero una società ideale e perfetta.
Le distopie sono spesso presenti nella letteratura e nel cinema di fantascienza, e sono utilizzate per mettere in discussione le attuali tendenze sociali, politiche ed economiche, e per mostrare le conseguenze negative di un futuro in cui queste tendenze non vengono corrette. Le distopie, comunque, possono anche essere utilizzate come strumento per riflettere sulle condizioni attuali della società e per ispirare il cambiamento sociale e politico.
La letteratura distopica esplora spesso i temi dell’oppressione, del controllo sociale e della lotta per la libertà e l’individualità. Boni Castellane lo fa molto bene e alcune caratteristiche e temi comuni che il lettore trova nel suo libro possono essere i seguenti:
Governo oppressivo o potere dominante: le società distopiche sono spesso caratterizzate da un governo oppressivo o potere dominante che cerca di mantenere il controllo sulla popolazione attraverso vari mezzi, come la sorveglianza, la propaganda e la censura.
Perdita di individualità e libertà: nelle distopie, l’individualità e la libertà sono spesso soppresse per mantenere il controllo sociale. I cittadini possono essere costretti a conformarsi a norme e regolamenti rigidi e le loro scelte e desideri personali possono essere limitati o eliminati del tutto.
Distruzione ambientale: molte storie distopiche esplorano le conseguenze negative della distruzione ambientale e l’impatto dell’attività umana sul mondo naturale.
Resistenza e ribellione: la letteratura distopica presenta spesso personaggi che resistono o si ribellano al regime oppressivo, spesso con grande rischio personale.
Disuguaglianza e ingiustizia sociale: le società distopiche mostrano spesso livelli estremi di disuguaglianza e ingiustizia sociale, con determinati gruppi o individui che godono di uno status privilegiato e dell’accesso alle risorse a spese di altri.
La tecnologia e le sue conseguenze: molte storie distopiche esplorano l’impatto della tecnologia avanzata sulla società e il potenziale della tecnologia da utilizzare per scopi nefasti.
La letteratura distopica funge da monito sui potenziali pericoli del governo oppressivo, del controllo sociale e della perdita dell’individualità e della libertà. Esplorando questi temi e caratteristiche, la letteratura distopica incoraggia i lettori a considerare l’importanza della libertà personale, della giustizia sociale e dei valori democratici.
I temi e le caratteristiche distopiche sono spesso l’opposto di quelli che si trovano nella letteratura utopica. Mentre la letteratura distopica esplora le conseguenze negative delle società oppressive, la letteratura utopica ritrae società ideali in cui le persone vivono in pace, prosperità e felicità. Alcune differenze chiave tra letteratura distopica e utopica includono:
Ordine sociale: nella letteratura distopica, l’ordine sociale è spesso mantenuto attraverso sistemi oppressivi di controllo e sorveglianza, mentre nella letteratura utopica, l’ordine sociale è mantenuto attraverso la cooperazione reciproca, l’armonia e valori condivisi.
Individualità e libertà: nella letteratura distopica, l’individualità e la libertà sono spesso soppresse per mantenere il controllo sociale, mentre nella letteratura utopica l’individualità e la libertà sono celebrate e incoraggiate.
Conflitto e lotta: la letteratura distopica ritrae spesso personaggi che lottano contro regimi oppressivi o sistemi di controllo, mentre la letteratura utopica tende a evitare il conflitto e si concentra sui benefici di una società armoniosa.
Tecnologia: nella letteratura distopica, la tecnologia è spesso usata come strumento di oppressione o controllo, mentre nella letteratura utopica la tecnologia è spesso usata per migliorare la vita delle persone e migliorare il loro benessere.
Uguaglianza e giustizia: le società distopiche sono spesso caratterizzate da livelli estremi di disuguaglianza e ingiustizia sociale, mentre le società utopiche mirano all’uguaglianza e alla giustizia per tutti.
La letteratura distopica funge da monito sui pericoli delle società oppressive, mentre la letteratura utopica presenta una visione idealizzata di una società perfetta. Sebbene entrambi i tipi di letteratura offrano visioni avvincenti del futuro, hanno obiettivi e temi fondamentalmente diversi. Ecco alcuni esempi di letteratura popolare distopica e utopica.
Letteratura distopica:
“1984” di George Orwell. Questo romanzo classico descrive una società totalitaria in cui il governo controlla ogni aspetto della vita dei cittadini e sopprime il dissenso attraverso la manipolazione e la sorveglianza.
“The Handmaid’s Tale” di Margaret Atwood. Ambientato in un futuro degli Stati Uniti, questo romanzo ritrae una società in cui le donne sono private dei loro diritti e costrette a servire come surrogati riproduttivi di uomini potenti.
“Brave New World” di Aldous Huxley. Questo romanzo descrive una società futuristica in cui i cittadini sono condizionati dalla nascita ad accettare i loro ruoli predeterminati nella società, e dove il piacere e il consumo sono gli obiettivi primari della vita.
“The Hunger Games” di Suzanne Collins. Ambientata in un Nord America post-apocalittico, questa serie segue un gruppo di adolescenti che sono costretti a partecipare a una lotta televisiva all’ultimo sangue come mezzo di controllo sociale da parte del governo al potere.
Letteratura utopica:
“Utopia” di Thomas More. Quest’opera influente, pubblicata all’inizio del XVI secolo, descrive una società ideale in cui i cittadini vivono in uguaglianza, pace e prosperità.
“Looking Backward” di Edward Bellamy. Questo romanzo, pubblicato alla fine del XIX secolo, ritrae una società futura in cui la ricchezza è condivisa equamente e i cittadini vivono in armonia e cooperazione.
“Walden Two” di B.F. Skinner. Questo romanzo esplora la possibilità di una società utopica basata sui principi di comportamentismo e management scientifico.
“The Dispossessed” di Ursula K. Le Guin. Questo romanzo racconta la storia di un fisico che vive su un pianeta anarchico utopico dove le persone vivono in libertà e uguaglianza.
Sia la letteratura distopica che quella utopica fungono da potenti strumenti per esplorare le possibili conseguenze delle tendenze e dei valori della società e per immaginare futuri alternativi.
Francesco Borgonovo, nella prefazione al libro inizia la presentazione del libro con questa frase: “Non possiamo non dirci reazionari”. Boni Castellane conclude il suo libro, suddiviso in XXIII capitoli, dopo avere segnalato “le scelte del nuovo passaggio al bosco”, conclude affermando che “tale è la vita in terra ostile”, il nostro presente distopico.
Il libro analizza la situazione attuale del mondo e della società, evidenziando come viviamo in un mondo ostile perchè invivibile, in una forma di schiavitù senza possibilità di affrancamento, con la negazione dei limiti naturali. La sua è una critica sociale totale.
L’autore sembra avere l’obiettivo di cambiare non solo i comportamenti e le abitudini delle persone, ma di modificarne radicalmente la vita, la costituzione e persino la biologia. Il libro è una lettura non facile, davvero distopica e reazionaria. Confesso che ho ripreso tra le mani il libro di Leibniz …
[image error]MEDIUM
- Antonio Gallo's profile
- 52 followers



