Giovanni De Matteo's Blog: Holonomikon, page 3
October 17, 2023
Il futuro delle serie
Ovviamente, non posso fare altro che sperare che i diritti opzionati per la serie di Briganti si traducano in qualcosa di concreto, ma allo stesso tempo non posso ignorare che il mondo della serialità, che più di ogni altro ha cambiato negli ultimi 15-20 anni il modo di concepire, costruire e raccontare storie complesse incentrate su personaggi multidimensionali, ha già iniziato a cambiare nuovamente pelle: la prossima era, in cui già cominciamo a muovere i primi passi, prevede un progressivo abbandono di temi sfidanti e del modello rischioso fondato su temi scomodi o comunque in grado di accendere discussioni (e di tabù Sezione π² e Corpi spenti ne infrangono qualcuno) e su personaggi disfunzionali (come sono quelli intorno a cui ruotano le mie storie), a favore del recupero del vecchio formato confezionato per soddisfare i palati del pubblico più ampio possibile, e per questo basato trame lineari se non proprio verticali, necessariamente accessibili, in grado di assicurare il ritorno dell’investimento.

Al cinema, in realtà, il vecchio modello non ha mai lasciato molto spazio al nuovo: è stato nella serialità che la sfida è risultata vincente in questi ultimi anni, perché nella serialità si è potuto osare di più, grazie all’audacia di nuovi player alla disperata ricerca di una formula in grado di sovvertire lo status quo della fruizione generalista tradizionale. Il prevalere di fenomeni come il binge watching ha sancito l’esito della scommessa e la scoperta del tanto ambito Sacro Graal dell’intrattenimento continuo, multipiattaforma e dal seguito social: le piattaforme di streaming hanno conquistato quote di mercato sempre più larghe, arrivando a diventare dominanti con un sorpasso epocale portato a termine nel corso del 2022, e hanno potuto fissare gli standard di un modello poco sostenibile ma valido anche per i concorrenti. Lo spiega molto bene questo articolo uscito ieri sul Post e non faccio fatica a crederci.
Le case di produzione (cioè le società che le serie le inventano e poi le realizzano dopo averle proposte a un canale o una piattaforma che accetta di finanziarle) spesso raccontano come gli stessi committenti che prima chiedevano qualcosa di coraggioso oggi vogliano prodotti sicuri e adatti al grande pubblico. Anche i canali che avevano costruito un business intorno all’idea di serie di prestigio sono diventati altro, spinti a seguire economie di scala e a crescere sempre di più, il che significa attirare un pubblico più ampio, cosa per la quale è necessaria una programmazione buona per tutti e quindi con un carattere più vicino alla televisione generalista.

Benché, specialmente in ambito cinematografico, la storia della fantascienza sia scandita da fallimenti di grande successo (o capolavori che si sono rivelati dei flop al botteghino, a seconda di come la si voglia guardare), da Blade Runner a GATTACA, da Strange Days a Blade Runner 2049 (per chiudere il cerchio), era nella serialità che la science fiction, da Battlestar Galactica in poi, sembrava aver trovato una sua dimensione in grado di coniugare il coraggio di un certo approccio sperimentale a produzioni, almeno nelle loro stagioni di esordio, poco più che indipendenti (penso tra le altre a The Man in the High Castle, Stranger Things, The Handmaid’s Tale, Love, Death & Robots e alla sfortunata Raised by Wolves o, sul versante della vecchia guardia, a Westworld, The Expanse e Watchmen).
Certo, esistono sempre le eccezioni, e per nominare una serie che non ho ancora citato magari prima o poi salterà fuori una nuova Stranger Things. Tuttavia, nessuna delle produzioni avviate negli ultimi anni sembra destinata a prenderne il posto (come sottolinea l’articolo citato) e appare sempre meno probabile che la ricerca della prossima Stranger Things sia perseguita dai produttori con la sistematica tenacia che abbiamo visto finora. E questa è un’inevitabile conseguenza del cambio di modello di business che sta prendendo forma.
Mi piacerebbe sbagliarmi. Spesso succede. Magari succederà anche stavolta.

Sezione psico-cinemato-grafica
La notizia è ormai della settimana scorsa, ma torneremo a parlarne anche perché ci sono altre novità che stanno maturando dietro le quinte, dove si consuma la gran parte del lavoro di chi scrive: la Fast Film, casa di produzione di recente costituzione (come dimostra il sito ancora in allestimento), ha opzionato i diritti cinematografici, televisivi e audiovisivi di Sezione π² e di Corpi spenti, i due romanzi incentrati sulla figura di Vincenzo Briganti e sui suoi agenti della Sezione Investigativa Speciale di Polizia Psicografica di Napoli.
Si tratta di un traguardo che non potevo nemmeno lontanamente prevedere quanto iniziavo a scrivere questa serie e a cui tanto meno potevo pensare di aspirare, ma alla fine è successo e sono doppiamente felice perché, al di là del risvolto personale, sancisce un interesse da parte di un circuito totalmente estraneo al mondo della fantascienza scritta in Italia per ciò che in questo mondo viene elaborato, prodotto e pubblicato. Un risultato tutt’altro che scontato, chiunque sia direttamente coinvolto, e quale che sia l’opera baciata dalla sorte.
Come sa bene chi bazzica questo mondo da un po’, non è comunque il caso di farsi troppe illusioni. I diritti opzionati che arrivano infine sul grande o sul piccolo schermo sono una piccola frazione delle acquisizioni totali che interessano l’editoria, ma ci sono dei potenziali investitori che hanno colto degli elementi di interesse in Briganti e nei suoi necromanti, e questo per il momento è abbastanza. È un risultato per cui sono grato a Urania e al suo curatore attuale, Franco Forte, a chi ha seguito la trattativa per conto dell’ufficio Movie&Domestic Rights di Mondadori, e naturalmente a Sergio Altieri e Giuseppe Lippi, all’epoca rispettivamente editor e curatore di “Urania”, che hanno creduto al lavoro di un giovane poco più che ventenne al punto da volergli offrire un’opportunità sulle pagine della più antica collana di fantascienza in circolazione. Senza di loro, non saremmo qui a commentare questa per me splendida notizia.
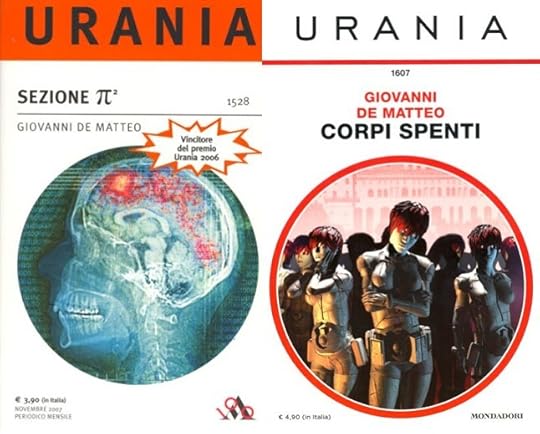
September 22, 2023
Dopo il vento, la tempesta
Momento di autopromozione spiccia, ma non poi così fine a se stessa. Finalmente è in uscita un’antologia che chi ci ha lavorato aspettava da un po’: la data è il 7 novembre, non proprio dietro l’angolo insomma, ma se ne comincerà a parlare già a Strani Mondi il prossimo 14-15 ottobre.
Come anticipa Carmine Treanni, che con Luca Ortino ne ha curato la selezione e scritto il saggio conclusivo che inquadra la climate fiction, il titolo è un omaggio neanche troppo velato a J. G. Ballard e al suo romanzo d’esordio, nonché primo tassello della sua tetralogia delle catastrofi naturali dedicate ai quattro elementi.
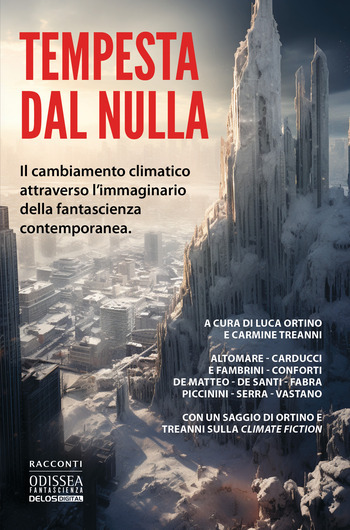
Nell’antologia, sono presente con un racconto che ho scritto nella prima metà del 2022 sullo slancio di un’ispirazione e di una motivazione ritrovati. S’intitola Santuario e parla di cambiamenti su diverse scale, dal tempo profondo della geologia a quello centenario delle società umane, per scendere fino alla granularità frammentata delle vite umane, che tuttavia, a volte, possono ritrovarsi a essere sconvolte dall’arrivo di un fronte d’onda nato nel passato, ma che nell’intervallo di pochi decenni ha saputo guadagnare abbastanza energia da stravolgere ogni cosa, spazzando via certezze che credevamo granitiche e convinzioni che dubitavamo potessero cedere il passo a una consapevolezza diversa. Santuario è, in diverse forme, un racconto sull’energia, il primo su questo tema con cui mi misuro in realtà ogni giorno da qualcosa come sedici anni. Ed è un racconto sul mutamento e sull’evoluzione, dell’uomo come specie e delle società che costruisce.
Credo che sia in fondo un lavoro molto tecnico ma anche un po’ poetico, e anche in questo racchiude la quintessenza di quello che dovrebbe essere il connettivismo. Ringrazio qui i curatori e in particolare Carmine per avermi invitato a partecipare al progetto, offrendomi l’occasione per cimentarmi con un tipo di scrittura per molti aspetti diverso dalla comfort zone a cui ero abituato.
June 18, 2023
La prigione della realtà
Ogni volta che muore uno scrittore con cui avverto una risonanza, o che in qualche modo ha avuto un’influenza sulla costruzione delle lenti attraverso cui osservo il mondo, non posso fare a meno che tornare alle sue pagine. A volte sono libri che ho già letto e a cui torno come si farebbe ritorno in una casa che abbiamo abitato per un po’, prima di partire per nuove destinazioni (non è così, in fondo, per tutti i libri che leggiamo, almeno i più belli?). Altre sono libri che mi prefiggevo da tempo di leggere ma che per un motivo o per l’altro (crediamo ci sia sempre tempo, per le cose importanti che necessitano di quel tempo) sono rimasti ad accumularsi sulle mensole della libreria. Era successo l’anno scorso con Valerio Evangelisti. Ed ero ancora immerso nelle sue pagine, quelle familiari intrise di un senso di claustrofobia di Cherudek e quelle crudeli e violente che leggevo per la prima volta di Veracruz, quando è arrivata la notizia della morte di Cormac McCarthy.
 Cormac McCarthy Photograph © Beowulf Sheehan http://www.beowulfsheehan.com (via
Literary Hub
)
Cormac McCarthy Photograph © Beowulf Sheehan http://www.beowulfsheehan.com (via
Literary Hub
)Adesso, leggere Sunset Limited potrebbe non essere stata la scelta migliore, mentre ero ancora intriso del mood di Cherudek e delle riflessioni di Mark Fisher, ma di sicuro ha amplificato quella risonanza, quel senso di sintonia con alcune considerazioni, sensazioni o convinzioni, che vanno montando da un po’, stratificandosi tra i miei pensieri, condizionando il mio modo di vivere e agire il mondo.
Il libro è un testo teatrale portato in scena per la prima volta nel 2006 a Chicago, e in seguito adattato anche per la televisione da Tommy Lee Jones, che lo ha interpretato con Samuel L. Jackson. Protagonisti sono due uomini con una vita di dolore e rabbia alle spalle, ma mentre il Nero ha trovato una via d’uscita da questa gabbia di oscurità (“Ho avuto quello che mi serviva invece di quello che volevo, e questa è grossomodo la più grande fortuna al mondo“, sostiene a pag. 100 dell’ultima edizione Einaudi del 2017, nella traduzione di Martina Testa), il Bianco continua a vivere in un “mondo buio“, in cui si sente in trappola.

Una mattina il Nero evita al Bianco di trasformarsi in un “pendolare terminale“, strappandolo dalle rotaie davanti al Sunset Limited in arrivo. Lo porta a casa sua, in uno squallido caseggiato popolato di tossici e crackomani, e inizia tra i due un lungo dialogo sui massimi sistemi: la vita, la morte, il destino dell’uomo, il senso del mondo. Una pagina prima, dopo una lunga insistenza da parte del Nero, il Bianco si era finalmente risolto a dichiarare il suo punto di vista:
Per me il mondo è fondamentalmente un campo di lavori forzati da cui ogni giorno si estraggono a sorte i detenuti – completamente innocenti – perché vengano giustiziati. Non è così che la vedo. E’ così che è. Esistono pareri diversi? Certo. Resistono a un esame approfondito? No.
Ma è un confronto che li porta a lambire un po’ tutto lo scibile umano, dalla musica di John Coltrane al metodo scientifico, dalla storia alla letteratura, diventando ben presto un esercizio olistico di critica, come in questo passaggio capace di coniugare fisica quantistica e narratologia:
BIANCO La Bibbia è piena di storie che devono servire da ammonimento. Anzi, ne è piena tutta la letteratura, se è per questo. Ci dicono di stare attenti. Attenti a cosa? A non prendere la strada sbagliata. Il sentiero sbagliato. Quante ne esistono, di strade sbagliate? Un numero infinito. E di strade giuste? Una sola. [pag. 57]
Il Bianco è un pessimista, un disilluso, e in diversi momenti sembra richiamare direttamente la lezione di Thomas Ligotti. Cormac McCarthy non compare nel lungo elenco di nomi e di titoli di cui il maestro delle tenebre fa menzione nelle sue interviste, ma giudicate un po’ voi davanti a una pagina come questa:
BIANCO Ok. Forse ha ragione. Va bene, ecco le notizie che ho da darle, reverendo. Io anelo all’oscurità. Io prego che arrivi la morte. La morte vera. Se pensassi che da morto incontrerei le persone che ho conosciuto in vita, non so cosa farei. Sarebbe la cosa più orrenda. Il colmo della disperazione. Se dovessi incontrare mia madre e ricominciare tutto daccapo, ma stavolta senza la prospettiva della morte a consolarmi… Be’, quello sarebbe l’incubo finale. Kafka coi controfiocchi.
NERO Cazzo, professore. Non vuoi rivedere tua mamma?
BIANCO No, per niente. Gliel’ho detto che si sarebbe arrabbiato. Io voglio che i morti restino morti. Per sempre. E voglio essere uno di loro. Sennonché, ovviamente non si può essere uno di loro, perché ciò che non esiste non può formare una comunità. Ecco: nessuna comunità. Mi si scalda il cuore soltanto all’idea. Silenzio. Buio. Solitudine. Pace. E tutto questo, nell’arco di un battito di ciglia.
NERO Cazzo, professore.
BIANCO Mi faccia finire. Io non considero il mio stato mentale una visione pessimistica del mondo. Io lo considero equivalente al mondo così com’è. L’evoluzione non potrà non condurre la vita intelligente alla consapevolezza di una certa cosa sopra tutte le altre, e questa cosa è la futilità. [pag. 109-110]
Ecco di cosa stiamo parlando, per intenderci. E ogni giorno di più ho la sensazione che la sofferenza sia davvero una costante ineluttabile, nelle nostre vite. Le cose possono andarci tanto bene da oltrepassare le nostre più rosee aspettative, eppure ci sarà sempre quel rumore di fondo a ricordarci che manca qualcosa, che qualcosa potrebbe andare meglio, che quella certa cosa poteva essere fatta meglio. Non è di insoddisfazione che sto parlando, ma proprio di vincoli, di oneri che ci opprimono, che ci schiacciano le spalle e il petto e ci impediscono di riempirci i polmoni di quell’ossigeno vitale di cui avremmo bisogno per dare sfogo alla nostra gioia. Nessuno è davvero libero, e nessuno, che se ne renda conto o meno, può trascendere la verità finale.
Perché, dopotutto, siamo tutti soli anche quando non siamo davvero soli: siamo soli con noi stessi davanti ai bilanci di natura personale, a quei piccoli check point con cui periodicamente sottoponiamo al vaglio ciò che abbiamo fatto e ciò che stiamo facendo, a quegli esami in cui ci misuriamo rispetto all’ideale che avevamo in mente quando abbiamo scelto di essere una determinata persona o fare una certa vita. Questo è qualcosa a cui non possiamo sfuggire, e non saranno le parole delle persone che abbiamo intorno, nemmeno le più vicine, a poter intercedere per noi con l’ultimo giudice a cui ognuno di noi si trova a rendere conto: sé stesso.
Possiamo nasconderci dietro alla facciata che ci siamo dati, dietro l’apparenza delle maschere che indossiamo ogni giorno, ma sotto è con questo che dobbiamo confrontarci. E sono qui che mi trastullo con queste riflessioni quando mi capita davanti questa visione di Hulk firmata da Mark Fielding:

Sembra un segnale dall’universo, no? Uno di quei messaggi che la realtà ti manda per metterti alla prova, per testare la tenuta delle tue convinzioni. Cosa dire, se non sposare ancora una volta le parole del Bianco di McCarthy, che qui entrano in risonanza con immagini di orrore cosmico in grado di richiamare addirittura H. P. Lovecraft:
La rabbia, di fatto, la provo solo nei giorni migliori. Ma in verità non me n’è rimasta molta. In verità le forme che vedo si sono andate pian piano svuotando. Non hanno più nessun contenuto. Sono soltanto figure. Un treno, un muro, un mondo. O un uomo. Una cosa che penzola con le sue espressioni insensate in mezzo a un vuoto ululante. Senza che ci sia alcun significato nella sua vita. Nelle sue parole. [pag. 112-113]
Dialogo sopra i massimi sistemi (con rivelazione metafisica finale)
S: Davide, quando eri un angelo, ce l’avevi la televisione?
D: Sì, però era senza bocca (sic).
S: E ti manca Dio?
D: No, non mi manca zio, l’ho visto ieri.
S: Non zio, Dio!
D: No, zio.
S: Davide, non zio, dicevo Dio.
D: Ma quello non è Dio, è una gru grande grande.
June 11, 2023
Piccoli film a colori
Ancora Mark Fisher, ancora J. G. Ballard. Leggo del progetto Tiny Colour Movies di John Foxx in un pezzo di Fisher antologizzato in Spettri della mia vita e mi fiondo ad ascoltare Skyscraper su YouTube sulla risonanza che innesca nella mia testa il collegamento alle sonorità di Vangelis per Blade Runner.
Nel brano ritrovo effettivamente quelle atmosfere, ma c’è in effetti anche altro, o forse sono atmosfere che sembrano simili, ma in realtà tradiscono uno spirito diverso. Perché se ogni nota di Vangelis ci parlava (e ci parla ancora) del futuro – sorvoliamo al momento se si tratti di un futuro che non è stato, da cui la nostalgia, o di un futuro che si è fin troppo inverato, da cui il rimpianto per un futuro ormai passato in cui avremmo fatto in tempo a correggere la traiettoria della storia – è invece vero che quella di John Foxx è più un’operazione che Fisher riconduce giustamente allo slowtime, “un tempo di distacco meditativo dalla confusione del presente”.
Il video, con quegli spezzoni decontestualizzati di riprese di grattacieli, le dissolvenze con le performance di Foxx, trasferisce lo spettatore/ascoltatore in una dimensione parallela. Un mondo in grado di esaltare sulla scala delle megalopoli lo smarrimento che proviamo davanti ai quadri surrealisti di Paul Delvaux o Giorgio De Chirico, in cui la metropoli progressivamente slitta – come le ombre dei palazzi fuori campo che scorrono in timelapse sulle facciate dei palazzi inquadrati – nella condizione di necropoli, e i suoi abitanti diventano spettri di passaggio. E ancora le dissolvenze, i tramonti, i bagliori del giorno sui grattacieli (c’è anche molto Hopper, nella luce che illumina quasi dolorosamente alcune sequenze), mentre le ombre della notte affiorano dalle strade.
Quando la notte trascorre e le insegne al neon che hanno intessuto con i fari delle auto una danza mistica si sciolgono nella luce spettrale di un nuovo giorno sospeso fuori dal tempo, si ha la sensazione di aver assistito davvero a un rito negromantico, un’evocazione che ha messo in comunicazione epoche diverse, che forse abbiamo abitato o altrimenti ricordiamo soltanto di aver abitato. Spazi a cui torneremo, quando da fantasmi torneremo a mischiarci con le ombre.
June 10, 2023
Hauntologia ballardiana
Tra Mark Fisher e J. G. Ballard, come relitti del futuro, si moltiplicano nel panorama mediatico i segni di una dimensione che siamo solo convinti di conoscere e di comprendere. Una dimensione in cui siamo tutti prigionieri, giocando il ruolo di operatori inconsapevoli.

August 18, 2022
Redonda, il regno degli scrittori
Di Matthew Phipps Shiel abbiamo già scritto, a proposito del suo capolavoro di fantascienza post-apocalittica La nuvola purpurea. Sul Post Libri Ludovica Lugli ha esplorato un’ulteriore ramificazione della sua storia, che parte dall’incoronazione da parte di suo padre Matthew Dowdy Shiell, che volle così celebrare la nascita di un figlio maschio dopo tante femmine, e di scrittore in scrittore, attraverso un labirinto di testi molto postmoderno tenuto attualmente in vita da Javier Marías, arriva fino a noi: la storia del Regno di Redonda.
August 13, 2022
La Biblioteca del Futuro
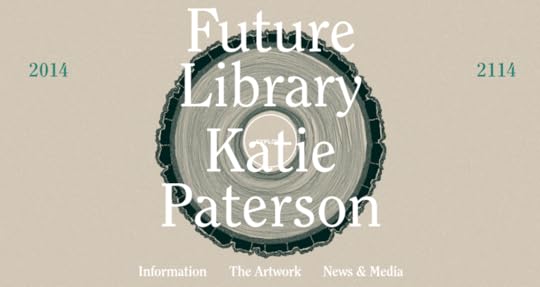
La Biblioteca del Futuro (Future Library, in norvegese Framtidsbiblioteket) nasce a Oslo da un progetto dell’artista scozzese Katie Paterson nel 2014. Da allora raccoglie ogni anno il manoscritto inedito di un autore o un’autrice internazionali destinato a essere custodito nella cosiddetta Silent Room per essere pubblicato solo nel 2114. In questi anni hanno preso parte all’iniziativa autori di prima grandezza come Margaret Atwood (Il racconto dell’ancella), Han Kang (Atti umani) e David Mitchell (Cloud Atlas), che all’inizio per la verità era scettico sulla valenza dell’operazione, ma poi ha dovuto ricredersi.
Il progetto si prefigge infatti di mettere in condizione gli autori di misurarsi con il pensiero a lungo termine, qualcosa che trascende le loro vite, e quelle dei lettori che avranno la possibilità di misurarsi con le loro opere: tutti gli autori che prenderanno parte alla Biblioteca prima della metà di questo secolo (e plausibilmente molti tra quelli che verranno anche dopo) scriveranno infatti lavori destinati a essere letti da generazioni nemmeno ancora nate al momento della stesura. Inoltre, i contributi che si aggiungeranno alla Biblioteca nel corso del tempo risentiranno inevitabilmente del mutare delle condizioni (politiche, sociali, economiche, culturali) in cui saranno scritti, attraversando un secolo intero di vita sulla Terra, e di sicuro il secolo più ricco di eventi, sconvolgimenti e ricadute tecnologiche tra tutti quelli trascorsi dalla comparsa di quel fenomeno che va sotto il nome di civiltà.
La Biblioteca del Futuro richiama un po’ anche l’intento della Long Now Foundation, che lavora su una scala temporale persino più ampia (10000 anni). L’idea, come scrive BBC Future, è ispirare le persone a superare le distrazioni momentanee e riflettere sulle responsabilità nei confronti delle generazioni che abiteranno il pianeta dopo di noi, promuovendo una prospettiva lungimirante sul futuro. Questo è il sito ufficiale della Future Library.
Trovo che, in un’epoca come la nostra, iniziative come queste dovrebbero fiorire un po’ dappertutto, finché non si sarà raggiunta una consapevolezza tale da poter dare per scontato che le nostre scelte nel presente possono avere una ricaduta a lungo termine, anche oltre l’orizzonte della nostra permanenza sulla Terra.
May 28, 2022
Su Evangelisti
L’articolo che avevo annunciato è online da alcuni giorni su Quaderni d’Altri Tempi. È un pezzo a cui tengo molto e che allo stesso tempo avrei preferito non dover scrivere.




