Amedeo Balbi's Blog, page 22
April 11, 2011
Domani
Domani fanno cinquant'anni esatti da quando Yuri Gagarin ha fatto il primo giro nello spazio intorno alla Terra. Qui c'è una cosa che ho scritto oggi per il Post. Domani invece sarò a parlare anche di Gagarin, ma non solo, alle 9 su Class News MSNBC, e poi alle 10.30 su Radio1, nella trasmissione Start.
Sempre domani, verrà reso pubblico First Orbit, un film pensato per chi vuole provare a rivivere in prima persona l'esperienza di Gagarin: è stato realizzato usando filmati girati da Paolo Nespoli sulla Stazione Spaziale Internazionale seguendo il percorso di quella prima orbita, montati insieme all'audio originale dell'epoca e a una nuova colonna sonora.





Sempre domani, verrà reso pubblico First Orbit, un film pensato per chi vuole provare a rivivere in prima persona l'esperienza di Gagarin: è stato realizzato usando filmati girati da Paolo Nespoli sulla Stazione Spaziale Internazionale seguendo il percorso di quella prima orbita, montati insieme all'audio originale dell'epoca e a una nuova colonna sonora.





Published on April 11, 2011 10:43
April 8, 2011
Si fa presto a dire "wow!"
Una delle domande ricorrenti di fronte a una bella immagine astronomica è: ma i miei occhi, di fronte a un oggetto del genere, cosa vedrebbero? Quanto è "realistica" la foto che sto osservando?
Qualunque foto è un'elaborazione della realtà, è ovvio. Ma nel caso delle immagini astronomiche la questione è un po' più complessa. Intanto, c'è il problema dei "falsi colori", che vengono assegnati in modo arbitrario per isolare informazioni provenienti da diverse bande elettromagnetiche. Ma, su questo, ho già scritto qualcosa in passato.
C'è però un altro aspetto, che ha a che fare con la limitata capacità degli occhi di osservare oggetti poco luminosi. Da ragazzini, siamo rimasti tutti a bocca aperta di fronte a questa scena:

Luke e Leia (o Leila, fate voi), da quello che sembra, stanno guardando una galassia a spirale, come la nostra Via Lattea. Sarebbe bello poter assistere a uno spettacolo del genere, no? Qualcosa ci dice che nella vita reale non è possibile, e in effetti è così. Ma la ragione non è quella che ci aspetteremmo. Il problema non è che ci manca un'astronave per poter avvicinarci a una galassia (o uscire dalla nostra per guardarla da fuori). Una galassia è un oggetto molto grande: per vederla così estesa, nel cielo, Luke e Leia non devono essersi avvicinati poi molto (relativamente parlando).
Prendiamo la galassia di Andromeda. È la più vicina alla nostra. Vicina si fa per dire: due milioni e mezzo di anni luce, ma insomma. È comunque abbastanza vicina da occupare una regione di cielo piuttosto grande: tra i tre e i quattro gradi. Per dare un'idea di quanto è grande, possiamo confrontarla con il disco lunare:

Credit: REU program, N.A.Sharp/NOAO/AURA/NSF
Più o meno ci siamo: quanto a grandezza, sembra proprio come la galassia che stanno guardando Luke e Leia. Ma perché, allora, alzando gli occhi al cielo non vediamo una cosa del genere? Ancora un po' di pazienza, ci stiamo arrivando.
Per specificare quanto ci appare luminoso un oggetto celeste, gli astronomi usano un numero: la magnitudine apparente. È un'unità di misura un po' strana. Più un oggetto appare luminoso, più è piccola la magnitudine. Il Sole, visto dalla Terra, è talmente luminoso che la sua magnitudine apparente è negativa: -26.74. La Luna piena ha una magnitudine apparente di -12.92. Ed ecco un'altra stranezza della magnitudine: è un'unità logaritmica. Quando la magnitudine aumenta di 1, la luminosità diminuisce di circa 2,5 volte. Quindi, la Luna è molto meno luminosa del Sole: ci sono circa 14 magnitudini di differenza, il che significa che la Luna è 2,5 elevato alla 14 volte meno luminosa del Sole. Ovvero, quasi quattrocentomila volte meno luminosa.
Bene, ci siamo quasi. Cerchiamo informazioni sulla magnitudine apparente della galassia di Andromeda, e troviamo 3.4. Ci sono circa 16,32 magnitudini di differenza con la Luna piena. Quindi, a conti fatti, la galassia di Andromeda è circa tre milioni di volte meno luminosa della Luna. Il confronto di sopra tra la Luna e Andromeda, dunque, è realistico per quanto riguarda le dimensioni, ma non per la luminosità.
Ma non è finita. Infatti, in buone condizioni di visibilità, si possono vedere a occhio nudo stelle di magnitudine compresa tra 3 e 4. Ma la galassia di Andromeda non è un puntino, come una stella: è un oggetto esteso. Questo significa che la stessa luminosità è "diluita" su un'area più grande, e i nostri occhi fanno più fatica a vederla chiaramente. Anche usando un telescopio, la luce della galassia dovrebbe depositarsi per un tempo sufficientemente lungo sul sensore di una fotocamera, prima di formare un'immagine del genere. Quando guardiamo un'immagine astronomica, quindi, dobbiamo sempre tenere presente che c'è voluto un certo tempo di osservazione, magari molto lungo, per ottenerla.
Morale della favola: Luke, Leia, e noi stessi, non possiamo assistere direttamente a uno spettacolo del genere. Ma non escluderei che R2-D2 e C-3PO possano farcela, beati loro.





Qualunque foto è un'elaborazione della realtà, è ovvio. Ma nel caso delle immagini astronomiche la questione è un po' più complessa. Intanto, c'è il problema dei "falsi colori", che vengono assegnati in modo arbitrario per isolare informazioni provenienti da diverse bande elettromagnetiche. Ma, su questo, ho già scritto qualcosa in passato.
C'è però un altro aspetto, che ha a che fare con la limitata capacità degli occhi di osservare oggetti poco luminosi. Da ragazzini, siamo rimasti tutti a bocca aperta di fronte a questa scena:

Luke e Leia (o Leila, fate voi), da quello che sembra, stanno guardando una galassia a spirale, come la nostra Via Lattea. Sarebbe bello poter assistere a uno spettacolo del genere, no? Qualcosa ci dice che nella vita reale non è possibile, e in effetti è così. Ma la ragione non è quella che ci aspetteremmo. Il problema non è che ci manca un'astronave per poter avvicinarci a una galassia (o uscire dalla nostra per guardarla da fuori). Una galassia è un oggetto molto grande: per vederla così estesa, nel cielo, Luke e Leia non devono essersi avvicinati poi molto (relativamente parlando).
Prendiamo la galassia di Andromeda. È la più vicina alla nostra. Vicina si fa per dire: due milioni e mezzo di anni luce, ma insomma. È comunque abbastanza vicina da occupare una regione di cielo piuttosto grande: tra i tre e i quattro gradi. Per dare un'idea di quanto è grande, possiamo confrontarla con il disco lunare:

Credit: REU program, N.A.Sharp/NOAO/AURA/NSF
Più o meno ci siamo: quanto a grandezza, sembra proprio come la galassia che stanno guardando Luke e Leia. Ma perché, allora, alzando gli occhi al cielo non vediamo una cosa del genere? Ancora un po' di pazienza, ci stiamo arrivando.
Per specificare quanto ci appare luminoso un oggetto celeste, gli astronomi usano un numero: la magnitudine apparente. È un'unità di misura un po' strana. Più un oggetto appare luminoso, più è piccola la magnitudine. Il Sole, visto dalla Terra, è talmente luminoso che la sua magnitudine apparente è negativa: -26.74. La Luna piena ha una magnitudine apparente di -12.92. Ed ecco un'altra stranezza della magnitudine: è un'unità logaritmica. Quando la magnitudine aumenta di 1, la luminosità diminuisce di circa 2,5 volte. Quindi, la Luna è molto meno luminosa del Sole: ci sono circa 14 magnitudini di differenza, il che significa che la Luna è 2,5 elevato alla 14 volte meno luminosa del Sole. Ovvero, quasi quattrocentomila volte meno luminosa.
Bene, ci siamo quasi. Cerchiamo informazioni sulla magnitudine apparente della galassia di Andromeda, e troviamo 3.4. Ci sono circa 16,32 magnitudini di differenza con la Luna piena. Quindi, a conti fatti, la galassia di Andromeda è circa tre milioni di volte meno luminosa della Luna. Il confronto di sopra tra la Luna e Andromeda, dunque, è realistico per quanto riguarda le dimensioni, ma non per la luminosità.
Ma non è finita. Infatti, in buone condizioni di visibilità, si possono vedere a occhio nudo stelle di magnitudine compresa tra 3 e 4. Ma la galassia di Andromeda non è un puntino, come una stella: è un oggetto esteso. Questo significa che la stessa luminosità è "diluita" su un'area più grande, e i nostri occhi fanno più fatica a vederla chiaramente. Anche usando un telescopio, la luce della galassia dovrebbe depositarsi per un tempo sufficientemente lungo sul sensore di una fotocamera, prima di formare un'immagine del genere. Quando guardiamo un'immagine astronomica, quindi, dobbiamo sempre tenere presente che c'è voluto un certo tempo di osservazione, magari molto lungo, per ottenerla.
Morale della favola: Luke, Leia, e noi stessi, non possiamo assistere direttamente a uno spettacolo del genere. Ma non escluderei che R2-D2 e C-3PO possano farcela, beati loro.





Published on April 08, 2011 04:23
April 7, 2011
Arretrati
Un paio di cose legate in qualche modo all'uscita del libro. Nell'inserto culturale del Fatto Quotidiano di due settimane fa c'era un mio articolo sul multiverso: si può leggere qui. Poi, la settimana scorsa, ho fatto una (lunga) intervista per la Radio Vaticana, che si può riascoltare qui.










Published on April 07, 2011 04:41
April 1, 2011
Il buio oltre le stelle
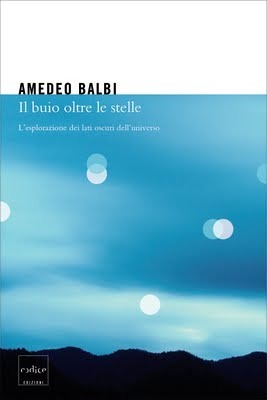
Dunque: è uscito il mio nuovo libro. Si chiama "Il buio oltre le stelle"
 , lo pubblica Codice, e costa 16 euro. Un po' più di duecento pagine che provano a raccontare l'esplorazione dei lati oscuri dell'universo, come dice il sottotitolo. Si parte dall'inizio, da quando il primo cannocchiale ha mostrato che nelle zone buie del cielo c'erano stelle che non si vedevano a occhio nudo, e si finisce con la materia oscura e poi con l'energia oscura, che non possiamo osservare direttamente e di cui sappiamo molto poco, nonostante costituiscano circa il 95% di tutto quello che c'è nell'universo. (Sempre che non abbiamo preso una grossa cantonata.)
, lo pubblica Codice, e costa 16 euro. Un po' più di duecento pagine che provano a raccontare l'esplorazione dei lati oscuri dell'universo, come dice il sottotitolo. Si parte dall'inizio, da quando il primo cannocchiale ha mostrato che nelle zone buie del cielo c'erano stelle che non si vedevano a occhio nudo, e si finisce con la materia oscura e poi con l'energia oscura, che non possiamo osservare direttamente e di cui sappiamo molto poco, nonostante costituiscano circa il 95% di tutto quello che c'è nell'universo. (Sempre che non abbiamo preso una grossa cantonata.)In anteprima, sul Post, potete leggere tutto il primo capitolo.
Il resto, come si dice, nelle migliori librerie, anche online.





Published on April 01, 2011 15:01
March 29, 2011
Tutti i pianeti di Kepler

L'infografica del giorno è l'elaborazione che raffigura gli oltre 1200 candidati di pianeti extrasolari della missione Kepler, in scala, assieme alla loro stella. Per riferimento, il Sole e Giove sono quelli fuori dalle righe, sulla destra in alto. Se volete vedere da vicino anche le stelle più piccole e i sistemi multipli, dovete ingrandire alla risoluzione più alta, che trovate qui. (Via APOD.)





Published on March 29, 2011 13:49
March 28, 2011
Relitti

Sembra un delicato anemone di mare, e invece è quello che resta di una supernova, uno degli eventi più violenti che avvengono nell'universo. Quei filamenti dall'apparenza batuffolosa sono in realtà potenti emissioni di raggi X osservate dal satellite Chandra, rilasciate da elettroni che si avvolgono intorno alle linee di forza del campo magnetico.
Se uno volesse farsi un'idea di quanto sia catastrofica la morte di una stella, questa immagine sarebbe un buon punto di partenza. Se non altro per una ragione molto semplice: essa è il residuo della supernova osservata a occhio nudo da Tycho Brahe nel 1572. Più di quattro secoli dopo, gusci di materiale espulso dalla stella morente si stanno ancora allontanando a velocità altissima dal centro dell'esplosione. Il diametro della regione è di circa 55 anni luce.
E per completare l'esperienza, si potrebbe fare un confronto con l'immagine di un altro residuo, quello della supernova osservata da Keplero nel 1604.






Published on March 28, 2011 06:33
March 26, 2011
Ancora una cosa
Un chiarimento per quanti arrivano da queste parti dopo i post dei giorni scorsi, e mi chiedono notizie aggiornate sulla situazione a Fukushima: io non ho notizie dirette, o diverse da quelle che avete voi. Leggo gli stessi giornali, vedo gli stessi servizi alla televisione e, soprattutto, cerco di leggere su internet la stampa internazionale e giapponese (in inglese), o i blog di persone sul posto, o resoconti ufficiali tecnicamente accurati, come quelli che si trovano su questo portale. E sono — al netto degli allarmismi isterici e delle grossolane imprecisioni — molto preoccupato per quello che leggo o sento, come è ovvio che sia. È evidente che la situazione nei reattori è molto seria e non ancora risolta, e che ci vorrà tempo prima che sia tecnicamente possibile avere una parola definitiva sull'entità dei danni e della contaminazione, e sulle loro cause.
Questa non è un'agenzia di stampa. È un blog che prova a spiegare un po' di scienza, e — mi ripeto — se ho scritto qualcosa sul nucleare è solo perché, in un momento di grande confusione, mi sembrava che ci fosse bisogno di strumenti per capire. E continuerò a farlo, se mi sembrerà di poter spiegare la scienza meglio di come la vedrò spiegata altrove.
Ma intanto spero solo, come tutti, che il Giappone possa riprendersi prima e meglio possibile da questa crisi. Che è l'unica cosa che conta davvero.





Questa non è un'agenzia di stampa. È un blog che prova a spiegare un po' di scienza, e — mi ripeto — se ho scritto qualcosa sul nucleare è solo perché, in un momento di grande confusione, mi sembrava che ci fosse bisogno di strumenti per capire. E continuerò a farlo, se mi sembrerà di poter spiegare la scienza meglio di come la vedrò spiegata altrove.
Ma intanto spero solo, come tutti, che il Giappone possa riprendersi prima e meglio possibile da questa crisi. Che è l'unica cosa che conta davvero.





Published on March 26, 2011 01:30
March 25, 2011
Un po' di bellezza
Negli ultimi mesi, a causa dell'aumento di attività solare, si sono viste aurore spettacolari nei cieli del nord. Questo è un montaggio di un paio di minuti, da vedere a schermo intero e in alta definizione.





Published on March 25, 2011 03:13
March 24, 2011
La nube
Tra ieri e oggi, è circolata la storia della "nube radioattiva" che doveva arrivare in Italia, storia che ha origine da notizie come questa (segnalatami in un commento al post precedente) o da filmati come questo, prodotto dall'istituto francese di sicurezza nucleare (ma in giro ce ne sono altri simili di altri istituti). La cosa è talmente risibile che nessun articolo di giornale ha potuto evitare di menzionare che non ci sono rischi reali, dalle nostre parti. Ma i titoli "la nube radioattiva arriva in Italia" li ho visti lo stesso.
Stiamo parlando di una simulazione del trasporto, per effetti di circolazione atmosferica, di eventuali elementi radioattivi (come il cesio-137) dispersi dalle centrali giapponesi. Che si tratti di un modello è scritto grande come una casa nel filmato (non bisogna sapere bene il francese per capirlo). Ma in ogni caso, avete notato le unità di misura in basso? Vi dicono di quanto si abbatte la concentrazione dell'elemento propagandosi nell'atmosfera, assumendo una certa concentrazione alla sorgente, cioè a Fukushima. Il fondo-scala dice max/100000000. Esatto, cento milioni di volte meno dell'ipotetico massimo di concentrazione presente nelle immediate vicinanze delle centrali in Giappone.
Tradotto in termini comprensibili: stare laggiù, a Fukushima, in questo momento è pericoloso. Ma quella nuvoletta gialla che si espande nel video può preoccuparvi solo se pensate di poter colorare l'oceano ribaltandoci un secchio di vernice. O se credete all'omeopatia.
Sarebbe fin troppo facile dire che l'unica nube che c'è, qui da noi, è quella del fumo dell'esagerazione intorno all'arrosto dei fatti.
È un continuo gioco al rialzo dello stimolo emotivo. Che talvolta arriva fino a vere e proprie creazioni letterarie, come nello strano caso di Futoshi Toba.





Stiamo parlando di una simulazione del trasporto, per effetti di circolazione atmosferica, di eventuali elementi radioattivi (come il cesio-137) dispersi dalle centrali giapponesi. Che si tratti di un modello è scritto grande come una casa nel filmato (non bisogna sapere bene il francese per capirlo). Ma in ogni caso, avete notato le unità di misura in basso? Vi dicono di quanto si abbatte la concentrazione dell'elemento propagandosi nell'atmosfera, assumendo una certa concentrazione alla sorgente, cioè a Fukushima. Il fondo-scala dice max/100000000. Esatto, cento milioni di volte meno dell'ipotetico massimo di concentrazione presente nelle immediate vicinanze delle centrali in Giappone.
Tradotto in termini comprensibili: stare laggiù, a Fukushima, in questo momento è pericoloso. Ma quella nuvoletta gialla che si espande nel video può preoccuparvi solo se pensate di poter colorare l'oceano ribaltandoci un secchio di vernice. O se credete all'omeopatia.
Sarebbe fin troppo facile dire che l'unica nube che c'è, qui da noi, è quella del fumo dell'esagerazione intorno all'arrosto dei fatti.
È un continuo gioco al rialzo dello stimolo emotivo. Che talvolta arriva fino a vere e proprie creazioni letterarie, come nello strano caso di Futoshi Toba.





Published on March 24, 2011 07:04
March 21, 2011
Dosi
Come avrete sentito da stampa e tv, tracce di elementi radioattivi (cesio-137 e iodio-131, per l'esattezza) sono stati trovati in alcuni campioni di latte e di spinaci nelle aree circostanti le centrali di Fukushima, e ne è stata vietata la vendita e il consumo. Giustissima precauzione da parte delle autorità giapponesi. Quello che stampa e tv italiane non vi danno, però (perché basta dire "radioattività nei cibi" e la notizia è fatta) sono dei punti di riferimento perché possiate valutare la gravità della contaminazione. Cosa che invece fa la stampa giapponese. Secondo le stesse autorità che hanno dato l'allarme, se qualcuno bevesse per un anno intero quel latte, riceverebbe la stessa quantità di radiazioni ricevuta quando si viene sottoposti a una TAC. Un anno di dieta a base di quegli spinaci, invece, corrisponderebbe a un quinto delle radiazioni assorbite in una TAC.
Nel frattempo, la miglior info-grafica per capire le dosi da radiazioni non l'ho vista su un giornale, ma sul blog di un vignettista. Che però ha una laurea in fisica.





Nel frattempo, la miglior info-grafica per capire le dosi da radiazioni non l'ho vista su un giornale, ma sul blog di un vignettista. Che però ha una laurea in fisica.





Published on March 21, 2011 14:00



