Alberto Prunetti's Blog, page 2
April 20, 2016
“Ve l’avevo detto…”
di Alberto Prunetti
 Quando il mi babbo mi diceva “te l’avevo detto”, mi stava sulle scatole. Però a volte aveva ragione. Sulla IPLOM di Busalla, sugli incidenti di quella raffineria che dalla costa attrae petrolio, lo raffina e lo spedisce alle industrie della Val Padana, sugli sversamenti di idrocarburi che lui conosceva bene… ce l’aveva detto. E mi sta sulle scatole sentirlo e sentirmi una sorta di Cassandra, ma la verità era sotto gli occhi di tutti, dalla Valle Scrivia alla creuza nei pressi di Genova. Basta un po’ di whitewashing aziendale a nascondere la verità? Chissà. Intanto consiglio la lettura di un paio di pagine di Amianto dove si parla della Iplom, dove Renato, mio padre, ha lavorato sette anni, tra un disastro industriale e un incidente, prima che le cellule dei suoi polmoni impazzissero. Quando ci passate accanto alla Iplom, sull’autostrada che porta a Milano, fate un piccolo esercizio yoga che si chiama pranayama. Ovvero respirate. A quel punto potrete capire Amianto, una storia operaia alla perfezione. Fino a entrare nei polmoni del protagonista, che quell’aria l’ha respirata sette anni. O nei polmoni di chi vive accanto alla raffineria, che la respira tutti i giorni.
Quando il mi babbo mi diceva “te l’avevo detto”, mi stava sulle scatole. Però a volte aveva ragione. Sulla IPLOM di Busalla, sugli incidenti di quella raffineria che dalla costa attrae petrolio, lo raffina e lo spedisce alle industrie della Val Padana, sugli sversamenti di idrocarburi che lui conosceva bene… ce l’aveva detto. E mi sta sulle scatole sentirlo e sentirmi una sorta di Cassandra, ma la verità era sotto gli occhi di tutti, dalla Valle Scrivia alla creuza nei pressi di Genova. Basta un po’ di whitewashing aziendale a nascondere la verità? Chissà. Intanto consiglio la lettura di un paio di pagine di Amianto dove si parla della Iplom, dove Renato, mio padre, ha lavorato sette anni, tra un disastro industriale e un incidente, prima che le cellule dei suoi polmoni impazzissero. Quando ci passate accanto alla Iplom, sull’autostrada che porta a Milano, fate un piccolo esercizio yoga che si chiama pranayama. Ovvero respirate. A quel punto potrete capire Amianto, una storia operaia alla perfezione. Fino a entrare nei polmoni del protagonista, che quell’aria l’ha respirata sette anni. O nei polmoni di chi vive accanto alla raffineria, che la respira tutti i giorni.
“Busalla è un piccolo paese in una vallata dell’Appennino ligure. Una corona di casette circondate dal verde dei boschi, tagliati dall’autostrada che da Genova sale fino a Milano. Ci vivono circa seimilacinquecento persone. Ma non sembra un paese, soprattutto passando dalla ferrovia o dall’autostrada Milano-Genova, di notte, quando decine di migliaia di tubi al neon creano un’allucinazione inquietante: un drago sbuffante di tubi e raccordi, un groviglio di cisterne, ciminiere e torrette, chilometri di tubature che sommergono Busalla e occupano la stretta valle Scrivia. La raffineria è dentro la valle, dentro la città e la gente vive prigioniera del drago. A poche decine di metri dalle abitazioni dei busallesi si lavorano gasoli, bitumi e oli combustibili e si realizza chimicamente la desolforazione dell’idrogeno.
Se poi una scintilla raggiunge una cisterna di gasolio e l’impianto si incendia, sembra sciogliersi anche l’asfalto per le strade di Busalla. Ma loro, i busallesi, sono costretti a vivere con il drago, come i tarantini, come i piombinesi: sono stretti nella morsa della fabbrica sia fisicamente, sia psicologicamente, perché lo stabilimento dà il ricatto del pane e pretende il diritto di inquinare. I sindacati del posto non sono descritti come particolarmente battaglieri – Renato lasciò per un anno le sue buste paga a un delegato busallese per avviare la prima volta la pratica Inps per i cosiddetti ‘benefici’ dei lavoratori esposti all’amianto: dovette andare a riprendersele dopo un anno senza che il tipo le avesse nemmeno tolte da un cassetto – mentre i proprietari mantengono le paghe un po’ più alte e fanno qualche investimento educativo per migliorare l’immagine aziendale.
Azienda che oltre a fatturare milioni di euro all’anno – da spartire tra la Finoil, la svizzera Energy Management e altre società statunitensi che rimandano alla francese Société Générale – alla gente del posto lascia qualcosa con cui campare e tanto inquinamento e malattie, come sostengono le associazioni locali che ne chiedono il trasferimento.
L’impianto di raffinazione è infatti notoriamente pericoloso, tanto da esser stato classificato ‘a rischio d’incidente rilevante” dal Dpr. 175/88: trasforma e lavora, tra le altre, sostanze chimiche contrassegnate dal marchio R45, che indica un elevato potere cancerogeno nell’uomo’. Una Taranto del nord, meno mastodontica forse, con le case a duecento metri dai muri che perimetrano i serbatoi pieni di greggio e un fiume a regime torrentizio che sfiora per un lato lo stabilimento. Mia madre si ricorda che Renato diceva di aver ricevuto una notte uno strano incarico: far la guardia al torrente per controllare che le acque non tracimassero invadendo la Iplom. Un impianto che ogni tanto rilascia una nube nera o versa idrocarburi nelle acque circostanti.
Una raffineria che è considerata come una bomba a orologeria pronta a esplodere. Che ogni tanto esplode. È successo nel 2008. E prima ancora nel 2005. E ancora nel 1991. Ma dagli anni ottanta si alternano ferimenti e ustioni di lavoratori, perdite oleose, sversamenti di idrocarburi nello Scrivia, nubi gassose. Il primo dei tre incendi più rilevanti riguarda questa stessa storia. Quella sera di fine agosto del 1991, quando dopo una vampata le fiamme si alzarono fino a venti metri, nel cuore del drago c’era anche Renato. Terrore, calore, paura che le fiamme arrivino al petrolio. Che tutto salti in aria. Le sirene che suonano, i feriti. Una nube acre, probabilmente tossica, che avvolge la vallata. La gente impazzita, fuori dallo stabilimento, che si ripara nei boschi. Gli operai in fuga, travolti e investiti dai soccorritori, come successe a un collega di Renato, come stava per succedere anche a lui. Voltarsi, schivare il furgone impazzito. Ambulanze. Vigili del fuoco. Carabinieri. Il sindaco minaccia. La proprietà promette indagini. Lavare l’immagine dell’azienda (istituire un paio di borse di studio per i figli degli operai). E i sindacalisti? ‘Ricordiamo ai compagni che criticare la fabbrica è come sputare sul piatto in cui si mangia.’ (‘E che cos’è questo fuoco? Pompieri, pompieri…’ cantava Piero Ciampi.)
E si ricomincia, mentre a Busalla si vive e ci si ammala sotto le zampe del drago.
Una serie di incidenti e la fastidiosa attività di controinformazione di un comitato civico obbligano la Iplom a elaborare un progetto di comunicazione per ripulire l’immagine dello stabilimento.
La strategia è abbastanza semplice e si articola in tre passi. Per cominciare, visita turistica di una scolaresca di un istituto commerciale genovese nella raffineria Iplom. Guide d’eccezione, un consulente per le relazioni esterne e il responsabile della sicurezza. Rientro in classe ed elaborazione – cito da “Il Secolo XIX” del 30 aprile 2002 – di ‘una fantasiosa campagna di marketing e comunicazione basata su slogan e fumetti, con protagonista una giovane e simpatica goccia di petrolio, per potenziare l’immagine della raffineria Iplom di Busalla sul territorio’. Di seguito, in maniera forse autoreferenziale, presentazione del progetto a presidente e amministratore delegato dell’azienda, con emissione di premi. ‘Fantasiosa’, la campagna di marketing, ben detto,perché chi ci lavorava nei primi anni novanta racconta altre cose.”
Le altre cose le trovate in Alberto Prunetti, Amianto, una storia operaia, Roma, Alegre, 2014.
March 15, 2016
Tris di incontri per oggetti narrativi ibridi
 Tre incontri in rapido avvicinamento tra Brescia e Bergamo. Domani, 16 marzo, presento PCSP (Piccola Controstoria Popolare) presso il Barrio Campagnola a Bergamo alle ore 21 (v. F. Dell’Orto 20). Il 17 marzo, la mattina incontro gli studenti di un Istituto tecnico professionale di Brescia per parlare di Amianto, una storia operaia, mentre alle 20,30 presento di nuovo PCSP nella casa del popolo E. Natali in via Risorgimento 18, sempre a Brescia.
Tre incontri in rapido avvicinamento tra Brescia e Bergamo. Domani, 16 marzo, presento PCSP (Piccola Controstoria Popolare) presso il Barrio Campagnola a Bergamo alle ore 21 (v. F. Dell’Orto 20). Il 17 marzo, la mattina incontro gli studenti di un Istituto tecnico professionale di Brescia per parlare di Amianto, una storia operaia, mentre alle 20,30 presento di nuovo PCSP nella casa del popolo E. Natali in via Risorgimento 18, sempre a Brescia.
February 2, 2016
Un compleanno, un triplete e un addio
Giornate di ricorrenze, di impegni e di partenze.
 In questi giorni abbiamo festeggiato i cinque anni della rivista Lavoro culturale: http://www.lavoroculturale.org/5-anni...
In questi giorni abbiamo festeggiato i cinque anni della rivista Lavoro culturale: http://www.lavoroculturale.org/5-anni...
Ricordo bene il lancio del seminario che fu uno dei primi atti dell’associazione culturale omonima. Nell’umida sala cinema della facoltà di Lettere di Siena io ragionai attorno al mio lavoro culturale di traduttore, mentre Wu Ming 1 tenne una memorabile conferenza su tempo, rivolta e utopia a partire da due opere di fantascienza: http://www.wumingfoundation.com/giap/... (andatevi a cercare il podcast).
Su Carmilla poi ripubblicai il post del lavoro culturale, firmato da Francesco Zucconi: http://www.carmillaonline.com/2011/01...

I 4 pard di PCSP per la matita di Dante Ossi
Venendo ai prossimi impegni, mi aspetta un impegnativo triplete: per ragioni che hanno a che vedere con bizzare sovrapposizioni, giovedì 4 febbraio a Bologna sarò presente in tre eventi.
_Alle 17,30 presso la Mediateca Gateway in via San Petronio Vecchio 33b farò un reading con brani di Amianto, una storia operaia e di PCSP: https://www.facebook.com/events/59875...
_Dalle 18,30 presso il BAR Dé Marchi in Piazza San Francesco, 4 PIUPRATEL e AFEVA Emilia Romagna organizzano un evento attorno al problema dell’amianto. Interverranno anche Andrea Caselli di Afeva e l’avvocato e scrittore Massimo Vaggi, mentre Il Teatro Subito leggerà brani del mio libro Amianto, una storia operaia. Anche se mi sarà impossibile fermarmi a lungo, farò anch’io un passaggio per una lettura e qualche anatema: https://www.facebook.com/events/22544...
_Infine alle 21 presso la Libreria Modo in via Mascarella 24b ci sarà la presentazione di PCSP (Piccola Controstoria Popolare) col sottoscritto, Wu Ming 1, curatore della Collana Quinto Tipo di Alegre, Adriano Masci e Marco Mongelli di 404:file not found (altra rivista culturale che ha un percorso simile a quello del Lavoro culturale): https://www.facebook.com/events/82829...
Infine un addio: è partito per il suo ultimo reportage Astrit Dakli, per anni corrispondente dall’Unione Sovietica del Manifesto. I suoi preziosi consigli mi furono utili in un viaggio in una delle Repubbliche dell’ex URSS. http://ilmanifesto.info/e-morto-astri...
Ciao, Astrit.
October 13, 2015
Amianto a Reggio Emilia
[La CGIL di Reggio Emilia ha organizzato una bella presentazione di Amianto per dopodomani, il 15 ottobre 2015. Ecco il comunicato stampa.] A.P.
COMUNICATO STAMPA di CGIL Reggio Emilia e AFEVA Emilia Romagna
AMIANTO. UNA STORIA OPERAIA : PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI ALBERTO PRUNETTI.
PARTECIPA RAFFAELE GUARINIELLO
Quella che vogliamo raccontare è la storia di un uomo, un operaio che “respira zinco, piombo e buona parte della tavola degli elementi di Mendeleev, fino a quando una fibra d’amianto trova la strada verso il torace”. La storia di un singolo che si fa storia collettiva e che Alberto Prunetti racconta con gli occhi di un figlio, perché Renato, il protagonista del libro, è suo padre, ma insieme con la lucidità di chi riconosce in quell’esperienza il senso di un’ingiustizia più ampia , che travalica il direttamente conosciuto e attraverso la scrittura si ribella.
Partiremo da qui, GIOVEDÌ 15 OTTOBRE, dalle ore 15:30, in Camera del Lavoro, in un incontro pubblico che vuole tenere alta l’attenzione di cittadini e istituzioni sul tema dell’amianto in un territorio dove le fibre minerali dell’asbesto hanno prodotto una ferita non ancora rimarginata.
Per farlo ci saranno, insieme ad Alberto Prunetti autore di “Amianto. Una storia operaia”, edizione Alegre, il Procuratore della Repubblica e PM nel processo Eternit che si sta svolgendo a Torino, Raffaele Guariniello; il coordinatore di AfeVA (Associazione Familiari e Vittime Amianto) di Casale Monferrato, territorio che ha pagato un prezzo altissimo, Bruno Pesce; un ex-operaio delle Officine Grandi Riparazioni di Bologna, che ha vissuto sulla propria pelle il dramma di lavorare con l’amianto, Salvatore Fais; il responsabile Salute e Sicurezza della Cgil di Reggio Emilia che potrà fare il punto sulla situazione nella nostra provincia, Ciro Maiocchi.
A coordinare il dibattito arriverà Giorgio Mottola, giornalista di Report, Rai3, e già autore di diverse inchieste giornalistiche sull’amianto nel nostro Paese.
Un insieme di ospiti quelli chiamati dalla Cgil di Reggio Emilia, insieme allo sportello AFeVA della Camera del Lavoro, che testimonia la volontà di indagare un fenomeno che è insieme vicenda umana e storia del lavoro, vicenda processuale in corso e storia di giustizia negata. Ed ancora storia del presente, davanti al pericolo che l’amianto ancora rappresenta nel lavoro e nel territorio. L’amianto in Italia è illegale dal 1992 eppure c’è chi continua ad importarlo e chi continua a lavorarci a contatto. E’ ancora presente in molte costruzioni civili e si ragiona di mappatura e di smaltimento, con non poche difficoltà, di quantità ingenti di materiale.
Parlare di amianto insomma è una cosa seria.
April 19, 2015
Divieto di calcio ai maggiori di anni undici
(Questo articolo è uscito su Repubblica edizione Firenze domenica 19 aprile 2015. Ringrazio il Centro di documentazione Marco Vettori che sabato mattina mi ha messo un pc a disposizione per scriverlo al volo. Nella foto sono ritratti Osvaldo Soriano e il mio amico Osvaldo Bayer.).
 Eduardo Galeano si starà rivoltando nella tomba. Osvaldo Soriano, che da qualche parte nel paradiso dei gatti e degli esuli sta palleggiando con una palla fatta di nuvole, riderà del surrealismo involontario degli italiani. In un comune toscano sarà presto affisso un cartello paradossale: “Divieto di calcio ai maggiori di anni undici”.
Eduardo Galeano si starà rivoltando nella tomba. Osvaldo Soriano, che da qualche parte nel paradiso dei gatti e degli esuli sta palleggiando con una palla fatta di nuvole, riderà del surrealismo involontario degli italiani. In un comune toscano sarà presto affisso un cartello paradossale: “Divieto di calcio ai maggiori di anni undici”.
Sì, Osvaldo, hai sentito bene.
Un tempo c’erano le panchine, i ragazzini che inseguivano un pallone, i vecchi che caricavano una briscola, gli altri che guardavano i lavori di un cantiere improvvisato; le donne che facevano i ferri mentre prendevano il fresco sull’uscio di casa. Si abitavano i gradini delle chiese e i muretti dei parchi. Si creavano forme di convivialità che duravano il tempo di una partitella, di una bevuta, di un giro di carte. E che non costavano nulla.
Si diventava amici in cinque minuti e per costruire relazioni bastava un tango o un supertele. La saracinesca di un garage si trasformava in una porta che valeva quanto San Siro o l’Olimpico. La noia e la solitudine erano mali sconosciuti, echi lontani di grandi metropoli dove per qualche strana ragione migliaia di esseri umani avevano deciso di andare a segregarsi.
Perché nei paesi di un tempo non ci si annoiava mai. Non in provincia, non in quei piccoli centri pieni di bimbetti con le ginocchia sbucciate. Ricordate quando eravamo piccoli? Le croste di sangue alle ginocchia duravano anche tre o quattro anni di seguito. Pallonate, impennate con la bici, frenate sul ghiaino. Lasciavi il pallone solo quando cominciavi a innamorarti della figlia dell’elettricista. Anzi, neanche allora. Perché per farla innamorare dovevi riuscire a farti vedere mentre palleggiavi fino a cento. Poi d’incanto le ginocchia guarivano e ti rovinavi il cuore.
Oggi no, anche nei piccoli borghi rurali, non si sa perché, stare fuori è pericoloso. Strani pericoli che si materializzano soprattutto nella mente di noi adulti vietano ai nostri figli di rovinarsi le ginocchia.
Ossessioni securitarie che alimentano i divieti più bizzarri. Vietate le panchine. Vietate gli scalini. Vietati i birrini. Ovvero, stai a casa, cercati amici virtuali, usa la PlayStation. Anche le partite, da grande, impara a guardarle in tv. Paghi qualcosa e c’è il replay. Non si sa mai cosa può succedere in curva. Di questi tempi poi. Ossessioni che cambiano il modo di fruire un evento. Che costringono a diventare utenti passivi di uno spettacolo. Il bambino che batte il pallone contro un muro rifiuta di essere un utente. Sta dicendo: io sono parte del gioco. Sta rivendicando una pratica tipica della cultura popolare, dall’Italia all’Inghilterra: reclama la strada. Take the street, reclaim the streets.
Il divieto di calcio salva l’intonaco dei muri delle piazze toscane. Protegge le ginocchia, i vetri delle finestre e i gerani sui balconi ma rovina la gioia di vivere in provincia. Crea un silenzio letale nei vicoletti. Rende più vuota anche la giornata della signora che ci tirava indietro il pallone perché le entrava nel cortile. Certo, ci diceva “ve lo buco”. Anche il signore di ottant’anni urlava “domani c’ho da alzarmi presto per andà al lavoro, portate rispetto”. La signora però il pallone non ce lo bucava mai e il vecchietto non andava a lavoro da anni perché era in pensione. Ma ognuno recitava la sua scena madre in quel grande gioco delle parti, in quel teatro che era la vita di strada dei paesi e che oggi sta definitivamente scomparendo.
Lasciandoci tutti davanti al televisore, tristi, solitari e finali.
March 16, 2015
Lavoro e disattivismo: Amianto in un paper dell’università di Utrecht
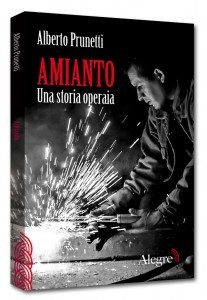 Pubblico un brano da un paper di Francesco Bozzi, studente dell’Università di Utrecht in Italian Contemporary Literature, che si interroga su Luciano Bianciardi e traccia alcune connessioni con la figura di Bartleby lo scrivano e con il precario figlio di un operaio di Amianto, una storia operaia.
Pubblico un brano da un paper di Francesco Bozzi, studente dell’Università di Utrecht in Italian Contemporary Literature, che si interroga su Luciano Bianciardi e traccia alcune connessioni con la figura di Bartleby lo scrivano e con il precario figlio di un operaio di Amianto, una storia operaia.
Bianciardi lo scrittore e il lavoratore Prunetti
di Francesco Bozzi
Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, Bianciardi lo scrivano, cioè il personaggio protagonista del romanzo La Vita Agra ripercorre le gesta del suo progenitore Bartleby nel cercare di inceppare i meccanismi ben oliati della laborioso produttività capitalista proponendo un’alternativa potenziale che si liberi dal giogo dell’attività lavorativa per farsi ostinata in-azione. Tuttavia, la componente autobiografica del romanzo inevitabilmente interseca le vicende dello scrivano Bianciardi con quelle dello scrittore Bianciardi, cioè di colui che realizza questa potenzialità alternativa in una scrittura di resistenza. In questo senso, analizzando quindi questa seconda traiettoria resistente si intende estendere il concetto resistente non solo al contenuto della scrittura ma all’atto stesso dello scrivere. Attraverso il supporto del concetto di “inoperosità” [désoeuvrement], proposto da Maurice Blanchot ne Lo Spazio Letterario, si paragonerà l'(in)-attività dello scrivere espressa da Bianciardi con quella del suo epigono Alberto Prunetti nel suo romanzo Amianto.
Maurice Blanchot ne Lo Spazio Letterario propone la concezione dell’opera letteraria come un evento che si compie, termina, si perfeziona nel senso etimologico, solo nell’interstizio che separa la sua composizione dalla sua fruizione; essa diventa “essere” nell’ “evento che si compie quando l’opera è l’intimità tra chi la scrive e di qualcuno che la legge” (8). Infatti, ciò che esprime lo scrittore con l’atto scrivente non è un’opera ma un libro. Paradossalmente proprio nel momento in cui il libro diventa opera, lo scrittore ne viene escluso, il suo atto viene espropriato e si compie in uno spazio che non gli appartiene più; “l’opera, alla fine, lo ignora, si richiude sulla sua assenza, nell’affermazione impersonale, anonima che essa è – e niente di più” (9). Espropriando lo spazio del suo compimento dal suo autore, l’opera “lo esclude, fa di lui il superstite, l’inoperoso, l’inoccupato, l’inerte dal quale l’arte non dipende” (10, corsivo mio). In questo senso il passaggio dall’atto scrivente al suo perfezionamento in quanto opera determina un’equivalente trans-formazione dell’attività in in-attività. In questa intercapedine, secondo Blanchot, si consuma questa mutazione ontologica in cui si celebra il paradosso di un potenziamento attraverso l’in-azione, dove “la parola non parla più, ma è, si vota alla pura passività dell’essere” (12). Perciò il concetto stesso di “inoperosità” [désoeuvrement] non mira alla perdita dell’opera ma al contrario l’inoperosità diventa la sorgente, la potenzialità che lo scrittore ricerca ma che il testo raggiunge solo quando lascia la penna del suo creatore. Riprendendo, il concetto di désoeuvrement, proposto da Blanchot, Giorgio Agamben in The Open, lega l’esperienza estetica alla resistenza politica; infatti, analizzando il dipinto “Le Tre Età dell’Uomo” di Tiziano, il filosofo italiano nota come l’esperienza in-operosa dei due amanti al centro del dipinto fornisca quel compimento, quella soddisfazione della potenzialità che resta invece inappagata e disarticolata dal potere costituito : “their [of the lovers] condition is otium, it is workless {senz’opera}. […] In their fulfillment, the lovers who have lost their mystery contemplate a human nature rendered perfectly inoperative—the inactivity {inoperosità} and désoeuvrement of the human and of the animal as the supreme and unsavable figure of life” (87, corsivo di Agamben). Di conseguenza il processo estetico, l’interstizio contemplativo in cui il testo passa dall’attività alla pura passività dell’opera rappresenta il momento in cui la potenzialità disarticolata, il nichilismo imperfetto del potere viene disabilitato. Come nota Arne De Boever, Agamben sostiene che “art reveals itself […] at this moment as the unworking or désoeuvrement of sovereign power” (154); il momento artistico non si compie quindi come re-azione o ipotesi competitiva nei confronti del sistema politico, ma si pone come potenzialità alternativa che esprime l’inoperosità profonda dell’essere , seguendo la terminologia di Blanchot.
Secondo questa prospettiva se confrontiamo la concezione dell’atto scrivente in Bianciardi e Prunetti possiamo verificare le potenzialità resistenti delle due scritture.
Il romanzo Amianto di Alberto Prunetti racconta le vicende autobiografiche del padre dell’autore, Renato, che nel corso della sua vita lavorativa passata come operaio saldatore nelle fabbriche di mezza Italia espose i suoi polmoni al contatto reiterato con la sostanza che da il titolo al testo. Dal punto di vista contenutistico il romanzo, per quanto si ispiri e si faccia epigono del lavoro culturale di Bianciardi , offre una rappresentazione dell’attività lavorativa che coinvolge il protagonista pressoché opposta rispetto a quella fornita dall’autore toscano. Se, infatti, per Bianciardi la laboriosità produttiva condannava l’operaio quanto l’intellettuale alla spersonalizzazione e all’inesorabile incomunicabilità, nel romanzo di Prunetti l’attività lavorativa, per quanto sia stata causa primaria della morte dell’operaio Renato, paradossalmente costituisce la componente ontologicamente essenziale per l’esistenza stessa del protagonista. Come scrive Valerio Evangelisti nella prefazione di Amianto, Renato Prunetti “[s]aldava, forgiava, ridisegnava i metalli. Ne andava fiero. Anche i suoi momenti di ribellione traevano origine da tali abilità” (11). Quindi, nel romanzo di Prunetti, nella sua “biografia operaia”, il lavoro, per quanto assassino, eroicizza suo padre Renato, “uno che nella vita ha solo e sempre lavorato e che ha identificato se stesso con il proprio mestiere di metalmeccanico” (20). Quindi appare evidente come le posizioni di Bianciardi e Prunetti nella rappresentazione del lavoro, in quanto attività ontologicamente essenziale, siano diametralmente divergenti. Similmente anche la concezione dell’atto scrivente, quello che permette la de-attivazione del sistema di potere tramite un’espressione resistente, sembra altrettanto differente. Prunetti, infatti, nelle prime righe di Amianto esprime come la scrittura stessa reiteri i meccanismi lavorativi che caratterizzano la produzione industriale:
“Il racconto dovrebbe tenere come un raccordo di tanti tubi diversi. Lui lo diceva sempre: mettici il canapone, regge più del teflon. Stai solo attento a rispettare il senso della filettatura e lega il tutto con un dito sporco di mastice verde. Poi stringi con forza, ma senza cattiveria. Non deve perdere. Ho fatto così, con la penna. Ho cercato di rispettare la filettatura della storia, senza forzare il passo degli eventi senza strozzature. Ho usato il mastice della fantasia e stretto senza cattiveria ma con decisione l’ordine del discorso” (15).
Per Prunetti, quindi, l’atto scrivente, non rappresenta una sospensione della produttività, ma, al contrario, esprime una sorta di continuazione del processo lavorativo che alimenta i meccanismi del sistema industriale. La scrittura non solo rappresenta il lavoro, ma si fa essa stessa lavoro nel tentativo di fornire una scrittura resistente, essa tende all’operosità. Inoltre, come il lavoro operaio segnava il fisico e l’esistenza eroica di Renato Prunetti, il lavoro (o l’assenza del lavoro) culturale sembra intaccare l’integrità fisica ed ontologica del figlio scrittore . Di conseguenza l’atto scrivente per Prunetti non comporta una liberazione dal giogo lavorativo, una de-attivazione, ma al contrario presuppone una iper-attivazione che cerca di riprodurre i meccanismi che caratterizzano la laboriosità industriale. In maniera opposta, Bianciardi ne La Vita Agra concepisce il lavoro, quella nuvola di polvere alzata per “dare la sensazione dell’attività” (125), come un intralcio all’in-attività che invece l’atto scrivente costituisce. Senza l’ingombro dell’attività produttiva che la società capitalista esige tanto dall’operaio quanto dall’intellettuale, la scrittura resistente può liberarsi in tutta la sua inoperosa potenzialità: “Vi darò la narrativa integrale . […] Proverò l’impasto linguistico, […] il romanzo tradizionale. […] Il romanzo neocapitalista, neoromantico o neocattolico, a scelta. […] Datemi il tempo, datemi i mezzi, e io toccherò tutta la tastiera – bianchi e neri – della sensibilità contemporanea. Vi canterò l’indifferenza, la disubbidienza, l’amor coniugale, il conformismo, la sonnolenza, lo spleen, la noia e il rompimento di palle” (30). In questo senso, a differenza di Prunetti, Bianciardi esprime quantomeno il bisogno che la scrittura ambisca all’in-azione, all’essere essa stessa processo de-attivante che si inserisca come un granello di sabbia negli ingranaggi della macchina produttiva; benché questa ricerca, come afferma Blanchot, non si possa perfezionare come opera nell’atto scrivente in se ma solamente quando, liberata dalla persona dell’autore, raggiunga l’intercapedine tra la sua creazione e la sua ricezione. Quindi se per Prunetti la scrittura di resistenza in quanto lavoro deve attivarsi come re-azione al sistema industriale, al contrario, per Bianciardi, l’atto creativo raggiunge una potenzialità de-attivante quando si pietrifica nella sospensione stessa di ogni volontà produttiva, in quel nichilismo perfetto, di cui parlano similmente Agamben, Deleuze e Blanchot, in cui la scrittura e l’essere non ricercano spasmodicamente une realizzazione attiva tramite la volontà. Alternativamente la scrittura di Bianciardi ricerca quella inoperosa potenzialità che permette un utilizzo alternativo della logica di potere, non si fa re-azione, ma mira all’in-azione; come fosse un sonno dell’attività lavorativa, la scrittura si compie nel désoeuvrement, in quell’attimo ozioso che si inserisce tra un meccanismo e l’altro e che permette all’individuo di resistere, di sparire in quanto lavoratore e diventare un essere potenziale in quel momento liberatorio che è la scrittura.“Poi il sonno è arrivato e per sei ore io non ci sono più” (La Vita Agra 220).
Bianciardi, scrivano e scrittore, personaggio ed autore, ci propone una resistenza a due facce. Da una parte, come il personaggio di Melville, esprime in quanto protagonista del suo stesso romanzo una resistenza quotidiana nei confronti dell’imposizione del lavoro in quanto dimensione indispensabile dell’esperienza umana. Lo scrivano Bianciardi si pone come alternativa in-attiva che con la sua passività contesta la fragile logica del sistema produttivo. Rispetto ai suoi epigoni moderni, ragionando per paradossi, tramite quel neocristianesimo a sfondo copulatorio che lo contraddistingue, Bianciardi fornisce una resistenza che in quanto paradossale si fa reale poiché contesta su un piano potenziale e non attuale l’attivismo ateleologico della laboriosità capitalista, non si fa re-azione ma in-azione. Questa resistenza passiva simultaneamente viene accompagnata da un’altra forma imprescindibile, quella di Bianciardi scrittore. Mentre per Prunetti l’atto scrivente è continuazione e re-azione a quel concetto etico ed ontologico del lavoro di stampo neorealista per cui, benché uccida, l’attività rimane sacra e necessaria; per Bianciardi, la scrittura di resistenza si costituisce in quella tendenza all’inoperosità che fa del testo un’opera. In questo senso, l’atto dello scrivere si fa resistente proprio perché di per se svincolato da ogni logica produttiva attiva, atto illogico, paradossale che mira alla pura passività dell’essere, e che si compie solo nel momento in cui si distacca dalle mani che lo hanno composto. Il testo, lo scrivere, quindi nega ogni attività o re-attività, ma si fa resistente solo quando rimane in-operoso, in-attivo.
March 7, 2015
“Sono acciaio ascendente amianto”. Una recensione di Amianto
Segnalo una recensione di “Amianto” scritta da Antonio Schina e pubblicata sul Notiziario del Centro di Documentazione di Pistoia
Alberto Prunetti, Amianto. Una storia operaia, Roma, Edizioni Alegre 2014, pp. 188 € 14,00
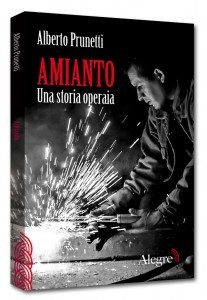 «Sono nato sotto il segno dell’amianto, sono venuto alla vita nel luogo in cui si va alla morte, in un luogo emblema di quella nocività che ha minato mio padre. E io ero lì, al sicuro, mentre Renato respirava fibre nocive… Sono nato tra l’amianto di Casale [Monferrato] e l’acciaio di Piombino, tra la polvere assassina e le colate degli altiforni… sono cresciuto sul mare dei fanghi rossi, giocando a pallone nel campo asfaltato dell’ex-Ilva, dove ho fatto le scuole. Per anni sono andato a lavorare sfiorando una fabbrica di titanio e di acido solforico e la strada che mi ha portato all’università seguiva il corso del Merse… che è un fiumiciattolo pieno di arsenico e di altri metalli pesanti, usciti dalle miniere allagate in cui sono stoccate tonnellate di ceneri di pirite. Sotto il segno dell’amianto e della nocività. Sono acciaio ascendente amianto» (p. 111).
«Sono nato sotto il segno dell’amianto, sono venuto alla vita nel luogo in cui si va alla morte, in un luogo emblema di quella nocività che ha minato mio padre. E io ero lì, al sicuro, mentre Renato respirava fibre nocive… Sono nato tra l’amianto di Casale [Monferrato] e l’acciaio di Piombino, tra la polvere assassina e le colate degli altiforni… sono cresciuto sul mare dei fanghi rossi, giocando a pallone nel campo asfaltato dell’ex-Ilva, dove ho fatto le scuole. Per anni sono andato a lavorare sfiorando una fabbrica di titanio e di acido solforico e la strada che mi ha portato all’università seguiva il corso del Merse… che è un fiumiciattolo pieno di arsenico e di altri metalli pesanti, usciti dalle miniere allagate in cui sono stoccate tonnellate di ceneri di pirite. Sotto il segno dell’amianto e della nocività. Sono acciaio ascendente amianto» (p. 111).
Ci sono, in questo libro, pagine di grande presa perché Prunetti, come scrive Valerio Evangelisti nella prefazione , è «uno scrittore vero» che sa suscitare, nello stesso tempo, «dolore, divertimento, pena, riflessione, compartecipazione».
Come questa pagina, scritta dopo aver appreso, mentre il padre sta morendo, che lui è stato concepito a Casale Monferrato, «la capitale del lutto e dell’amianto».
Il libro, pubblicato nel 2014 in seconda edizione (la prima era apparsa nel 2012, per Agenzia X di Milano), racconta la storia di Renato Prunetti, padre dell’autore, che per tutta la vita fa il saldatore-tubista, prevalentemente come trasfertista, in una sequenza impressionante di luoghi diversi, in giro per tutta Italia, nel petrolchimico e nella siderurgia, cominciando dalla Solvay di Rosignano Marittimo. Nel frattempo si sposa con Francesca e si stabilisce a Follonica, dove nel 1973 nasce il figlio Alberto.
L’alta Maremma, tra Follonica e Scarlino, è la realtà in cui, dopo la chiusura delle miniere di pirite, nasce un grande polo chimico che produce acido solforico e titanio, per poco tempo usando gli scarti della pirite, ben presto gli scarti della lavorazione del petrolio, che vengono trasportati via mare dall’estero.
Con tutta una serie di conseguenze: fanghi rossi in mare, ceneri di pirite nelle miniere dismesse, inquinamento generale della zona, che sconta anche tutta la presenza di rifiuti tossici e nocivi del periodo delle miniere con falde acquifere inquinate, arsenico nelle acque e nel suolo, enormi accumuli di materiale che dovrà essere prima o poi smaltito. Senza contare che all’altro lato del golfo c’è Piombino con le acciaierie.
Eppure il golfo, con la sua curva perfetta, ha dei paesaggi e degli ambienti notevoli: spiagge di sabbia fina, pinete estesissime, zone umide, boschi di castagni che arrivano fino al mare, campagne e colline di vigne e olivi, paesi medievali arroccati.
Credo sia per questo che Prunetti ne parla sempre, malgrado tutto, con un tono che a me è parso di assoluto affetto.
Anche perché è l’ambiente dove si muovono i personaggi della sua storia, con la loro umanità rude ma autentica, che Prunetti classifica in varie originalissime tipologie: l’uomo-tuttofare che nasce nel periodo della riforma agraria degli anni Cinquanta del ’900 ed è «un contadino esperto anche di meccanica che si intende anche di muratura idraulica, impianti elettrici, falegnameria», «pionieri del west maremmano»; gli altri, invece, tra cui suo padre, che non provengono da un contesto rurale e che, nel primo boom industriale, assumono le caratteristiche di operaio-massa (lavoro alla catena produttiva e da non specializzato, con salari più bassi) o specializzato (con competenze tecniche più elevate, anche se più settoriali).
Anche se poi pure quest’ultimi un legame con l’agricoltura ce l’hanno, perché quasi tutti, da pensionati, usano la tuta blu per lavorare nell’oliveta di famiglia: «non un semplice ripiego identitario, ma… un atto di liberazione, un modo di irridere l’azienda».
E poi c’è un’altra distinzione, quella tra maremmani e livornesi, che appare, per chi conosce anche solo un po’ quella realtà, del tutto verosimile: «se il maremmano non conosce tempo libero e preferibilmente si veste in mimetica anche per andare a fare la spesa per far capire che per lui la caccia è sempre aperta, anche quando è costretto dalla moglie ad andare alla Coop a fare la spesa, il livornese, non appena si toglie la tuta blu si rigoverna “a modo”», perché i livornesi sono «tutta gente di porto, biondi, boni e marinai, col libeccio nel cuore» (p. 96).
E infine, un elemento che accomuna tutti gli uomini è l’ethos operaio, sia maremmano che livornese, secondo cui «guai se un uomo si piegava a fare i lavoretti di casa, soprattutto se ad indurlo era la moglie» (p. 69).
È questa umanità che si trova a fare i conti con il passaggio epocale dagli anni ’70 agli anni ’80 del ’900: i primi, «anni di alti salari e alta conflittualità, anni bellissimi… in cui i semplici operai come mio padre, aderenti alla Fiom-Cgil, godevano con le loro tutele salariali dei vantaggi derivati dal fatto che il partito e il sindacato facevano da rubinetto per il contenimento dell’idra rivoluzionaria» (p. 37), i secondi, con le ristrutturazioni che volevano «tagliare posti, allungare gli orari e contrarre gli stipendi», distruggendo e smantellando il sogno di egemonia della classe operaia: «la crisi non serviva a migliorare la produttività ma a distruggere l’alternativa di contropotere e di autogestione operaia dei rapporti tra capitale e lavoro» (p. 97).
In questo quadro, il padre di Alberto, con i suoi continui cambi di luogo di lavoro, finisce, si potrebbe dire, inesorabilmente per consumarsi precocemente. Malgrado la sua consapevolezza dei meccanismi derivanti dal lavoro e dalle sue logiche, espone i polmoni a gas devastanti, si rovina l’udito, gli diminuisce la vista, perde i denti.
È un carico pesantissimo di lavori usuranti ma dovrà aspettare di avere 35 anni di lavoro per riuscire ad andare in pensione, oltretutto ammalandosi pochissimi anni dopo: la diagnosi è tumore polmonare dovuto all’amianto, anche se ci vorrà dell’altro tempo per arrivare a capire con chiarezza che di questo si tratta, fino a morire, nel 2004, a soli 59 anni.
E Alberto si troverà a decidere, assieme alla madre, ad andare in causa con l’Inps, per ottenere, ma solo anni dopo, nel 2011, che venga riconosciuto l’esposizione del padre all’amianto e il fatto che l’amianto l’ha ammazzato, e per apprendere che aveva diritto a ben sette anni di prepensionamento.
«Sette anni di prepensionamento sono sette anni fuori dal giogo del lavoro, sono sette anni di vita, sono sette anni senza essere esposti alla nocività, ad altro amianto, altro piombo, altri metalli pesanti. Sette anni possono salvarti la vita, interrompendo la deriva cellulare di un organismo spinto oltre il limite della biologia nel nome della produttività, nel nome dei lavori di merda che i padroni fanno fare a noi chiedendoci poi sacrifici, flessibilità, docilità e gratitudine… Andate in culo, ma di cuore, per sette anni sette, mille volte sette anni vi maledico, dal padroncino fino ai vertici della classe industriale italiana. Tutta gente che se per caso gli stringi la mano, ti devi riconta’ i diti p’esse sicuro di avecceli tutti, ‘sti ladri» (pp. 125-126).
Il libro è tutto questo ma anche molto altro che qui non è possibile affrontare: per prima cosa, un’occasione per riflettere sull’attuale condizione del precariato intellettuale, partendo dal racconto di Alberto, che si intercala con la vicenda del padre e con quella fa continui, illuminanti, confronti.
Alberto che non ha mai fatto uno sciopero, non essendo mai stato assunto, che fa anche lavoro manuale per sopravvivere, e molto altro. È questo l’argomento prevalente della discussione con Wu Ming 1 e con Girolamo di Michele, prima nel blog Giap, ora nell’appendice alla seconda edizione di Amianto, a cui si rimanda per chi vuole approfondire.
E ancora: il libro rientra pienamente nel filone di quelle narrazioni, non-fiction novel, reportage narrativo ecc., che Wu Ming 1 chiama «oggetti narrativi non identificati… narrazioni ibride, … fatte da autori che vogliono raccontare le loro storie con ogni mezzo necessario… con una collisione tra le varie tecniche e retoriche usate.. che sprigiona una grande potenza» e che sono alla base del progetto della nuova collana Quinto tipo della casa editrice Alegre.
E infine il testo sta pienamente dentro la vicenda delle morti per amianto, che si trascina ormai da decenni, ma che è tornata all’attenzione dell’opinione pubblica a seguito dell’assoluzione in cassazione del proprietario svizzero e dei dirigenti della Eternit di Casale Monferrato, nel novembre 2014.
C’è un altro aspetto che vorrei affrontare e che mi pare non toccato dalle molte recensioni che pure Amianto ha avuto. Parto dalla constatazione che molto della realtà descritta nel libro di Prunetti, per ambientazione fisica e sociale, corrisponde a quella raccontata da Cinzia Avallone nel notissimo Acciaio, uscito nel 2010 per Rizzoli. Lì la realtà, negli anni 2001-2002, è quella di Piombino, in particolare le acciaierie Lucchini e il quartiere Salivoli, a due passi veramente dalla Follonica di Prunetti.
Non credo proprio che abbia ragione Goffredo Fofi quando sostiene che di personaggi come quelli della Avallone «non se ne trovano nella letteratura italiana oggi». A me sembrano in realtà descritti in modo del tutto approssimativo, un po’ tagliati con l’accetta. Però sono personaggi che corrispondono alla realtà che conosce anche Prunetti e forse molto più presenti di quanto si possa pensare ad una prima impressione. Sono operai senza alcuna coscienza di classe e neanche alcuna consapevolezza di se stessi:
Enrico è chiuso nel suo mondo che comprende solo casa e lavoro e assolutamente nient’altro, picchia sistematicamente moglie e figlia, vive nel terrore che la figlia Francesca quattordicenne abbia rapporti sessuali e quindi la controlla in modo ossessivo. Un vero mostro, come lo definisce la figlia; Antonio, licenziato dalla Lucchini perché scoperto a rubare carburante è un giocatore d’azzardo e trafficone, «che riteneva gli iscritti alla Fiom degli sfigati. Una sola certezza nella vita: lavorare stanca»; suo figlio Alessio, giovane operaio della Lucchini, è cocainomane come gran parte dei suoi amici, ed è iscritto alla Fiom ma elettore di Forza Italia.
Sullo sfondo c’è la realtà dei giovani operai assunti da poco: «Adesso erano rimasti in due-mila, comprese le ditte in appalto. La spostavano a est, i padroni. Alcuni rami della fabbrica morivano, ciminiere e capannoni venivano fatti saltare con il tritolo. Se ne stava andando tutto a puttane. Ma loro, gli operai della settimana generazione, si divertivano a cavalcare
gli escavatori come tori, con le radioline portatili a palla e una pasticca di anfetamina sciolta sotto la lingua» (p. 27).
Mentre Prunetti ha una capacità di rappresentare la realtà, anche attraverso l’interloquire dei personaggi, assolutamente verosimile, il linguaggio dei personaggi della Avallone non ha questa dote, anzi. Le situazioni danno l’impressione di essere esasperate alla ricerca dell’effetto.
Devo dire però che i dubbi sulla realtà rappresentata dalla Avallone, che avevo tutti interi alla fine della lettura, si sono dissolti quando, poco dopo, per caso, ho conosciuto un paio di giovani assunti della Lucchini, fisicamente, ma soprattutto nei comportamenti e nel modo di relazionarsi agli altri, con le stesse caratteristiche di Alessio e dei suoi giovani colleghi di lavoro.
Per cui i Prunetti, padre (di qualche generazione precedente) e figlio (che grosso modo sta nel mezzo tra i padri e i figli di Acciaio) appaiono veramente appartenere a una piccola minoranza che prova a resistere a tutto ciò che li circonda. La maggioranza sta veramente da un’altra parte.
Ed è vero che dovrebbe essere preservato come elemento essenziale «il passaggio di testimone tra padre e figlio, … la buona vecchia coscienza di classe, … la coscienza di un “proletario che permette ad Alberto di confrontare due storie lavorative (la sua e quella del su’ babbo) senza mettere una generazione contro l’altra» (Wu Ming 1, Il triello, Wu Ming 1, Girolamo De Michele e Alberto Prunetti discutono in appendice a Amianto, p. 149). Ma questo passaggio non avviene più, se non appunto per rarissime eccezioni.
Prunetti cita ad un certo punto Luciano Bianciardi: un bel passo de Il lavoro culturale che racconta di Corinto, muratore invalido e poi bidello stalinista, figlio di anarchici, e della sua teoria sul lavoro forzato per ragionieri e preti (pp. 127-128).
Proprio Bianciardi ci aiuta a capire dove si devono andare a cercare le origini di questa perdita totale di identità, della coscienza di classe appunto, quando si domanda cosa è mancato alla sinistra. E risponde: la formazione e l’educazione individuale e collettiva.
Ben altre, è vero, erano le priorità della pratica politica maggioritaria della sinistra moderata, che ha privilegiato l’obiettivo del cambiamento dei rapporti di produzione, senza porsi minimamente l’obiettivo del cambiamento dei modi di produzione.
E sicuramente se il lavoro di educazione collettiva è stato un elemento costitutivo del movimento socialista alle sue origini tra ’800 e ’900, questo si è perso quasi completamente nella tradizione comunista, che formava i quadri in una prospettiva tutta interna alla logica del partito, con una palese disattenzione alla costruzione della capacità critica e di confronto.
Da qui a cascata è successo il resto: il facile e veloce attenuarsi della capacità di resistere ai richiami del consumismo, l’accettazione crescente dei suoi modelli di vita, la conseguente definitiva perdita di una propria identità.
C’è un film – che per una straordinaria coincidenza è ambientato proprio a Piombino – che racconta una fase fondamentale di questo passaggio, quando a partire dalla sconfitta operaia della fine degli anni ’70, la ristrutturazione, che riguarda anche le acciaierie, fa balenare la possibilità di raggiungere la bella vita. È l’esordio del 1994 di PaoloVirzì, che si intitola appunto così La bella vita, e spiega benissimo, cento volte più di tante analisi sociologiche, cosa sta avvenendo irreversibilmente nella società e nella testa della gente.
Sullo sfondo della crisi coniugale tra Bruno, operaio, e Mirella, commessa del supermercato, che si infatua di Gerry, presentatore di una tv locale, c’è un accordo sindacale al ribasso, c’è la mobilità. Quattro operai decidono di accettare le dimissioni consensuali, in cambio di 40 milioni a testa con i quali pensano di fare il salto di classe: comperare un terreno, costruire un capannone e iniziare a produrre semilavorati per l’edilizia, con l’acciaio dell’Ilva.
Il progetto non va in porto perché non viene ottenuto il fido bancario, il terreno acquistato servirà per costruire uno stabilimento balneare all’ombra delle torri della centrale elettrica di Torre del Sale.
C’è veramente tutto: i primi suicidi degli operai costretti alla cassa integrazione, l’abbandono di ogni prospettiva di resistenza, l’illusione di essere accettati dal sistema economico, in una parola la rinuncia alla storia e alla identità di classe.
Malgrado tutto, non c’è che da sperare – anche se la realtà sembra andare in ben altra direzione, tanto che, come scrive Prunetti, «ad un certo punto ci hanno fatto quasi vergognare delle nostre origini, negli anni Ottanta-Novanta» – che prima o poi riappaia, certo in forme che saranno totalmente nuove, «la voglia di riscatto e il senso di solidarietà».
Amianto aiuta a mantenere viva questa speranza.
November 17, 2014
19 Novembre: il processo Eternit arriva in Cassazione
Non so come commentare. Da una parte è una cosa più importante di qualsiasi premio letterario: trovare il proprio nome sui muri della città che è il simbolo della resistenza e della lotta contro l’amianto. La città in cui i miei genitori per alcuni mesi hanno vissuto prima della mia nascita, perché babbo lavorava alla raffineria Maura, a tre chilometri da Casale Monferrato. E’ una cosa che mi riempie di orgoglio. Dall’altro è una cosa che mi crea rimorso, perché quella è una lotta in cui altri, come Romana, come Bruno, come Nicola, come Luca, come Maria Assunta, come tanti altri casalesi, si sono impegnati da tanti, tanti anni e meriterebbero più di me di stare su quel manifesto. Alcuni a questa lotta hanno dedicato una vita intera e combattono da 35 anni. Poi ci sono i nomi di duemila vittime di Casale che meritano di stare su quel manifesto più di tutti, perché mercoledì si va a parlare di loro in Cassazione. Della loro vita che non c’è più. Del loro respiro, della loro tosse, dei loro nipoti che non hanno potuto giocare a pallone coi nonni. Della memoria che è arrivata prima della giustizia. Di una giustizia che deve dimostrare di non stare dalla parte del più forte ma da quella del più debole, dello sconfitto, del tormentato, di chi subisce i soprusi, non da chi li provoca e poi si nasconde dietro un dito, dicendo non sapevo. E allora mercoledì saremo in tanti, da Casale e da Rubiera e da tutta Italia. Dalla Francia, dalla Spagna, dal Belgio. E dal Brasile, dove l’Eternit continua a stampare ondulini in fibrocemento. Saremo lì, in Cassazione, perché c’era dolo, mica solo colpa. Perché conoscevano i profitti e i danni ma hanno conteggiato solo i primi e hanno socializzato i secondi. Perché noi invece non abbiamo dimenticato né li abbiamo lasciati soli e dopo tanti anni, saremo tutti lì, alle porte della Cassazione, sotto le bandiere dell’Afeva.
May 3, 2014
1954: sessant’anni dopo, la poesia a braccio ricorda i minatori di Ribolla
di Alberto Prunetti
[Quest'articolo è apparso nell'edizione toscana di la Repubblica lo scorso 30 aprile]
E’ il 1954. La televisione inizia la trasmissione del segnale anche in Italia. In Africa i ribelli Mau Mau lottano contro i colonialisti inglesi. La Jugoslavia cerca un socialismo distinto da quello sovietico. Cary Grant pensa a un nuovo film da girare con Hitchcock. E in Toscana? La notizia forse più rilevante è quella di un’esplosione in una miniera maremmana, a Ribolla, nel pozzo Camorra, dove perdono la vita 43 minatori. Unepisodiochecreeràun’onda di sensazionale emozione e cambierà la vita di molti. Dalle famiglie dei minatori, le vedove e gli orfani, fino a intellettuali come Bianciardi e Cassola che dedicheranno mesi di indagini su quell’evento. Bianciardi arriverà al punto di lasciare la Maremma e di emigrare a Milano, tanto che il protagonista del suo libro più famoso, La vita Agra, giunge a Milano proprio per far saltare il palazzone sede della società estrattiva considerata responsabile del disastro. Una responsabilità mai acclarata in un tribunale perché il processo si chiuse con un niente di fatto. Anzi, con un fatto «che non sussiste». Per quei 43 minatori sembrano quasi valere le parole di Enzensberger, nella traduzione di Fortini: «A schiere dimenticati (…). Non registrati, non decifrabili nella polvere ma scomparsi i loro nomi, i cucchiai, le suole». Non sussistono. La giustizia dimentica, ma i poeti no. A Ribolla lo scorso 13 aprile c’è stato l’annuale raduno dei poeti estemporanei, che tengono viva, tra la Toscana e l’Alto Lazio, la tradizione contadina della poesia d’improvvisazione in ottava rima: inventano endecasillabi sfidandosi a coppie, con una successione metrica precisa e l’obbligo di prendere il filo della rima dove l’ha lasciato l’antagonista.
Quest’anno un omaggio doveroso è andato ai minatori morti nell’esplosione di grisù di Ribolla, di cui ricorre il sessantesimo anniversario il prossimo 4 maggio. Per tradizione l’incontro dei poeti cade la seconda domenica di aprile, poi segue il 25 aprile, il primo maggio e la commemorazione della strage del Pozzo Camorra: un calendario fitto in cui la memoria, la poesia, i canti popolari e la politica si incontrano, per trasmettere la memoria come si faceva prima della televisione. Quest’anno a rifornire i poeti di vino schietto c’è Antonello Ricci, studioso di paesaggi e di ottava rima. Colma anche il mio bicchiere e poi si mette a ragionare dell’affresco di Simone Martini, Guidoriccio da Fogliano all’assedio del castello di Montemassi. Antonello mi conduce fuori dal circolo Arci che ospita l’evento. Ci orientiamo sui colli circostanti: mi fa notare che nel punto in cui il cavallo di Guidoriccio posa il suo zoccolo, oggi c’è Ribolla. Un villaggio minerario che è rimasto sotto il tacco della Montecatini, la società estrattiva che poi si è trasformata in Montedison. Un paese che cerca di risanare le ferite della propria memoria anche attraverso la poesia, che alimenta la memoria e passa il testimone alle giovani generazioni. E non è un caso se l’anniversario di quell’esplosione di grisù sia ricordato da una formazione musicale di bambini, che interpretano i versi di un noto poeta improvvisatore, il Mastacchini, uno che ormai molto anziano regala ancora dal palco i suoi versi, cantati con un soffio di voce. “Maledetta miniera tu sia/ maledetto carbon disumano / questo luogo del grossetano / tutto il lutto voleste gettar”. Non stupisce che anche questo sia un canto di maledizione, come accade spesso nella tradizione maremmana: il canto più famoso, Maremma amara, è una maledizione verso una terra che viverci un tempo era una condanna. Ma niente destini avversi o fatalità: è l’uomo a schiacciare il peso di quello zoccolo, a rendere la miniera il pane più duro. Quel pane avogni velenato che cinicamente risolve la contraddizione tipica del capitalismo industriale tra fame e disoccupazione contro pane e malattia: i minatori morti, come scrisse Amedeo Bordiga all’epoca del disastro minerario, «non mangiano». La poesia e il canto popolare. Un binomio che viene evocato dall’organizzatore di ventidue anni di poesia estemporanea a Ribolla: Domenico Gamberi, ex minatore, imponente figura storica della poesia a braccio maremmana. Per tanti anni la sua spalla è stato un altro minatore, Demo Civilini, da poco scomparso. Gamberi, vestito come sempre da cacciatore, ricorda dal palco il Civilini. «Ci incontrammo a lavoro in miniera. Nei momenti di pausa e durante i viaggi si parlava di poeti, di canti popolari, dei maggerini. Capitava di mettersi a cantare. Tra i preferiti c’era la Pia de’ Tolomei e il Caserio». Il Caserio è l’inno scritto dall’anarchico livornese Pietro Gori, molto popolare in Maremma: “Lavoratori a voi diretto è il canto /di questa mia canzon che sa di pianto”. E poi un augurio ai giorni che si approssimano: “Vieni o maggio ti aspettan le genti”. Dietro Gamberi, sul palco, c’è la tradizione e il futuro della poesia a braccio. C’è il vecchio Mastacchini che si regge sul bastone e Enrico Rustici, giovane medico di Braccagni, che colma le ottave con endecasillabi saturi di ritmo e ironia. E poi è tornato anche al suo antico splendore Niccolino Grassi, pastore di Massa Marittima, forse il migliore sulla piazza, che lancia la sfida al cantastorie Mario Chechi. E dietro di loro pare profilarsi ancora la sagoma di un grande poeta contadino come Altamante Logli o di Carlo Monni, che veniva anno come “ascoltante” e alla fine calcava anche lui il palco. 1954. Sessant’anni fa. I morti di Ribolla, l’indagine di Bianciardi e Cassola. Il palazzone de La vita agra. Il neocapitalismo con un piede a Milano e l’altro in provincia, sotto lo zoccolo del cavallo di Guidoriccio da Fogliano. Cary Grant, i Mau Mau. E un apparecchio televisore che entra nelle case degli italiani. Anche nella provincia toscana. La storia di quell’elettrodomestico me la racconta a Ribolla il figlio di un boscaiolo. «In campagna il televisore arrivò da noi per primi. Ce lo regalò un parente che stava bene, faceva il fattore a Rapolano. Ci portò il televisore, lo mettemmo in casa, al podere, col siparietto a tendina, come un mobile. Però non funzionava. Allora sentimmo il sarto. Il sarto aveva le Singer, era l’unico a saper far funzionare le macchine. Ci disse: “Ma ce l’avete al podere l’elettricità?” Il televisore era arrivato anche da queste parti sessant’anni fa, nel ‘54, la corrente elettrica in casa ancora no. E la storia di quei 43 morti allora poteva solo correre di bocca in bocca attraverso le rime dei poeti contadini, senza il filtro dei cinegiornali e dei “comunicati». La televisione ha la memoria corta, i poeti contadini — che conoscono ogni ottava dell’Ariosto — ce l’hanno lunga e ricordano anche oggi. Per questo, per loro, il fatto sussiste
May 2, 2014
Messaggio ai librai: in arrivo la nuova edizione di Amianto.
Sta per arrivare in libreria la ristampa, in edizione accresciuta, di Amianto, una storia operaia per i tipi di Alegre Edizioni. Il libro, distribuito a partire dal 7 maggio, contiene un nuovo epilogo inedito e una postfazione con un dialogo a tre (“il triello”) sul libro, condotto da Wu Ming 1, assieme a Girolamo De Michele e al sottoscritto.
Invito i librai che hanno sui propri scaffali ancora la vecchia edizione di Amianto di fare la resa dell’edizione Agenzia x e di ordinare la nuova edizione Alegre. Il distributore di Alegre è PDE e il magazzino dell’editrice ha copie sufficienti per una vasta distribuzione, dal momento che la stampa del libro è tipografica e non digitale.
Questo è il link alla pagina ufficiale di Amianto, una storia operaia: http://ilmegafonoquotidiano.it/libri/...




