Vivere con Sofia ...
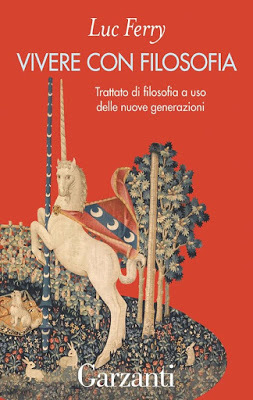 Ho un debito con la filosofia, ovvero “il mondo di Sofia”, per dirla tutta con il titolo di un libro che ho letto con tanto piacere la scorsa estate.
Ho un debito con la filosofia, ovvero “il mondo di Sofia”, per dirla tutta con il titolo di un libro che ho letto con tanto piacere la scorsa estate.
Ne ho parlato brevemente qui al link su GoodReads, riservandomi di farlo poi. Dovevo, infatti, prima completare la raccolta della collezione dedicata alla filosofia, così come è uscita, edita dal “Corriere” nella collana Grandangolo.
Ben 45 volumi dedicati ognuno ad un filosofo a partire da Socrate per finire a Campanella.
Non ho avuto la fortuna di apprezzare “Sofia” sui banchi di scuola. Ebbi il piacere di averne un “assaggio” in maniera quanto mai personale e privata da un prete al quale mio Padre mi affidò nella speranza che mi aiutasse a seguire le lezioni al ginnasio/liceo.
Era una persona straordinaria, una di quelle che non si dimenticano se ne incontri una quando sei giovane, non hai voglia di imparare quello che ti vogliono imporre e hai solo il desiderio di “studiare la vita”.
In effetti, con lui, nella sua piccola stanza del convento dove viveva, (ma non era un frate!) ripiena di libri, nella quale non potevi nemmeno muoverti, di tutto parlavamo, tranne che di filosofie.
Confesso che non ebbero molto successo le sue lezioni. Vennero sfortunatamente interrotte da un tragico evento. Lui insegnava fuori paese e ogni mattina, con un “passaggio”, si recava a scuola. Quel giorno fatale, su di un camion di fortuna, finì i suoi giorni in uno scontro. Per capire la filosofia, devi capire la vita.
“Vivere con filosofia” di Luc Ferry è un’opera avvincente e accessibile. L’autore è un discendente del fondatore della scuola francese, filosofo già ministro di governo. Il sottotitolo dice che è un “trattato di filosofia a uso delle nuove generazioni”. Ma, a mio modesto parere, è molto, molto di più. Racconta la storia della pertinenza duratura della filosofia intesa come storia della vita. Ferry scrive:
«Tutte le filosofie, per quanto divergenti possano talvolta trovarsi nelle risposte che portano, ci promettono una via di fuga dalle paure primitive. Possiedono, in comune con le religioni, la convinzione che l’angoscia ci impedisce di vivere una buona vita: ci impedisce non solo di essere felici, ma anche di essere liberi».
Fin prima dei Greci, i filosofi hanno cercato di rispondere all’ansia provocata dalla “paura dell’irreversibile”, derivante dalle nostre inevitabili limitazioni e e dalla umana mortalità. Questa paura impedisce alle persone di pensare e agire liberamente. Quindi la domanda finale per i filosofi è come persuadere le persone a “salvarsi”.
Anche se credo che l’affermazione di Ferry non è vera in tutti i casi, sarebbe difficile negare che questo sia stato un fattore importante nella storia della filosofia. Ferry considera la religione come la rivale della filosofia, ma non la denuncia. Non crede che la fede religiosa sia assurda o che si possa provare che Dio non esiste.
Ma sia il problema del male che la promessa di qualche vita dopo la morte, che molte religioni annunciano, spingono fino al punto di rottura. Quando si mettono in dubbio le risposte religiose, ci si rivolge alla filosofia per trovare un modo per “salvarsi” dalla paura dell ‘“irreversibile”. In un modo che ricorda la famosa triade kantiana:
Cosa posso sapere? Cosa dovrei fare? Cosa posso sperare?
Ferry identifica tre dimensioni della filosofia. C’è una “teoria” che cerca di scoprire la portata completa di ciò che esiste. Una profonda riflessione sulla realtà, o sulle cose come sono”. C’è l’ “etica” che riguarda la condotta umana. Considera ciò che dovremmo fare o evitare. E in terzo luogo, c’è la questione culminante della “saggezza”, vale a dire ciò a cui dovremmo mirare a realizzare nella nostra vita nel suo insieme.
La storia del pensiero è la storia degli sforzi dei filosofi per rispondere a queste domande. Ferry inizia la sua storia con interessanti, anche se brevi, discussioni personalizzate, dirette al lettore che viene così sempre coinvolto in quello che lui dice e scrive. La sua scrittura tende sempre ad assicurarsi che il lettore lo segue nel suo pensiero.
Queste discussioni gettano le basi per il suo progetto principale, vale a dire la storia della modernità, le sue origini, le sue convinzioni centrali e le sue conseguenze.
Lo Stoicismo, per Ferry, è il culmine del pensiero dell’antica Grecia. Insegnava che, sotto l’apparente caos delle cose, c’è un cosmo, un universo logicamente ben ordinato e armonioso che funge da modello per ogni buona condotta umana. Il compito degli esseri umani è trovare i loro legittimi posti all’interno di questo cosmo. In generale, per gli stoici,
“il bene era ciò che era in accordo con l’ordine cosmico, che uno lo volesse o no e ciò che era cattivo andava contro questo ordine, che piacesse o no”.
La morte fa parte di questo ordine naturale, ma non è un annientamento. Invece, è un passaggio a un modo diverso di far parte del cosmo.
“Poiché l’universo è eterno, rimarremo per sempre un frammento, anche noi non smetteremo mai di esistere”.
Per gli Stoici, i due grandi ostacoli al raggiungimento della saggezza sono la nostalgia o l’attaccamento al passato e la speranza o l’ansia per il futuro.
In verità, non esiste altra realtà se non quella in cui viviamo qui e ora. Se affrontiamo esattamente questa realtà, né la povertà, né la malattia né la morte ci disturberanno. Ameremo il mondo, qualunque cosa accada.
Qualunque siano i suoi punti di forza, il tentativo dello stoicismo di alleviarci delle paure associate alla morte è però insoddisfacente. La sua dottrina di salvezza “è decisamente anonima e impersonale”. La morte cancella l’identità di una persona.
Il Cristianesimo ha approfittato di questa inadeguatezza stoica e ha sviluppato una nuova concezione di salvezza che ha dominato per quasi 1500 anni. La “dottrina della salvezza”, proclamata dal Cristianesimo, si basa su un Dio personale disponibile a chiunque.
La fonte ultima di questa salvezza è la carità cristiana, che abbraccia tutti. E unica tra le religioni è la sua dottrina della risurrezione personale. Pertanto
“la risposta cristiana alla mortalità, almeno per i credenti, è senza dubbio la più” efficace di tutte le risposte”.
Ma questa risposta ha un prezzo elevato. Invece di pensare per se stessi, si suppone che il cristiano riponga la sua fiducia nell’Uomo-Dio, Cristo, che afferma di essere il figlio di Dio, il Logos incarnato.
La fede ha la priorità sulla ragione e la filosofia si trasforma in un secco scolasticismo che non è più una fonte vivente di saggezza. La visione del mondo cristiano è crollata sotto l’impatto delle opere di Copernico, Galileo, Cartesio e Newton.
Nel loro insieme, queste opere hanno ridotto sia l’autorità religiosa sia la concezione dell’universo come un universo finito, armoniosamente ordinato. Hanno inaugurato un periodo di stupore e radicale scetticismo. D’ora in poi la domanda fondamentale per la filosofia è:
“Come possiamo confrontare la fragilità e la finezza dell’esistenza umana, la mortalità di tutte le cose in questo mondo, in assenza di qualsiasi principio esterno e superiore a quello umano?”
Due filosofi sono in prima linea nella risposta moderna. Uno è Cartesio, che ha cercato di eliminare i dubbi sviluppando un metodo di pensiero che potesse prevenire errori e rendere possibile la scienza moderna.
L’altro è Kant, che ha stabilito il disinteresse e l’universalità come criteri per ogni condotta eticamente corretta. Basandosi sulle opere di queste due figure, la risposta della Modernità alla domanda di “salvezza” è:
“salviamo le nostre vite dedicandole o sacrificandole per qualche nobile causa.”
Tra le nobili cause proposte vi sono (a)le verità della scienza, (b) la sicurezza e il benessere della propria patria e © una qualche forma di rivoluzione politica, ad esempio la Rivoluzione francese o il Comunismo.
Tuttavia, qualunque sia l’attrattiva di una di queste nobili cause, “anche se ci dedichiamo a una causa” superiore “, nella convinzione che l’ideale sia infinitamente superiore all’individuo, rimane vero che alla fine è l’individuo che soffre e muore”.
La ricetta della modernità per la salvezza, sotto l’assalto postmoderno avviato da Nietzsche, si è dimostrata una vera soluzione. Il pensiero postmoderno mina i due principali principi moderni, vale a dire le credenze
“che l’individuo umano è al centro del mondo … e che la ragione sia una forza irresistibile per l’emancipazione”.
Nietzsche ha sostenuto che questi principi sono “idoli”. Si tratta di una fede analoga alla fede religiosa che il Modernismo aveva respinto. Per lui, la ricerca modernista della verità assoluta sminuisce la realtà del mondo sensibile enfatizzando un mondo ideale, presumibilmente intelligibile, come il mondo della scienza o della religione.
Invece della concezione illuministica della salvezza, Nietzsche promuove il concetto di “ricorrenza eterna”. Sull’interpretazione di Ferry, abbracciare questa nozione significa adottare come criterio per decidere quali momenti della vita valgono e quali non sono la “regola” che “rimpianti e rimorsi non hanno spazio e non hanno senso. Tale è la vita vissuta secondo la verità ”.
Questo criterio porta ad amor fati, “ad amare il reale qualunque sia il caso, senza scegliere e scegliere, e soprattutto senza desiderare che nulla sia diverso da quello che è”. Nietzsche promuove quindi una sorta di salvezza che ricorda lo stoicismo, ma con una differenza cruciale. Per lui, non ha senso considerare il mondo un universo armonioso in cui ogni cosa ha il suo posto assegnato.
La risposta di Nietzsche, sostiene Ferry, fallisce. Da un lato, non è esso stesso un ideale? E, soprattutto, una vita senza idee autentiche porta al puro cinismo e alla competizione sfrenata?
Né Nietzsche né gli altri pensatori postmoderni hanno una risposta soddisfacente al mondo tecnologico in cui ora abitiamo, un mondo privo di scopo. In questo mondo, il progresso è
“ridotto al significato non più del risultato automatico della libera concorrenza tra le sue parti costituenti”.
Contro questo contesto, Ferry propone la propria concezione del tipo di filosofia di salvezza che può ragionevolmente promuovere oggi. Così chiude il suo libro:
“Ogni grande filosofia sintetizza con il pensiero un’esperienza fondamentale dell’umanità, come ogni grande opera d’arte o di letteratura traduce le possibilità delle tendenze umane in forme più sensibili. Il rispetto dell’altro non esclude la scelta personale, ma al contrario ne costituisce la condizione essenziale.”

Published on April 20, 2020 07:25
No comments have been added yet.
MEDIUM
Nessuno è stato mai me. Può darsi che io sia il primo. Nobody has been me before. Maybe I’m the first one.
- Antonio Gallo's profile
- 52 followers



