L’ “Itanglese” e la realtà aumentata
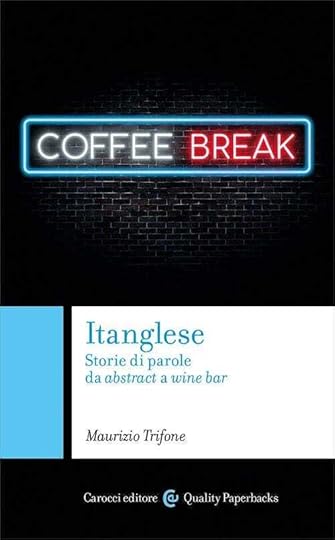 Il Libro
Il LibroQuesto è un post che non intende essere tanto una recensione quanto il pensiero libero e sempre contro corrente di chi questa lingua, l’inglese, la considera la sua “seconda lingua”, dopo quella materna.
Sono ormai oltre cinquanta anni, piu’ di mezzo secolo, che mi difendo dall’accusa di essere un anglomane, sopratutto per motivi strettamente linguistici. Non credo che l’inglese stia “assassinando” l’italiano.
Se le cose stessero così, di cadaveri la lingua di Britannia ne avrebbe seminato molti lungo il suo cammino nel tempo e nello spazio. Le cose stanno diversamente e spero di provarlo in maniera semplice e pratica, lontano da filosofismi o intellettualismi.
La verità è che le lingue, tutte le lingue, e ovviamente le loro culture, nel mondo contemporaneo, con l’avvento della IT — Informazione Tecnologica — sono destinate ad avere identità diverse da quelle che le hanno caratterizzato per secoli. Per alcuni studiosi questa è la quarta rivoluzione non ancora conclusa e completata: la “Infosfera”.
Dopo Copernico, Darwin e Freud, questa in corso è destinata a mescolare tutto. Se penso a come iniziai a studiare la lingua inglese, quella che oggi è sotto processo per tentato “assassinio” soltanto una manciata di anni fa, mi vien da sorridere.
Ne ho scritto in diverse occasioni e non è il caso che mi ripeta. Quando ero ancora “in cattedra” a scuola, mi sono trovato spesso in conflitto con i docenti di lettere di tutti gli istituti superiori della Scuola italiana.
Ho dovuto litigare con i cari colleghi di latino e greco i quali hanno avuto uno spazio egemone, decisivo e determinante nella formazione culturale degli studenti italiani.
Hanno sempre ritenuto che il latino non era una “lingua morta” e le poche ore che che fino a pochi anni fa venivano assegnate allo studio delle lingue moderne, in particolare all’inglese, era tempo perso. Non si sono mai resi conto che fuori dalle mura della scuola il mondo stava cambiando inesorabilmente.
Radio, cinema, televisione, telefono, fino all’arrivo del Commodore 64 agli inizi degli anni ottanta, il primo pc alla portata di tutti, insieme alla diversa visione della cultura diventata improvvisamente un immenso “ipertesto” globale. Avrebbe trasformato non solo la comunicazione linguistica, ma gli stessi contenuti culturali.
Adesso scoprono che ci sono troppi termini stranieri nella lingua italiana, troppi anglicismi, forestierismi, barbarismi, deviazioni linguistiche che danno vita a deviazioni mentali e culturali. Non si tratta di voler fare gli americani, ricordando una famosa canzone di Renato Carosone in auge negli anni cinquanta.
In effetti il famoso musicista, con la famosa canzone “Tu vuò fà l’americano” anticipava la storia. Non credete a chi dice, teme e scrive che l’italiano sta prendendo il posto del latino nello status di “lingua morta”. Il latino non è mai morto, nè tanto meno quel possente antico “mostro” del greco antico.
Sia l’una che l’altra, sono lingue essenziali e decisive per lo studio delle lingue moderne e per la costruzione di una vera identità europea ed occidentale destinata a confrontarsi dall’interno della cultura greco-latina e mediterranea, non solo con quella anglo-americana, ma con altre ben diverse come la cultura araba e quella orientale.
Quello a cui dobbiamo state attenti quando si parla di anglicismi e di invasione linguistica, per quanto riguarda specialmente noi Italiani, è il travaso dell’inglese nell’italiano. La voglia di fare non solo gli americani, alla Carosone, ma di atteggiarsi ad essere “globish”, parola che sta per “global english”, atteggiarsi e credere di conoscere davvero l’inglese.
Questi anglicismi di cui si parla e si legge nel Parlamento e nel Paese Italia, sono pseudo anglicismi che nessun anglofono comprende davvero. Sono parole inglesi usate quasi sempre in senso diverso. “Ad usum delphini” è il caso di dire, anche se il “delfino” non è morto e non è fesso!
Austerity, e-book, fake news, gossip, homepage, meeting, selfie, trend…: la lista delle parole inglesi entrate a far parte del nostro vocabolario è lunghissima. Per questo tra i cultori dell’idioma di Dante è diffuso il timore che l’italiano possa trasformarsi in un “itanglese”, cioè in un italiano infarcito di anglicismi e pseudoanglicismi.
Attraverso una ricca serie di esempi, spesso divertenti, tratti dalla lingua quotidiana e dai giornali, questo recente volume racconta la storia di numerose parole inglesi o angloamericane penetrate nell’italiano in diverse epoche e per vie talvolta imprevedibili.
L’intento non è certo quello di deplorare l’ingresso di parole straniere nella nostra lingua o di imporre sostituti italiani, ma solo di fare luce su un fenomeno linguistico inarrestabile e aiutare il lettore a riflettere sulle risorse lessicali a sua disposizione: generalmente il parlante può scegliere tra un anglicismo e un suo altrettanto valido corrispettivo italiano… a patto che lo conosca.
Itanglese. Storie di parole da “astratto” a “wine bar” è un libro di Maurizio Trifone, linguista e lessicografo italiano, noto per i suoi studi sull’evoluzione della lingua italiana e sugli influssi stranieri, in particolare dall’inglese. Il volume esplora il fenomeno ”Itanglese”, ovvero l’uso sempre più frequente di parole e costrutti inglesi all’interno della lingua italiana, spesso con adattamenti di significato o pronuncia. Trifone analizza come questi prestiti linguistici entrano nel lessico quotidiano, a volte diventando indispensabili (come computer o smartphone), altre volte suscitando polemiche (come welfare o smart working).
Il libro è organizzato come una raccolta di brevi storie lessicali, che partono da parole astratte (come accountability o leadership) per arrivare a termini legati alla vita quotidiana e al consumo (come wine bar o food delivery). Trifone non si limita a elencare anglicismi, ma ne racconta l’origine, l’evoluzione e l’impatto sulla società italiana, tra moda e business (brand, trendy, fashion), tecnologia e social media (hashtag, streaming, fake news), cibo e lifestyle (brunch, happy hour, gluten free), politica ed economia (spread, governance, jobs act).
Trifone adotta un tono divulgativo ma rigoroso, senza demonizzare gli anglicismi ma evidenziandone sia l’utilità (quando arricchiscono la lingua) sia i rischi (quando sostituiscono inutilmente parole italiane esistenti). Il libro è adatto a chi è curioso di linguistica, ma anche a chi vuole riflettere sull’identità dell’italiano contemporaneo. Il titolo gioca sull’ibridazione tra Italiano e English, proprio come fa la lingua reale. Trifone è anche autore del Devoto-Oli, uno dei più importanti dizionari italiani, e ha lavorato a lungo sull’evoluzione lessicale. Ecco alcuni esempi significativi.
Astratti e istituzionali: accountability (rendicontabilità, trasparenza). Leadership (in politica e business). Welfare (stato sociale vs. uso aziendale). Governance (gestione del potere). Smart working (polemiche sul sostituto di “lavoro agile”). Economia e finanza: spread (divario tra BTP e Bund tedeschi). Jobs Act (riforma del lavoro italiana con nome inglese). Startup (imprese innovative). Default (fallimento). Brand (marchio, ma con sfumature diverse). Tecnologia e social media: hashtag (dai social alla cultura pop). Fake news (disinformazione). Streaming (netflix e non solo). Cloud (nuvola informatica). Chatbot (intelligenza artificiale). Cibo e lifestyle: wine bar (enoteca “moderna”). Brunch (fusione breakfast + lunch). Happy hour (aperitivo all’anglosassone). Food delivery (consegna a domicilio). Gluten free (senza glutine, ma più trendy). Moda e consumo. Fashion (moda, ma con un’aura internazionale). Trendy (alla moda). Outlet (negozi di stock a prezzi scontati). Must-have (oggetti irrinunciabili). Street style (moda urbana). Altri esempi curiosi: abstract (riassunto accademico). Briefing (riunione informativa). Privacy (tutela dei dati, ma usato spesso al posto di “riservatezza”). Performance (prestazione, ma con connotati artistici). Know-how (competenza tecnica).
Mi è piaciuto l’approccio di Trifone. Per ogni termine, l’autore ne spiega l’origine, l’adattamento all’italiano e le reazioni della società (dall’entusiasmo al rifiuto). Alcuni esempi sono divertenti (come mocaccino, ibrido tra mocaccino e cappuccino), altri rivelano tensioni culturali (es. spread, parola tecnica diventata populista). Una parola in particolare, mi serve per capire come la realtà in questi ultimi tempi e andata sempre più ingrossandosi. Anzi, aumentata.
Nel libro, Trifone dedica attenzione a “augmented reality” (AR), un anglicismo entrato nell’italiano tecnologico senza un vero equivalente (se non la traduzione letterale “realtà aumentata”, ormai accettata ma meno usata nel marketing). Perché è un caso interessante? Si tratta di un’adozione senza traduzione. Mentre altre lingue cercano calchi (es. francese réalité augmentée), in italiano prevale la forma inglese, soprattutto in ambito tech e pubblicitario.
Esempio: “Scarica l’app con l’augmented reality!” (invece di “realtà aumentata”). Uso settoriale vs. quotidiano. Nella tecnologia è dominante (es. AR glasses, AR filters), ma nella vita di tutti i giorni si preferiscono spiegazioni: “quel filtro che sovrappone immagini alla realtà”.
Trifone nota come l’inglese crei una barriera tecnologica tra esperti e non. Concorrenza con “virtual reality” (VR). Spesso confuse, ma l’AR (augmented) arricchisce la realtà esistente (es. Pokémon GO), mentre la VR (virtual) la sostituisce (es. Oculus Rift).
In italiano, però, molti usano “realtà virtuale” per entrambi, mostrando un adattamento imperfetto. Effetto moda. L’AR è diventato un buzzword (parola chiave trendy) per campagne pubblicitarie, anche quando non centra: “Scopri il nostro menù in augmented reality!” (per un semplice QR code).
Critiche e polemiche. Trifone sottolinea che l’uso eccessivo di “augmented reality” (invece di realtà aumentata) esclude chi non conosce l’inglese, soprattutto anziani o meno esperti. È un esempio di come il tecno-lingua inglese domini settori innovativi, lasciando l’italiano in ritardo.
Una curiosità. In italiano esiste anche “realtà mista” (mixed reality, MR), ma è quasi sconosciuta. Alcuni brand italiani provano a resistere: IKEA Italia usa “realtà aumentata” nel sito, ma Apple Italia preferisce “AR”.
La realtà si può davvero “aumentare”? Un gioco tra linguaggio e tecnologia.
La domanda è filosofica quasi quanto tecnologica! Maurizio Trifone non approfondisce il lato metafisico dell’augmented reality, ma l’uso di questa espressione rivela molto sul rapporto tra lingua e innovazione.
Il resto lo fa la fantasia che resta una emozione tutta umana. Non credo ci sia un algoritmo che nasca dalla fantasia. Forse mi sbaglio. È la fantasia a creare l’algoritmo.[image error]
Published on April 12, 2025 00:06
No comments have been added yet.
MEDIUM
Nessuno è stato mai me. Può darsi che io sia il primo. Nobody has been me before. Maybe I’m the first one.
- Antonio Gallo's profile
- 52 followers



