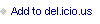Sergio Maistrello's Blog, page 6
October 12, 2015
Il wifi a scuola e le porte aperte sul cambiamento
L’Istituto superiore Evangelista Torricelli di Maniago, in provincia di Pordenone, mi ha invitato a intervenire in occasione dell’inaugurazione del sistema di accesso WiFi d’istituto, e-Vangelista. Questo è quello che ho raccontato agli insegnanti e agli studenti presenti questa mattina.
§
Ci troviamo qui stamattina per inaugurare una manciata di scatolotti di plastica e di circuiti elettronici, un po’ di antenne e qualche centinaio di metri di cavi. Perché è importante, al punto da spingere il vostro dirigente scolastico a impegnare per l’occasione mezza mattina del nostro tempo? Perché quegli scatolotti, quelle antenne, quelle onde radio sono una porta aperta. Avete idealmente spalancato una porta tra le vostre idee e attività e le idee e le attività di tutti gli altri, là fuori.
Certo, molto probabilmente non avevate bisogno del WiFi di istituto per aprire quella porta. Molti di voi ne avranno sicuramente una a portata di mano, in tasca, nel vostro telefonino. E a casa. E nei vostri luoghi di ritrovo preferiti. Accendere un WiFi dentro una scuola è però una dichiarazione programmatica di accoglienza del cambiamento, di senso del presente, di voglia di mettersi in gioco. Dove se non a scuola? Dove se non nel luogo in cui si formano i cittadini di un mondo che è sempre più basato sulla capacità di aprire porte e far circolare rapidamente le idee?
Quello che stiamo vivendo è un cambiamento frenetico, esponenziale. Non facciamo in tempo a venire a capo delle sfide avanzate da ieri che siamo già in forte ritardo per affrontare quelle di domani. Gran parte delle discussioni sul futuro che impegnano in questi anni le classi dirigenti di questo Paese, e a cui noi facciamo da ingenuo coro greco, con ogni probabilità suoneranno ridicole quando vivremo effettivamente il futuro che oggi stiamo immaginando e pianificando. Sta succedendo tutto molto più velocemente di quanto siamo pronti ad assecondare. E questi cambiamenti stanno incidendo sulla forma della nostra società molto più profondamente di quanto siamo preparati a riconoscere e a gestire. Allora un WiFi acceso in una scuola è un piccolo segno di accettazione di questa velocità e della volontà di sperimentare insieme nuove dimensioni operative, nuove velocità, nuove connessioni, ognuno nel suo ruolo.
(Naturalmente trovare modi nuovi per copiare la versione di latino o il tema di italiano da parte degli studenti, e arginare in modo altrettanto aggiornato queste furbizie da parte degli insegnanti, lo considero parte integrante di questo percorso di apprendimento condiviso.)
In questo senso, e-Vangelista mi sembra un nome particolarmente evocativo. Mi rendo conto che è quasi un caso, avrebbe potuto essere e-Ugenio o e-Rmenegildo se solo mamma e papà Torricelli avessero scelto diversamente. Ma mi ha fatto tornare in mente quello che diceva lo scrittore Ferdinando Camon inaugurando un’edizione precoce di Pordenonelegge, diversi anni fa. Camon in verità parlava delle ragioni della lettura e della scrittura, ma a un certo punto suggerì che l’imperativo etico dei nostri giorni, prima ancora che “ama il prossimo tuo come te stesso”, dovesse essere “acquisisci il maggior numero possibile di informazioni sugli altri e fornisci agli altri il maggior numero di informazioni su di te”. Sulla disponibilità e sullo scambio di informazioni, diceva, si fonda il dialogo tra le persone, l’incontro delle culture, il senso della civiltà.
Acquisisci informazioni. Fornisci informazioni. Imperativo etico. Senso della civiltà. Io trovo che sia una meravigliosa, quanto probabilmente involontaria, definizione della rete come piattaforma sociale, almeno per come ho avuto la fortuna di viverla io nell’ultimo paio di decenni. Internet si fonda sulla possibilità garantita a ciascuno di contribuire con il proprio tassello a uno sterminato mosaico universale della conoscenza. Più siamo capaci di rappresentare sulla Rete le nostre idee, le nostre esperienze e le nostre competenze e più è probabile che queste trovino interlocutori interessati con cui dialogare, con cui collaborare, con cui fare affari. Vale per i singoli, ma vale a maggior ragione per le nostre comunità territoriali, che sono così ricche di identità e di specificità. Quel che la globalizzazione del lavoro e delle merci ha tolto al manifatturiero delle lavatrici, dei frigoriferi, dei televisori, dei mobili, dei coltelli, oggi la globalizzazione della conoscenza potrebbe restituire ai nostri eventi culturali, alle nostre imprese innovative, alle tante eccellenze nelle professioni e nelle arti, alla manifattura e all’artigianato che assecondano la smaterializzazione dei beni.
Se la circolazione della conoscenza è il fattore strategico, il tempo è il fattore competitivo. I centri maggiori, le città d’arte, le metropoli saranno sempre più appetibili della nostra periferica e contenuta provincia. Ma oltre a essere più interessanti, le grandi città sono anche più complesse: fare sistema a Milano è, in proporzione, molto più complicato che farlo a Pordenone o a Maniago. Questo è il momento storico in cui hanno maggiori possibilità di emergere le città a misura d’uomo, ricche di identità e propense alle relazioni, coese intorno a una visione di futuro. Provinciale un tempo era chi veniva raggiunto a fatica dalle storie del mondo. Oggi provinciale è chi non si adopera per far arrivare le sue storie nel mondo.
Internet in questo senso è il sistema operativo imprescindibile: aderisce alle reti naturali della nostra società, esalta le affinità tra le persone e tra i contenuti, costruisce ponti tra i territori e le specializzazioni, permette alle informazioni interessanti di diffondersi velocemente. È più semplice da usare di quel che sembra, ma rema contro decenni di alfabetizzazione mediatica e in questo senso è controintuiva: per esempio, chiede di lasciare andare i lettori se vogliamo che tornino, di collaborare con i concorrenti se vogliamo competere, di regalare i nostri prodotti se vogliamo venderli. Sono tecnologie dell’esperienza, come imparare ad andare in bicicletta o a nuotare: una volta trovato l’equilibrio, diventa una competenza acquisita.
Lo scarto più sensibile è culturale, non tecnologico. La Rete non è una vetrina né una bacheca dove appendere locandine: prima che uno strumento di pubblicazione è uno strumento di relazione, che diventa tanto più potente e utile quanto più impara a conoscerci. Il comunicato stampa occasionale serviva poco prima e serve sempre meno ora, comunicare in Rete significa alimentare un progetto narrativo coerente che crei contesto e lo sviluppi giorno per giorno. La storia passata è la fonte della reputazione e del capitale sociale, che nell’economia della conoscenza sono le valute da spendere al mercato delle opportunità. Ditelo per esempio ai nostri festival di dignità nazionale e internazionale, che si ostinano a chiudere gli archivi in un cassetto.
Lo sforzo non può che essere collettivo e distribuito: l’iniziativa del singolo o dell’istituzione può essere di stimolo, ma non basta. Il volano si avvia soltanto se tanti si mettono in gioco e se ognuno fa la sua piccola parte. Del resto la redistribuzione delle responsabilità in ogni aspetto della nostra vita comune sarà un processo inevitabile e colossale, al termine di questo cambiamento che da otto anni chiamiamo crisi. Crisalide, la chiama Luca De Biase: terminerà quando avremo saputo interpretare la transizione.
Voi, cari e-Vangelisti, oggi diventate a tutti gli effetti un nodo al servizio di questo sforzo collettivo. Avete scelto di fare rete, di tessere rete al vostro interno, ma in questo modo ora siete inevitabimente connessi da nodo ad altri nodi. Da questo momento il vostro compito non è già più semplicemente amministrare i vostri hotspot, i vostri punti di accesso interni. Dovrete avere cura del benessere delle reti delle comunità a cui appartenete – la comunità territoriale maniaghese e pordenonese, ma anche le comunità di interessi specifici, come quella del mondo della scuola per esempio. È una responsabilità che viene insieme all’accesso, compresa nel prezzo per così dire. Ed è un ecosistema: ogni vostra azione, nel suo piccolo, influenzerà in bene e in male i destini della comunità, e dunque il vostro stesso destino nel lungo periodo.
Mi chiedo – e lo chiedo in particolare agli studenti presenti oggi – se vi rendiate conto dello spostamento di potere che quello scatolotto e quelle antennine implicano. Non più di venti o trent’anni fa, io ero seduto al vostro posto, in una sala simile a questa, in una scuola che peraltro il vostro preside conosce molto bene. Allora l’urgenza di comunicare ci portava a stampare giornalini scolastici con il ciclostile e a montare video che testimoniavano le nostre attività utilizzando la telecamera della scuola e i due videoregistratori del laboratorio di scienze. Già il fatto che la scuola avesse acquistato una telecamera e la facesse usare agli studenti, in quegli anni, era straordinario. Potete ad ogni modo immaginare il risultato. Quei giornalini e quei video li vedevano, quando andava bene, alcuni nostri compagni di classe e forse gli insegnanti più curiosi. Potevamo addirittura uscire con le nostre idee fuori dall’edificio, se per esempio il video veniva abbastanza bene da competere al concorso video della Casa dello Studente o se l’articolo del giornalino solleticava la curiosità del giornale locale.
Oggi voi potete comunicare direttamente al mondo, potete far arrivare le vostre idee ovunque in un attimo e, se sono valide e ben confezionate, potete assistere al miracolo di vederle sbocciare. La scuola, con iniziative come quella che celebriamo oggi, vi aiuta a farlo. Potete ascoltare il mondo e potete parlare al mondo. Fornite informazioni, acquisite informazioni. Avete nelle vostre mani un potere enorme, rispetto a quello che avevamo noi alla vostra età. Ma anche molto spesso rispetto a quello che hanno ancora oggi gli adulti che, dalla famiglia alle istituzioni, sono incaricati di guidarvi.
Da grandi poteri derivano grandi responsabilità, diceva negli anni ‘60 Ben Parker (lo zio di Spiderman, per capirci). Questo è il compito che avete davanti nei prossimi mesi, dal mio punto di vista, ora che la rete è fatta. Comprendere quali sono le responsabilità di cui dovete farvi carico in quanto nodi della vostra comunità scolastica e cittadina. Responsabilità rispetto al modo in cui trattate le informazioni e rispettate l’oggettività dei fatti. Responsabilità nel selezionare i contenuti più interessanti per voi stessi, per i vostri percorsi di approfondimento, perché le vostre scelte, i vostri commenti, i vostri apprezzamenti indirizzano le scelte altrui e permettono alla comunità di far emergere solo ciò che merita davvero. Responsabilità nel riconoscere e difendere l’interesse generale di una comunità, un valore che oggi sembra drammaticamente trascurato dentro i gruppi di discussione locale nei social network. Responsabilità nelle cause che decidete di sostenere o combattere, sapendo che la rete è un grande alleato di chi si spende in positivo a favore di ciò in cui crede e che il modo migliore per boicottare ciò che non ci piace è semplicemente ignorarlo.
Insomma, credevate di avere per le mani semplicemente una rete di hotspot WiFi. State invece inaugurando un piccolo laboratorio sociale, dove imparare a diventare comunità intelligente, scuola intelligente, cittadini del mondo intelligenti. Fatene buon uso.







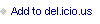
October 3, 2015
State of the Net 2015
Domenica e lunedì c’è State of the Net, la conferenza internazionale dedicata alla rete e al suo impatto sulla società, che ho il privilegio di organizzare con Beniamino Pagliaro e Paolo Valdemarin. Quest’anno andiamo in trasferta a Milano con la scusa di Expo 2015, ospiti di UniCredit nel nuovo e bellissimo Pavilion a Porta Nuova. Parleremo di algoritmi e di come software sempre più potenti, che interagiscono con quantità crescenti di dati, imprimeranno accelerazioni forse ancora a noi poco comprensibili in ogni ambito della nostra società.
Come al solito, ci raggiungeranno imprenditori, analisti e visionari da mezzo mondo. Domenica pomeriggio li incontriamo nel corso di una sessione aperta e informale, insieme ai partecipanti che vorranno far parte della conversazione dal giorno prima. Lunedì conference as usual, secondo il format consolidato di State of the Net. Dai un’occhiata alla lista degli interventi. Ci puoi seguire anche in streaming.
» Il programma
» Gli speaker
» Social wall #sotn15







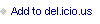
September 24, 2015
Pordenonelegge 2015 in soggettiva
September 16, 2015
La rievocazione medioevale di Valvasone
May 25, 2015
La logistica di Amazon
Che cosa succede quando Amazon, il colosso del commercio elettronico mondiale, riceve un ordine da un cliente? Per scoprirlo, lo scorso 23 maggio sono entrato nel centro logistico di Castel San Giovanni, a 20 chilometri da Piacenza. Aperto nel 2013, lo stabilimento ha una superficie operativa di 85.000 metri quadrati nella quale lavorano 620 dipendenti.
Dentro lo stabilimento, la proverbiale ossessione per la soddisfazione del cliente per cui è nota l’azienda americana diventa soprattutto ossessione per la formazione, l’organizzazione e la sicurezza del personale. L’attenzione maniacale per i dettagli che possono rendere più fluida l’attività è evidente fin dal parcheggio, dove le auto devono entrare in retromarcia negli stalli, per rendere più scorrevole e sicura l’uscita a fine turno.
Il primo settore che visito è quello delle merci in arrivo. Qui i prodotti dei fornitori vengono disimballati, codificati e infine assegnati dal software di gestione al settore del magazzino più funzionale. I ritmi di lavoro sono sostenuti, ma anche la possibilità di veder prese in considerazione le proprie proposte. Alcune idee di dipendenti italiani sono diventati standard per tutti gli stabilimenti di Amazon nel mondo.
Tutto è collocato in modo da rendere la composizione degli ordini il più efficiente possibile. Le merci si muovono rapidamente attraverso carrelli, nastri e scivoli. Nella sede italian non sono ancora operativi i robot introdotti in alcuni fulfillment center degli Stati Uniti.
Il magazzino è diviso in tre settori: quello per gli articoli pesanti e di grandi dimensioni, quello per i prodotti ingombranti di medie dimensioni e quello per i prodotti piccoli e leggeri. Il settore dedicato a libri, cd, dvd e piccoli oggetti si estende per quattro piani in altezza. I prodotti stivati sono milioni.
L’aspetto più sorprendente è che i prodotti non sono divisi in modo omogeneo per tipologia, ma in modo quasi casuale. I nuovi arrivi vengono collocati semplicemente dove c’è uno spazio libero, è sufficiente che siano indicizzati con precisione dal software di gestione. Prodotti simili sono tenuti volutamente distanti per ridurre al massimo la possibilità di un errore.
Il magazzino è suddiviso in zone. Ogni zona è coperta da un addetto, che riceve le richieste dei prodotti di sua competenza, li raccoglie e li manda avanti alla fase di composizione degli ordini. Quando tutti i prodotti di un ordine sono stati raccolti, vengono assemblati nella confezione più adatta e preparati per la spedizione. Quindi vengono etichettati e affrancati.
La chiusura di un ordine è un incastro stupefacente tra i contributi di diversi addetti, che nel completarsi tra loro garantiscono anche successivi livelli di controllo sulla sua correttezza. I pacchi sono quindi suddivisi in modo automatico in base alla priorità, alla dimensione e al tipo di spedizione, e condotti attraverso nastri al contenitore del corriere che lo prenderà in carico. In questa fase viene svolto anche l’ultimo controllo di coerenza tra la dimensione e il peso attesi e quelli effettivi. Se non coincidono il pacco viene trattenuto e riesaminato.
Tutto è orchestrato in modo rapido e automatico dal sistema logistico, che sceglie in ogni momento le combinazioni più efficienti tra disponibilità di uomini e mezzi, complessità degli ordini da trattare, dislocazione degli articoli da recuperare tra le decine di milioni stivate, tempi di consegna concordati con i clienti e scadenze di trasferimento dei pacchi agli spedizionieri.
È in questo modo che a Castel San Giovanni sono riusciti a far fronte a un picco di quasi 250.000 spedizioni e 400.000 ordini in un giorno solo, sotto Natale. Un ritmo da oltre 4 ordini al secondo.
In occasione del Family&Friends Day del 23 maggio, Amazon ha annunciato anche in Italia l’apertura delle visite nel centro logistico a tutti gli interessati.







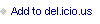

May 22, 2015
C’è un nuovo nodo in città (approfittiamone)
Milano, Barcellona, Tirana, New York e… Pordenone, ovvio. Da un paio d’anni sapevo dell’intenzione di aprire un Talent Garden in Friuli Venezia Giulia, ma non ci speravo troppo. Questo territorio è una scommessa rischiosa: la promessa di enormi potenzialità (come ho già avuto modo di dire) è ostacolata dall’incapacità cronica di tessere reti tra le competenze e di respirare l’aria del presente in tempo utile per ossigenare le idee. Ieri è stato inaugurato il nuovissimo TAG Pordenone, che va ad aggiungersi ai tre nodi pordenonesi della rete Cowo, ed è una bellissima notizia per chi crede nella forza della condivisione e della collaborazione.







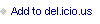

April 26, 2015
Che cos’è un Coder Dojo?
Mio figlio Giorgio è tornato entusiasta anche questa volta, la seconda. Guidato da Gianpiero, volontario del CoderDojo Friuli Venezia Giulia, nel giro di un paio d’ore ha creato un gioco basato su una ranocchia che deve far scoppiare dei palloncini. Un gioco semplice e spartano, con cui però avrebbe giocato tutta la sera, come succede quando inventa nuove costruzioni con i Lego.
Un coder dojo è una palestra di programmazione: non una scuola di coding in senso stretto, ma un’esperienza di avviamento alla logica algoritmica per ragazzi dai 7 anni in su. Si sceglie uno scenario, si introducono personaggi e oggetti, si attribuiscono caratteristiche e azioni e si generano le relazioni che animano il gioco. Il tutto avviene dentro un ambiente di sviluppo amichevole e visuale, Scratch, sviluppato e distribuito gratuitamente dal Massachusetts Institute of Technology.
I coder dojo sono nati in Irlanda nel 2011 e da allora si sono diffusi in tutto il mondo, dando vita a un network globale di volontari ed eventi. L’Italia, per una volta, è uno dei paesi più attivi, con club informali presenti su tutto il territorio e decine di occasioni di incontro ogni mese. Centinaia i mentor, ovvero gli appassionati di programmazione che dedicano alcune ore alle attività di divulgazione. Si moltiplicano anche le occasioni per portare i coder dojo a scuola, coinvolgendo insegnanti e studenti in esperienze didattiche innovative.







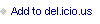

April 22, 2015
Un umanista informatico ante litteram
A poco più di un anno dalla scomparsa, è uscito un volume per ricordare opera, pensieri e ispirazioni di Franco Fileni, sociologo e a lungo docente all’Università di Trieste. Si può leggere integralmente nel sito delle collane di ateneo. C’è anche una mia breve testimonianza.
Gli studi dei docenti sono lunghi lunghi e stretti stretti, nell’edificio centrale dell’Università di Trieste. Franco Fileni il suo ufficio l’aveva trasformato in laboratorio e in aula di lezione, riempiendo ogni spazio lasciato libero dalle scrivanie e dai libri con computer, monitor, stampanti, scanner, webcam e ogni sorta di dispositivo informatico. Alle pareti le riproduzioni di alcune opere di Escher. Negli anni ’80, Fileni aveva sviluppato questa profonda curiosità accademica per i risvolti epistemologici della diffusione dei computer, conscio che la supposta e allora inossidabile divisione tra regno dell’analogico e regno del digitale di per sé non era né sufficiente né in fondo del tutto calzante per spiegare l’impatto di quelle macchine sul pensiero e sulla comunicazione. Né apocalittico né integrato, Franco si interrogava semmai sui confini, sulle terre di mezzo, sulle strutture connettive dove vecchio e nuovo si toccavano dando vita a sintesi inedite da esplorare con la sensibilità dell’antropologo. Bateson davanti al pc.
[continua a leggere questo ricordo o l’intero libro sul sito dell’Università di Trieste]







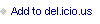

April 7, 2015
Le narrazioni globali delle piccole città
Il Messaggero Veneto mi ha chiesto di contribuire al dibattito sul futuro di Pordenone, in corso da qualche mese sulle pagine dell’edizione locale. Questa – uscita sul giornale di domenica – è la mia riflessione, che vale per la mia città ma più in generale per molte altre piccole località ricche di storie da raccontare. Fa tesoro di conversazioni di lunga durata e con molte persone in rete su questi temi. È in debito di link in particolare con Giuseppe Granieri e Piervincenzo Di Terlizzi.
§
Nell’epoca delle narrazioni globali accelerate da Internet, la circolazione della conoscenza è il fattore strategico per una città. Più siamo capaci di rappresentare sulla Rete le nostre idee, le nostre esperienze e le nostre competenze e più è probabile che queste trovino interlocutori interessati con cui dialogare, collaborare o commerciare. Pordenone ha un potenziale enorme, molto superiore a quello che ci si aspetterebbe da una città delle sue dimensioni, ma per ora sta scegliendo di sprecarlo. Un po’ come bruciare in piazza un bancale di buoni del Tesoro esigibili, per rendere l’idea a chi non è pratico di comunicazione digitale.
L’effetto che facciamo oggi a chi si informa su di noi da lontano utilizzando il web e i social network è quello di una città qualunque, anonima. Chi si spinge fino qui scopre invece che organizziamo feste straordinarie per monumenti viventi della letteratura mondiale; che passiamo una settimana all’anno in compagnia di un buon centinaio di intellettuali di grido; che ogni settimana piccoli e grandi eventi richiamano persone da fuori provincia, da fuori regione, spesso dall’estero. Qui ogni autunno si danno appuntamento da tutto il mondo studiosi e appassionati del cinema muto. Qui vivono artisti e artigiani attivi in nicchie insolite o innovative. Qui hanno sede imprese e cooperative sociali con una visione del futuro coraggiosa e contagiosa.
Tutto questo c’è, ma spesso è poco riconoscibile perfino da chi a Pordenone ci abita, segno che probabilmente siamo più bravi a organizzare che a comunicare. Segno, soprattutto, che siamo ricchi di energie ma ancora non siamo riusciti a metterle in rete, sostenendo e amplificando in modo sistematico le opportunità per chi si dà da fare e per tutta la città come conseguenza. La posta in gioco è alta: quel che la globalizzazione del lavoro e delle merci ha tolto alla Pordenone delle lavatrici, dei frigoriferi, dei televisori e dei mobili, ora la globalizzazione della conoscenza potrebbe restituire alla Pordenone degli eventi culturali, delle imprese innovative, delle eccellenze nelle professioni e nelle arti, della manifattura e dell’artigianato che assecondano la smaterializzazione dei beni.
I centri maggiori, le città d’arte, le metropoli saranno sempre più appetibili della nostra periferica e contenuta provincia. Ma oltre a essere più interessanti, le grandi città sono anche più complesse: fare sistema a Milano è, in proporzione, molto più complicato che farlo a Pordenone. Questo è il momento storico in cui hanno maggiori possibilità di emergere le città a misura d’uomo, ricche di identità e propense alle relazioni, coese intorno a una visione di futuro. Il tempo, dunque, è un fattore competitivo, e qui ne abbiamo già perso parecchio.
Abbiamo già dimostrato di esserne capaci. Un anno fa, proprio di questi tempi, ci stavamo preparando ad accogliere cinquecentomila alpini da tutta Italia, dieci volte il numero dei residenti, mettendo in discussione ogni dettaglio della routine della città. Poco importa il pretesto. Il fatto è che per qualche settimana, sotto la pressione di una scadenza fuori scala per le nostre abitudini, stretti dietro allo stemma della città con le porte aperte, abbiamo comunicato molto più del solito tra di noi e abbiamo spiegato tanto di noi agli altri. Abbiamo fatto rete, abbiamo lavorato in rete e, per la prima volta in modo così consapevole, abbiamo usato la Rete per rilanciare in Italia e nel mondo il marchio ideale della nostra città.
Potremmo ripartire da qui. Internet è il sistema operativo imprescindibile: aderisce alle reti naturali della società, esalta le affinità tra persone e contenuti, costruisce ponti tra i territori e permette alle informazioni interessanti di diffondersi velocemente. È più semplice da usare di quel che sembra, ma rema contro decenni di alfabetizzazione mediatica e in questo senso è controintuiva: per esempio, chiede di lasciare andare i lettori se vogliamo che tornino, di collaborare con i concorrenti se vogliamo competere, di regalare i nostri prodotti se vogliamo venderli. Sono tecnologie dell’esperienza, come imparare ad andare in bicicletta o a nuotare: una volta trovato l’equilibrio, diventa una competenza acquisita.
Lo scarto più sensibile è culturale, non tecnologico. La Rete non è una vetrina né una bacheca dove appendere locandine: prima che uno strumento di pubblicazione è uno strumento di relazione, che diventa tanto più potente e utile quanto più impara a conoscerci. Il comunicato stampa occasionale qui non serve, comunicare in Rete significa alimentare un progetto narrativo coerente che crei contesto e lo sviluppi giorno per giorno. Abituati a chiudere le notizie scadute in un armadio, trascuriamo l’importanza che in questo ambiente assumono gli archivi: la storia passata è la fonte della reputazione e del capitale sociale, che nell’economia della conoscenza sono le valute da spendere al mercato delle opportunità.
L’obiezione più frequente, anche nelle organizzazioni meno improvvisate, è che mancano se non le competenze, di certo le energie. Le prime è in ogni caso urgente acquisirle, saranno sempre più un requisito competitivo. Quanto alle energie, in realtà la comunicazione in Rete non è una sovrastruttura che si aggiunge alle incombenze precedenti e tanto meno un servizio che può essere esternalizzato. È un diario di viaggio che dovrebbe nascere il più possibile vicino al cervello e al cuore di una passione o di un’attività. È un metodo che ridefinisce i tempi complessivi della comunicazione: può essere impegnativa in fase di avvio, ma un buon progetto editoriale incentrato sul web alimenta a cascata tutti gli altri canali informativi, con significative economie di scala sia in termini di costi che di tempo. In ogni caso è un investimento: la quantità di contatti e ritorni diretti e indiretti che si possono generare il più delle volte ripagano ampiamente l’impegno.
Provinciale un tempo era chi veniva raggiunto a fatica dalle storie del mondo. Oggi provinciale è chi non si adopera per far arrivare le sue storie nel mondo. Pordenone ha caratteristiche decisamente contemporanee, non c’è motivo per cui debba comunicarle come nel 1995. Lo sforzo non può che essere collettivo: l’iniziativa del singolo o dell’istituzione può essere di stimolo, ma non basta. Il volano si avvia soltanto se tanti si mettono in gioco e se ognuno fa la sua piccola parte. Del resto la redistribuzione delle responsabilità in ogni aspetto della nostra vita comune sarà un processo inevitabile e colossale, al termine di questa strana transizione che da quasi otto anni chiamiamo crisi. Tanto vale cominciare ad affrontarla laddove promette di generare vantaggi per tutti.







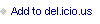

February 5, 2015
Se Pordenone perde l’università (che non ha)
Io invece penso che a Pordenone tutto sommato farebbe bene perdere l’università (laddove università è usata come sineddoche per un consorzio universitario che accoglie alcuni corsi distaccati da Udine e Trieste, un’ipotesi tramontata di dipartimento e alcuni master universitari). Per due motivi, uno di sistema e uno locale.
Quello di sistema: penso che la decentralizzazione dei corsi di laurea e dei dipartimenti abbia portato poco nei territori (salvo i rarissimi casi in cui corsi molto specialistici attingevano ai distretti locali e restituivano nuove competenze, come in origine era stato anche qui in Friuli) e abbiano invece tolto molto alle università. La moltiplicazione e distribuzione di sedi, servizi e docenti non è mai stata davvero sostenibile, ma in questa congiuntura economica lo è meno che mai. Se vogliamo un’università competitiva e garantire davvero il diritto allo studio così come qualche reale opportunità di ricerca sono convinto sia meglio mantenere le università in un’unica sede (e già due poli regionali sono un lusso), concentrando gli investimenti in dotazioni eccellenti e in offerta didattica realmente competitiva col resto del mondo. Mi pare che l’economia delle università ricalchi per molti versi quella degli aeroporti: pochi hub regionali mantengono vivo e vivace l’intero sistema nazionale, troppi scali di provincia drenano risorse dal territorio, coprono a stento i costi operativi e indeboliscono la rete impedendo l’ottimizzazione dei servizi e peggiorando l’efficienza nazionale.
Il secondo motivo, quello tutto locale. Credo che l’università di oggi non sia più lo strumento di cui abbiamo bisogno per rispondere in modo flessibile alle necessità e alle opportunità di formazione continua e avanzata del territorio. L’università deve fare l’università e probabilmente è giusto che la faccia altrove, dove può rendere al meglio nel nostro stesso interesse. Negli spazi bellissimi e ormai ben attrezzati di via Prasecco, difficilmente riconvertibili in altro salvo ulteriori investimenti, abbiamo invece l’opportunità di reinventare la formazione su misura per questo luogo in questo tempo, in modo snello ed efficiente, servendo con rapidità ed elasticità i volani di sviluppo su cui la città deciderà di scommettere in futuro. Come ripeto spesso, Pordenone è una città ricca di identità, di competenze e di specializzazioni, che dovremmo arrenderci a mettere in rete se vogliamo competere sul mercato globale della conoscenza. Da queste reti e dalle loro connessioni in Italia e nel mondo, possono uscire moduli didattici aggiornati al servizio di scuole, aziende, ordini professionali, amministratori, cittadini. Basta un po’ di coraggio, un gruppo di persone competenti e pienamente inserite nel presente, un piano economico solido, non impossibile da raggiungere se mettiamo a sistema le risorse di oggi e se impariamo a utilizzare in modo intelligente le opportunità della tecnologia. Io, prima di investire altri milioni a fondo perduto su un sistema che sta evidentemente segnando il termine di un’epoca, ci farei almeno un bel pensiero.