Giovanni Covone's Blog, page 2
October 11, 2023
Alexander von Humboldt e la geografia dell’universo
 Un’immagine dalla versione del Kosmos di Traott Bromme (“Atlas zu Alexander von Humboldt’s Kosmos”, Stoccarda 1861).
Un’immagine dalla versione del Kosmos di Traott Bromme (“Atlas zu Alexander von Humboldt’s Kosmos”, Stoccarda 1861).Nel 1936 l’astronomo americano Edwin Hubble pubblicò “The Realm of the Nebulae”, una pietra miliare nella storia della cosmologia. Nebula era il nome latino usato in quegli anni per indicare le galassie, la cui natura era stata appena scoperta. Oggi tradurremo “The Realm of the Nebulae” con “il Regno delle galassie”. Era la rassegna di uno straordinario decennio di osservazioni astronomiche che avevano portato alla scoperta delle galassie e dell’espansione dell’Universo. Hubble aveva contribuito a queste scoperte, insieme a molti altri astronomi. Nel libro rifletteva sulla nascita dell’espressione “universi isola” usata per indicare le galassie. Egli fa risalire l’introduzione del termine ad Alexander von Humboldt, (1769 – 1859) il grande naturalista, esploratore e geografo tedesco, una figura di primo ordine nella scienza della prima metà dell’Ottocento e oggi quasi sconosciuto ai più. La sua opera principale fu Kosmos (o meglio “Il cosmo, progetto di una descrizione fisica del mondo”), un lavoro gigantesco, in cinque volumi, pubblicati tra il 1845 e il 1862 e tradotti in poco tempo in quasi tutte le lingue d’Europa.
Hubble scrisse: “La moltiplicazione dei sistemi stellari portò al termine Weltinseln (‘Universi isola’) usato in Kosmos da von Humboldt”, presumibilmente per la prima volta. Nella nota traduzione inglese di Otte (1855), il termine è tradotto letteralmente come “world islands”. Von Humboldt usa questo termine quando si riferisce alla Via Lattea, il sistema stellare a cui appartiene il Sole: “la nostra isola cosmica forma un sistema di stelle a forma di disco.” Più avanti Hubble scrive giustamente che il passaggio al termine più comune “universi isola” fu un passo naturale.
La breve nota di Hubble è solo una delle tante testimonianze dell’impatto che l’opera di von Humboldt aveva avuto sulla comunità scientifica in tutto il mondo e in particolare sugli astronomi, nonostante non fosse egli un astronomo professionista. L’ultimo notevole esempio di questa influenza è “Cosmos“, il libro di divulgazione scientifica e la serie televisiva del 1980 dell’astronomo Carl Sagan, che fa esplicito riferimento all’opera di von Humboldt sia nel titolo che nella forma di un viaggio tra le stelle e le galassie.
Nel 1845, quando fu pubblicato il primo volume di Kosmos, l’esplorazione dell’Universo con i telescopi stava muovendo i primi passi: la meccanica celeste era applicata solo al Sistema Solare; la fotografia astronomica (ossia, la registrazione oggettiva delle osservazioni) non esisteva; la spettroscopia – l’unico modo per determinare la composizione materiale dei corpi celesti – non era ancora stat applicata all’astronomia; la natura fisica delle nebulose era sconosciuta (non si sapeva se si trattava di sistemi stellari o gassosi, se erano interni o esterni alla Via Lattea). Eppure, l’opera aveva un carattere visionario che possiamo apprezzare anche oggi. In Kosmos, von Humboldt descrive un viaggio, partendo dalla considerazione della Terra nel suo contesto cosmico. Nell’introduzione scrisse: “La descrizione dell’universo non inizia con la Terra, da cui un punto di vista meramente soggettivo avrebbe potuto farci partire, ma piuttosto con gli oggetti compresi nelle regioni dello spazio cosmico“. Questo punto di partenza non era una novità nelle opere scientifiche divulgative. Ma, a quel tempo, i trattati di geografia fisica erano generalmente preceduti da un’introduzione astronomica in cui la Terra era considerata esclusivamente come una parte del Sistema Solare. Von Humboldt segue un percorso diametralmente opposto, ampliando la visione: “Per valutare adeguatamente la dignità del Cosmo, è necessario che la parte siderale […] non sia subordinata a quella terrestre. Nella scienza del Cosmo, secondo l’espressione di Aristarco di Samo, il pioniere del sistema copernicano, il Sole, con i suoi satelliti, non era altro che una delle innumerevoli stelle che occupano lo spazio. La storia fisica del mondo deve quindi iniziare con la descrizione dei corpi celesti e con uno schizzo geografico dell’universo, o, per meglio dire, una vera e propria ‘mappa del mondo’, come quella tracciata dalla mano audace di William Herschel“.
Von Humboldt descrive infatti la prima mappa in assoluto della Via Lattea, ottenuta da William Herschel. “Herschel, come un altro Colombo, si addentrò in un oceano sconosciuto, dal quale vide coste e gruppi di isole, la cui vera posizione resta da determinare nelle epoche future.”
Von Humboldt descrive le osservazioni di William Herschel e del figlio John, di Lord Parson e altri astronomi e propone una classificazione originale dei corpi celesti osservati. Alcuni dei termini introdotti per la prima volta da von Humboldt sono ancora oggi comunemente utilizzati nella letteratura astronomica. Abbiamo citato il termine “universi isola“, oggi utilizzato soprattutto nella letteratura scientifica divulgativa, ma dobbiamo a von Humboldt anche l’espressione “cintura di asteroidi”, oggi comunemente usata per indicare la famiglia di corpi minori del Sistema Solare tra Marte e Giove.
Von Humboldt non era solo uno scrittore straordinario che descriveva in modo brillante le conoscenze astronomiche e i loro limiti. Ebbe anche intuizioni profonde, in particolare sul problema allora irrisolto dell’età del cosmo. Fu uno dei primi scienziati a collegare la vastità del cosmo e la velocità finita della luce all’età dell’Universo. Nel 1845, si stavano accumulando prove che la Terra fosse molto più antica di quanto raccontato dalla Bibbia, ma c’era una contraddizione tra le stime geologiche e quelle astronomiche, con le prime a favore di una Terra più antica. Von Humboldt osservò correttamente che “dalla conoscenza che abbiamo della velocità di propagazione dei raggi luminosi, la luce dei corpi celesti lontani ci presenta la più antica prova percepibile dell’esistenza della materia”. In altre parole, quando guardiamo lontano nello spazio guardiamo anche indietro nel tempo. Quindi sappiamo che la materia esisteva nell’universo molto tempo fa, perché oggi ci giunge la sua luce dopo innumerevoli anni. Tuttavia, questa intuizione non fu compresa e approfondita per oltre mezzo secolo. Solo nel 1901, il fisico Lord Kelvin stabilì un collegamento quantitativo tra l’età delle stelle vecchie e lontane e l’età e l’estensione dell’Universo osservabile.
Von Humboldt era consapevole della vastità della nostra ignoranza in cosmologia: “Se, nonostante la piccolezza del nostro pianeta, lo spazio più considerevole e la considerazione più attenta vengono qui concessi a ciò che lo riguarda esclusivamente, ciò deriva unicamente dalla sproporzione nell’estensione della nostra conoscenza di ciò che è accessibile e di ciò che è chiuso alla nostra osservazione”. È affascinante notare la somiglianza tra queste parole e l’immagine della Terra scattata quasi 150 anni dopo dalla sonda spaziale Voyager 1, quando Carl Sagan propose di fotografare il nostro pianeta dai confini del Sistema Solare. L’immagine, la famosa “Pale Blue Dot”, mostra un piccolo e fragile pianeta in un cosmo immenso ancora da esplorare.

September 4, 2023
Piccoli incontri meravigliosi

Non sono mai stato allo storico telescopio di 1,93 metri dell’Osservatorio dell’Alta Provenza (Observatoire de Haute-Provence o semplicemente OHP, come si dice in francese). È il telescopio usato da Michel Mayor e Didier Queloz per scoprire il primo pianeta intorno ad un’altra stella, 51 Pegasi b, nel 1995. Ma poi, a volte, ci sono piccoli inattesi miracoli che accadono quando il tuo libro gira per il mondo e fa incontri meravigliosi.
Pochi giorni fa ho ricevuto una gentilissima email dal signor Jean-Pierre Masviel, astrofilo di Lione, un grande e competente appassionato del cielo e di scienza. Il signor Masviel sta studiando l’italiano e questa estate ha letto il mio libro. Mi ha scritto semplicemente per ringraziarmi per i bei momenti trascorsi con il mio libro e per mandarmi questa foto: io non sono mai stato all’OHP, ma il mio libro sì.
Grazie ancora al signor Masviel, anche perché mi ha ricordato che prima ancora di scoprire un pianeta extrasolare, gli astronomi avevano trovato le prove dell’esistenza delle comete intorno ad altre stelle! Mi ha regalato una nuova storia da scoprire e da raccontare (presto)! Come potrei mai ringraziarlo?
Il sito web del signor Masviel merita una vostra visita: http://astrosurf.com/jpmasviel/2023OHP/2023OHP.html
August 26, 2023
La Terra vista dalla Luna (prima dei viaggi spaziali)

Questa è la Terra vista dalla Luna. Disegnata (e quindi “osservata”) prima che andassimo sulla Luna. È un dipinto del 1939 di Charles Bittinger, straordinariamente simile alle fotografie scattate trenta anni dopo dagli astronauti dell’Apollo. Alcuni dettagli sono di un realismo impressionante, come i bordi rialzati dei crateri lunari. Charles Bittinger (1879 – 1970) era un artista americano. Nel 1939, il National Geographic gli assegnò il compito di creare una serie di dipinti per mostrare ai lettori i paesaggi che un giorno avremmo visto da vicino nello spazio siderale.
“Progettando ed elaborando questi dipinti, sono arrivato a sentire più che mai come l’astronomia è il più grande monumento all’intelligenza umana, che ha esplorato le profondità inimmaginabili dello spazio con niente di più tangibile delle fragili onde della luce”. (Charles Bittinger)
Fonte: National Geographic
August 16, 2023
Fahrenheit
La mia (lunga) intervista con Graziano Graziani per Fahrenheit su Radio 3, in onda lunedi 14 agosto.
L’intera puntata è qui: Fahrenheit 14 agosto 2023
July 31, 2023
La prima luce di Euclid
 Credits: © ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, CC BY-SA 3.0 IGO
Credits: © ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, CC BY-SA 3.0 IGO Credits: © ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, CC BY-SA 3.0 IGO
Credits: © ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, CC BY-SA 3.0 IGOC’è un momento speciale nella vita di un telescopio, e ha un bellissimo nome: la prima luce. The first light.
È il momento in cui il telscopio “apre gli occhi”: punta per la prima volta verso le stelle, mette in azione il rivelatore e ottiene la prima immagine del cosmo.
Questa prima osservazione non è mai un evento di grande importanza scientifica, la prima immagine non serve a fare una scoperta. Serve semplicemente a capire se tutto funziona, se il telescopio mantiene le promesse, se le centinaia di donne e uomini che hanno lavorato per anni (ingeneri, tecnici, astronomi) sono riusciti a trasformare un sogno in uno strumento.
E proprio per questo è il momento più atteso e emozionate nella vita di un telescopio.
Euclid oggi ha aperto gli occhi. Dopo aver viaggiato quasi un mese nello spazio e aver raggiunto il suo luogo di osservazione a oltre un milione di chilometri dalla Terra, Euclid ha usato VIS e NISP, i suoi due strumenti, per osservare le stelle.
Il risultato è quello che vedete qui: è pieno di stelle e di galassie là fuori. Emozionante, poetico e pronto produrre immagini dense di scoperte da fare.
Lunga vita a Euclid!
July 19, 2023
Un’intervista sul dialogo tra filosofia e fisica
Nel 2017 ho tenuto alcune lezioni all’Ischia Summer School of Humanities sul rapporto fra fisica e filosofia. Questa è una breve intervista con Maria Cristina Mennuti, apparsa su Oubliette Magazine.
All’interno del percorso dell’Ischia Summer School of Humanities a condurci alla scoperta della dimensione interstellare è stato Giovanni Covone, astrofisico e ricercatore presso il Dipartimento di Fisica dell’Università “Federico II” di Napoli.
Docente di Storia dell’Astronomia, Fisica delle Galassie e Cosmologia osservativa. I suoi interessi scientifici riguardano lo studio della natura della materia oscura, l’evoluzione delle strutture cosmiche e lo sviluppo del pensiero scientifico.
In questa breve quanto densa intervista, il professor Covone ci spiega perché ha deciso di avventurarsi in un ambito che i più considerano così lontano dalla fisica: quello della filosofia.
Incredibilmente i due campi disciplinari si mescolano nelle sue parole; rivelano una consonanza di fondo, un intreccio spesso celato. E così si scopre la possibilità, la concretezza di un dialogo tra filosofia e fisica che ha molto da dirci, più di quanto potremmo immaginare.
M.C.M.: Può essere possibile il dialogo tra filosofia e fisica, in particolare per quanto riguarda la cosmologia, e in che modo possono secondo te collaborare entrambe alla conoscenza?
Giovanni Covone: Quando sono stato invitato a partecipare alla Summer School ho accettato subito con entusiasmo perché era un tipo di confronto con il mondo umanistico – filosofico che cercavo da tempo in qualità di fisico, anche se sul tema del Nichilismo era difficile anche per me prevedere inizialmente un punto di contatto. Per dirlo in modo diretto, infatti, per sua stessa natura il fisico, lo scienziato sperimentale non è e non può essere nichilista. C’è un aspetto del nichilismo, emerso maggiormente nel confronto col prof. Tarca, che è quello del nichilismo epistemologico che nega la possibilità alla specie umana di conoscere, di indagare il mondo esterno, se non addirittura negare la realtà esterna in qualche modo; oppure, altrimenti, nega la fiducia nella possibilità che il mondo esterno sia razionale, che sia un cosmo. Queste sono forme di nichilismo che non appartengono allo scienziato; tuttavia, c’è un nichilismo che può essere inteso come metodo, metodo del dubbio, che è parte integrante dell’indagine scientifica. Se ad esempio pensiamo a Nietzsche, massimo esponente del nichilismo attivo nel ‘900 europeo, egli conferisce alle scienze naturali una funzione nichilistica importante, perché distruggono e decostruiscono l’impianto razionale che presenta l’uomo al centro. La rivoluzione copernicana, la rivoluzione di Darwin hanno parimenti questo compito e perseguono una decostruzione nichilistica, condivisa anche da molteplici tesi filosofiche.
M.C.M.: Abbiamo parlato di nichilismo in filosofia. Come definiresti il Nichilismo in fisica?
Giovanni Covone: La mia stessa perplessità di trovare del nichilismo in fisica è un fattore che mi accomuna ai miei colleghi fisici; ma probabilmente l’aspetto nichilistico delle scienze sosta proprio nel metodo, il mettere in dubbio le verità già dette, il continuo esperimento di teorie già formulate. Un astrofisico osservativo come me o un fisico sperimentale, hanno come massima aspirazione quella di fare un’osservazione, un esperimento che falsifichi la teoria, la neghi. In questo senso lo scienziato presenta un atteggiamento nichilistico nella metodologia, pur mantenendo un atteggiamento positivo nei confronti della realtà e di fiducia incondizionata nella razionalità del mondo e della possibilità di comprenderlo.
M.C.M.: A proposito del confronto con Tarca è emerso il tema della Bellezza: una bellezza che va tirata fuori dalle fessure della realtà e di cui si può godere. In questo modo preserviamo quell’atteggiamento di meraviglia da cui, come già ci ha insegnato Aristotele, si dipana la speculazione filosofica. Secondo te anche in fisica la matrice, lo stimolo originario dello studio è la meraviglia, oppure occorre porre basi diverse per le indagini scientifiche?
Giovanni Covone: Indubbiamente si desidera diventare scienziati proprio perché si parte da un atteggiamento di amore per la conoscenza e di meraviglia verso il mondo esterno. Lo scienziato parte dalla consapevolezza di quanto l’universo, il mondo, la natura siano tanto affascinanti quanto misteriosi per poi lasciare posto alla volontà e alla curiosità di scoprire le loro funzionalità interne, le leggi matematiche intrinseche che governino i fenomeni. La meraviglia è una costante nell’indagine scientifica: è la sorpresa per la “funzionalità degli elementi naturali” e per la scoperta di teorie che sembrano spiegare il mondo esterno. La meraviglia quindi si rivolge anche al metodo. È grazie alla meraviglia che lo scienziato conserva sempre l’interesse per la scoperta, la curiosità per una ricerca inesauribile.
M.C.M.: In uno dei tuoi lucidi fornivi come incipit di discussione la solitudine cosmica: secondo te oggi la scienza può nutrire la speranza nel non essere nichilisticamente soli nell’Universo?
Giovanni Covone: Questo sì, è sicuramente un altro aspetto del nichilismo. Attivamente noi ascoltiamo sempre l’Universo nella speranza di ricevere un segno, un messaggio, consapevole e non, dell’esistenza di specie intelligenti come noi. La speranza da un lato viene nutrita con l’osservazione di pianeti della galassia per molti versi simili al nostro, nelle medesime condizioni ambientali; d’altro lato intorno a noi c’è il nulla, nessuno ci ha visitato, mettendo da parte rapimenti e incontri alieni del terzo tipo (sorride). Possediamo programmi con i quali ascoltare il cosmo, ad esempio il SETI (Search for Extra–Terrestrial Intelligence), che però non ci hanno fornito alcun risultato, ci hanno restituito e continuano a restituirci il silenzio. Dunque, esiste un paradosso: perché un ambiente così pieno e foriero di vita è così vuoto? Allora, il nichilismo non sta tanto nell’assenza di speranza, ma in quella possibile, catastrofica risposta che la scienza ci può dare: una società aliena che potrebbe esistere ma che si trova sempre in crisi ed è incapace di superarla, come la crisi che viviamo in questo momento per la gestione sostenibile del nostro pianeta. Se il nostro stesso pianeta Terra si configura come esempio tipico di una società intelligente e tecnologicamente avanzata, dobbiamo dubitare delle capacità delle specie intelligenti di superare questi momenti di crisi. Il nichilismo nella scienza cede il passo ad un monito per il futuro.
M.C.M.: Dunque, sembra che dal tuo discorso emerga una nota positiva circa questa Summer School. Cosa ti ha lasciato questa esperienza, la ripeteresti?
Giovanni Covone: Non c’è dubbio, la rifarei! È stato un modo inedito per conoscere un mondo a cui non mi ero mai approcciato direttamente. Il contesto della Summer School è stato sicuramente fertile per confronti con colleghi appartenenti ad ambiti disciplinari diversi, ma anche per rapportarmi con gli studenti e costruire diversi livelli di discorso. Inoltre, è stato stimolante fare la conoscenza di diverse generazioni di filosofi, per le quali ho registrato un interesse crescente per il dialogo interdisciplinare. È emersa una concreta possibilità e disponibilità a superare le distanze, soprattutto fra i più giovani. Ed anzi, proprio le domande che mi sono state rivolte da questi ultimi e che mi hanno maggiormente messo in difficoltà, mi hanno fatto capire l’esigenza di una maggiore chiarezza in termini e concetti. Ho toccato con mano la possibilità del futuro di superare questo divario tra filosofia e scienza, che nasce innanzitutto dalla mancanza di insegnamenti incrociati tra queste discipline in ambito accademico.
M.C.M.: Infine, concludo con una domanda un po’ provocatoria: chi preferisci tra Aristotele ed Hawking?
Giovanni Covone: (ride) Sono innanzitutto distanti 2500 anni e avevano interessi per problemi differenti. Aristotele ha avuto la fortuna di vivere in un momento storico in cui si poteva fare filosofia e fisica contemporaneamente; uno scienziato come Hawking può sforzarsi di interessarsi alla filosofia, ma non può praticarla nel senso più professionale del termine. Se vogliamo Aristotele, così come Leonardo, appartenevano ad un’epoca d’oro in cui ci si poteva interessare di più ambiti del sapere e dare un contributo concreto a ciascuno di essi. Oggi il rischio è la settorializzazione ed Hawking è un risultato di quello. Quando il fisico inglese, secondo me, prende delle cantonate negando qualsiasi importanza alla filosofia, non tiene conto di quello che è oggi la filosofia: non è più la filosofia aristotelica che vuole competere con la fisica. Tuttavia, lo stesso Hawking è vittima di quel sapere settorializzato per cui si diventa massimi esperti di un particolare ambito della conoscenza, precludendosi il dialogo con altre branche del sapere. Pertanto, quando poi ci si avventura fuori dal proprio giardino, si rischia di camminare male. La sfida che ho raccolto e attuato in questa Summer School è stata proprio quella di “nuotare fuori dal mio acquario”; un’esperienza di dialogo con la cultura in senso lato sconsigliata nel mondo accademico, se non addirittura ostacolata, ma che ineludibilmente procura piacere ed è utile a capire il senso di quelle che sono le nostre attività quotidiane.
Queste le parole con cui il professor Covone conclude questa piacevole chiacchierata. Non resta che accogliere i molteplici input di riflessione che possiamo cogliervi e farci continuamente animare dalla meraviglia filosofica e dall’interesse scientifico.
E se Hawking ci dice che “La filosofia è morta!” non possiamo proprio credergli!
July 16, 2023
“Non funziona!”
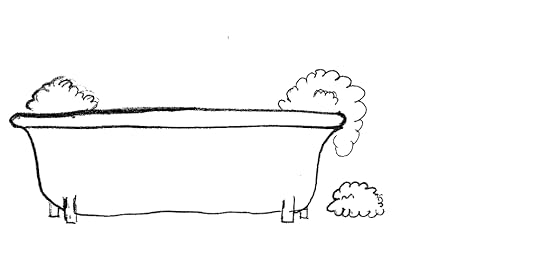
Come arriva uno scienziato ad una scoperta? Forse il primo esempio che ci viene in mente è Archimede che scopre la legge sui corpi galleggianti. Archimede a mollo nella vasca da bagno, un po’ pensoso o forse con la testa fra le nuvole, all’improvviso salta fuori e corre verso casa gridando: «Èureka! Ho trovato!». È un aneddoto senza basi storiche, eppure è diventato il simbolo del momento della scoperta e della figura dello scienziato distratto e geniale.
Nella realtà, il momento-eureka non è parte della giornata-tipo di uno scienziato. La scoperta è un momento raro. L’espressione più comune non è «Èureka», ma forse «Non funziona!». La scoperta è una consapevolezza che si afferma lentamente, man mano che si escludono ipotesi alternative per spiegare i risultati di un esperimento. Gli errori o i momenti di sconforto sono molto più frequenti.
Fuori dai laboratori, si ha a volte una percezione sbagliata di come la scienza proceda, giorno per giorno. La ricerca scientifica non è soltanto attività razionale: ingredienti umani come passione, ostinazione e illusione giocano anch’essi un ruolo. Ad esempio, cosa accade in un laboratorio di fronte all’evidenza di essersi sbagliati? Come nella vita, anche in un laboratorio è difficile riconoscere di aver inseguito un’idea che si è dimostrata infondata, riconoscere di essersi innamorati troppo di un’idea senza basi. Il fisico Richard Feynman ripeteva proprio questo ai suoi studenti: “Il principio primo è che non devi ingannare te stesso, e tu sei la persona più facile da ingannare. Devi stare molto attento a questo. Dopo che non hai ingannato te stesso, è facile non ingannare gli altri scienziati”.
La scienza è fatta da donne e uomini appassionati che a volte si trovano a dover ammettere i propri errori. Ma non sempre riescono ad abbandonare le proprie convinzioni, anche di fronte alle evidenze. Agli scienziati accade quello che è successo a tutti noi almeno una volta nella vita: abbiamo dovuto rinunciare a un’idea, una passione e non sempre abbiamo avuto l’onestà intellettuale o il coraggio di riconoscere l’errore e andare oltre.
La storia della ricerca scientifica è ricca di teorie errate, previsioni corrette ma rifiutate per un pregiudizio, scoperte smentite, ricercatori ostinati e scienziati troppo innamorati delle proprie idee. Dalla storia dei fallimenti così come da quella dei successi scientifici, c’è molto da imparare sulla realtà del mondo scientifico e anche sulla natura degli essere umani che lo animano.
July 9, 2023
Esopianeti inabitabili
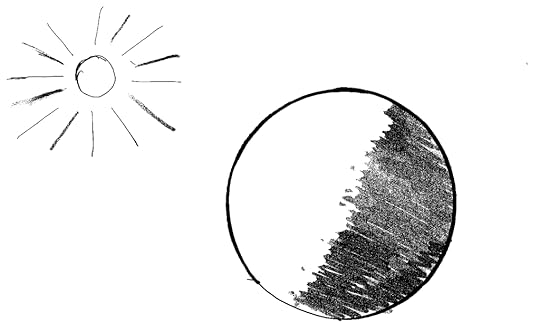
Anche se nessuna di esse è visibile ad occhio nudo, le stelle nane rosse sono di gran lunga la maggioranza delle stelle nella Galassia. La stella più vicina al Sole è una nana rossa (Proxima Centauri) e anche la stella intorno a cui per decenni si è creduto esistessero altri pianeti (la stella di Barnard) è dello stesso tipo, prima di capire che si trattava di falsi allarmi. La maggior parte dei pianeti extrasolari ha quindi come stella madre una di questa stelline, molto meno luminose del Sole (almeno cento volte di meno) che emettono gran parte della propria energia nell’infrarosso.
Trappist-1 è il più famoso di questi sistemi planetari intorno a una stella nana rossa, e non solo per il richiamo alle famose birre belghe: si tratta di un sistema planetario vicino a noi, a “soli” 40 anni luce di distanza, con ben sette pianeti, tutti di dimensioni simili alla Terra. E alcuni di questi potrebbero avere una temperatura superficiale compatibile con la vita, se avessero un’atmosfera.
La ricerca delle atmosfere intorno ai pianeti di tipo terrestre è il primo passo nella lunga strada della ricerca della vita nel Cosmo. Data la sua relativa vicinanza, il sistema planetario di Trappist-1 è uno degli obiettivi principali del telescopio spaziale JWST. Nelle ultime settimane sono apparsi i primi risultati delle prime osservazioni: e questi risultati sono allo stesso tempo in accordo con le previsioni teoriche e deludenti.
La teoria ci dice che le piccole stelle rosse sono stelle inquiete, molto variabili, con improvvise esplosioni di energia (brillamenti), che investono i pianeti vicini con grandi quanti di raggi UV e X. Questi brillamenti potrebbero essere così intensi da spazzare via le atmosfere e persino sterilizzare la superficie dei pianeti più vicini. Le recenti osservazioni dei pianeti Trappist-1 b e c, i due più vicini alla stella, non hanno trovato tracce di atmosfere. O, se queste sono presenti, sono così sottili e poco dense, da non poter essere rivelate dai nostri strumenti.
Due diversi gruppi di astronomi hanno utilizzato lo strumento MIRI del James Webb Space Telescope per misurare la temperatura dei due pianeti osservando nell’infrarosso. In un’altra occasione parleremo di come funziona questa tecnica. Per ora ci basta ricordare che la quantità di luce nell’infrarosso emessa da un pianeta è correlata alla sua temperatura, a sua volta influenzata dall’atmosfera.
Sappiamo che i due pianeti sono così vicini alla stella che rivolgono sempre lo stesso emisfero verso di essa (come la Luna con la Terra). Le osservazioni con MIRI hanno permesso di misurare le temperature sui due emisferi dei pianeti (quello sempre illuminato e quello avvolto nelle tenebre). Per entrambi i pianeti, la differenza di temperatura osservata può essere spiegata con la quasi totale senza di atmosfera.
Gli astronomi sapevano già che questi due mondi sono troppo vicini alla loro stella per essere potenzialmente abitali, secondo i criteri che conosciamo per la vita. Ma nel sistema di Trappist-1, ci sono altri tre pianeti (Trappist-1e, 1f e 1g) che potrebbero presentare le condizioni per l’esistenza di acqua liquida sulla loro superficie. Tuttavia, ora appare più probabile che anche questi pianeti potrebbero aver subito lo stesso destino dei due fratelli più vicini alla stella: le eruzioni di energia della loro stella potrebbe aver strappato via anche le loro atmosfere.
Le osservazioni proseguono. Chissà, i prossimi dati magari smentiranno questa tesi. Per ora, sembra un po’ più probabile che i pianeti di tipo terrestre abitabili siano estremamente rari intorno alle stelle più abbondanti nella nostra Galassia.
Per saperne di più:
“No thick carbon dioxide atmosphere on the rocky exoplanet TRAPPIST-1 c” di S. Zieba et al. (giugno 2023)
July 7, 2023
Fosforo (e vita?) su Encelado
 Encelado: illustrazione del National Geographic
Encelado: illustrazione del National GeographicTutti i sei elementi chimici necessari per la vita come la conosciamo sono stati trovati nei geyser di acqua di Encelado, uno dei satelliti di Saturno. Anche il fosforo.
Sulla Terra, il fosforo è presente nel DNA e nell’RNA: fra gli elementi fondamentali per la vita sulla Terra è relativamente raro sulla Terra, tuttavia costutisce la spina dorsale dell’acido nucleico. Su Encelado è stata misurata una concentrazione di fosforo cento volte superiori rispetto agli oceani della Terra. Il satellite ghiacciato di Saturnoè l’unico corpo celeste oltre la Terra con un oceano contenente tutti e sei gli elementi necessari alla vita.
Tutto questo grazie ai dati della sonda Cassini, le cui operazioni sono terminate sei anni fa. Cosa scopriremo quando torneremo nel sistema di Saturno?



