What do you think?
Rate this book


78 pages, Paperback
First published September 1, 2002

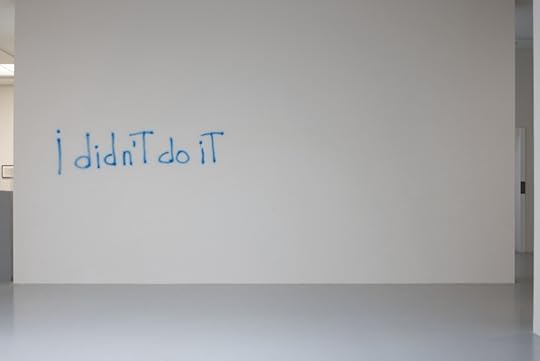

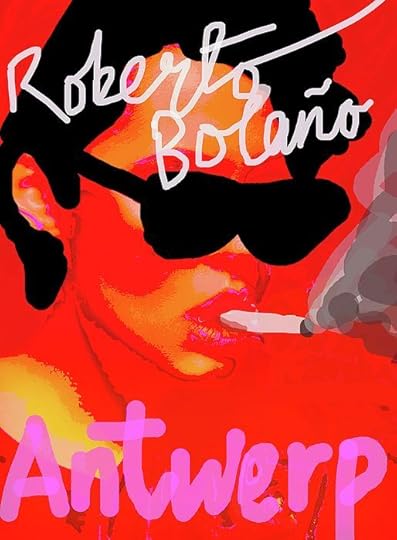
Twin highways flung across the evening, when everything seems to indicate that memory and finer feelings are kaput, like the rental car of a tourist who unknowingly ventures into war zones and never returns, at least not by car, a man who speeds down highways strung across a zone that his mind refuses to accept as a barrier, vanishing point (the transparent dragon), and in the news Sophie Podolski is kaput in Belgium, the girl from the Montfaucon Research Center (a smell unbefitting a woman), and the lips say "I see waiters, hired for the summer, walking along a deserted beach at eight o'clock at night" ... "Slow movements, real or unreal I don't know" ... "A sandswept group" ... "For an instant, a fat eleven-year-old girl lit up the public pool"..."So is Colan Yar after you too?" ... "The highway, a black-topped strip of prairie?" ... The man sits at one of the cafes in the hypothetical ghetto. He writes postcards because breathing prevents him from writing the poems he'd like to write. I mean: free poems, no extra tax. His eyes retain a vision of naked bodies coming slowly out of the sea. Then all that's left is emptiness. "Waiters walking along the beach" ... "The evening light dismantles our sense of the wind"...